Osservazioni sul canto I dell Inferno
|
|
|
- Luigina Parodi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Osservazioni sul canto I dell Inferno SELENE SARTESCHI selene.sarteschi@libero.it RIASSUNTO: L articolo ripercorre il testo del I canto dell Inferno mettendone in evidenza i momenti di maggiore tensione espressiva ed intertetsuale, illustrando da una parte le fonti del poeta e dall altra il doppio livello del significato (letterale ed allegorico). La lettura è condotta con attenzione estrema ai concreti aspetti verbali, cercando di coglierne ogni volta le allusioni e le suggestioni, sia sul versante fonico che su quello semantico. PAROLE CHIAVE: Inferno, selva, veltro, Virgilio, poeta. ABSTRACT: This article examines the text of Canto I of the Inferno, highlighting the moments of greatest expressive and inter-textual tension, and showing, on the one hand, the poet s sources, and on the other, the double level of meaning (literal and allegorical). The reading pays very close attention to the concrete verbal aspects, trying to pick out each allusion and each suggestion both semantic and phonic. Key words: Inferno, selva, veltro, Virgil, poet. 65
2 Tenzone Il primo canto dell Inferno, proemiale a tutte e tre le cantiche, riveste sicuramente un importanza fondamentale nell economia dell intero poema. Il canto misura 136 versi ed è facilmente divisibile in quattro parti che possiamo concepire come quattro grandi scene che sfilano una dopo l altra, perfettamente collegate fra loro ma in certo qual modo indipendenti una dall altra. Le prime tre parti possiedono la medesima lunghezza di 30 versi ciascuna, l ultima è più lunga, contando 46 versi. In particolare dal primo verso al verso 60 ossia nelle due parti iniziali il protagonista passa rapidamente attraverso una serie di esperienze che alternano fasi negative a fasi positive, fasi di speranza e di disperazione. Dal verso 1 al verso 30 è in primo piano la figura dell uomo smarrito che tenta di ritrovare la «diritta via»; dal verso 31 al verso 60 le tre fiere dominano le dieci terzine; dal verso 61 al verso 90 protagonista del canto è Virgilio; quindi nella quarta e ultima parte le prime 13 terzine sono occupate dal lungo discorso del poeta latino, per convincere Dante a compiere il viaggio nell oltretomba, 2 terzine contengono l assenso e la preghiera di quest ultimo affinché Virgilio lo guidi, mentre il verso finale si riallaccia circolarmente al primo, con ripresa dell immagine del cammino su cui il canto si era aperto. Dopo questa breve premessa ricordiamo che è nel quarto trattato del Convivio che Dante fissa a 35 anni la metà della durata ideale del corso della vita di un uomo (Convivio IV, XXIII, 6-10). Quindi, sulla base del Salmo 89, 10 «Dies annorum nostrorum [ ] septuaginta anni» e di un brano di Isaia (38, 10), il poeta prende questo dato temporale e lo trasforma in una perifrasi, quella che dà avvio al canto: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. (Inf. I, 1-3) La terzina iniziale della Commedia è di una nitidezza cristallina: i primi due endecasillabi, in apertura, saldano in un unica proposizione le maglie di una trama letterale e allegorica sulla quale si impernia l intera costruzione. La storia narrata dall autore riferirà, o meglio dirà, tratterà della 66
3 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno condizione esistenziale di un singolo uomo, ma questi rappresenta, al contempo, ed è sufficiente la presenza dell aggettivo possessivo di prima persona plurale nel sintagma «nostra vita» per fissare questa duplicità, la condizione di qualsiasi uomo. 1 Fissato incipitariamente tale punto di vista la macchina poematica si è messa in movimento e si incarica di raccontare un percorso salvifico straordinario, soggettivo e universale. Il fatto che il protagonista-autore possa raccontare la sua avventura predispone all ascolto o alla lettura di una vicenda che iniziata in modo tragico si è svolta, poi, in modo comico, ossia con un finale positivo (Cfr. Epistola XIII, X). È notevole la quantità di informazioni che il lettore può ricavare solo da questi primi tre versi: l io narrante coincide con l agens, questi ha 35 anni e si è smarrito, allontanatosi dalla strada che conduce alla mèta, in una «selva oscura». L espressione ritrovarsi per indica che il protagonista, resosi conto di aver smarrito il cammino, sta ora vagando in tutte le direzioni all interno della selva per cercare di uscirne. La scena iniziale ha una sua valenza epica e universale, recando con sé, come è stato messo in evidenza, l eco di passi biblici e patristici che le conferiscono una tonalità profetica. Sullo sfondo della prima scena v è infatti, come abbiamo accennato, il brano di Is. 38, 10, «Ego dixi: in dimidio dierorum meorum vadam ad portas inferi». Chi parla è il re Ezechia, al quale Dio concede, su preghiera sincera del re, altri tre lustri di vita. La vicenda del poema, che pare svolgersi attraverso un tessuto linguistico dimesso e piano, acquista, attraverso il riscontro biblico, una profondità escatologica che ne costituirà, dall inizio alla fine, il piano di fondo. Ecco che il primo canto infernale, e in particolare le prime terzine, rappresenta la base necessaria affinché le dichiarazioni dell autore assumano un valore non solo locale, ma metatestuale: è questo il proemio dell intera Commedia, ed è qui necessario che il lettore colga la doppia valenza di una scrittura letterale e allegorica, aderente alla dimensione terrena ma già proiettata verso l oltremondo. In questa dimensione, letterale e allegorica, la selva reale e minacciosa rappresenta anche «la selva erronea di questa vita» (Convivio IV, XXIV, 12), eco probabile di una frase agostiniana, In Ioannem, 16, 6: «Amara 67
4 Tenzone silva mundus hic fuit»: la concretezza di un esistenza, tanto personale quanto generale, perduta nell errore. Parlare di questo luogo, anche adesso che la vicenda è terminata, procura ancora sofferenza all autore che ricorda: Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura. Tant è amara che poco è più morte. (Inf. I, vv. 4-7) L asprezza del luogo riattualizza nella mente la paura e «paura» è parola che ricorre ben cinque volte nella prima metà del canto (v. 6; v. 15; v. 19; v. 44; v. 53) e l auctor rende il carattere negativo della selva con un verso in climax, che guizza di sibilanti: «esta selva selvaggia e aspra e forte»; tale selva si rivela, in un gioco allitterativo che sottolinea la carica semantica dell immagine, poco meno amara della stessa morte, con ripresa di quell aggettivo «amara» che risale all Ecclesiaste, VII, 27: «Et inveni amariorem morte mulierem», e ancora, significativamente, a Isaia, 38, 15 e 17. Il verso 8 inizia con un avversativa: «Ma». Nonostante sia duro parlare della selva, Dante si ripropone lo scopo di «trattare del ben ch i vi trovai» (v. 8). La finalità didascalica del racconto è in piena luce perché ciò che l autore ha vissuto in prima persona possa tornare utile a quanti leggeranno. Anche nella selva, dunque, nell oscurità e nel terrore, Dante ha scorto cose di cui merita riferire, perché è in questo luogo che, dopo lungo tempo, egli ha sentito rinascere l impulso di ritornare, dal buio nel quale era immerso e dalla morte del peccato, alla luce solare ed alla vita della grazia divina. 68 Io non so ben ridir com i v intrai, tant era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch i fui al piè di un colle giunto, là dove terminava quella valle che m avea di paura il cor compunto,
5 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogne calle. (Inf. I, vv ) Dante non si ricorda come sia entrato nella selva, a motivo del «sonno» che lo impediva nell attività razionale nel momento di smarrire quella via che è definita «verace» (v. 12), con preciso richiamo sia a un passo di Agostino: «somnus autem animae est oblivisci Deum suum» (Enarr. in Ps. 62, 4), sia, con ripresa della «diritta via» del verso 3, a un brano di Io. 14, 6, in riferimento al Cristo: «Ego sum via, veritas et vita». I passi di Dante compiuti nella notte di angoscia e di paura trascorsa nel buio della selva hanno termine e questi si ritrova, continuando a cercare la via diritta, ai piedi di un «colle», proprio nel punto in cui «[ ] terminava quella valle / che m avea di paura il cor compunto» (vv ). Guardando verso l alto il poeta ricorda di aver visto la sommità del colle illuminata dai raggi del sole che conduce rettamente ogni uomo per ogni sentiero. Il sole, simbolo di Dio, e dunque della grazia, conduce dirittamente ciascun individuo per qualsiasi luogo: il messaggio allegorico del poema si coglie nei minimi particolari e coinvolge l uomo in una prospettiva di salvezza che coincide con il fine stesso dell intero poema. All oscurità della selva si oppone la luce del sole, così come termini negativi che possiamo far rientrare nell area semantica della morte, dell annullamento, si oppongono a termini positivi, di vita, di ripresa del protagonista. Si pensi, ad esempio, alla sequenza metaforica che viene a crearsi a partire dall aggettivo «oscura» (v. 2). Dopo tale aggettivo da cui deriva quel clima di paralisi intellettuale che caratterizza il canto sino all arrivo del protagonista al colle illuminato, abbiamo, al verso 4, «dura», al successivo il trinomio in climax «selvaggia e aspra e forte», al sesto, il sostantivo «paura». Al settimo verso incontriamo «amara» e «morte», in significativa allitterazione. Al verso 11 troviamo il sostantivo «sonno», equivalente all obnubilamento della coscienza, ai versi 13 e 15 riscontriamo l opposizione fra «colle» e «valle». Alla condizione di difficoltà e di crisi del protagonista fanno da contraltare il suo guardare in alto e scorgere le 69
6 Tenzone «spalle» (v. 16) del colle illuminate dai raggi del sole «che mena dritto altrui per ogne calle» (v. 18). In questo primo canto si alternano paura e speranza, almeno sino a un certo punto, al di là del quale entrerà in gioco una nuova figura che darà alla vicenda una svolta positiva fondamentale. Tale alternarsi rappresenta a livello letterale ciò che avviene nel canto, ossia nella storia narrata, sino all arrivo di Virgilio, il primo vero personaggio reale, storico della Commedia. Un passaggio continuo fra paura e speranza caratterizza i primi trenta ed i secondi trenta versi del canto, al pari di un intervallarsi rapido e continuo di momenti vitali e di momenti di stasi assoluta, prossima all annichilimento. Consideriamo un momento il primo sostantivo, «mezzo», con cui il canto si apre. Al di là delle implicazioni fondamentali di carattere cronologico che il termine ci offre, sembra possibile credere che la parola possa rappresentare simbolicamente ciò che accade in questo primo canto: allo slancio dell anima del viator, sinora chiuso nell errore, che tenta con tutte le proprie energie di riattingere la dimensione della positività, non corrisponde una realtà univoca: il protagonista rimane nel mezzo di ogni sua impresa, in un variare estenuante fra momenti negativi e momenti positivi, di spinte propulsive e di fallimenti. Ad ogni successo parziale corrisponde un insuccesso. L avanzamento è sempre minato dalla retrocessione. Si contrappongono due movimenti, uno in avanti, uno all indietro. Ecco il «mezzo»: il viaggio verso la libertà dal peccato tenta di iniziare e ogni volta interviene un elemento a bloccarlo. Il mezzo del cammino infatti si può intendere letteralmente come un punto che divide il cammino a metà fra quello percorso e quello da percorrere. Possiamo immaginare quel «mezzo» come un posizionamento che sia ubicato in modo tale da offrire necessariamente due possibilità di camminata: o in salita e scalata, oppure di ritorno e discesa nella valle. Le due possibilità sono evidenziate da una serie di isotopie che si alternano indicando in tempi diversi le due alternative. La dimensione dimidiata del protagonista fra paura e speranza, fra avanzamento e sconfitta si scioglierà solo nel momento in cui interverrà la grazia divina. 70
7 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno Il campo semantico che indica il movimento ascensionale di Dante è costituito dai seguenti dati (limitiamo i prelievi ai più significativi): «al piè di un colle giunto» (v. 13); «guardai in alto» (v. 16); «uscito fuor del pelago a la riva» (v. 23); «ripresi via per la piaggia diserta» (v. 29); «speranza dell altezza» (v. 54), dove si rileva che il movimento è tutto nella speranza, ossia nel desiderio di uscire dalla selva; «non sali il dilettoso monte» (v. 77); «A le quai poi se tu vorrai salire» (v. 121). Ma riprendiamo a osservare Dante, il quale alla vista dei primi raggi del sole, si rincuora: «Allor fu la paura un poco queta, / che nel lago del cor m era durata / la notte ch i passai con tanta pieta» (ivi, vv ). Gli spiriti vitali presenti nella concavità che è il ricettacolo del sangue e di ogni passione umana, si rinfrancano. Ma «lago», in significativa giunzione con «notte» e con «pieta», appartiene all area semantica dei sostantivi che indicano morte, stasi, interruzione, al pari di «valle» (v. 14). L autore ci ha condotto sino alla prima similitudine del poema, nella quale è descritta la figura del naufrago salvatosi a stento dal mare. In questa similitudine incontriamo espressioni che si oppongono al movimento in ascesa dell agens: «si volge a l acqua» (v. 24); «si volse a retro» (v. 26): E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago a la riva, si volge a l acqua perigliosa e guata, così l animo mio, ch ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. (vv ). L animo del protagonista è in primo piano: come il naufrago, approdato alla riva sicura, dopo essere scampato alla morte nel mare, si volta con lo sguardo verso l acqua che stava per inghiottirlo, altrettanto l animo del poeta si volta indietro a guardare con spavento quel «passo» che non permise a nessun uomo che vi restasse di sopravvivere. Il passo è comunque il passaggio pericoloso che come in altri casi del poema rappresenta l ostacolo che il viator si trova costretto a superare per continuare il proprio percorso. 71
8 Tenzone Riposato un poco il corpo stanco il protagonista si incammina per la «piaggia diserta». Si tratta di un luogo che si trova fra la selva ed il colle e che possiede, al pari della selva e del colle, un significato allegorico: lontano dalla luce divina esiste unicamente il deserto dell anima: Agostino, commentando il Salmo 62, 1 scriveva nelle Enarrationes: «Et hic desertum, ubi multum sititur». Procedendo lungo la spiaggia disabitata Dante dichiara di muoversi in modo tale «sì che l piè fermo sempre era l più basso» (v. 30). Si tratta di un verso tormentato dagli esegeti che ha un duplice valore, letterale e metaforico. Leggiamo la nota ad locum di Giorgio Inglese: 30. così che sempre il piede fermo soggiaceva al piede in movimento come accade quando si cammina in piano: quando si sale, invece, per una parte del passo il piede fermo è più in alto di quello in movimento. Vuol dire che il pendìo era impercettibile; oppure gioca con il paradosso fisico ( salivo e camminavo in piano [ ]) per rilevare un senso allegorico: lo sforzo del protagonista verso il bene è insufficiente, infruttuoso (Inglese in Alighieri 2007: 41). 4 Termina, al verso 30, la prima parte del canto nella quale il poeta ha descritto eminentemente la sua situazione di difficoltà nella selva, il suo tentativo di uscirne alla vista dei primi raggi solari, in un misto emotivo di paura e sollievo. Ma a partire dal verso 31 sino al verso 60 Dante sperimenterà soprattutto la sensazione della paura, poiché non appena egli ha iniziato a dirigersi verso il colle, per salirlo, gli si fanno incontro tre terribili fiere: una lonza, un leone, una lupa. È in questa sezione del canto, eminentemente, che incontriamo gli indicatori del movimento di discesa verso il basso che si oppongono alla riemersione di Dante mantenendolo in quella situazione di «mezzo» cui abbiamo accennato. Tali indicatori di discesa sono i seguenti: «ritornar più volte volto» (v. 36); «mi ripigneva là dove l sol tace» (v. 60); «rovinava in basso loco» (v. 61); «ritorni a tanta noia» (v. 76); «per cu io mi volsi» (v. 88). Nel complesso il campo semantico più ricco è quello ascensionale, e questo perché la macchina del poema non si muoverebbe se mancasse una propulsione in avanti. Tuttavia la propulsione è tenuta a freno dal campo semantico op- 72
9 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno posto che pur non essendo ricchissimo possiede elementi forti che rappresentano l impedimento alla continuazione del viaggio: e sono gli animali. Quindi questi hanno un peso reale che dà al canto quel senso di stasi, di immobile irrequietezza o diciamo tensione senza la quale la macchina poematica starebbe in uno stato di inerzia perenne. Al momento dell incontro con le fiere il tempo stagionale e atmosferico è favorevole, al punto che il pellegrino pensa di poter avere la meglio sul primo animale che gli sbarra la strada, la lonza «che di pel macolato era coverta» (v. 33); la lonza impedisce il moto ascensionale di Dante: «anzi mpediva tanto il mio cammino» (v. 35): verso importante perché rafforza il senso del racconto introducendo un impedimento e, non a caso, si registra il ritorno della parola «cammino». Ma il movimento di ascesa sembra continuare poiché è presente il tempo divino che, per il momento, dissipa ogni difficoltà: Temp era dal principio del mattino, e l sol montava n su con quelle stelle ch eran con lui quando l amor divino mosse di prima quelle cose belle; sì ch a bene sperar m era cagione di quella fiera a la gaetta pelle l ora del tempo e la dolce stagione; ma non sì che paura non mi desse la vista che m apparve d un leone. (vv ). L illusione del poeta è comunque vana: nonostante il sole stia nascendo e si trovi nella costellazione dell Ariete, in primavera, nella stessa stagione in cui si pensava che Dio avesse dato avvio alla creazione, il viator è bloccato dalla belva più terribile e più temibile dello stesso leone che si è fatto incontro a Dante con le fauci spalancate e con la testa alta. Simboli, rispettivamente, della lussuria e della superbia, la lonza ed il leone, la lupa è invece simbolo della radice di tutti i peccati, ossia della cupidigia. 2 La sua descrizione è notabile anche per i suoni aspri che evoca, con la ripetizione in tre versi contigui del nesso consonantico: gr. 73
10 Tenzone Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch uscia di sua vista, ch io perdei la speranza de l altezza. E qual è quei che volontieri acquista e giugne l tempo che perder lo face, che n tutti i suoi pensier piange e s attrista, tal mi fece la bestia sanza pace, che, venendomi ncontro a poco a poco mi ripigneva là dove l sol tace. (vv ) Anche le fiere dantesche appartengono, al pari di molti altri oggetti o entità nominate in questo primo canto, al repertorio biblico e sono presenti in Ier. 5, 6: passo nel quale il Signore invia tre bestie a colpire i peccatori: «percussit eos leo de silva, lupus [ ] vastavit eos, pardus vigilans super civitatem eorum». Al verso 54 è chiaro il movimento che si oppone alla salita verso la salvezza: «ch io perdei la speranza de l altezza», dove si rileva che il movimento è tutto nella speranza, ossia nel desiderio di uscire dalla selva. Quindi la similitudine ai versi non può che riferirsi a Dante stesso ed essere, dunque, una pseudosimilitudine di cui il senso è il seguente: è qual è colui che con impegno ha ottenuto un successo, ossia con soddisfazione si è reso conto di aver fatto fronte alle asperità, e arriva il tempo che gli fa perdere quanto ha acquistato, e in tutti i suoi pensieri si addolora, tal, ossia sconsolato e piangente mi rese la lupa che è priva di pace e che venendomi incontro mi respingeva inesorabilmente verso la selva, dove domina il buio. Siamo quasi alla metà esatta del canto e Dante è ritornato alla situazione di partenza: all oscurità. Anche in questo caso un esame lessicale, in particolare dei verbi usati fino a questo punto può essere indicativo. Dante usa i verbi «era smarrita» e «abbandonare» per indicare il suo allontanamento dalla strada diritta (v. 3 e v. 12); successivamente il verbo «giungere», in relazione al suo arrivo alla base del colle illuminato dai raggi del sole (v. 13); poi il verbo biblico «compunto» (v. 15) per indicare la paura che aveva afflitto il suo cuore nel periodo
11 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno trascorso nella «valle»; quindi l espressione «guardare in alto» (v. 16); «menare dritto» (v. 18) per indicare un movimento in positivo. La «paura» infatti si «queta» (v. 19) e egli può tentare la scalata del colle (v. 29). La prima fiera tuttavia lo costringe a «ritornar più volte vòlto» (v. 36); eppure rinasce la fiducia, poiché Dante si trova a compiere la scalata nel momento più favorevole dell anno: la primavera. E anche in questo caso i verbi sono indicatori dell ondeggiamento degli stati d animo e delle azioni del protagonista, a metà «nel mezzo», appunto fra successo e insuccesso. È da ritenere fondamentale la presenza al verso 40 del verbo muovere : «e l sol montava in su con quelle stelle / ch eran con lui quando l amor divino / mosse di prima quelle cose belle». Il verbo muovere ha sempre un significato positivo e indica la presenza di Dio nelle cose celesti ed umane. Non a caso tale verbo concluderà il nostro canto e tornerà nel secondo, in un luogo cruciale «Amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf. II, 72), nelle parole di Beatrice a Virgilio. Tuttavia al «sì ch a ben sperar m era cagione / di quella fiera a la gaetta pelle» (vv ) fa da contraltare dopo l apparizione della lupa: «ch io perdei la speranza de l altezza» (v. 54). All acquisto si oppone diametralmente una perdita. Al momento della comparsa della lupa il tentativo di Dante di salvarsi con le proprie forze, la sua stessa fiducia di poter superare gli ostacoli si sono vanificati: è in questo momento, il più negativo, quando ogni cosa sembra perduta, che accade qualcosa. Sta al singolo individuo decidere di cogliere o meno l intervento della grazia. Mentre ch i rovinava in basso loco, dinanzi a li occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, «Miserere di me», gridai a lui, «qual che tu sii, od ombra od omo certo!». (vv ) Mentre dunque Dante sta rovinando di nuovo nella selva, con la duplice perdita della speranza e della stessa vita «via impiorum tenebrosa; nesciunt ubi corruant» (Prov. 4, 19) ecco che gli si presenta alla vista 75
12 Tenzone chi a causa di un lungo silenzio parea privo di voce. Anche in questo caso siamo di fronte ad una vera e propria crux. Ma poiché il nuovo personaggio che entra in scena è il rappresentante della grazia divina che, sapremo ben presto, ha lungamente parlato con Beatrice nel canto II dell Inferno, penso si possa escludere il fatto che Virgilio appaia fioco a Dante a motivo di un «lungo silenzio». Tale silenzio appartiene al protagonista che per lungo tempo non ha più udito la voce della ragione. Il verso 63, per quanti sforzi si facciano, non contiene un significato letterale di chiara evidenza: mentre è chiarissimo sul piano allegorico. Ma non per questo è un verso mancato. Nel momento in cui il poeta romano giunge in aiuto a Dante, inviato dalla grazia celeste, e si noti la rapidità dell espressione «dinanzi a li occhi mi si fu offerto», tutto accade in un attimo. Di quell attimo Dante coglie i contorni sfumati, e forse, proprio in quell attimo, che pare «lungo», attende una parola di conforto. Ma poiché questa parola non arriva e non può arrivare, dal momento che il peccatore deve dimostrare la propria umiltà, la propria contrizione quell ombra indistinta appare muta. Solo il «Miserere di me» ha la possibilità di ribaltare la situazione e di compiere il miracolo della salvezza. Conclusasi, dunque, al verso 60 la seconda parte del canto anche essa formata di 10 terzine siamo entrati nella terza: che durerà esattamente altri 30 versi, sino al verso 90. Questa terza parte del primo canto della Commedia è la più distesa e la più serena. È nel corso di questi trenta versi che Virgilio dapprima si presenta: innanzi tutto offrendo a Dante i suoi dati biografici e poi dichiarandogli la sua attività in vita, quella di poeta. Inizia un altro segmento di versi riservati a presentare il primo vero personaggio del poema, perché già appartiene al mondo dei morti. Non credo casuale che la parola chiave «poeta» compaia per la prima volta nel poema al verso 73 (la cui somma dà 10), poiché è solo in virtù della perfezione della parola poetica che, previo il mandato divino, Dante può compiere il suo viaggio di redenzione e, dopo aver seguito Virgilio sino al Paradiso terrestre, quindi Beatrice e San Bernardo, compiuto il viaggio, può come poeta ridire del «bene» che ha trovato addirittura nella 76
13 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno selva e di tutte le cose che ha visto durante il suo itinerario nell oltretomba. Così parla Virgilio: Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d Anchise che venne di Troia, poi che l superbo Ilïon fu combusto. (vv ). La parola «poeta» è a inizio di verso e Virgilio si conferma cantore di quell Enea, ossia di quel giusto, il più giusto fra gli uomini: «quo iustior alter / nec pietate fuit nec bello maior et armis» (Aen. I ), figlio di Anchise proveniente da Troia, dopo che la città fu incendiata. È in questo luogo preciso, ove si menziona perifrasticamente Enea come uomo giusto per eccellenza, che la Commedia dantesca incorpora l insegnamento del poema pagano e ne fa propria una parte del messaggio: quella relativa alla giustizia, la più grande fra le virtù cardinali, soprattutto se abbinata alla pietas, quella che il viator rivendicherà a sé, fra poco, in apertura del canto II: «[ ] e io sol uno / m apparecchiava a sostener la guerra / sì del cammino e sì de la pietate, / che ritrarrà la mente che non erra» (Inf. II, 3-6). Identicamente, nel canto II, Dante dichiarerà a Virgilio i propri timori a compiere il viaggio paragonandosi direttamente proprio ad Enea. In questi versi del I canto infernale, dunque, il lettore assiste all incontro fra il poema classico antico e il poema cristiano moderno, quello che porterà a compimento un mandato del cielo: ricondurre la giustizia nel mondo, ricondurvi quell Astrea, ultima dea a lasciare la terra, perché un nuovo ordo possa regnare, perché possa avverarsi, finalmente, quella tanto attesa palingenesi dell umanità che ha perduto le sue guide. Riconosciuto dunque Virgilio, Dante gli manifesta la sua profonda riconoscenza e l amore per l intero suo «volume» (v. 84). Tu se lo mio maestro e l mio autore, tu se solo colui da cu io tolsi lo bello stilo che m ha fatto onore. Vedi la bestia per cu io mi volsi; 77
14 Tenzone aiutami da lei, famoso saggio, ch ella mi fa tremar le vene e i polsi. (vv ). Se in un primo momento Virgilio aveva domandato a Dante perché non salisse il colle dilettoso (si veda il ritorno del concetto di ascensionalità): «perché non sali il dilettoso monte» (v. 77), simbolo della felicità che l uomo può ottenere nei limiti della natura, adesso il poeta latino scorte le lacrime di Dante («poi che lagrimar mi vide»; v. 92), prova della sua profonda compunzione risponde con altra chiarezza: «A te convien tenere altro vïaggio» (v. 91). Si annuncia così, in questa ultima, lunga quarta parte del canto, la necessità di iniziare un cammino diverso, di percorrere una via altra da quella tentata inizialmente. E questo perché la lupa, aggiunge Virgilio, impedisce a chiunque di passare per la sua strada e lo impedisce al punto tale da ucciderlo. La parola tematica dell ultima parte del canto è «viaggio» (v. 91). In questo segmento non troviamo alcun vettore specifico di salita o discesa : qui riappare essenzialmente la dimensione allegorica del viaggio della «nostra vita» con la spiegazione del ruolo sociale e politico della lupa. E in questa descrizione le indicazioni di movimento de-scensionale sono di natura teologico-cosmica, perché il demonio («invidia prima») ha inviato questo animale-peccato capitale sulla terra per turbare la pace e il benessere dell umanità. La «bramosa voglia» (v. 98) della lupa è tanta che «dopo l pasto ha più fame che pria» (v. 99). Sono molti gli animali a cui la lupa si accoppia, ossia sono molti gli uomini che cadono in preda del vizio della cupidigia e aumenteranno di numero, aggiunge Virgilio, annunciando la grande profezia del canto I, «[ ] infin che l veltro / verrà, che la farà morir con doglia. / Questi non ciberà terra né peltro, / ma sapïenza, amore e virtute, / e sua nazion sarà fra feltro e feltro» (vv ). Il veltro, grosso cane da caccia, avrà il potere di scacciare e stanare la lupa da ogni luogo, rimettendola nell Inferno da cui Lucifero l aveva inviata nel mondo. Il veltro rappresenterà la salvezza per quella «umile Italia» (v. 106) per cui morirono, combattendo assieme, se pure su opposti schieramenti, latini e troiani: la vergine Camilla, figlia del re dei Volsci, Turno, re dei Rutuli, Eurialo e Niso, amici fraterni. Come l espressione «superbo Ilïon» è virgiliana (Aen. III 2-3), 78
15 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno anche il sintagma «umile Italia» proviene da Aen. III : «humilemque videmus / Italiam»; ma l aggettivo è usato da Dante in senso diverso, non geografico e neppure morale, affettivo. L umile Italia non è la «misera Italia» di Conv. IV, IX 10; non è la «miseranda Ytalia» di Ep. V 5, lettera scritta per l elezione di Arrigo VII. È altamente probabile, considerate le speranze che Dante nutriva nella figura di un nuovo imperatore che riportasse l Italia alla felicità che il veltro sia nel disegno dantesco proprio un imperatore, ministro senza intermediari della provvidenza di Dio nella storia, chiamato a salvare «l Italia umile, semplice, nel senso anche di autentica, non corrotta, non superba, virtuosa, portatrice e depositaria di virtù profonde, di valori etici che non potranno infine non trionfare in un rinnovato contesto e sotto la guida di un restauratore della pace e della giustizia» (Malato 2007: 52). Nel primo canto infernale Dante enuncerebbe, dunque, le grandi speranze in un imminente riscatto della società civile, con a capo quelle auctoritates provvidenziali, in primis quella imperiale, in grado di garantire la felicità di questo mondo e dell altro, quello eterno. Ed è nell eterno che Virgilio guiderà Dante, proponendosi come sua «guida» (v. 113): Ond io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco etterno; ove udirai le disperate strida, vedrai li antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida; e vederai color che son contenti nel foco, perché speran di venire quando che sia a le beate genti. A le quai poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna: con lei ti lascerò nel mio partire: ché quello imperador che là su regna, perch i fui ribellante a la sua legge, non vuol che n sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge; 79
16 Tenzone quivi è la sua città e l alto seggio: oh felice colui cu ivi elegge! (vv ). È in questo primo lungo discorso di 39 versi, che Virgilio inviato da Beatrice a salvare Dante che sta combattendo e soccombendo «su la fiumana ove l mar non ha vanto» (Inf. II, 108), usa per la sua missione salvifica la parola «guida», che non tornerà mai più nell Inferno. E in questi versi ( ) preannuncia al pellegrino il viaggio attraverso i due regni, in sua compagnia, e persino il viaggio attraverso il Paradiso, in compagnia di un anima beata. L epifonema contenuto nel verso 129 contribuisce fin dall inizio a velare di malinconia la figura del grande poeta classico, per sempre escluso dalla grazia divina, relegato, come sapremo, nel Limbo. Le parole di Virgilio non sono state spese invano: tant è che al termine del suo monologo, Dante immediatamente implora la guida, in nome di quel Dio che egli non poté conoscere, di condurlo «[ ] là dov or dicesti, / sì ch io veggia la porta di San Pietro / e color cui tu fai cotanto mesti» (vv ). E circolarmente, così come il primo verso del canto indicava un cammino, altrettanto l ultimo verso accenna all inizio del cammino di Virgilio che appena mosso è seguito da Dante: «Allor si mosse, e io li tenni dietro» (v. 136). La più straordinaria delle avventure sta per iniziare. 80
17 Selene SARTESCHI Osservazioni sul canto I dell Inferno NOTE 1 Sono sempre fondamentali al riguardo gli studi di Singleton, per cui si rinvia a Singleton (1978). 2 Cfr. 1 Tim. 6, 10: «radix enim omnium malorum cupiditas, quam quidam appetentes [ ] inseruerunt se in doloribus multis». 81
18 Tenzone RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALIGHIERI, D. (2007): Commedia, revisione del testo e commento di G. Inglese, Inferno, Roma, Carocci. MALATO, E. (2007): «Saggio di un nuovo commento a Dante: il primo canto dell Inferno», Rivista di studi danteschi a. VII, I, pp SINGLETON, CH. S. (1978): La poesia della Divina Commedia, Bologna, Il Mulino. 82
Dante Inferno I canto
 Times New Roman Font ImpReading Font Dante Inferno I canto Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta
Times New Roman Font ImpReading Font Dante Inferno I canto Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta
DANTE INFERNO canto 1. DANTE INFERNO canto 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.
 Arial Font DANTE INFERNO canto 1 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra
Arial Font DANTE INFERNO canto 1 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra
Inferno. La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri. con le splendide illustrazioni di Gustave Doré
 Inferno La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri con le splendide illustrazioni di Gustave Doré Libro e audiolibro Acquista il libro completo in versione cartacea o digitale: www.caffescuola.com/inferno-libro-e-audiolibro/
Inferno La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri con le splendide illustrazioni di Gustave Doré Libro e audiolibro Acquista il libro completo in versione cartacea o digitale: www.caffescuola.com/inferno-libro-e-audiolibro/
DIVINA COMMEDIA COMMENTO. Canto I RAUCCI BIAGIO. 15 febbraio 2014
 DIVINA COMMEDIA COMMENTO Canto I RAUCCI BIAGIO 15 febbraio 2014 IL primo canto della Commedia serve da prologo all intero poema, e non a caso può considerarsi fuori numerazione, all interno del sistema
DIVINA COMMEDIA COMMENTO Canto I RAUCCI BIAGIO 15 febbraio 2014 IL primo canto della Commedia serve da prologo all intero poema, e non a caso può considerarsi fuori numerazione, all interno del sistema
La selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita.
 LUCA CURCIO 3D 1999-2000, Steiner Dante Alighieri La selva oscura Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita. Dante a trentacinque anni si trova
LUCA CURCIO 3D 1999-2000, Steiner Dante Alighieri La selva oscura Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita. Dante a trentacinque anni si trova
IN VIAGGIO CON DANTE
 IN VIAGGIO CON DANTE LA SELVA OSCURA E IL BENE CHE DANTE VI HA TROVATO Io non so ben ridir com i v intrai, tant era piendi sonno a quel punto che la verace via abbandonai Ma proprio in quella selvaselvaggia
IN VIAGGIO CON DANTE LA SELVA OSCURA E IL BENE CHE DANTE VI HA TROVATO Io non so ben ridir com i v intrai, tant era piendi sonno a quel punto che la verace via abbandonai Ma proprio in quella selvaselvaggia
CANTO 1 DELL inferno
 CANTO 1 DELL inferno Il cronotopo Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. La metà ideale della vita sono i 35 anni: siamo nel 1300, il primo
CANTO 1 DELL inferno Il cronotopo Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. La metà ideale della vita sono i 35 anni: siamo nel 1300, il primo
 DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
Il primo canto della Divina Commedia
 Il primo canto della Divina Commedia INTRODUZIONE Dante Alighieri, il sommo poeta della letteratura italiana, nacque a Firenze verso la fine di maggio del 1265 (sotto il segno dei Gemelli, che a quel tempo
Il primo canto della Divina Commedia INTRODUZIONE Dante Alighieri, il sommo poeta della letteratura italiana, nacque a Firenze verso la fine di maggio del 1265 (sotto il segno dei Gemelli, che a quel tempo
Opere di Dante. Convivio E un opera nella quale Dante esalta la filosofia e la sapienza. E composto da prose e poesie.
 Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
 libro letteratura aperto italiana 2 letteratura italiana Avvertenza La presente opera, dal titolo Il testo e il problema: La Divina Commedia, fa parte del progetto Libro Aperto, il primo manuale scolastico
libro letteratura aperto italiana 2 letteratura italiana Avvertenza La presente opera, dal titolo Il testo e il problema: La Divina Commedia, fa parte del progetto Libro Aperto, il primo manuale scolastico
DANTE ALIGHIERI INFERNO
 DANTE ALIGHIERI INFERNO STRUTTURA Vestibolo e 9 cerchi Peccatori divisi secondo tre disposizioni al vizio individuate da Aristotele nell'etica nicomachea: incontinenza, malizia e la matta /bestialitade
DANTE ALIGHIERI INFERNO STRUTTURA Vestibolo e 9 cerchi Peccatori divisi secondo tre disposizioni al vizio individuate da Aristotele nell'etica nicomachea: incontinenza, malizia e la matta /bestialitade
Francesco Petrarca ( )
 Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova ( )
 Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
Tanto gentile e tanto onesta pare Dante, La vita nova (1293-1295) Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand ella altrui saluta, ch ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l ardiscon di
La spiritualità dell animatore. Giacomo Prati
 + La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
+ La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
Dante nella selva oscura
 Dante nella selva oscura Da La Divina Commedia Inferno, Canto 1 I.I.S. G. Cantoni Treviglio (BG) classi 4 A-4 E a.s. 2012/2013 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, 3 ché
Dante nella selva oscura Da La Divina Commedia Inferno, Canto 1 I.I.S. G. Cantoni Treviglio (BG) classi 4 A-4 E a.s. 2012/2013 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, 3 ché
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno
 Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10
 L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
 OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
Le poesie del divino amore
 Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE. 27/10/2010 Parrocchia "Maria Ss. Assunta" - Biccari
 SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
ATTO PENITENZIALE Con fiducia e umiltà presentiamo al Signore la nostra vita e quella dei defunti, perché egli perdoni i nostri e i loro peccati.
 INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE È un giorno mesto il 2 novembre, ma non è un giorno triste. È mesto per il ricordo dei nostri cari defunti, ma non è triste se guidato dalla fiducia nel Signore risorto e
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE È un giorno mesto il 2 novembre, ma non è un giorno triste. È mesto per il ricordo dei nostri cari defunti, ma non è triste se guidato dalla fiducia nel Signore risorto e
Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità
 Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità primo giorno Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità primo giorno Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
ALLELUIA ( Simonetta )
 ALLELUIA ( Simonetta ) Do Sol Fa Do Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (3 v.) Andate e annunciate a tutte le nazioni, così dice il Signore: Io sarò con voi tutti giorni, fino alla fine del
ALLELUIA ( Simonetta ) Do Sol Fa Do Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (3 v.) Andate e annunciate a tutte le nazioni, così dice il Signore: Io sarò con voi tutti giorni, fino alla fine del
Verso l invalsi. Allora... in un tempo assai lunge felice fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora!
 Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
Dante Alighieri. La Commedia II C
 Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL
 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE
 INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE Sorelle e fratelli, ci raduniamo in assemblea all inizio del nuovo anno che vogliamo porre sotto lo sguardo benedicente del Signore che nell incarnazione ha voluto condividere
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE Sorelle e fratelli, ci raduniamo in assemblea all inizio del nuovo anno che vogliamo porre sotto lo sguardo benedicente del Signore che nell incarnazione ha voluto condividere
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO
 PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA
 Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Indice. La Divina Commedia. Dante e il poema sacro 2. Inferno 14
 Indice La Divina Commedia Dante e il poema sacro 2 La composizione 2 Il titolo, i contenuti e la struttura 3 Spazio e tempo nella Commedia 5 I percorsi tematici 7 APPROFONDIMENTO I canti politici della
Indice La Divina Commedia Dante e il poema sacro 2 La composizione 2 Il titolo, i contenuti e la struttura 3 Spazio e tempo nella Commedia 5 I percorsi tematici 7 APPROFONDIMENTO I canti politici della
Una delle più classiche è quella della donna giovane e bella, in. abbigliamento belle epoque che convive con una donna anziana, dal naso e dai
 Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina?
 Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
BENVENUTO IO HO UNA GIOIA NEL CUORE
 Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Lodi di Dio Altissimo
 Lodi di Dio Altissimo Tu sei Santo, Signore Dio Fai cose grandi, meravigliose, Tu sei il Bene, il sommo bene, Tu sei il Signore onnipotente Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l Altissimo, Onnipotente,
Lodi di Dio Altissimo Tu sei Santo, Signore Dio Fai cose grandi, meravigliose, Tu sei il Bene, il sommo bene, Tu sei il Signore onnipotente Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l Altissimo, Onnipotente,
Le attività Fragile (l ombra che resta)
 1 Le attività Fragile (l ombra che resta) 13 1. Fragile (l ombra che resta) Testo: Fabio Caon Musica: Marco Celegon, Fabio Caon Livelli degli studenti Elementi lessicali Elementi linguistico-grammaticali
1 Le attività Fragile (l ombra che resta) 13 1. Fragile (l ombra che resta) Testo: Fabio Caon Musica: Marco Celegon, Fabio Caon Livelli degli studenti Elementi lessicali Elementi linguistico-grammaticali
IL CONTRO DELLA SELVA OSCURA CANTO I INFERNO CANTO I PERSONAGGI. TEMPO giovedì santo 7 aprile 1300, notte venerdì santo 8 aprile, alba
 CAT CAT CAT L CAT DLLA SLVA SCUA 6 TMP giovedì santo 7 aprile 1300, notte venerdì santo 8 aprile, alba PSAGG LUG LA SLVA SCUA Un bosco intricato e selvaggio. Ai suoi margini, separato da un dolce pendio,
CAT CAT CAT L CAT DLLA SLVA SCUA 6 TMP giovedì santo 7 aprile 1300, notte venerdì santo 8 aprile, alba PSAGG LUG LA SLVA SCUA Un bosco intricato e selvaggio. Ai suoi margini, separato da un dolce pendio,
L ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA
 Dante Alighieri L ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi Edizione bianca Antologia della DIVINA COMMEDIA Dante Alighieri L ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA
Dante Alighieri L ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi Edizione bianca Antologia della DIVINA COMMEDIA Dante Alighieri L ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA
Questa tua parola non avrà mai fine,ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
 AVE MARIA (BALDUZZI/CASUCCI) Donna del presente e madre del ritorno / Donna della terra e madre dell amore / Donna dell attesa e madre di speranza / Donna del sorriso e madre del silenzio / Ave Maria,
AVE MARIA (BALDUZZI/CASUCCI) Donna del presente e madre del ritorno / Donna della terra e madre dell amore / Donna dell attesa e madre di speranza / Donna del sorriso e madre del silenzio / Ave Maria,
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
Preghiere per i bambini. Marco Gionta Tutti i diritti riservati
 Preghiere per i bambini Marco Gionta www.marcogionta.com Tutti i diritti riservati 1 Preghiere del mattino 1. I l luminoso mattino con la sua luce rosata Mi ha svegliato; Padre, io possiedo solo il tuo
Preghiere per i bambini Marco Gionta www.marcogionta.com Tutti i diritti riservati 1 Preghiere del mattino 1. I l luminoso mattino con la sua luce rosata Mi ha svegliato; Padre, io possiedo solo il tuo
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
MARINO MORETTI. L ore non passavan mai. TEST D INGRESSO 3 II anno. Nome: Cognome: Classe: Data:
 TEST D INGRESSO 3 II anno Nome: Cognome: Classe: Data: MARINO MORETTI L ore non passavan mai Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un giorno dissi a me stesso: «Non ci voglio andare» e non andai. Mi misi
TEST D INGRESSO 3 II anno Nome: Cognome: Classe: Data: MARINO MORETTI L ore non passavan mai Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un giorno dissi a me stesso: «Non ci voglio andare» e non andai. Mi misi
1 Novembre - TUTTI I SANTI
 1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
Il biglietto di sola andata
 Il biglietto di sola andata Daniela Demontis IL BIGLIETTO DI SOLA ANDATA racconto www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Daniela Demontis Tutti i diritti riservati A mia madre, perché il modo migliore
Il biglietto di sola andata Daniela Demontis IL BIGLIETTO DI SOLA ANDATA racconto www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Daniela Demontis Tutti i diritti riservati A mia madre, perché il modo migliore
Battesimo di Gesù / A
 Battesimo di Gesù / A Mt 3,13-17 Tu sei il mio figlio prediletto L attesa è finalmente compiuta e tutto accade al fiume Giordano. È lì che il cielo si apre e si unisce alla terra per generare il nuovo,
Battesimo di Gesù / A Mt 3,13-17 Tu sei il mio figlio prediletto L attesa è finalmente compiuta e tutto accade al fiume Giordano. È lì che il cielo si apre e si unisce alla terra per generare il nuovo,
II - STATI D ANIMO NEGATIVI
 II - STATI D ANIMO NEGATIVI Attraverso la preghiera è possibile comprendere, trovare rimedio e superare ostacoli esterni, problemi interni a noi, che ci affliggono, ci rendono tristi, ci tolgono le energie
II - STATI D ANIMO NEGATIVI Attraverso la preghiera è possibile comprendere, trovare rimedio e superare ostacoli esterni, problemi interni a noi, che ci affliggono, ci rendono tristi, ci tolgono le energie
all uomo il Mistero, la Storia della Salvezza. La risposta dell uomo è ascolto e docilità. La Lectio Divina ha quindi una sua dinamica: è ascolto,
 Presentazione «Quando, lo scorso anno, mi decisi per un serio cammino spirituale, il mio direttore spirituale mi condusse alla Lectio Divina quotidiana. Ero scettica ma lo feci fedelmente. Oggi posso testimoniare
Presentazione «Quando, lo scorso anno, mi decisi per un serio cammino spirituale, il mio direttore spirituale mi condusse alla Lectio Divina quotidiana. Ero scettica ma lo feci fedelmente. Oggi posso testimoniare
Io sono la porta delle pecore
 IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) A cura di Emio Cinardo Io sono la porta delle pecore Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) Io sono la porta delle pecore. In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità
IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) A cura di Emio Cinardo Io sono la porta delle pecore Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) Io sono la porta delle pecore. In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
A cura di Chiesacattolica.it e LaChiesa.it. PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
 NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) Grado della Celebrazione: DOMENICA Colore liturgico: Viola Introduzione La quarta domenica di Avvento, per la sua vicinanza al Natale, ci invita a capire fino in fondo
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) Grado della Celebrazione: DOMENICA Colore liturgico: Viola Introduzione La quarta domenica di Avvento, per la sua vicinanza al Natale, ci invita a capire fino in fondo
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
LITANIE MARIANE DOMENICANE. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi
 LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE
 PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
amor cortese dolce stil novo
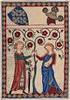 Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
Messaggio di Papa Francesco
 Messaggio di Papa Francesco Giobbe «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15). sapientia cordis Sapienza del cuore un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel
Messaggio di Papa Francesco Giobbe «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15). sapientia cordis Sapienza del cuore un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel
La Vocazione. Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016
 Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
[194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio.
![[194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. [194] INDICE 68. Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio.](/thumbs/63/49051943.jpg) APPENDICE - Indice del manoscritto 155 [194] INDICE 68 Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. 1º GIORNO della Divina Volontà. Il primo passo della Divina Volontà nell Immacolato
APPENDICE - Indice del manoscritto 155 [194] INDICE 68 Preghiera alla Celeste Regina per ogni giorno del mese di Maggio. 1º GIORNO della Divina Volontà. Il primo passo della Divina Volontà nell Immacolato
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE
 SOLTANTO ABBI FEDE - 72 - GUIDA PASTORALE 2012/13 GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e resta il segno della Croce. È una professione,
SOLTANTO ABBI FEDE - 72 - GUIDA PASTORALE 2012/13 GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e resta il segno della Croce. È una professione,
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
 Salmo 131 1 Canto delle salite. Di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto; non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. 2 Io invece resto quieto e sereno:
Salmo 131 1 Canto delle salite. Di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto; non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. 2 Io invece resto quieto e sereno:
La volta della Cappella Sistina
 Michelangelo> Sibilla Eritrea _ Roma, Cappella Sistina, volta Le Sibille per il mondo classico e i Profeti per il Vecchio Testamento sono coloro che più si sono avvicinati, per ispirazione divina, al mistero
Michelangelo> Sibilla Eritrea _ Roma, Cappella Sistina, volta Le Sibille per il mondo classico e i Profeti per il Vecchio Testamento sono coloro che più si sono avvicinati, per ispirazione divina, al mistero
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti
 Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
3 anno LORENZO E LA GRANDE GUERRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado LORENZO E LA GRANDE GUERRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE La durezza e la miseria della guerra rivissute attraverso gli occhi di un ragazzo undicenne. AUTORE:
3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado LORENZO E LA GRANDE GUERRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE La durezza e la miseria della guerra rivissute attraverso gli occhi di un ragazzo undicenne. AUTORE:
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ
 Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
15 Novembre 2015 I Domenica di Avvento (Liturgia vigiliare vespertina) Anno C
 15 Novembre 2015 I Domenica di Avvento (Liturgia vigiliare vespertina) Anno C Lucernario Chi mi segue CD 541 Inno Responsorio Salmello Vedi Lezionario Vedi Lezionario Vedi Lezionario Ecco, viene la nostra
15 Novembre 2015 I Domenica di Avvento (Liturgia vigiliare vespertina) Anno C Lucernario Chi mi segue CD 541 Inno Responsorio Salmello Vedi Lezionario Vedi Lezionario Vedi Lezionario Ecco, viene la nostra
RAVVEDITI. Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò
 RAVVEDITI Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò Hai nome tu di vivere, eppur sei morto, Rafferma ciò che
RAVVEDITI Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò Hai nome tu di vivere, eppur sei morto, Rafferma ciò che
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA
 generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA Testi di Carmelo Sambugar rivisti e aggiornati da Marta Sambugar e Gabriella Salà. 2004 RCS Libri S.p.A., Milano 1 a edizione: gennaio 2004 Coordinamento
generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA Testi di Carmelo Sambugar rivisti e aggiornati da Marta Sambugar e Gabriella Salà. 2004 RCS Libri S.p.A., Milano 1 a edizione: gennaio 2004 Coordinamento
RICEVI LO SPIRITO SANTO
 RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio
 LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana
 9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE PRIMA DEL CANTO D INGRESSO Prima dell ingresso del sacerdote con i ministri, il commentatore introduce il canto d inizio: Oggi l ingresso del sacerdote
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE PRIMA DEL CANTO D INGRESSO Prima dell ingresso del sacerdote con i ministri, il commentatore introduce il canto d inizio: Oggi l ingresso del sacerdote
Pater, Ave, 3 Gloria
 che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mondo. Tu che sei l Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai riempito d immenso piacere l anima della Beata Madre di Dio e di tue le consolazioni,
che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mondo. Tu che sei l Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai riempito d immenso piacere l anima della Beata Madre di Dio e di tue le consolazioni,
Per me vivere. è Cristo. (Fil. 1,21) La centralità del Signore Gesù nella vita del catechista
 Per me vivere è Cristo (Fil. 1,21) La centralità del Signore Gesù nella vita del catechista 1. Paolo un appassionato di Cristo L apostolo Paolo non conosce mezze misure: dal disprezzo per Cristo > all
Per me vivere è Cristo (Fil. 1,21) La centralità del Signore Gesù nella vita del catechista 1. Paolo un appassionato di Cristo L apostolo Paolo non conosce mezze misure: dal disprezzo per Cristo > all
Natale. Ho tanta stanchezza sulle spalle
 Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci
 Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA
 BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
Indici. Beato quell uomo che teme il Salmo 127. Benedite il Signore Salmo 133 B15 Bonum est confidere Salmo 90,2-
 Adoramus te D1 Alba nuova F9 Alleluia A2 Alleluia Salmo 150 B22 Alleluia (la nostra festa) A3 Alleluia (Passeranno i cieli...) A2 Alleluia cantate al Signore A2 Andate per le strade Matteo 10,7-33 C5 Angelus
Adoramus te D1 Alba nuova F9 Alleluia A2 Alleluia Salmo 150 B22 Alleluia (la nostra festa) A3 Alleluia (Passeranno i cieli...) A2 Alleluia cantate al Signore A2 Andate per le strade Matteo 10,7-33 C5 Angelus
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
C R I S T I A N E S I M O
 CRISTIANESIMO «La fede domanda» Il 22 febbraio ricorre l anniversario della morte di don Luigi Giussani. Ricordandolo con gratitudine e speranza, pubblichiamo alcune sue frasi sulla preghiera. Si potrebbero
CRISTIANESIMO «La fede domanda» Il 22 febbraio ricorre l anniversario della morte di don Luigi Giussani. Ricordandolo con gratitudine e speranza, pubblichiamo alcune sue frasi sulla preghiera. Si potrebbero
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
Maria Rosa Zazzano RACCOLTA POESIE
 Raccolta poesie Maria Rosa Zazzano RACCOLTA POESIE www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Maria Rosa Zazzano Tutti i diritti riservati Vi lascio le poesie non sono d autore le ho scritte io me le ha
Raccolta poesie Maria Rosa Zazzano RACCOLTA POESIE www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Maria Rosa Zazzano Tutti i diritti riservati Vi lascio le poesie non sono d autore le ho scritte io me le ha
Violetta di campo. È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo
 Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO
 PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
LEZIONE SESTA. GENESI cap.11
 LEZIONE SESTA GENESI cap.11 Ziqqurat LA TORRE DIBABELE Premessa QUALE E IL TITOLO DEL BRANO? La torre di Babele? Torre è solo in connessione con la città. Il titolo del brano a) Il termine MIGDAL significa
LEZIONE SESTA GENESI cap.11 Ziqqurat LA TORRE DIBABELE Premessa QUALE E IL TITOLO DEL BRANO? La torre di Babele? Torre è solo in connessione con la città. Il titolo del brano a) Il termine MIGDAL significa
- Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano)
 GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
Istituto Paritario Maria Ausiliatrice Scuola dell Infanzia AVVENTO 2015
 AVVENTO 2015 Istituto Paritario Maria Ausiliatrice Scuola dell Infanzia Tel. 0332/291.711 fax 0332/291.707 email:infanzia@scuolamariausiliatrice.com website: www.scuolamariausiliatrice.com Quando venne
AVVENTO 2015 Istituto Paritario Maria Ausiliatrice Scuola dell Infanzia Tel. 0332/291.711 fax 0332/291.707 email:infanzia@scuolamariausiliatrice.com website: www.scuolamariausiliatrice.com Quando venne
... verso il.
 ... in compagnia di... La figura affascinante e misteriosa del discepolo che Gesù amava è presente unicamente nel Vangelo secondo Giovanni, dove compare in sei scene. Egli appare la prima volta nel capitolo
... in compagnia di... La figura affascinante e misteriosa del discepolo che Gesù amava è presente unicamente nel Vangelo secondo Giovanni, dove compare in sei scene. Egli appare la prima volta nel capitolo
Lu c i a n o Ma n i c a r d i è nato a Campagnola Emilia (RE) il 26 novembre Laureato in Lettere indirizzo Classico presso l Università degli
 Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
5 gennaio Liturgia del giorno
 5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
 SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE Gentilissima Professoressa, Egregio Professore, riteniamo di farle cosa gradita ricordandole che Tra la terra e il cielo ed. verde è un libro a norma secondo i Traguardi
SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE Gentilissima Professoressa, Egregio Professore, riteniamo di farle cosa gradita ricordandole che Tra la terra e il cielo ed. verde è un libro a norma secondo i Traguardi
