LINEE GUIDA per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI
|
|
|
- Nicoletta Elvira Carraro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI Rev. 03/2018
2 Le informazioni contenute in questo documento sono state messe a punto sulla base delle migliori esperienze fatte sul campo da chi ha contribuito alla sua redazione e delle normative vigenti e rappresentano un supporto teorico e generale. Si sottolinea questo carattere generale del documento per evidenziare come l impossibilità di poter considerare in modo esaustivo le reali condizioni di applicazione e le caratteristiche di ogni singolo prodotto presente sul mercato richieda una lettura critica di quanto scritto e, comunque, l intervento sul campo di esperti in materia. CONPAVIPER e gli autori del documento - declina quindi ogni responsabilità, diretta, indiretta o implicita, su quanto possa accadere nella realtà comune applicando quanto qui riportato. La Revisione 03 del documento è stata messa a punto dalla Sezione Resine CONPAVIPER Il documento è stato pubblicato nel mese di Luglio Tutti i diritti sono riservati. La pubblicazione, anche parziale, su carta o su web, richiede la specifica autorizzazione del CONPAVIPER.
3 SOMMARIO 1 SCOPO E CONTENUTI RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI SISTEMI DI MISURA CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI SISTEMI RESINOSI CONTINUI Premessa Sistemi incorporati: impregnazione semplice e impregnazione a saturazione Sistemi resinosi riportati Sistemi pellicolari Sistemi resinosi multistrato Sistemi resinosi autolivellanti Sistemi a malta resinosa Sistemi resinosi con caratteristiche prestazionali particolari Sistemi resinosi antistatici o conduttivi Sistemi resinosi con alta resistenza chimica Sistemi resinosi decorativi Altri sistemi resinosi speciali I MATERIALI REATTIVI IMPIEGATI I leganti organici I leganti epossidici (EP) I leganti poliuretanici (PUR) I leganti epossi-poliuretanici I leganti polimetilmetacrilici Leganti ottenuti da prodotti organici e cemento LA SUPERFICIE DI POSA E LE METODOLOGIE DI PREPARAZIONE Premessa La superficie di posa La preparazione della superficie di posa Carteggiatura Molatura o levigatura Pallinatura Scarifica Operazioni complementari Idrolavaggio Rimozioni di rivestimenti e/o strati superficiali esistenti, correzioni di quote Pulizia fine della superficie LA SCELTA DEI SISTEMI La caratterizzazione di un sistema resinoso APPLICAZIONE DEI SISTEMI RESINOSI
4 9.1 L importanza dello scambio d informazioni La posa dei sistemi resinosi Le condizioni ambientali La temperatura L umidità Sottofondi umidi o con risalite di umidità il fenomeno dell osmosi L indurimento dei materiali L organizzazione, l igiene e la sicurezza del cantiere La durata VERIFICHE PRESTAZIONALI E CRITERI DI ACCETTAZIONE Le verifiche prestazionali Criteri di accettazione Criteri di accettazione per i vari tipi di sistema resinoso La verifica tecnica La determinazione dello spessore finale realizzato Vizi e/o difetti di un rivestimento finito Il problema delle bruciatura da frizione delle ruote La temperatura di transizione vetrosa La bruciatura dei sistemi resinosi causata dalla frizione delle ruote Le macchie da ritenzione di sporco La verifica delle caratteristiche prestazionali L esame visivo La verifica dell adesione Altre caratteristiche e prestazioni richiedibili Resistenza chimica Resistenza alla temperatura Dilatazioni termiche Colore, brillantezza, aspetti generali del grado di finitura Proprietà antiscivolo Proprietà antistatica, conducibilità elettrica Le problematiche relative alla valutazione della qualità estetica dei sistemi decorativi LA MANUTENZIONE ORDINARIA La pulizia della pavimentazione La manutenzione straordinaria ALLEGATI ALL. A MODULO RACCOLTA DATI ALL. B - SCHEDA PROCESSO ESECUTIVO ALL. C - TABELLA DEI PUNTI DI CONDENSA CONPAVIPER Chi è CONPAVIPER
5 13.2 Perché iscriversi al CONPAVIPER La difesa del settore Una Rappresentanza democratica a difesa dei Valori I Diritti dei Soci CONPAVIPER
6 1 SCOPO E CONTENUTI Lo scopo principale di questa terza edizione delle LINEE GUIDA per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI è quello di fornire, nel rispetto della vigente normativa, un valido strumento operativo per Committenti, Progettisti, Applicatori, Tecnici e Fornitori che svolgono la loro attività professionale e/o imprenditoriale nel settore dei rivestimenti continui in resina per pavimentazioni. I sistemi resinosi per pavimentazioni impiegati in ambito civile, commerciale ed industriale sono in grado oggi se adeguatamente specificati di soddisfare le più diverse necessità prestazionali, funzionali ed economiche. Questo grazie ad un importante evoluzione tecnologica che ha permesso la produzione di un ampissima gamma di sistemi e la nascita di soggetti specializzati per la loro applicazione. In questo contesto è però fondamentale che la scelta del rivestimento resinoso sia effettuata in modo appropriato, così come l affidamento dei lavori. I capitolati dovranno quindi tenere in debita considerazione le raccomandazioni tecniche che sono frutto di esperienza e studi di tutti gli operatori del settore e delle normative vigenti, prevedere l individuazione di tutte le caratteristiche prestazionali necessarie sia per identificare i sistemi resinosi che la scelta degli applicatori, in modo da raggiungere i risultati attesi in termini di funzionalità e la rispondenza a specifiche esigenze. Le Linee Guida CONPAVIPER rappresentano un valido strumento di supporto tecnico e di carattere formativo, teso a fornire raccomandazioni operative e valutative per la corretta: prescrizione della tipologia, delle prestazioni e delle caratteristiche del rivestimento resinoso; definizione delle modalità posa; individuazione dei controlli in corso d opera e del collaudo, e dei relativi criteri di accettazione; gestione delle variabili di cantiere, e delle possibili difformità e problematiche; programmazione delle attività di manutenzione dei sistemi. 6
7 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Nella stesura del presente documento si è fatto riferimento alle norme italiane, europee e internazionali e alle direttive CE vigenti alla data di pubblicazione. Tutti i riferimenti normativi sono di seguito riportati, e citati nel testo nella trattazione degli argomenti specifici. Tutti gli aggiornamenti o revisioni apportati in data successiva alla pubblicazione delle Linee Guida dovranno quindi essere valutati dal lettore e, in ogni caso, in caso di diversa indicazione, sostituiscono quanto qui previsto. [*] Tab Riferimenti normativi, direttive e regolamenti della CE DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. UNI EN Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Parte 2. Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo. UNI EN Massetti e materiali per massetti Proprietà e requisiti. Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 Regolamento Delegato (UE) 364/2016 Classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. D.M. 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. Direttiva 2014/34/UE del 26 febbraio 2014 Armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. UNI Posa dei rivestimenti di pavimentazione - Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni Istruzioni per la progettazione e l esecuzione. UNI EN :2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione. 7
8 UNI EN 1542 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova - Misurazione dell'aderenza per trazione diretta. UNI EN 1081 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica. UNI 8297 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni Terminologia. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Determinazione dell'adesione del rivestimento al supporto. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 2. Determinazione della resistenza al punzonamento dinamico. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 3: Determinazione della resistenza al punzonamento statico. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 4. Determinazione della resistenza agli agenti chimici. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 5. Determinazione del comportamento all'acqua. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 6: Determinazione della resistenza all'invecchiamento termico in aria. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 8. Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 9: Determinazione della resistenza all'abrasione. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 10: Determinazione della resistenza elettrica. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 12. Determinazione dello spessore. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 14: Determinazione della lavabilità e della resistenza al lavaggio. 8
9 UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 15. Preparazione dei provini per la determinazione della massa volumica apparente. UNI Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 16: Determinazione del coefficiente di attrito. UNI 8636 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Significatività delle caratteristiche. UNI EN Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 4: Metodo per la misurazione della resistenza allo slittamento/derapaggio di una superficie: Metodo del pendolo. UNI EN Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova - Resistenza agli attacchi chimici severi. UNI EN ISO Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della resistenza all usura - Apparecchiatura di prova di abrasione Taber. UNI EN Trattamento superficiale con malte a freddo - Parte 3. Metodo di prova - Consistenza. UNI EN Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini. UNI EN Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell indice sclerometrico. UNI EN Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 1: classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. UNI ENV Prodotti da costruzione - Determinazione delle emissioni di composti organici volatili - Metodo in camera di prova di emissione. UNI EN parti 1--8 Serie di Norme UNI EN sui metodi di prova dei materiali per massetti. UNI EN Determinazione delle resistenze a compressione e flessione delle malte di cemento. UNI EN Cemento parte I Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni. UNI EN 425 Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Prova della sedia con ruote. 9
10 UNI EN 433 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'impronta residua dopo l'applicazione di un carico statico. UNI EN ISO Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie plastiche non alveolari - Parte 1. Metodo a immersione, metodo del picnometro in mezzo liquido e metodo per titolazione. UNI EN ISO Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie plastiche non alveolari - Parte 2 Metodo della colonna a gradiente di massa volumica. UNI EN ISO parti 1-14 Serie di norme UNI EN ISO su camere bianche ed ambienti associati controllati. UNI EN ISO 6272 Pitture e vernici - Prove di deformazione rapida (resistenza all'urto) - Parte 1: Prova con massa cadente con punzone di larga superficie. UNI EN ISO Pitture e vernici - Determinazione del grado di trasmissione del vapore acqueo - Metodo della capsula per pellicole libere. ISO 868 Plastic and ebonite determination of indentation hardness by means of a durometer (shore hardness). ANSI/ESD STM 97.1 Floor Materials and Footwear--Resistance in Combination with a Person. ANSI/ESD STM 97.2 Floor Materials and Footwear Voltage Measurement in Combination with a Person. ASTM D 3359 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. DIN Testing of floor coverings. Determination of anti-slip properties. Wet-loaded bare foot areas. Walking method. Ramp test. DIN Testing of floor coverings. Determination of anti-slip properties. Workrooms and fields of activities with slip danger, walking method - Ramp test. DIN Determinazione della resistenza alla lacerazione di gomme elastomeriche e film di materiali plastici. 10
11 DIN Testing of rubber - Determination of tensile strength at break, tensile stress at yield, elongation at break and stress values in a tensile test. DIN Testing of rubber Shore A and Shore D hardness test. DIN EN ISO 2409 Cross-cut test. ISO 4624 Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion. IEC :2003+AMD1:2015 CSV Consolidated version Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specificapplications - Electrical resistance offloor coverings and installed floors. Nota: Le norme vengono individuate con una sigla e un numero. La sigla identifica l ente o l organismo che l ha elaborata. UNI Elabora le norme nazionali italiane e nel caso sia l unica sigla presente significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati; EN Le norme sono state elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme EN devono essere recepite dai Paesi membri CEN. In Italia la sigla diviene UNI EN. Queste norme servono a uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto. ISO La sigla identifica le norme elaborate dall ISO (International Organization for Standardization). Un Paese può decidere di adottarle come proprie norme nazionali, eventualmente modificandole in modo più restrittivo. In Italia la sigla diventa UNI ISO o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo. ASTM International Organismo di normalizzazione statunitense, noto semplicemente come ASTM (American Section of the International Association for Testing Materials). DIN Istituto tedesco per la standardizzazione ( Deutsches Institut für Normung). Diviene DIN EN ISO quando adotta e/o riadatta, norme a livello europeo elaborate da ISO. CEI Associazione responsabile della normazione in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni in ambito nazionale, con la partecipazione diretta, su mandato dello Stato Italiano, nelle organizzazioni di normazione europea CENELEC e mondiale IEC. BS Fondato nel 1901 in Inghilterra è il primo ente di normazione al mondo. Oggi uno dei principali organismi di certificazione e formazione a livello mondiale (British Standards Institution). IEC organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate. (International Electrotechnical Commission). 11
12 3 TERMINI E DEFINIZIONI Nel trattare gli argomenti è importante utilizzare in modo corretto i termini tecnici, affinché si possa essere certi che ciò di cui si parla o si scrive sia non solo comprensibile ma soprattutto chiaro e univocamente definito, in particolare nella elaborazione dei Capitolati, dei Progetti, delle comunicazioni tra le parti coinvolte. Molto usati sono termini o abbreviazioni relativi a fenomeni chimici e fisici, e alla definizione di caratteristiche o proprietà dei prodotti impiegati. Essi si trovano nelle schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti, ed è quindi evidente quanto sia importante conoscerne il significato preciso. Con l obiettivo di fornire un glossario unico per il settore e di rendere chiaro quanto riportato nel presente documento, si riportano i termini e le definizioni seguenti. Alto solido Prodotti che presentano un valore del contenuto in solidi maggiore dell 85%. Base Uno dei componenti che costituiscono una resina EP o PUR. Coefficiente di dilatazione termica λ Misura della variazione delle dimensioni di un corpo al variare della temperatura. È una caratteristica propria dei materiali. Il valore di λ si riferisce alla dilatazione lineare che è pari a 1/3 di quella volumetrica α (λ = α/3). Contenuto in solidi Percentuale di prodotto non volatile, che determina lo spessore finale del film di rivestimento resinoso. Densità Valore che indica il rapporto tra la massa e il volume di un materiale d = m/v e viene espressa in [kg/dm 3 ] o anche [kg/l]. Deformazioni elastiche e plastiche Si dice elastica una deformazione, in generale piccola, che scompare al cessare della sollecitazione. Viceversa le deformazioni plastiche sono permanenti, cioè restano anche quando la sollecitazione esterna ha smesso di agire lasciando il materiale deformato. In generale vi sono materiali che hanno praticamente solo deformazione plastica e materiali che sono elastici fino un certo valore della sollecitazione, dopo il quale si ha plasticità fino alla rottura. Dielettrico Si definisce dielettrico un materiale non conduttivo, isolante, le cui molecole vengono polarizzate da un campo elettrico, cioè si orientano con la zona positiva verso il polo negativo del campo elettrico e viceversa. Questo fenomeno viene chiamato polarizzazione ed è molto importante nei condensatori. Il termine viene spesso impropriamente utilizzato per descrivere una caratteristica dei rivestimenti resinosi. 12
13 Durezza Resistenza offerta da un materiale a lasciarsi penetrare da un altro. Elastomeri e plastomeri Tutti i materiali hanno la capacità di subire deformazioni quando sottoposti a sollecitazione esterne. I materiali vengono definiti elastomeri quando hanno la capacità di riacquistare la loro forma originale una volta interrotta la sollecitazione esterna. In caso contrario, quando si ha una deformazione permanente più o meno evidente, i materiali si definiscono plastomeri. Emulsione Stato fisico tipico dei prodotti dispersi in acqua. Le resine non sono solubili in acqua, ma si possono disperdere in essa creando, appunto, delle emulsioni che hanno il tipico colore bianco lattiginoso. EP - resine epossidiche Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti con reazione a freddo. Il formulato è normalmente costituito da una resina base (componente A) e da un indurente (componente B), i quali, miscelati accuratamente nel rapporto d uso indicato dal produttore, si solidificheranno, dando origine ad uno strato vetrificato lucido. Fase solvente Si dice per quei prodotti che presentano solventi nella loro formulazione. Finiture Prodotti in grado di realizzare uno spessore medio compreso tra 40 µm 100 µm; spesso indicano i prodotti utilizzati in ultima mano. Fluido Si definisce fluido un materiale (generalmente costituito da una sostanza o da una miscela di più sostanze) che si deforma illimitatamente se sottoposto a uno sforzo di taglio, indipendentemente dall'entità di quest'ultimo. È un particolare stato della materia che comprende principalmente i liquidi e gli aeriformi. Formulazione Insieme di più prodotti, di diversa tipologia e natura chimica, miscelati in modo da ottenere un composto con prestazioni e caratteristiche rispondenti a determinate esigenze. Granulometria È la dimensione delle particelle che compongono una carica o un aggregato; è generalmente espressa in [mm], ad esempio: 0,06 0,25 vuol dire che la carica è composta da granuli che hanno diametro minimo 0,06 mm e massimo 0,25 mm. Idrorepellente (Trattamento) Trattamento protettivo principalmente destinato alle superfici verticali. Un liquido a contatto con una superficie idrorepellente assume la tipica forma a goccia e scivola senza bagnarla. L utilizzo di trattamenti idrorepellenti su superfici orizzontali, quali le pavimentazioni, non può garantire l assenza di assorbimento del liquido che ristagna per lungo tempo e sul quale possono anche agire sollecitazioni meccaniche o pressioni di varia natura che ne favorirebbero la penetrazione nel sottofondo. Attenzione, non è quindi detto che una superficie idrorepellente sia anche impermeabile. 13
14 Indurente Uno dei componenti che costituiscono una resina epossidica o poliuretanica. Lettere dell alfabeto greco In questo documento si fa uso di alcune lettere dell alfabeto greco che rappresentano diverse grandezze fisiche. Di seguito elenchiamo quelle di nostro maggiore interesse: α alfa coefficiente di dilatazione termico volumetrico. λ gamma coefficiente di dilatazione termico lineare. Δ delta indica una differenza tra due valori della grandezza fisica rappresentata dal simbolo che la segue. Es. ΔT rappresenta la differenza tra due valori diversi di temperatura. ν ni viscosità cinematica. ρ ro usata per indicare sia la resistività sia la densità. τ tau tensioni tangenziali, ad esempio sforzi di taglio. µ mu Indica un milionesimo della grandezza che segue, es. µm indica un milionesimo di metro, ossia un millesimo di millimetro. Ω omega Ohm, unità di misura della resistenza elettrica Monomero Indica una molecola semplice dotata di gruppi funzionali tali da reagire con altri monomeri identici o complementari (detti copolimeri), in modo da formare una molecola ad alto peso molecolare (polimero). Osmosi Fenomeno fisico spontaneo, che avviene molto spesso in natura. Consiste nella diffusione di un liquido di una soluzione a più bassa concentrazione di soluti verso un altra soluzione a concentrazione maggiore. Le soluzioni sono separate da una membrana semi-permeabile, cioè permeabile al liquido ma impermeabile ai soluti. Questo passaggio esercita una pressione sulla membrana detta pressione osmotica. PMMA - Polimetilmetacrilato Composto chimico formato da polimeri del metacrilato di metile. Presenta caratteristiche di elevata trasparenza. Nei rivestimenti in resina trova impiego essenzialmente perché è possibile modificarne il tempo di indurimento mediante apposito catalizzatore (perossido) indipendentemente dalla temperatura di applicazione. Poliaddizione Reazione di polimerizzazione che avviene esclusivamente attraverso un processo di ripetuta addizione di monomeri, senza produzione di altre sostanze. Polimerizzazione Reazione chimica nella quale più monomeri si uniscono per formare un polimero; 14
15 Polimero Dal greco più parti è una grossa molecola, con alto peso molecolare, costituita da un gran numero di monomeri uguali o diversi (in questo caso si definiscono copolimeri) uniti mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame. Pot life Tempo utile di impiego di una resina. È il tempo che intercorre tra la miscelazione dei due componenti e l inizio della fase di indurimento. Si tenga presente che il pot-life è calcolato a t = + 23 C e UR = 50% e si riferisce a una quantità di prodotto ben definita. Il pot-life dipende dalla temperatura e dalla massa. Aumenta all aumentare della temperatura e della massa e viceversa. Il pot-life deve essere utilizzato come valore di confronto. Esso, infatti, indica la vita utile di una definita quantità di prodotto resinoso, a temperatura e grado di umidità standard (+23 C; 50% UR), ed è espresso in minuti. Tale tempo non è la vita utile della quantità contenuta nella confezione acquistata, in quanto, anche se le condizioni ambientali fossero quelle standard, il pot-life si riferisce a quantità molto più ridotte di prodotto. L aggiunta di cariche, diluenti o tixotropizzanti modifica il pot-life di un prodotto. Preparazione della superficie di posa Operazione atta all eliminazione di eventuali impedimenti alla buona adesione, nonché alla realizzazione del corretto profilo in base agli spessori del rivestimento da applicare. Primer Formulato resinoso, atto a svolgere più funzioni: promotore d adesione, fondo sigillante turapori, consolidante corticale. Vengono utilizzati formulati in fase solvente, idrodispersi o a contenuto totale di solidi. Punto di rugiada o dew point La temperatura di rugiada, t d (in C) è la temperatura alla quale, per un determinato valore di UR, si osserva la comparsa delle prime goccioline di condensa. Può indicare anche il valore della temperatura alla quale l aria, per raffreddamento a pressione costante, diventa satura di vapore. PUR - resine poliuretaniche Composti chimici formati da uno o due componenti da miscelare prima dell uso. Si differenziano principalmente in aromatici e alifatici. Rispetto alle resine epossidiche possono presentare maggiore elasticità e migliori resistenze agli UV (poliuretaniche alifatiche). Rapporto di impiego Indica le percentuali esatte in volume o in peso del componente base e del componente indurente da impiegare per ottenere un corretto indurimento del prodotto. È questo il parametro che bisogna tenere presente quando non si vuole miscelare una confezione intera, ma solo una parte di essa. Resilienza Capacità di un materiale di assorbire energia di deformazione elastica. I materiali che presentano bassa resilienza sono detti fragili. Reticolazione Formazione di un reticolo tridimensionale intermolecolare tra più catene di polimeri. 15
16 Soluzioni Miscele omogenee di due o più specie chimiche. Le soluzioni possono essere liquide, solide, gassose. Superficie di posa Identifica il piano sul quale verrà applicato il rivestimento (calcestruzzo, legno, acciaio ecc.), ma anche la superficie dei vari strati intermedi su cui applicare lo strato successivo. Nella pratica quotidiana è in uso chiamare tali superfici supporto termine che invece si riferisce a un altro elemento costituente il pavimento (vedi supporto) o sottofondo, che risulta più appropriato. Supporto S intende per supporto l insieme degli strati sottostanti alla piastra portante di un pavimento e non come spesso si usa dire la superficie di posa (vedi). Nel pavimento contro terra il supporto può comprendere: massicciata, rilevato, strato di bonifica, suolo. Tempo di ricopertura Intervallo di tempo minimo e massimo entro il quale effettuare l applicazione dello strato successivo. Tale intervallo di tempo viene riferito alla temperatura di 23 C e UR = 50%. È necessario prestare attenzione alle condizioni ambientali al momento dell applicazione, in quanto tale intervallo potrebbe aumentare o ridursi anche drasticamente. Termoindurenti Prodotti in grado di formare legami forti con altre sostanze, legami che non possono rompersi per effetto del riscaldamento. Il riscaldamento determina inizialmente un parziale rammollimento e poi la definitiva carbonizzazione del prodotto. Termoplastici Prodotti in grado di subire deformazioni plastiche reversibili per effetto del riscaldamento. Viscosità È una caratteristica fisica dei fluidi, molto importante per i liquidi. Essa definisce l attrito interno, ossia l attitudine di uno strato di liquido a trascinare con sé gli strati di liquido immediatamente adiacenti. La viscosità è una grandezza che dipende dalla temperatura. Essa aumenta con il diminuire della temperatura e viceversa. VOC Composti Organici Volatili (dall'inglese: Volatile Organic Compounds). La maggior parte dei solventi usati nei prodotti per rivestimenti resinosi è definita VOC. L acronimo può trovarsi anche nella forma italiana COV. 16
17 4 SISTEMI DI MISURA Il sistema adottato, quasi universalmente, è il Sistema Internazionale (SI). Le tabelle indicano le unità base del SI. Unità di misura Simbolo Grandezza misurata metro m lunghezza kilogrammo kg massa secondo s tempo ampere A intensità della corrente elettrica kelvin K temperatura Mole mol quantità di sostanza Simboli e grandezze utilizzati nel presente documento fanno generalmente riferimento al SI. Alcune grandezze e relativi simboli vengono riportati facendo riferimento al sistema MKSA, in quanto ancora in uso nella pratica quotidiana. Qui di seguito alcuni fattori di conversione tra i due sistemi. Sistema MKSA Sistema Internazionale t ( C) T (K) (0 C = 273,15 K) 273,15 K K C 0 C 1 kg f 10 N 1 atm 10 4 Pa 10 kg f /cm 2 = 10 atm 1 N/mm 2 = 1MPa 0 C = 273,15 K Simboli t T temperatura [ C] espressa in gradi centigradi temperatura [K] espressa in Kelvin U.R. umidità relativa dell aria [%] p d s Rs pressione [N/mm 2 ] o [MPa] densità [kg/dm 3 ] o [kg/l] spessore rivestimento [mm] o [µm] micrometri (nella pratica quotidiana chiamati semplicemente micron, pari a 1/1000 di mm) resistività superficiale, pari a W/L o a ρ/s, dove W è la larghezza e L la lunghezza, s lo spessore, ρ la resistività [Ω] ν viscosità [cps] (centipoise) λ coefficiente di dilatazione termica lineare [K -1 ] 17
18 5 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI SISTEMI RESINOSI CONTINUI 5.1 Premessa Il pavimento è l insieme costituito dal supporto, dalla piastra portante e dalla pavimentazione. La piastra portante in calcestruzzo armato ha il compito di sopportare i carichi statici e dinamici; la pavimentazione è lo strato a vista del pavimento e può essere costituita da un sistema resinoso continuo. Gli elementi che costituiscono un pavimento contro terra (non sempre sono presenti tutti) sono raffigurati in figura. I rivestimenti resinosi rappresentano una tipologia esecutiva di pavimentazione, cioè lo strato protettivo e di usura del pavimento. Il termine sistema resinoso continuo identifica il composito monolitico ottenuto con la sovrapposizione di due o più strati di formulati resinosi, generalmente liquidi, applicati l uno sopra l altro in sequenza logica e tali da formare un insieme compatto. L indurimento dei materiali avviene per reazione chimica degli stessi tra loro (es. resine polimetilmetacrilati) o con specifici indurenti (es. resine epossidiche e poliuretaniche) anche contemporaneamente a reazione con leganti idraulici (es. composti poliuretano-cemento ed epossicemento) o con l umidità dell aria (alcune resine poliuretaniche). I componenti che costituiscono un formulato resinoso, normalmente identificati con i nomi base e indurente ma a cui si possono aggiungere anche altri materiali reattivi quali il cemento, devono essere intimamente miscelati tra loro, in rapporti ben definiti, prima dell uso, in maniera che la reazione avvenga in modo completo, omogeneo e uniforme e coinvolga tutta la massa. Nella scelta della stratificazione del sistema resinoso è importante la valutazione della compatibilità dei formulati che verranno a contatto tra loro. Un sistema resinoso può presentare caratteristiche fisiche e chimiche diverse a seconda di come viene realizzato e dei componenti che lo costituiscono. Può essere più o meno resistente agli agenti aggressivi, può essere più o meno elastico, avere caratteristiche meccaniche di resistenza agli urti e all usura più o meno marcate. 18
19 La norma UNI 8297 classifica i sistemi resinosi in relazione allo spessore finale crescente, cioè allo spessore del sistema, a indurimento avvenuto di tutti i vari strati che lo compongono: sistemi incorporati, quelli che non formano uno strato superficiale apprezzabile, e che quindi vengono assorbiti dal supporto; sistemi riportati, quelli in grado di formare uno strato superficiale più o meno spesso e variabile tra 0,150 mm 10 mm (raramente oltre). La terminologia utilizzata per distinguere i vari sistemi fa riferimento per alcuni rivestimenti allo spessore, per altri alla tecnica applicativa, per altri ancora alle caratteristiche di fluidità del prodotto. 5.2 Sistemi incorporati: impregnazione semplice e impregnazione a saturazione Sono essenzialmente trattamenti tesi a migliorare le caratteristiche della superficie di posa, come indicato nella norma UNI Si impiegano prodotti ad alto potere penetrante in fase solvente o in dispersione acquosa, scelti in relazione al grado di penetrazione e saturazione delle porosità superficiali desiderati e alla compatibilità con l eventuale strato successivo. Con l impregnazione cosiddetta semplice i pori e le capillarità sono rivestiti internamente, ma non risultano completamente riempiti. Non vi è alcuna pellicola apprezzabile sulla superficie e l'aspetto estetico, in modo particolare quando si usano formulati epossidici, evidenzia un imbrunimento superficiale, detto effetto bagnato. La superficie è caratterizzata da un marcato effetto idrorepellente. Con l impregnazione cosiddetta a saturazione il trattamento viene invece eseguito con più strati e/o più in profondità, determinando il parziale o totale riempimento delle porosità superficiali. La pellicola risulta sottilissima e difficilmente valutabile, discontinua e non uniforme. Rende la superficie cromaticamente non omogenea, con macchie più o meno scure e più o meno lucide, a seconda del grado di assorbimento della resina e dell uniformità dell eventuale pellicola superficiale che si dovesse formare. Va ancora sottolineato che nonostante tale tipo di impregnazione sia comunemente chiamata a saturazione, essa in realtà non garantisce il completo riempimento delle porosità della superficie dei sottofondi trattati. L impregnazione ha la funzione di promuovere l adesione di eventuali successivi strati di rivestimento e/o di migliorare le caratteristiche meccaniche superficiali consolidando la parte corticale della superficie di posa e rendendola così meno permeabile ai liquidi in genere. L Impregnazione è in ogni caso un trattamento superficiale realizzato mediante l applicazione di un unico prodotto, il più delle volte su superfici cementizie, generalmente trasparente, liquido e a bassa viscosità. 19
20 Trattamento di primerizzazione Trattamento antipolvere Riduzione dell assorbimento di liquidi [*] Trattamento di consolidamento La superficie è pronta a ricevere altri strati resinosi. La superficie presenta una ridotta attitudine a sfarinarsi per attrito, riducendo conseguentemente la formazione di polvere La superficie assorbe meno facilmente, temporaneamente, liquidi come acqua o oli. Il trattamento non può essere considerato in alcun modo un trattamento di impermeabilizzazione. Lo strato corticale è più coeso. Eseguito nel caso di superfici poco compatte, con una penetrazione fino ad alcuni millimetri di profondità, in relazione alla porosità della superficie. (*) I lavaggi riducono e annullano nel tempo la riduzione dell assorbimento dei liquidi. Esempi di superfici impregnate 20
21 La scheda riassume le caratteristiche di un trattamento impregnante. IMPREGNAZIONE Riferimento normativo UNI 10966:2007 punto UNI EN Spessore Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Natura prodotti Preparazione della superficie di posa Applicazione Pulizia Penetra nei pori superficiali. Solo in caso di più strati applicati in successione fino a completa saturazione della superficie, forma una sottilissima pellicola, difficilmente valutabile. Riduzione dell assorbimento di liquidi (*), facilità di pulizia anche con detergenti, consolidamento corticale, primerizzazione per l applicazione di ulteriori strati, contenimento dello sfarinamento superficiale (effetto antipolvere). Normalmente opaco/satinato, possono evidenziarsi chiazze più o meno lucide per il diverso assorbimento. Evidenzia le microfessure superficiali, ad esempio le cosiddette fessure a ragnatela, oltre a diverse tonalità di colore o gradi di ruvidità della superficie, che si accentuano per l effetto bagnato. Trattamento antipolvere, consolidamento supporti poco compatti, primerizzazione, locali con destinazione d uso con traffico leggero. Trattamento iniziale di grandi superfici dove il rapporto prezzo/ prestazioni è favorevole. Prodotti molto fluidi: resine epossidiche, generalmente in fase solvente o emulsione acquosa; resine poliuretaniche idroindurenti in fase solvente. Prodotti inorganici. Carteggiatura o levigatura.. A spruzzo o rullo. L applicazione a rullo è consigliata per favorire la penetrazione del prodotto. Per alcuni prodotti è possibile l applicazione con macchina lavapavimenti. Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN per gli impregnanti (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Resistenza all abrasione secondo EN ISO Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Almeno 30% di miglioramento rispetto a un campione dello stesso sottofondo non impregnato (prova eseguita in conformità alla norma per gli impregnanti) Abrasimetro Taber - mola H g 1000 giri w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN NOTA: (*) Per i sistemi a impregnazione i dati relativi alla resistenza all abrasione, all assorbimento e alla permeabilità sono poco significativi per l intrinseca disomogeneità del trattamento in opera e per i limitati spessori coinvolti, e ancor più in presenza di stati precedentemente applicati superficialmente, ad esempio uno spolvero di cemento. Questo salvo verifiche preliminari con prove appropriate. 21
22 5.3 Sistemi resinosi riportati La classificazione dei sistemi resinosi riportati in relazione al loro spessore finale si basa sulla considerazione che lo spessore è uno dei parametri che influenzano la durata del rivestimento. La durata di un rivestimento resinoso è infatti influenzata dalle caratteristiche tecniche del rivestimento, dal suo spessore, dalla natura e consistenza della superficie di posa, dalle condizioni ambientali durante l utilizzo, dalla tipologia e intensità del traffico su di esso agente, dalla presenza o meno di agenti aggressivi e di possibili cause di degrado degli strati sottostanti ecc. La classificazione dei sistemi resinosi riportati terrà conto del parametro spessore e i vari sistemi saranno elencandoli in ordine crescente in base allo spessore finale del rivestimento. sistemi pellicolari; sistemi multistrato; sistemi autolivellanti; sistemi di malta resinosa Sistemi pellicolari Sistemi resinosi, normalmente colorati, in grado di formare pellicola superficiale con spessori generalmente compresi tra 150 µm e 1000 µm (1 millimetro). A loro volta si possono suddividere in: sistemi pellicolari a film sottile; s = 150 µm 300 µm sistemi pellicolari a film spesso; s = 300 µm 1000 µm Richiedono generalmente l applicazione di un primer sul supporto. Lo spessore finale può essere ottenuto con un solo strato applicando prodotti ad alto contenuto di solidi o con due o più strati nel caso d impiego di formulati in fase solvente o in emulsione acquosa. In questi casi lo spessore per ogni singolo strato deve essere limitato per favorire l evaporazione delle sostanze volatili, evitando che restino inglobate nello strato resinoso Sistemi pellicolari a film sottile (s = 150 µm 300 µm) Sono sistemi non perfettamente impermeabili, in quanto il loro ridotto spessore può presentare soluzioni di discontinuità in corrispondenza delle asperità o di piccoli residui di impurità non asportabili e presenti sulla superficie di posa. Con l uso, la pellicola superficiale che si è creata sulle asperità si usura e il rivestimento si fora. Il rivestimento a film sottile non è in grado di compensare le asperità, non si dispone, quindi, con spessore uniforme sulla superficie. 22
23 Il rivestimento a film sottile si distribuisce sulla superficie, formando, in corrispondenza delle punte, uno spessore minimo o nullo in relazione all altezza dell asperità e alla quantità di materiale Sistemi pellicolari a film spesso (s = 300 µm 1000 µm) Sistemi pellicolari realizzati con prodotti resinosi colorati, applicati a rullo o con spatola a lama diritta o racla, in due o più strati. Alcune di queste fasi possono anche essere ottenute con uno stesso formulato resinoso. Gli spessori variano da un minimo di circa 300 µm a un massimo di 1 mm. Spesso per la realizzazione di tali sistemi vengono impiegati prodotti autolivellanti o comunque ad alto contenuto di solidi, non inferiore a 85-90% in volume. Si utilizzano sia prodotti epossidici sia prodotti poliuretanici o epossi-poliuretanici. La loro scelta è dettata, oltre che da specifiche richieste prestazionali, anche da considerazioni in merito alla loro elasticità e alla conseguente attitudine ad assecondare, entro determinati limiti più o meno marcati, i movimenti del supporto. Per l ottimizzazione dei costi applicativi è opportuno privilegiare la tecnica in unica stesura mediante spatola a lama diritta, racla o spatole dentate con denti triangolari piccoli (2 2,5 mm) di formulati autolivellanti. Di seguito le schede che riassumono le caratteristiche di un sistema pellicolare sottile e di uno spesso. 23
24 PELLICOLARE A FILM SOTTILE Riferimento normativo UNI 10966:2007 punto UNI EN Spessore secco Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Preparazione della superficie di posa Natura prodotti Applicazione Pulizia Fino a 300 µm. Scarsa impermeabilizzazione. Facilità di pulizia con buona resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, buona uniformità cromatica e contenimento dello sfarinamento (proprietà antipolvere). Discrete proprietà di resistenza meccanica. Scarsa o modesta resistenza chimica per la non perfetta impermeabilità del sistema. Colorato, lucido, opaco, liscio, satinato, ruvido. Riproduce le imperfezioni superficiali. Trattamento antipolvere, colorato, in locali con presenza di normale traffico gommato e moderato traffico con muletti. Generalmente su supporti cementizi nuovi lisci (elicotterati). Levigatura o carteggiatura.. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN Resine epossidiche o poliuretaniche fluide in fase solvente o in emulsione acquosa. Resine poliuretaniche mono o bi componenti in fase solvente o in emulsione acquosa. A rullo o spruzzo con gli idonei presidi di protezione personale e verso terzi. Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Resistenza allo scivolamento, metodo del pendolo secondo EN w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 > 40 a secco, per pavimentazioni di Classe II (interne asciutte). > 40 ad umido, per pavimentazioni di Classe I (interne in presenza di acqua). La scelta del tipo più idoneo di Classe deve essere fatta a livello progettuale considerando le reali condizioni di utilizzo della pavimentazione una volta in esercizio. Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN
25 PELLICOLARE A FILM SPESSO Riferimento normativo Spessore secco Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Natura prodotti Preparazione della superficie di posa Applicazione Pulizia UNI 10966:2007 punto UNI EN 1504/2 Tra 300 µm 1000 µm. Impermeabilizzazione. Facilità di pulizia con buona resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, buona uniformità cromatica e contenimento dello sfarinamento (proprietà antipolvere). Buone proprietà di resistenza meccanica. Buona resistenza chimica a sostanze non particolarmente aggressive. Colorato, lucido, opaco, liscio, satinato, ruvido. Locali con presenza di normale traffico gommato e moderato traffico con muletti. Generalmente su supporti cementizi nuovi lisci (elicotterati). Resine epossidiche o poliuretaniche fluide senza solventi o ad alto contenuto di solidi. Levigatura. A rullo, o spatola a lama diritta o dentata, racla, con successiva distensione del prodotto ancora fresco con rullo. Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Resistenza all abrasione Metodo BCA, secondo UNI EN 13892/4 Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Resistenza allo scivolamento, metodo del pendolo secondo EN Classe AR1 o più resistente (ad esclusione dei sistemi elastici). w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 > 40 a secco, per pavimentazioni di Classe II (interne asciutte). > 40 ad umido, per pavimentazioni di Classe I (interne in presenza di acqua). La scelta del tipo più idoneo di Classe deve essere fatta a livello progettuale considerando le reali condizioni di utilizzo della pavimentazione una volta in esercizio. Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN
26 LINEE GUIDA Sistemi resinosi multistrato La terminologia multistrato deriva dalla tecnica realizzativa del sistema. Tali rivestimenti sono infatti ottenuti mediante l applicazione di uno o più prodotti, in vari strati, intervallati da semine a saturazione, o rifiuto, di quarzo o altri tipi di aggregati. Lo spessore finale varia in relazione al tipo di prodotto impiegato, al numero di strati eseguiti, alla granulometria e quantità del quarzo seminato. L uso di prodotti vernicianti applicati a rullo consente l ottenimento di rivestimenti con spessori limitati, ma in ogni caso non dovranno essere inferiori a 1,5 mm. Per ottenere spessori maggiori, 2,5 mm 3,5 mm, è opportuno l impiego di prodotti autolivellanti applicati a spatola. La granulometria del quarzo impiegato per la semina a rifiuto (le più comunemente utilizzate sono 0,06 0,25 mm; 0,1 0,5 mm; 0,3 0,9 mm e solo in casi particolari 0,7 1,2 mm) incide sullo spessore finale del rivestimento e sul grado di ruvidità, e quindi sulla caratteristica antiscivolo della superficie. Il grado di ruvidità è anche influenzato dalla tecnica di posa dell ultimo strato di resina; l applicazione con spatola d acciaio liscia comporta una maggior quantità di materiale e minore ruvidità, mentre l applicazione diretta a rullo può ridurre il consumo di materiale ed esaltare il grado di ruvidità. Esempi di diversi gradi di ruvidità ottenuti seminando lo stesso tipo di sabbia, ma applicando quantità diverse di materiale nell ultima mano (prima e seconda immagine) o seminando sabbia di granulometria maggiore (terza immagine). 26
27 Un minor consumo di materiale può influenzare il potere coprente del colore dell ultimo strato. In funzione del sistema e del relativo ciclo di applicazione, la semina di quarzo può essere fatta leggera, ovvero con una quantità di inerte tale da non nascondere tutto il primer, o a saturazione, detta anche a rifiuto, in cui invece la quantità di inerte ricopre praticamente l intera superficie, talvolta con un voluto eccesso di consumo per una copertura totale al 100%. Nota Lo spolvero, o semina, di inerti quarziferi va fatto indirizzando il getto verso l alto, evitando di indirizzare il quarzo sulla superficie della resina ancora fresca facendolo scorrere sulla stessa come un soffio di vento. Altrimenti, a indurimento avvenuto la superficie resinosa si presenterà ondulata nella zona di impatto, con creste dure createsi in conseguenza dello spostamento della resina sotto l azione cinetica dello spolvero. verso dello spolvero effetto "onda" per errato spolvero 27
28 MULTISTRATO Riferimento normativo UNI 10966:2007 punto UNI EN 1504/2 e UNI EN Spessore secco Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi d impiego Natura prodotti Preparazione della superficie di posa Applicazione Pulizia Almeno 1,5 mm. Impermeabilità, facilità di pulizia con ottima resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, uniformità cromatica, ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza all usura e chimica. Colorato, lucido, opaco, satinato, liscio, ruvido. Locali con presenza di traffico particolarmente intenso di veicoli gommati e muletti. Resine epossidiche, poliuretaniche o polimetilmetacrilati. Pallinatura o levigatura. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN Spatola a lama diritta o racla, con interposti spolveri a saturazione di quarzo.(*) Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Resistenza allo scivolamento, metodo del pendolo secondo EN Resistenza a compressione secondo EN w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 > 40 a secco, per pavimentazioni di Classe II (interne asciutte). > 40 ad umido, per pavimentazioni di Classe I (interne in presenza di acqua). La scelta del tipo più idoneo di Classe deve essere fatta a livello progettuale considerando le reali condizioni di utilizzo della pavimentazione una volta in esercizio. Classe I 35 N/mm 2 per traffico con ruote di poliammide Classe II 50 N/mm 2 per pavimenti trafficati da ruote di acciaio Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN
29 5.3.3 Sistemi resinosi autolivellanti Sistemi colorati che presentano una superficie molto omogenea e continua. Gli spessori variano da 2 mm a un massimo che raramente supera i 4 mm. Tali spessori si realizzano con un unica stesura del prodotto resinoso utilizzando spatola dentata, preferibilmente con denti triangolari, spatola liscia o racla. La definizione autolivellante del prodotto deriva dalla sua proprietà di livellarsi sui segni lasciati dall attrezzo di posa. La superficie può essere resa più resistente al graffio con uno spolvero di corindone (o altri spolveri specifici) sulla superficie ancora fresca, con grado di saturazione variabile anche in relazione all estetica finale. Note La superficie di posa deve essere planare. A volte, per ottenere la planarità, è necessario eseguire uno o più strati di rasature preliminari, eventualmente intervallati da spolveri di quarzo, che consentiranno di evitare, in caso di superfici particolarmente porose, anche antiestetici crateri (vedi soffiature). Lo spolvero di corindone (o altri materiali specifici) sui sistemi autolivellanti è una tecnica operativa che richiede personale esperto e addestrato all uso di tale tecnica, altrimenti si rischia di ottenere risultati del tutto insoddisfacenti. 29
30 AUTOLIVELLANTE Riferimento normativo UNI 10966: 2007 punto UNI EN 1504/2 e UNI EN Spessore secco Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Applicazione Natura prodotti Preparazione della superficie di posa Pulizia Almeno 2,0 mm. Impermeabilità, facilità di pulizia con ottima resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, uniformità cromatica, ottime caratteristiche estetiche, meccaniche, resistenza all usura e chimica. Colorato, lucido, opaco, liscio con pregio estetico. Locali con traffico gommato anche intenso, industria alimentare, tessile, chimica, show-room, negozi, locali commerciali. Con spatola dentata o liscia e rullo frangibolle. Resine epossidiche, poliuretaniche o polimetilmetacrilati. Pallinatura. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Resistenza allo scivolamento, metodo del pendolo secondo EN Resistenza a compressione secondo EN w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 > 40 a secco, per pavimentazioni di Classe II (interne asciutte). > 40 ad umido, per pavimentazioni di Classe I (interne in presenza di acqua). La scelta del tipo più idoneo di Classe deve essere fatta a livello progettuale considerando le reali condizioni di utilizzo della pavimentazione una volta in esercizio. Classe I 35 N/mm 2 per traffico con ruote di poliammide Classe II 50 N/mm 2 per pavimenti trafficati da ruote di acciaio Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN
31 5.3.4 Sistemi a malta resinosa Sistemi con un elevata resistenza ai carichi e all usura. Gli spessori realizzati variano da 5 mm a 10 mm, talvolta oltre. Si applicano con staggia e vengono compattati e lisciati manualmente o meccanicamente con macchinario a pale rotanti (frattazzatrice meccanica, detta anche elicottero ). La malta per realizzare tali sistemi è ottenuta impastando resina liquida con inerti, generalmente quarziferi, in curva granulometrica idonea, in rapporti tali che gli impasti ottenuti siano stendibili mediante staggia e regoli. Il rapporto resina/inerte deve essere tale da permettere il rotolamento dei granelli di inerti durante la posa, e questo si ottiene quando la quantità di liquido è quella strettamente necessaria a ricoprirne la superficie. fig. a poca carica, molta resina fig. b rapporto resina/carica giusto, miscela non compattata fig. c rapporto resina/carica giusto, miscela compattata La malta compattata e indurita risulta di norma troppo porosa per garantire impermeabilità ai liquidi. Vengono quindi realizzate due o più rasature superficiali di saturazione con formulato resinoso fluido. La realizzazione di una semina di quarzo tra gli strati di rasatura è utile per conferire una finitura antiscivolo al sistema. 31
32 MALTA RESINOSA Caratteristica Descrizione Riferimento normativo UNI 10966:2007 punto UNI EN 1504/2 e UNI EN Spessore secco Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Applicazione Natura prodotti Preparazione di posa Pulizia della superficie 5 10 mm. Impermeabilità, facilità di pulizia con ottima resistenza agli urti, ai frequenti lavaggi e ai detergenti, uniformità cromatica, resistenza all usura, meccanica e chimica. Colorato, lucido, opaco, liscio, ruvido. Locali con traffico intenso, industria alimentare, tessile, chimica, meccanica, metallurgica. Mediante regoli e staggia, compattata e lisciata con lisciatrice meccanica (elicottero). Resine epossidiche, poliuretaniche o metacrilati. Scarifica o energica pallinatura. Esempi di prestazioni minime secondo UNI EN Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. (per le descrizioni dettagliate dei seguenti requisiti si veda la norma stessa) Resistenza all abrasione metodo BCA, secondo UNI EN 13892/4 Assorbimento capillare e permeabilità all acqua secondo EN Resistenza allo scivolamento, metodo del pendolo secondo EN Resistenza a compressione secondo EN Classe AR1 o più resistente (a esclusione dei sistemi elastici). w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 > 40 a secco, per pavimentazioni di Classe II (interne asciutte). > 40 ad umido, per pavimentazioni di Classe I (interne in presenza di acqua). La scelta del tipo più idoneo di Classe deve essere fatta a livello progettuale considerando le reali condizioni di utilizzo della pavimentazione una volta in esercizio. Classe I 35 N/mm 2 per traffico con ruote di poliammide Classe II 50 N/mm 2 per pavimenti trafficati da ruote di acciaio Per la tipologia e la classificazione di ulteriori requisiti prestazionali si deve fare riferimento alla UNI EN e/o alla UNI EN Note: 1) La sdrucciolevolezza di una pavimentazione dipende da svariati fattori, tra questi certamente la rugosità superficiale del sistema resinoso applicato, ma anche dalle lavorazioni effettuate durante l uso, dai prodotti presenti normalmente o occasionalmente sul pavimento. Per tale motivo il valore di 40 inserito nelle tabelle deve essere inteso come livello indicativo di tendenziale pericolosità ; maggiore sarà tale valore, minori saranno i problemi legati alla sdrucciolevolezza del pavimento. 32
33 Per tale motivo si consiglia di valutare con attenzione tale aspetto anche e soprattutto in relazione agli inquinanti presenti, dato che le prove secondo norma vengono eseguite con sola acqua. Nel caso di pavimentazioni all esterno, la UNI EN indica un valore >55 nella prova con il metodo del pendolo, Classe III. Si evidenzia inoltre che il valore determinato sul pavimento nuovo realizzato, a causa dell uso e della conseguente abrasione superficiale, potrà diminuire nel tempo. Si raccomanda quindi di predisporre delle verifiche programmate in relazione alle specifiche condizioni esistenti. 2) La resistenza a compressione secondo EN si riferisce ai valori del prodotto confezionato in laboratorio; i valori reali del prodotto realizzato in opera, date le differenti modalità applicative e condizioni ambientali, sono in genere inferiori. 5.4 Sistemi resinosi con caratteristiche prestazionali particolari L impiego di idonei indurenti o cariche, ma anche l uso di prodotti caratterizzati da colori brillanti e/o in grado di fornire particolari effetti estetici, permettono di realizzare rivestimenti resinosi con caratteristiche prestazionali molto specifiche e peculiari in grado di: soddisfare richieste di resistenze chimiche molto spinte; dissipare o evitare accumuli di cariche elettrostatiche; non propagare fiamma e avere una bassa emissione di fumi tossici e nocivi; fornire pregevoli effetti estetici Sistemi resinosi antistatici o conduttivi Come tutte le sostanze isolanti, anche i composti resinosi epossidici o poliuretanici si caricano elettricamente per effetto dell uso e del transito di mezzi e persone. Per particolari applicazioni o per specifiche destinazioni d uso dei locali quali, ad esempio, sale operatorie, industrie produttrici di componentistica elettronica, camere bianche, dove vi sia il rischio di presenza di atmosfere o sostanze infiammabili o esplosive, può risultare importante, ed essere prerogativa essenziale, che il sistema resinoso presenti caratteristiche di conducibilità elettrica, anche se ridotte, tali da evitare l accumulo di cariche elettrostatiche e consentire la loro dissipazione verso la rete equipotenziale (messa a terra). Con la direttiva 1999/92/CE, il Parlamento Europeo ha emanato le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti a rischio di atmosfere esplosive (Direttiva Atex). Tale direttiva fa riferimento anche alla possibilità di scariche per accumulo di cariche elettrostatiche nelle normali condizioni di attività industriale. La direttiva identifica le attività industriali nelle quali tipicamente sono in lavorazione sostanze che potrebbero formare miscele esplosive con l aria, e dispone affinché ogni azienda individui tali aree. La EN 1504/2 inserisce due classi prestazionali per i sistemi resinosi antistatici, utilizzando come metodo di prova per la valutazione della resistenza a terra la UNI EN Comportamento antistatico secondo EN Metodo di prova secondo UNI EN 1081 Classe I: 10 4 <Re<10 6 Ω (esplosivi) Classe II: 10 6 <Re<10 8 Ω (esplosione di sostanze pericolose) Nelle aziende elettroniche, o dove si producono o si assemblano dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche, può essere richiesto che la superficie del pavimento soddisfi particolari requisiti 33
34 imposti dalle norme ANSI/ESD STM97.1 e ANSI/ESD STM97.2 in cui si richiede che, qualora il personale operante in tali ambienti sia connesso alla presa di terra solo attraverso le scarpe antistatiche e la pavimentazione, la resistenza alla presa di terra totale del sistema persona/scarpa conduttiva/pavimentazione sia compresa tra 75 KOhm e 35 MOhm o, in alternativa, che una persona che cammini con scarpe antistatiche sulla superficie del pavimento non assuma una carica maggiore di 100 Volt (media dei 5 picchi misurati nel test) contemporaneamente a una Re< 10 9 Ohm. Qualora il personale operante su tali aree sia invece collegato alla presa di terra con l apposito braccialetto, allora è sufficiente avere Re < 10 9 Ohm. Tali aree vengono individuate e indicate con cartelli come quello di seguito riportato: Altra normativa che può essere considerata di riferimento è: IEC Funzionalità elettrostatica dei rivestimenti da pavimento e dei pavimenti installati. L accumulo delle cariche elettrostatiche dipende in modo rilevante dall umidità dell aria. 34
35 Con aria secca (UR 40%) il fenomeno è molto marcato, mentre mano a mano che l umidità relativa aumenta il fenomeno va sempre più diminuendo fino a non verificarsi praticamente più per UR > 75%. I rivestimenti antistatici vengono generalmente classificati, per convenzione, come segue: rivestimenti antistatici conduttivi: quando 10 4 Ω < Re < 10 6 Ω; rivestimenti antistatici dissipativi: quando 10 6 Ω < Re < 10 9 Ω. rivestimenti isolanti: quando Re > 10 9 Ω. 35
36 SISTEMA RESINOSO ANTISTATICO PER ZONE ATEX Caratteristica Riferimento normativo Spessore secco Tipo di sistema Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Natura prodotti Preparazione della superficie di posa. Pulizia Descrizione EN UNI EN 1081 classi I e II 1,5 3 mm. Autolivellante, multistrato. Antistaticità, conducibilità elettrica, impermeabilità, facilità di pulizia, resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, effetto antipolvere, resistenza meccanica e chimica. Colorato, liscio o ruvido. Aree definite dalla Direttiva Atex, depositi e lavorazioni di solventi, vernici, esplosivi, materiali infiammabili ecc. Resine epossidiche o poliuretaniche. Pallinatura o levigatura Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. SISTEMA RESINOSO ANTISTATICO PER AZIENDE ELETTRONICHE ZONE EPA PROTEZIONE DAL FENOMENO ESD Caratteristica Riferimento normativo Spessore Tipo di sistema Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Natura prodotti Preparazione della superficie di posa. Pulizia Descrizione IEC ANSI/ESD STM97.1 e ANSI/ESD STM97.2 Film secco 1,5 3 mm. Autolivellante. Antistaticità, conducibilità elettrica, impermeabilità, facilità di pulizia, resistenza ai frequenti lavaggi e ai detergenti, effetto antipolvere, resistenza meccanica e chimica. Colorato, liscio. Sale operatorie, industrie chimiche, elettroniche, camere bianche. Resine epossidiche o poliuretaniche. Pallinatura o levigatura Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. 36
37 5.4.2 Sistemi resinosi con alta resistenza chimica Un rivestimento resinoso continuo generalmente presenta una buona resistenza alle aggressioni chimiche, ma se questo è un requisito specifico occorre prevedere l uso di sistemi adatti: la scelta di opportuni prodotti può infatti migliorare la specifica resistenza in relazione alla destinazione d uso dei locali in cui è posizionato il pavimento. Il rivestimento che ha l obiettivo di aumentare la resistenza chimica di un pavimento deve essere impermeabile, perché in caso contrario non potrebbe svolgere alcuna azione protettiva (attenzione, non è detto che un rivestimento impermeabile sia sempre caratterizzato da buone resistenze chimiche). Trattandosi di superfici sottoposte a usura, per i pavimenti si dovrà considerare in genere uno spessore minimo del rivestimento di 800 µm. L aggressione chimica da parte di una sostanza può avvenire in modi diversi e provocare deterioramenti più o meno gravi. Rientra nella normalità, nel caso di sostanze particolarmente aggressive, che il rivestimento subisca scolorimento o viraggi di colore, purché non si abbia un evidente calo delle prestazioni e delle resistenze generali del sistema resinoso. È importante ricordare che anche sostanze normalmente utilizzate nell uso quotidiano (candeggina, anticalcare ecc.) o anche alimentari (bevande a base di cola, bibite, succhi di frutta, caffè, vino ecc.) possono provocare corrosione o alterazioni cromatiche del rivestimento. Si deve tenere presente che l aggressione chimica sulla superficie di una pavimentazione è fortemente influenzata, oltre che dalla natura, dalla concentrazione e temperatura della sostanza aggressiva, anche dai seguenti fattori: tempo di contatto; presenza di altre sostanze in miscela che possono aumentarne il potere aggressivo; contemporanea presenza di stress meccanici (es. urti, transito di mezzi ecc.); contemporanea presenza di shock termici. 37
38 È inoltre buona norma rimuovere al più presto possibile l aggressivo chimico che sia venuto a contatto col rivestimento resinoso. Non basta la corretta scelta del formulato resinoso a garantire l idonea resistenza chimica del rivestimento. È necessario rispettare anche altri parametri, come: omogeneità della miscela base e indurente. Una superficie resinosa ottenuta con un formulato non correttamente miscelato (base, indurente) presenterà zone non perfettamente indurite. Tale rivestimento è facilmente aggredibile; le sostanze aggressive devono venire in contatto con lo strato resinoso quando lo stesso sarà completamente indurito. Un anticipato contatto con la superficie resinosa non ancora perfettamente indurita può determinare il danneggiamento del rivestimento. SISTEMA RESINOSO CON ALTA RESISTENZA CHIMICA Caratteristica Normativa Spessore secco Tipo di sistema Proprietà conferite alla superficie Aspetto estetico Campi di impiego Natura prodotti Pulizia Descrizione UNI EN 1504/2 che divide in classi di resistenza chimica sulla base della UNI EN (attacco chimico severo) Almeno 800 µm. Multistrato, autolivellante, malta resinosa. Alta resistenza a sostanze chimiche aggressive, impermeabilità. Colorato, liscio o ruvido. Locali dove possono verificarsi versamenti di sostanze chimiche aggressive. Resine epossidiche, poliuretano-cemento, polimetilmetacrilati. Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. 38
39 5.4.3 Sistemi resinosi decorativi Nell ambito dei sistemi resinosi continui l uso del termine decorativo (spesso si usa anche l aggettivo architettonico ) si riferisce alla funzionalità principale con cui viene realizzato il rivestimento e quindi anche alla destinazione d uso dei locali. Si tratta di rivestimenti quindi in genere utilizzati per usi residenziali, espositivi commerciali (show room), o per particolari esigenze (stage teatrali, ). In questi casi la pavimentazione si caratterizza, oltre che per le sue qualità di durabilità, manutenzione, pulizia, per la sua valenza estetica che è in grado di valorizzare un ambiente abbellendolo, ornandolo. Non si parla quindi di sistemi resinosi decorativi quando è prevista una destinazione d uso in ambito industriale, dove il tipo di sollecitazione è di natura diversa. La valutazione del design è molto soggettiva e dettata da scelte e gusti personali in merito ai locali e agli spazi da pavimentare. Così, un rivestimento monocromatico del tutto simile a quello realizzato in un locale industriale può assumere un alto pregio decorativo. In questo caso è importante la corretta definizione, nella fase preliminare alla vendita, dell aspetto finale che dovrà essere formalizzata per iscritto e mediante un mock-up accettato dal Committente. La tipologia applicativa varia al variare della natura del formulato resinoso impiegato e, ovviamente, a seconda della finalità artistica e decorativa della pavimentazione. Per tali scopi vengono impiegate resine acriliche, epossidiche e poliuretaniche. Una distinzione tra i vari stili ed effetti decorativi può essere fatta sulla base della tecnica esecutiva e/o in relazione all effetto estetico finale. Nella valutazione estetica del rivestimento non può essere mai trascurato l aspetto artigianale della realizzazione, che può produrre imperfezioni dovute all esecuzione manuale. Occorre inoltre tenere presente che, per quanti accorgimenti protettivi possano essere adottati, non è possibile escludere del tutto l eventualità che alcuni inquinanti, anche in quantità molto limitata, possano essere presenti sul rivestimento a fine applicazione. Si dovrà inoltre tenere conto del fatto che la normale usura della superficie dovuta all utilizzo della pavimentazione potrà modificare in parte il grado di lucentezza, o creare graffi, o modificare sensibilmente l aspetto, anche in modo non uniforme o in particolari aree. 39
40 SISTEMA RESINOSO DECORATIVO Caratteristica Spessore secco Tipo di sistema Denominazione dei rivestimenti più comuni Descrizione 2 10 mm. Multistrato, autolivellante, malta resinosa lucidata con dischi abrasivi con granulometria variabile. Nuvolato, Spatolato, Terrazzo veneziano, Policromia, Autolivellante trasparente con inserti ecc. Aspetto estetico Campi di impiego nuvolato spatolato Terrazzo policromia con inserti Sono visibili effetti simili a nuvole ottenuti con variazioni di toni dello stesso colore o con diversi colori sfruttando la tecnica della trasparenza. La superficie si presenta liscia, senza alcun effetto di rigature. La superficie presenta evidenti segni di spatolate più o meno ampie e direzioni non definite, monocromatiche (toni su toni) o con più colori. Inoltre sono presenti i rilievi delle spatolate e i graffi, in modo più o meno evidente. Riprendono l antica tecnica del terrazzo veneziano realizzato in cemento, sostituendo il legante cementizio con un legante epossidico o polimetilmetilmetacrilato. Accoppiamento omogeneo di più colori utilizzando formulati autolivellanti stesi a spatola a rasare o colati. Rivestimenti ottenuti con l impiego di chip, quarzi colorati ceramizzati, inserti vari (oggetti metallici, vegetali, pietre naturali, teli, fotografie, giornali ecc.). Gli inserti vengono congelati in un letto di resina generalmente epossidica, trasparente incolore, poco ingiallente. Locali commerciali, edilizia civile. Natura prodotti Pulizia Resine epossidiche, poliuretaniche, polimetilmetacrilati, acriliche. Lavaggio con detergenti opportuni in base al tipo di sporco da rimuovere. Si consiglia sempre di effettuare un test di compatibilità del detergente col rivestimento. 40
41 5.4.4 Altri sistemi resinosi speciali Particolari sistemi resinosi possono essere richiesti in ambienti con caratteristiche particolari Parcheggi esterni o multipiano Possono essere richiesti sistemi resinosi elastici, in grado di fare ponte su minimi movimenti di fessure del supporto (crack-bridging property) migliorando così la protezione contro le infiltrazioni di acqua nella soletta. Tale caratteristica è molto importante in quelle zone in cui si usano sali antigelo, che veicolati dall acqua potrebbero penetrare nel sottofondo e, dato l elevato contenuto di cloruri, aggredire i ferri di armatura. Il produttore deve dichiarare la classe di crack-bridging del sistema resinoso proposto, come prescritto dalla UNI EN , secondo EN Bisognerà specificare se trattasi di crackbridging statico o di crack-bridging dinamico, più severo, e la temperatura a cui è stata rilevata la classe, che, salvo eventuali particolari richieste, di solito è a +20 C, a -10 C e a -20 C. Le temperature più basse simulano condizioni più critiche. Si noti che la classe di crack-bridging è riferita all intero sistema resinoso e non a un singolo strato che lo compone. In funzione del tipo d uso previsto e della collocazione ambientale, la prescrizione dovrebbe prendere in considerazione altri requisiti: Adesione al supporto (UNI EN 1542) Compatibilità termica (UNI EN 13687/1, in particolare nei casi di parcheggi esterni) Coefficiente di assorbimento capillare (UNI EN 1062/3) Per le coperture carrabili, resistenza allo scivolamento/strisciamento: Classe III (UNI EN 13036/4 - prova ad umido per le superfici esterne) Resistenza all impatto (UNI EN ISO Classe I, Classe II o Classe III) Resistenza agli agenti atmosferici artificiali (UNI EN 1062/11, in particolare nei casi di parcheggi esterni) Resistenza all abrasione (UNI EN ISO 5470/1 oppure meglio UNI EN 13892/4 (BCA). Classi di usura AR6... AR0,5) Classe di reazione al fuoco (UNI EN 13501/1: Cfl-S1 oppure Bfl-S1) 41
42 Camere bianche Si definiscono tali quei locali che, per motivi di produzione o sicurezza, devono avere bassissimi livelli di inquinanti nell aria quali pulviscolo, particelle sospese, molecole di composti organici, batteri ecc. In tali ambienti si svolge un rigido controllo della quantità di tali inquinanti, oltre ad altri parametri quali la temperatura e l umidità relativa. I sistemi resinosi utilizzati nelle camere bianche devono ridurre al minimo l apporto di inquinanti dell aria sotto forma di molecole, dette anche AMC (Airborne Molecular Contaminants) secondo UNI EN ISO , e numero e dimensione delle particelle rilasciate in sospensione nell aria, qualora soggetti a frizione, secondo UNI EN ISO
43 6 I MATERIALI REATTIVI IMPIEGATI 6.1 I leganti organici Tra i vari leganti organici sintetici, quelli più largamente utilizzati nei sistemi usati per i rivestimenti di pavimenti industriali e civili sono: resine epossidiche (EP), termoindurenti, reazione di poliaddizione base e indurente; resine poliuretaniche (PUR), termoindurenti, reazione di poliaddizione base e indurente; polimetilmetacrilati (PMMA), termoplastiche, reazione di polimerizzazione mediante catalizzatore. Si possono utilizzare anche sistemi misti EP-PUR. Va ricordato che si intendono termoplastici quei materiali che si possono scaldare e rimodellare più volte e che dopo raffreddamento riacquistano le loro caratteristiche iniziali, mentre vengono definiti termoindurenti quei materiali che, una volta avvenuta la polimerizzazione, non possono essere rimodellati incrementandone la temperatura. Un riscaldamento eccessivo di un materiale termoindurente ne provocherebbe anzi la carbonizzazione I leganti epossidici (EP) Col termine epossidico si identifica una famiglia di composti della classe degli eteri caratterizzati dall anello di atomi triangolare, che rappresenta il gruppo funzionale, formato da due atomi di carbonio (C) e un atomo di ossigeno (O). La formula chimica di una resina epossidica bifunzionale, cioè con due gruppi funzionali agli estremi della catena è: Questi gruppi funzionali reagiscono a freddo con gli atomi di idrogeno attivi dell indurente; quest ultimo può essere costituito da prodotti facenti parte delle classi delle poliammine (alifatiche, cicloalifatiche, aromatiche ecc.), dei poliammidi, degli addotti di ammine, dei polisolfuri ecc. Il prodotto della reazione presenta una struttura reticolata tridimensionale altamente stabile. Il composto derivante presenta quindi caratteristiche meccaniche e chimiche completamente diverse dai prodotti di partenza. Variando opportunamente l indurente, si ottengono resine epossidiche indurite con diverse caratteristiche chimico-fisiche, pur partendo dalla stessa base. I gruppi funzionali e gli atomi di idrogeno attivi devono essere in numero uguale. Ciò significa che base e indurente devono essere presenti in quantità ben definite che tengano conto del numero delle parti reattive presenti in entrambi. Di conseguenza, questi prodotti sono normalmente venduti con quantità precise di base e indurente. Inoltre deve essere chiaramente indicato il rapporto tra la quantità dell uno e dell altro materiale da miscelare insieme. Tale rapporto, chiamato rapporto d impiego o di miscelazione, deve essere sempre rispettato quando si miscelano i due componenti. 43
44 Le resine epossidiche presentano un ottima adesione su un ampia varietà di materiali, una buona resistenza chimica a gran parte delle sostanze e una resistenza condizionata agli acidi. Presentano bassa sensibilità all acqua ed è possibile, con particolari resine e indurenti, ottenere l adesione sia su supporti umidi sia su strutture in acciaio o calcestruzzo sommerse. Le caratteristiche di una EP possono riassumersi in: buona resistenza a gran parte delle sostanze chimiche; resistenza condizionata alle sostanze acide; ottima adesione su diversi materiali (acciaio, calcestruzzo, conglomerati cementizi, pietre naturali, legno); buona resistenza meccanica agli urti e all usura; minimo ritiro durante la reazione di indurimento I leganti poliuretanici (PUR) Si identifica con il termine poliuretaniche l insieme di sostanze sintetiche caratterizzate dal gruppo di legami chimici denominati uretanici e schematicamente rappresentabili con: Legame chimico uretanico; molecola resina poliuretanica. La loro sintesi ha come base la reazione tra un poliisocianato e un prodotto che presenta gruppi ossidrili (-OH) quali, ad esempio, gli alcoli polivalenti, detti polioli. Dato che le resine poliuretaniche sono producibili in un ampia varietà di diverse formulazioni, le loro caratteristiche chimico-fisiche peculiari possono essere: durezza; elasticità; elevata resistenza all abrasione; resistenza agli agenti atmosferici; resistenza chimica; resistenza alla luce ecc. Possono essere derivate da isocianati aromatici o alifatici. I primi, gli aromatici, hanno una bassa resistenza alle radiazioni UV e tendono pertanto a sfarinare e a ingiallire se sottoposte a tale azione. Le resine poliuretaniche alifatiche, invece, hanno una buona resistenza ai raggi UV. Come polioli vengono generalmente utilizzati sia i poliesteri sia i polieteri. Alcuni prodotti sono formulati in maniera tale da polimerizzare e indurire, una volta applicati, grazie alla reazione che avviene con l umidità presente nell aria. Tale categoria di resine poliuretaniche viene quindi definita igroindurente. I prodotti possono essere autolivellanti, vernici, finiture, sigillanti in cartucce, in fase solvente o in emulsione acquosa. 44
45 Presentano una buona adesione su vari tipi di supporto. Quando impiegati su calcestruzzo, sia come finiture sia come autolivellanti, è spesso richiesta l applicazione di uno strato di fondo epossidico, poiché le resine poliuretaniche sono molto sensibili all umidità. L isocianato presenta la stessa reattività chimica con l acqua e con gli alcoli. La reazione con l acqua porta alla formazione di anidride carbonica (CO 2 ) e un ammina, secondo la reazione generica: N = C = O + H 2 O = NH 2 + CO 2 La reazione può avvenire solo se vi sono molecole di isocianato libere, quindi quando il prodotto è in fase di indurimento e non completamente reticolato. L anidride carbonica liberata può comportare formazione di schiuma, bollicine ecc. La sensibilità all acqua delle resine poliuretaniche richiede che durante l applicazione venga fatta molta attenzione alla presenza di umidità nel supporto, nell aria e nelle cariche eventualmente aggiunte I leganti epossi-poliuretanici Sono prodotti cosiddetti modificati, ottenuti miscelando, in vari rapporti, leganti epossidici e leganti poliuretanici. I prodotti risultanti presentano caratteristiche intermedie rispetto ai prodotti di partenza, a seconda della percentuale di questi ultimi all interno del prodotto finale. Si potranno avere quindi prodotti con caratteristiche di elasticità più o meno evidenziate, pur conservando una buona resistenza meccanica tipica delle epossidiche I leganti polimetilmetacrilici Sono resine termoplastiche ottenute per polimerizzazione del metacrilato di metile. La formula di base più generale è: Polimerizzano per azione di un catalizzatore, in genere perossido di benzoile al 50% (formula abbreviata PBO). La velocità di reazione può essere modificata (rallentata o accelerata) variando la quantità di catalizzatore aggiunto. Il pot-life delle miscele è comunque abbastanza breve e richiede pertanto squadre di posa qualificate. Il prodotto è instabile e di conseguenza lo stoccaggio non può essere prolungato oltre un certo tempo (5 6 mesi massimo). Il loro rapido indurimento (1 2 ore) anche alle basse temperature (applicabili fino a 25 C) li fa preferire in quelle applicazioni dove sono richiesti interventi in tempi molto brevi o con temperature molto basse. Sono composti normalmente resistenti agli acidi, agli oli, all acqua, alle soluzioni di sali, agli idrocarburi. 45
46 6.2 Leganti ottenuti da prodotti organici e cemento Sono formulati ottenuti mediante miscelazione di leganti organici in emulsione acquosa (epossidici o poliuretanici) con cemento. Sono definiti, molto semplicemente, con i termini epossi-cemento o poliuretano-cemento. I prodotti così ottenuti presentano caratteristiche chimico-fisiche particolari; ciò è vero soprattutto per i poliuretano-cemento, la cui resistenza chimica e agli shock termici fa sì che siano ampiamente utilizzati nelle aziende chimiche e alimentari. 46
47 7 LA SUPERFICIE DI POSA E LE METODOLOGIE DI PREPARAZIONE 7.1 Premessa Nella pratica quotidiana è in uso il termine supporto per specificare la superficie su cui applicare il rivestimento resinoso, in luogo del più appropriato superficie di posa in quanto, come specificato al par. 5.1, col termine supporto si intende definire quella parte del pavimento che ha il compito di supportare i vari carichi, compreso il peso proprio della piastra portante. Col termine, quindi, di superficie di posa si identifica la superficie sulla quale sarà posato il rivestimento resinoso o i vari strati che in sequenza compongono il rivestimento stesso. Con l espressione preparazione delle superfici di posa si indicano tutte quelle operazioni preliminari all applicazione di prodotti resinosi, e non, tese a rendere la superficie su cui gli stessi dovranno essere applicati adeguatamente pulita e compatta per garantire una perfetta adesione. Una corretta preparazione deve fornire una superficie compatta, asciutta, esente da inquinanti chimici, priva di parti incoerenti o in distacco, sporco, oli, grassi o altri agenti contaminanti che possano compromettere l adesione. È importante che l adesione avvenga uniformemente su tutta la superficie di contatto e che non intervengano sostanze o fattori che la possano compromettere. Durante l uso della pavimentazione si genereranno tensioni e sollecitazioni tra il rivestimento e la superficie di posa e se l adesione non è sufficientemente adeguata si manifesteranno fessurazioni, distacchi e rigonfiamenti. In ambito edile industriale o civile, diversi sono stati i materiali con i quali sono stati realizzati i rivestimenti dei pavimenti e che, quindi, costituiscono le possibili superfici di posa sulle quali dover realizzare un rivestimento resinoso: legno, piastrelle, gres, clinker, calcestruzzo ecc. La natura della superficie di posa è un fattore fondamentale per la scelta della metodologia esecutiva e/o delle attrezzature necessarie per la preparazione, oltre ad altre importanti informazioni quali: operazione da eseguirsi in luogo all interno o all esterno; restrizioni di qualsiasi tipo in termini di livelli di rumorosità, vibrazioni, esalazioni o smaltimento dei residui di lavorazione; lavoro da eseguirsi su piani intermedi e quindi con eventuali limiti di peso o di attrezzature da utilizzare; presenza di altri rivestimenti resinosi o strati corticali poco compatti o poco aderenti; condizioni della superficie di posa; presenza di adeguata fonte di energia elettrica per far funzionare i macchinari; tipo di rivestimento che dovrà essere applicato. Tutte queste informazioni vengono assunte durante un altra fase preliminare all applicazione, la prima in termini di tempo, e una delle più importanti: il sopralluogo. Nella norma UNI 10966:2007 sezione 9 è riportato un promemoria dei dati più importanti da rilevare in fase di sopralluogo. La superficie di posa e il sistema resinoso interagiscono tra loro nel senso che, sia l uno sia l altro, trasferiscono sollecitazioni. L entità e la natura di tali sollecitazioni dipendono dalle caratteristiche chimico-fisiche della superficie di posa, dalla presenza o meno di umidità, dalla variazione delle condizioni ambientali e di utilizzo, dalle tensioni di scorrimento per effetto del diverso coefficiente di dilatazione termica che dipenderanno dalla natura del prodotto e dallo spessore finale del sistema. Più elevati saranno gli spessori, più grandi saranno gli sforzi di scorrimento. 47
48 Se consideriamo la sezione del rivestimento, essa è pari a: a = s x l da cui: F = τ x a = τ x s x l Un rivestimento resinoso tende a strappare la superficie sottostante, nella misura in cui la stessa impedisce lo scorrimento. Lo schizzo riporta gli stati tensionali che si determinano in una tale situazione: la forza F è data dal prodotto delle tensioni all interno del rivestimento per la superficie su cui esse agiscono. La forza F, riferita all unità di larghezza (l = 1 m), è funzione delle tensioni, τ, e dello spessore. In altre parole, per rivestimenti eseguiti con prodotti elastici e spessori contenuti, le tensioni risulteranno più basse; viceversa, prodotti poco elastici, anche a parità di spessore, eserciteranno sulla superficie di contatto tensioni più elevate. È importante conoscere tali variabili quando si progetta o si applica un sistema resinoso. Attraverso la conoscenza di tutte queste informazioni e delle caratteristiche dei vari sistemi resinosi si potrà progettare il rivestimento più idoneo, sia relativamente al soddisfacimento delle varie richieste ed esigenze tecniche, sia relativamente alle caratteristiche fisiche specifiche, necessarie per quella particolare superficie di posa. La superficie di posa La natura chimica, le caratteristiche chimico-fisiche e, soprattutto, lo stato di fatto delle superfici di posa sono molto variabili. La tabella sottostante riporta alcune importanti caratteristiche generali della superficie e degli strati interni del sottofondo che devono essere misurati e valutati nei seguenti casi: prima dell esecuzione del rivestimento, per la scelta più corretta del ciclo da proporre e della relativa preparazione; a rivestimento realizzato, in caso insorgano contestazioni o difformità impreviste. 48
49 Tab. 7.1 Caratteristiche generali delle superfici di posa e fattori di scelta Prima della realizzazione del rivestimento Relative alla superficie potere assorbente planarità friabilità rugosità inquinamento resistenza a trazione Dopo la realizzazione del rivestimento Relative alla superficie destinazione d uso presenza continua d acqua o liquidi in genere presenza di sostanze chimiche aggressive frequenza di lavaggi azioni meccaniche di abrasione, impatti ecc. shock termici Relative agli strati interni grado d umidità coefficiente di dilatazione termica temperatura porosità, capillarità presenza o meno della barriera vapore coesione modulo elastico Relative agli strati interni degrado cedimenti e assestamenti fessurazioni La resistenza superficiale, espressa dalla resistenza meccanica dello strato corticale, è indicativa del rischio che, nelle condizioni di esercizio, questo strato possa provocare distacchi. La valutazione di questa caratteristica è importante soprattutto nel caso di rivestimenti esposti a carichi statici e/o dinamici elevati o per applicazioni in esterno o comunque con forti escursioni termiche. Resistenza superficiale Pull-off test (N/mm 2 ) Livello di resistenza superficiale Livello di rischio distacchi 0,9 R 1,0 Moderato/medio Alto per rivestimenti in esterno o con alte escursioni termiche; Moderato per rivestimenti in interni con spessore s > 1 mm 1,0 R 1,5 Medio/buono Moderato per rivestimenti in esterni; Moderato per sistemi in interno in malta resinosa 1,5 R Buono/alto Rischio molto limitato 49
50 Le condizioni del sottofondo si possono valutare in due modi: valutazione visiva. È un tipo di valutazione rapido e non distruttivo, che dà una prima idea sulle condizioni di salute del sottofondo. Si dovranno valutare visivamente lo stato di integrità superficiale, la presenza di inquinanti, crepe, macchie di umidità, cedimenti del sottofondo ecc. Si possono inoltre eseguire alcune semplici e veloci prove per avere un idea del grado di coesione degli strati interni, quali far rotolare sulla superficie una biglia di acciaio o trascinare sulla superficie un oggetto metallico pesante. Un cambio netto di rumore causato dall attrezzo o dalla biglia potrebbe indicare zone in cui il sottofondo presenta distacchi o delaminazione dagli strati sottostanti. valutazione strumentale. Qualora la valutazione visiva o le prime prove empiriche dovessero fornire qualche dubbio sulla qualità del sottofondo è opportuno procedere con prove e analisi più precise e approfondite, di tipo strumentale. Le più utilizzate sono le prove di pull-off, per valutare la resistenza a strappo del sottofondo, prove di misurazione dell umidità con igrometro a carburo e prelievo di campioni cilindrici (carotaggio) per analizzare gli strati interni del sottofondo. L umidità degli strati costituenti la superficie di posa può essere valutata con opportune prove non distruttive, purché il sistema di misurazione e la strumentazione utilizzata siano opportunamente validati. In caso di dubbio è opportuno procedere con l igrometro a carburo, secondo quanto prescritto dalla UNI Dovranno essere eseguite misurazioni in ogni locale interessato alla posa del rivestimento. Il valore massimo della percentuale di umidità ammessa è di 3,5-4% (salvo diversa e precisa prescrizione del produttore dei sistemi resinosi). Quando il grado di umidità supera tale valore è necessario intervenire utilizzando prodotti traspiranti o sistemi specifici per sottofondi umidi. Le fessurazioni eventualmente presenti devono essere stuccate e riparate, dopo averne appurato la natura e la causa, valutando con attenzione quale sia la probabilità di eventuali deformazioni residue del sottofondo. Nel caso di rivestimenti preesistenti, l eventuale strato di finitura deve essere aderente al supporto. Parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse. Le sostanze contaminanti eventualmente presenti sulla superficie possono essere di varia natura e devono essere completamente rimosse prima della posa del sistema resinoso: lattime di cemento; oli, grassi; tracce o residui di pitture o vernici; adesivi; sostanze chimiche di varia natura; siliconi e disarmanti; sangue, sostanze organiche. 7.2 La preparazione della superficie di posa Le metodologie di preparazione delle superfici di posa possono essere classificate in relazione alla quantità di superficie asportata e alla relativa modalità di realizzazione. Nella tabella che segue vediamo una classificazione delle metodologie di preparazione in funzione del tipo di azione applicata. 50
51 Tab. 7.2 Classificazione metodologie di preparazione Abrasione Getto Percussione Azione abrasiva superficiale di nastri, dischi, mole Azione sulla superficie di getti d acqua, materiali abradenti o miscele di essi Carteggiatura Idrolavaggio Scarifica Azione di utensili, rotanti o non, che martellano la superficie di posa asportandone lo strato corticale Molatura o levigatura Pallinatura Carteggiatura Trattamento eseguito con carteggiatrici orbitali (monospazzole). Possono essere impiegati dischi o tazze che utilizzano come abrasivo il carburo di silicio o corindone, ma anche carte e reti abrasive. L azione, che coinvolgerà strati molto superficiali (pochi µm), sarà tanto più completa e omogenea quanto più planare sarà la superficie. Spesso i macchinari sono predisposti per l utilizzo con idonei sistemi d aspirazione. Questo trattamento richiede un attenta pulizia finale. Carteggiatrice orbitale, può comportare la presenza di alcune zone non carteggiate in quanto il disco rigido poggia sulle creste della superficie, non agendo nelle zone depresse. Le carteggiatrici orbitali sono semplici da manovrare, ma hanno il limite di lasciare aree depresse non abrase. Se il disco abrasivo è fissato su un supporto rigido, che quindi poco si adatta alla non planarità della superficie da trattare, produce un azione abrasiva più marcata sulle parti rialzate lasciando praticamente non trattate le zone avvallate. Tale problema può essere parzialmente risolto, ma non del tutto eliminato, inserendo tra il disco trascinatore e il disco abrasivo del materiale comprimibile o utilizzando dischi abrasivi spessi e deformabili. Le zone non carteggiate possono indurre distacchi, soprattutto quando la superficie da preparare è un rivestimento resinoso vecchio. Tab. 7.3 Carteggiatura Superficie di posa Vantaggi Svantaggi Suggerito per sistemi Calcestruzzo Resina Bassa formazione di polveri Facilità esecutiva Scarsa incisione Possibile presenza di zone non trattate Richiede pulizia finale Accettato per sistemi Impregnazione Film sottile 51
52 7.2.2 Molatura o levigatura È un trattamento che si esegue con macchine a rotazione sull asse verticale. Possono essere monodisco oppure planetarie (a più dischi controrotanti). La possibilità di ottenere una superficie uniforme e planare rende questa tecnologia ideale per le preparazioni in vista dell applicazione di rivestimenti a basso spessore, per la rimozione di strati superficiali e irregolarità, per la rimozione di colle e vernici, per l irruvidimento di piastrelle, gres e per la molatura di pavimentazioni in marmo, granito o con sistema Terrazzo. La loro estrema versatilità è riconducibile al fatto che sui dischi possono essere montati vari tipi di utensili diamantati a legante metallico o resinoide, di varie tipologie di durezza in relazione alla consistenza della superficie da trattare e di varie grane in relazione al grado di finitura desiderato. È possibile utilizzare utensili posizionati a taglio PCD (Poly Crystalline Diamond) che lavorando a strappo permettono di rimuovere anche bassi rivestimenti e materiale elastico, e particolari rulli a bocciarda, muniti di inserti in carburo di tungsteno per rimozioni o irruvidimenti più incisivi. In funzione delle produzioni richieste, la gamma delle soluzioni è molto ampia e l elemento cruciale di valutazione, che influenza le prestazioni, è determinato dal rapporto esistente fra il peso dell attrezzatura e la potenza del motore. Predisposte per l utilizzo con idonei sistemi di aspirazione, necessitano comunque di una pulizia finale della superficie mediante spazzolatura e aspirazione dei residui di polvere, prima di poter procedere alla posa dei formulati resinosi. Le levigatrici planetarie con utensili diamantati consentono la preparazione di superfici con un elevato grado di pulizia senza incrementare in maniera eccesiva la rugosità superficiale, permettendo così l applicazione di sistemi pellicolari a basso spessore su superfici in calcestruzzo. Permettono inoltre la sistemazione della planarità di superfici trattate con macchinari a percussione. Tab. 7.4 Molatura o levigatura Superficie di posa Vantaggi Svantaggi Calcestruzzo Resina Pietra naturale Ceramica Gres Klinker Finiture uniformi e planari Possibilità di regolare il grado di finitura Richiede pulizia finale Suggerito per sistemi Impregnazione Sistemi pellicolari: o film sottile o film spesso Accettato per sistemi Multistrato 52
53 7.2.3 Pallinatura La pallinatura è un processo meccanico basato sul principio della sabbiatura che utilizza graniglia metallica invece che sabbia. Il materiale abrasivo, proiettato attraverso una turbina, impatta sulla superficie e, per effetto del rimbalzo e dell azione aspirante del sistema, ritorna nel macchinario insieme alla polvere asportata. La graniglia abrasiva, all interno dell attrezzatura, viene separata dal materiale asportato mediante un giro forzato. La polvere risultante dalla lavorazione viene convogliata, sempre dal sistema d aspirazione, in un apposito raccoglitore per lo smaltimento successivo, mentre la graniglia abrasiva ritorna nella turbina. Il profilo dell irruvidimento superficiale è determinato dalla dimensione della graniglia impiegata, dalla quantità proiettata sulla superficie e dalla velocità di avanzamento del macchinario. L operatore valuta e definisce tali variabili agendo sull attrezzatura, utilizzando la sua esperienza e professionalità. È possibile ottenere effetti e risultati differenti e più consoni allo stato di fatto della superficie di posa e a quanto richiesto per l applicazione del rivestimento resinoso agendo su più elementi: la quantità di graniglia impiegata, aumentando o diminuendo l apertura della valvola a farfalla; la dimensione e la forma della graniglia da impiegare; il tempo di permanenza del getto sulla superficie, variando, cioè, la velocità di avanzamento del macchinario; la scelta dell attrezzatura più idonea in relazione al rapporto fra potenza del motore e larghezza di lavoro. La preparazione è effettuata a secco in una o due passate al fine di rimuovere uniformemente la parte corticale della superficie di posa, rendendola perfettamente pulita. La pallinatura rappresenta la tecnologia per la preparazione delle superfici più utilizzata e da più tempo impiegata nel settore. Consente il trattamento di superfici anche in corrispondenza di crepe, cavillature, giunti e dislivelli, lasciandole perfettamente pulite e con il giusto grado di rugosità per la successiva applicazione. L attrezzatura utilizzata deve essere ben manutenuta e in perfetto stato di efficienza. L uso di macchinari con scarsa manutenzione o obsoleti può riflettersi sulla qualità del trattamento e sulla pulizia finale della superficie. Tab. 7.5 Pallinatura Superficie di posa Calcestruzzo Resina Pietra naturale Ceramica Gres Klinker Acciaio Vantaggi Svantaggi Suggerito per sistemi Limitatissima formazione di polveri Non Multistrato durate l esecuzione utilizzabile su Autolivellante Possibilità di regolare il grado di superfici Malta resinosa rugosità bagnate e Autolivellante Sicura eliminazione delle parti resilienti di PUR-cemento incoerenti superficiali Ottima velocità esecutiva Utilizzabile in ambienti limitrofi ad aree lavorative Accettato per sistemi Film spesso 53
54 7.2.4 Scarifica Per scarifica, in questo contesto, intendiamo il risultato dell abbinamento di due tipi di tecnologia: la bocciardatura eseguita con utensili a percussione verticale e la fresatura eseguita con utensili fissi su un tamburo rotante. Su un tamburo multi-albero vengono montati utensili liberi di ruotare sugli alberi stessi; il tamburo ruota facendo impattare gli utensili sulla superficie della pavimentazione. Tale azione comporta l asportazione di uno strato superficiale della pavimentazione, la cui profondità può essere regolata grazie ad apposite leve presenti sull attrezzatura. Le attrezzature consentono di eseguire, secondo le esigenze, sia interventi di semplice abrasione sia di asportazione di più alti spessori (anche 7 8 mm per passata, in relazione alla durezza della superficie, al peso e alla potenza dell attrezzatura e alla velocità di avanzamento). Possono eseguire scanalature, ad esempio a ridosso di giunti ammalorati, raggiungendo profondità fino a 20 mm. Facili da utilizzare, sono anche strumenti molto versatili perché, sostituendo semplicemente gli utensili, permettono di ottenere risultati e profili, in termini di ruvidità e/o rugosità, molto diversi. L impiego delle scarificatrici è ottimale per l asportazione di vecchi rivestimenti a spessore, colle, livelline o spolveri di indurenti, per il risanamento profondo di superfici contaminate da agenti quali oli, grassi ecc. e per tutti gli interventi di preparazione prima della posa di rivestimenti con alti spessori. Pur essendo macchinari predisposti per l utilizzo con idonei sistemi d aspirazione, prima della posa è comunque necessaria una pulizia accurata della superficie sia mediante spazzolatura dei materiali di risulta sia, successivamente, tramite aspirazione delle polveri. Tab. 7.6 Scarifica Superficie di posa Vantaggi Svantaggi Suggerito per sistemi Calcestruzzo Resina Pietra naturale Possibilità di regolare la profondità di lavoro Possibilità di rimuovere rivestimenti anche spessi Richiede pulizia finale Malta resinosa Autolivellante e massetto di poliuretanocemento Accettato per sistemi Autolivellanti 54
55 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PREPARAZIONI a impregnazione semplice 1.b impregnazione a saturazione 2. rivestimento a film sottile 3. rivestimento a film spesso 4 rivestimento multistrato 5. rivestimento autolivellante 6. rivestimento a malta rivestimento autolivellante ad alte resistenze rivestimento a massetto ad alte resistenze CARTEGGIATURA LEVIGATURA PALLINATURA SCARIFICA Note A volte per ottenere la migliore preparazione, sia in termini di risultato che di velocità di esecuzione, è opportuno intervenire con due tecnologie in abbinamento. Esempi: Scarifica più levigatura: quando si devono rimuovere rivestimenti a spessore per poi riapplicare rivestimento di spessore più ridotto. Levigatura più pallinatura: quando si vogliono velocizzare interventi su sottofondi molto duri quali gres o klinker e contemporaneamente ottenere una buona preparazione tra le fughe delle piastrelle. A volte non è possibile intervenire con la tecnologia più idonea per questioni di inaccessibilità con le attrezzature dell area di lavoro o per particolari condizioni del sottofondo. Esempio: Levigatura o scarifica su aree molto ristrette, o con limiti di sopportazione di pesi, rampe fortemente inclinate ecc. 7.3 Operazioni complementari Quando si parla di preparazione delle superfici si intende riferirsi, oltre che alla preparazione in senso stretto, come indicato ai paragrafi precedenti, anche a eventuali operazioni preliminari o successive ai trattamenti stessi, come: lavaggio e/o sgrassaggio della superficie, eventuali decerature; rimozione di rivestimenti esistenti; asportazione di strati ammalorati o in distacco; correzione di quote; completamento delle operazioni di preparazione nelle zone difficili o impossibili da raggiungere con attrezzature progettate per grandi superfici; pulizia finale della superficie con aspiratori elettrici al fine di rimuovere accuratamente polveri e inquinanti presenti. 55
56 7.3.1 Idrolavaggio È un trattamento di pulizia con o senza detergenti o sgrassanti, eseguito con macchinario con getto d acqua, calda o fredda, ad alta pressione e recupero del liquido di lavaggio. L idrolavaggio a pressione viene sempre meno utilizzato come trattamento di preparazione delle superfici. Il suo utilizzo prevede l impiego di grosse quantità d acqua. Ancora impiegato è l idrolavaggio non a pressione, eseguito con idonei macchinari. Tale lavorazione viene utilizzata non tanto come unica preparazione della superficie, ma come preliminare lavaggio sgrassante e pulente di superfici inquinate, sulle quali successivamente operare la corretta preparazione atta a rendere la superficie idonea per l adesione del rivestimento resinoso Rimozioni di rivestimenti e/o strati superficiali esistenti, correzioni di quote Può accadere che la superficie di posa presenti strati corticali incoerenti e/o in distacco con spessori tali che un trattamento come quelli precedentemente descritti non è in grado di rimuovere. L operazione è necessaria anche quando è già presente un rivestimento e la sua adesione al sottofondo non è tale da permettere direttamente l applicazione del nuovo sistema o quando è necessario correggere preliminarmente la planarità mediante asportazione di strati superficiali. 56
57 Rimozioni, correzioni di quote Operazioni di asportazione di rivestimenti esistenti o di strati incoerenti o in distacco. L apparecchiatura normalmente utilizzata è la fresatrice, attrezzatura a tamburo rotante, sull asse orizzontale, sul quale sono montati, in modo fisso, più utensili in metallo duro in grado di asportare spessori fino a 15 mm per passata. La superficie viene incisa in profondità e dopo il trattamento presenta grosse scanalature create dagli utensili. Generalmente dopo la fresatura si rende necessario un ulteriore intervento di preparazione della superficie, prima della posa del rivestimento resinoso, col fine di ridurre la scabrosità superficiale. La fresatura può essere eseguita su superfici in calcestruzzo, resina e autolivellanti cementizi e presenta il vantaggio di poter asportare anche alti spessori. Limitazioni sono la dimensione e il peso del macchinario, e la necessità di pulizia preliminare prima di eseguire qualsiasi altra fase lavorativa Stripping (scrostature, asportazioni) Intervento eseguito con attrezzatura a lama, vibrante e/o battente in orizzontale, manuale, pneumatica o elettrica, in grado di asportare rivestimenti applicati a colla. Trova quindi impiego per la rimozione di rivestimenti resilienti, linoleum, moquette, parquet, piastrelle, gomma, ma a volte può essere utilizzato per asportare rivestimenti in resina e pastine, se consistenti e in fase di distacco generalizzato. Presenta il vantaggio di una rapida esecuzione, in relazione alla tenacità e al tipo di collante, con una limitata formazione di polveri; consente inoltre di evitare gravosi danneggiamenti della sottostante superficie che comporterebbero ulteriori opere di risanamento. 7.4 Pulizia fine della superficie Qualsiasi macchinario venga usato per la preparazione della superficie di posa non è in grado di agire sull intera superficie e, pertanto, in relazione alla tipologia di attrezzatura si avranno aree non trattate. Queste aree sono in corrispondenza di ostacoli, pareti, pilastri, colonne, vani di limitata altezza ecc., aree più o meno ampie difficili o impossibili da raggiungere in relazione alla grandezza e sporgenza dello chassis delle attrezzature utilizzate. Per ciascuna delle tecnologie di preparazione pallinatura, scarifica, molatura esistono le corrispondenti attrezzature manuali o carrellate che operano esattamente con lo stesso principio ma sono studiate per intervenire in aree ristrette o difficilmente raggiungibili con le grandi attrezzature. Per queste operazioni vengono impiegati utensili elettrici aventi forma e struttura varie: smerigliatrici, fresatrici, levigatrici, bocciardatrici, pistole ad aghi. Altra operazione complementare di pulizia fine è l aspirazione delle polveri. Prima di applicare un formulato resinoso è importante che la superficie di posa risulti idonea a ricevere le resine, cioè sia priva di sostanze che possano compromettere l adesione di tali prodotti. Una superficie ben preparata, come già detto, deve essere priva di parti poco coese, in distacco, senza oli, grassi e polveri. I trattamenti di preparazione sono in grado di risolvere, come visto, le varie problematiche riguardanti lo stato e la consistenza delle superfici, e sono provvisti di sistema di aspirazione che in generale assolve la funzione di preservare l attrezzatura e di tutelare la sicurezza e l igiene in cantiere. Il sistema di aspirazione incorporato non è però in grado di eliminare ogni traccia di polveri fini ed è pertanto necessario, prima della posa del sistema resinoso, eseguire un ulteriore pulizia fine della superficie mediante aspiratori elettrici professionali di adeguata potenza e capacità. È sconsigliato utilizzare scope o similari, perché oltre a non garantire una perfetta pulizia, sollevando la polvere creerebbero condizioni non idonee per la salubrità e l igiene dei luoghi di lavoro. 57
58 8 LA SCELTA DEI SISTEMI 8.1 La caratterizzazione di un sistema resinoso Un sistema resinoso dovrà essere scelto e caratterizzato in base alle esigenze specifiche richieste. Non esiste infatti un sistema che possa andar bene sempre, a prescindere dalle esigenze, non ultime quelle relative ai costi. Occorre ricordare che le prestazioni assolvibili dai rivestimenti derivano proprio dal tipo di rivestimento adottato, quindi scegliere sistemi che non assolvono i compiti loro affidati è estremamente sconsigliabile e deleterio. Nella tabella che segue vengono riportate le caratteristiche principali dei sistemi standard più comunemente realizzati. L indicazione dei vari parametri delle caratteristiche prestazionali fornisce un informazione base utile a procedere verso un adeguata scelta del rivestimento nonché delle sue modalità applicative. Simbolo Parametro Descrizione SL = sollecitazione leggera Traffico pedonale leggero. Occasionale traffico di veicoli con ruote in gomma. Abitazioni civili. Traffico pedonale continuo, frequente con muletti e SM = sollecitazione media S occasionale con trans-pallets con ruote dure. Locali pubblici. SP = sollecitazione pesante Traffico continuo con muletti e trans-pallets con ruote dure. Possibili impatti. SPM = sollecitazione molto pesante Pesantemente sollecitato da traffico con ruote dure, cingoli ecc. Frequenti e costanti impatti. S Spessore [µm] o [mm] Spessore del rivestimento finito dopo indurimento. R UV Resistenza ai raggi UV Se sì, il rivestimento è applicabile in esterno o comunque no sfarinamento, ingiallimento sotto l azione dei raggi UV (tra parentesi viene indicata la sì buona, sfarinamento e ingiallimento natura del legante idoneo). ridotti R chim. AS P R Resistenza chimica: no nessuna l limitata, solo cadute occasionali e rimozione rapida b- buona e elevata Aspetto finale: U = uniforme N = non uniforme cui va aggiunto: 1 = lucido 2 = satinato 3 = opaco Tab. 8.1 Legenda PF = Facilità di pulizia APF = Alto grado di pulizia e igiene Conducibilità elettrica p = possibile np = non possibile Resistenza all azione corrosiva o disgregatrice prodotta da sostanze chimiche. Effetto estetico finale, grado di uniformità cromatica e/o di aspetto superficiale correlato al grado di brillantezza. Per alcuni sistemi, esempio i decorativi, il grado di non uniformità dell aspetto è una caratteristica voluta. Rivestimento di facile pulizia e igienicità. Rivestimento di facile pulizia e igienicità, ottenibili anche con mezzi e sistemi intensi e frequenti. Caratteristica di conducibilità elettrica del rivestimento. 58
59 Tab. 8.2 Sistemi resinosi standard Descrizione Tipo Nome d uso sintetica Caratteristiche S s R UV R chim. AS P R 1 1 a Impregnazione semplice. 1 b Impregnazione a saturazione. Unico strato con funzione di primerizzazione. Applicato in due o più strati per consolidamento superficiale. - - no no N - np SL µm no no N PF np 2 Rivestimento pellicolare film sottile. Applicato in due o più strati, colorato EP o PUR. SL SM µm sì PUR l U 123 PF np 3 Rivestimento pellicolare film spesso. Applicato in due o più strati, colorato EP o PUR. SM µm sì PUR b U 123 PF p 4 Rivestimento multistrato. Applicato in due o più strati, colorato con interposto spolvero di quarzo. SM 2-3 SP mm sì PUR b U 23 PF p 5 Rivestimento autolivellante. Applicato a spatola dentata, colorato, in grado di autolivellarsi. SL 2-4 mm sì PUR b U 123 AP F p 6 Rivestimento a malta (EP, PUR, PMMA). Sistema fortemente caricato con aggregati, steso con staggia ed elicotterato, successivamente rasato per saturarne i pori. SM 5-10 SP mm sì PUR b U 23 AP F p 7 Rivestimento autolivellante PUR- Cemento. Sistema applicato a spatola o racla dentata, colorato, in grado di livellarsi. SP SMP 4-6 mm no e U 23 AP F p 8 Rivestimento a malta PUR-Cemento. Sistema ad alto spessore a finitura antiscivolo, applicato a racla o spatola. SMP 6-10 mm no e N 23 AP F p 59
60 9 APPLICAZIONE DEI SISTEMI RESINOSI 9.1 L importanza dello scambio d informazioni L adeguatezza dei requisiti prestazionali definiti nei capitoli precedenti può essere ottenuta e garantita solo se tutti i ruoli decisionali coinvolti nell esecuzione del rivestimento e nell accettazione del contratto d appalto hanno una chiara cognizione delle caratteristiche e dei limiti prestazionali che il sistema resinoso che si andrà a eseguire sarà in grado di fornire. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede, come condizione essenziale, che vi sia un ampio scambio di informazioni fra le parti coinvolte, compresi gli esecutori di attività in subappalto e, sarebbe auspicabile, i fornitori di materiali. Tali informazioni dovranno essere riportate in modo chiaro e comprensibile nel contratto d appalto sottoscritto dalle parti. In particolare, quando l oggetto dei lavori è un sistema resinoso decorativo o con particolari esigenze prestazionali, è necessario che in fase preliminare alla scelta siano predisposti adeguati strumenti per la valutazione del risultato finale (ad esempio, campionatura in loco, visita ad analoghi lavori già eseguiti ecc.). Ciò favorirà certamente la scelta e l accettazione finale del rivestimento resinoso. Al Committente, direttamente o attraverso tecnici da lui incaricati, compete la definizione dei requisiti tecnici ed estetici, e delle prestazioni che il rivestimento deve possedere. L applicatore dovrà garantire la rispondenza tra ciò che ha proposto e quanto ha realizzato. In altre parole, la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto e alle decisioni concordate e sottoscritte con il Committente, compresi la qualità dei materiali impiegati (in conformità alle normative vigenti) e la verifica dello stato e idoneità della superficie di posa, la cura e la protezione dei lavori durante e dopo la posa fino alla consegna e l igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. 9.2 La posa dei sistemi resinosi Per la posa dei sistemi resinosi si fa uso di diversi tipi di attrezzature. La scelta dell attrezzatura è fatta in relazione agli spessori da realizzare, vale a dire al tipo di sistema da ottenere. Sulla base del progetto elaborato, della verifica delle caratteristiche della superficie di posa e del controllo delle condizioni ambientali in cantiere, il posatore predispone e concorda con il Committente un programma delle attività di posa. Questo programma deve rispettare le esigenze temporali delle diverse operazioni, come pure i tempi richiesti dai vari materiali per indurire, tenuto conto delle temperature ambientali dei locali dove sarà eseguita la posa. Eventuali difformità fra stato della superficie di posa e quanto verificato in fase preliminare e riportato nel progetto devono essere formalmente denunciate dal posatore al Committente, predisponendo le necessarie eventuali modifiche. L illuminazione del cantiere deve essere adeguata e consentire al posatore di assicurare la conformità ai requisiti qualitativi dei rivestimenti. I materiali devono essere controllati e adeguatamente immagazzinati, seguendo le prescrizioni fornite dai produttori. Il Committente deve assicurare le richieste condizioni di stoccaggio in cantiere. È importante che si instauri un ampia consultazione fra le parti interessate, compresi gli esecutori di attività in subappalto. Il coinvolgimento dell utilizzatore finale in genere non professionalmente qualificato per la gestione degli aspetti tecnici, ma interessato alla funzionalità, anche estetica, del rivestimento è determinante per evitare o quanto meno ridurre le contestazioni a fine lavori. Durante tutto il tempo destinato alla posa, la temperatura e l umidità ambientali, nonché l esposizione ai raggi solari, non devono raggiungere livelli tali da pregiudicare l applicazione e il corretto indurimento dei prodotti. In generale, la posa non può essere intrapresa quando la temperatura dell aria e/o della superficie di posa è minore di +10 C o maggiore di +35 C (salvo diverse specifiche del produttore), né può 60
61 essere effettuata all esterno in caso di avverse condizioni meteorologiche (eccessivo caldo, pioggia, neve, vento). È consigliabile per l applicatore, o suo incaricato, compilare durante tutte le fasi di posa la Scheda Processo Esecutivo, di cui rilascerà una copia al Committente al momento della consegna dei lavori. La scheda sarà completata nella parte relativa alla manutenzione ordinaria e conservata con cura. Questa documentazione, non strettamente necessaria per piccoli interventi ma comunque sempre suggerita anche in tali situazioni, permetterà in caso di contestazione di avere una tracciabilità di quanto realizzato e della cadenza con cui sono stati eseguiti, o meno, gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 9.3 Le condizioni ambientali La temperatura e l umidità dell aria e del sottofondo influiscono molto sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti resinosi durante la fase applicativa La temperatura La reazione chimica che avviene tra base e indurente è molto influenzata dalla temperatura. Infatti, temperature inferiori o prossime a 0 C ritardano l indurimento dei prodotti fino a impedirlo nella maggior parte dei casi. Temperature prossime o superiori a +30 C accelerano il processo di indurimento in modo tale da rendere a volte gravosa o impossibile la posa. È importante rilevare sia la temperatura dell aria ambientale, t a, sia la temperatura della superficie di posa, t s, in quanto è in base soprattutto a tale temperatura che si valuta la fattibilità o meno della posa dei prodotti. I tempi di sovrapponibilità degli strati o di pedonalità del rivestimento variano tra estate e inverno. Il tempo di sovrapponibilità e di indurimento dei formulati resinosi aumenta nel periodo invernale, dove la pedonalità potrebbe essere critica anche dopo ore dall applicazione. Nel periodo estivo, invece, i tempi si riducono notevolmente, col rischio però di problemi durante la posa in caso di elevata temperatura ambientale, quali ad esempio la riduzione del tempo di applicabilità con conseguente indurimento del prodotto quando questo si trova ancora nel contenitore e non si è avuto tempo sufficiente per posarlo. Le temperature più elevate riducono anche i tempi di attesa minimi e massimi tra i vari strati del sistema. Prestare attenzione nella scelta del sito di stoccaggio dei materiali. Tale luogo dovrà essere fresco d estate e possibilmente riscaldato nei periodi freddi, in modo da mantenere la temperatura del prodotto su valori ideali variabili tra +15 C e +20 C. L operatore deve tenere bene in conto tali considerazioni quando applica i prodotti resinosi, sapendo che il non rispettare i tempi di sovrapponibilità comporta problematiche di adesione tra i vari strati. Valori indicativi ( * ) di variazione delle tempistiche di posa in funzione della temperatura Intervallo di temperatura della superficie di posa e 10 C t s 30 C dell ambiente per l applicazione Tempo di sovrapponibilità 10 C t S 20 C ore 20 C t S 30 C 8 16 ore Incremento (+) o riduzione (-) % del pot-life (*) 10 C t a 20 C + 20% + 40% 20 C t a 30 C - 20% - 40% (*) Attenzione: i tempi variano anche in relazione al tipo di formulato e al grado di umidità relativa ambientale. 61
62 9.3.2 L umidità Il grado di umidità ambientale può essere causa di non adesione tra gli strati o determinare altre problematiche, in relazione alla natura del formulato resinoso impiegato. È sconsigliata l applicazione con grado di umidità superiore all 80%. Conseguenza principale di un eccessiva umidità dell aria è la condensa, o rugiada, del vapore acqueo sulla superficie di posa, in quantità più o meno evidente, in relazione alla temperatura della superficie e del grado di umidità. La presenza di tale strato inquinante, non sempre visibile, può determinare mancanza di adesione tra gli strati, alterazioni delle caratteristiche meccaniche e chimiche del prodotto steso, difetti estetici quali sbiancamenti, formazione di bollicine sui prodotti PUR (causa la formazione di CO 2 come già visto al capitolo 6.3) ecc. Affinché si possa scongiurare la presenza di rugiada sulla superficie su cui eseguire il rivestimento resinoso o su cui applicare un ulteriore strato, è necessario che la temperatura della superficie sulla quale si deve applicare la resina sia maggiore di almeno 3 C della temperatura di rugiada t d, anche detta dew point. In questo caso l operatore può eseguire con sufficiente tranquillità la posa (relativamente alla possibile presenza di condensa sul supporto), in quanto tale scarto garantisce, con accettabile sicurezza, l impossibilità di formazione di rugiada durante i lavori nell eventualità di variazione delle condizioni ambientali o del microclima relativo ai locali dove si sta realizzando il rivestimento resinoso. In Appendice la tabella di valutazione della temperatura di rugiada t d in relazione alla temperatura e al grado di umidità dell aria. Valori di riferimento del grado di umidità ambientale Valori del grado di umidità ambientale limite per l applicazione Valori della temperatura della superficie di posa (t S ) per evitare condensa 20% UR 80% t s t d + 3 C Sottofondi umidi o con risalite di umidità il fenomeno dell osmosi I sistemi resinosi sono normalmente impermeabili sia ai liquidi che al vapore acqueo. Questa loro caratteristica può creare qualche inconveniente qualora vengano direttamente applicati su sottofondi cementizi umidi o con risalite capillari di umidità. In questi casi è molto probabile che si verifichi il fenomeno di distacco del rivestimento, più o meno grave, causato dalla formazione di numerose bolle, rigonfie di acqua in pressione. Il fenomeno fisico che causa questo problema non è ancora stato del tutto accertato con assoluta chiarezza, ma è molto probabile che sia innescato dalla presenza di pressioni osmotiche che si vengono a formare all interfaccia tra il sottofondo cementizio e il rivestimento resinoso. Le pressioni osmotiche possono raggiungere valori ben superiori alla coesione del sottofondo cementizio, causando così il distacco e successivo rigonfiamento di piccole singole porzioni di rivestimento. Va precisato che una volta innescato il primo punto di distacco, si sospetta che la pressione successiva per far crescere di dimensioni le bolle non debba più avere necessariamente valori elevati, in quanto il successivo sollevamento dello strato resinoso avverrebbe più per peeling che per trazione diretta. È quindi probabile che alla diffusione del fenomeno su ampie parti di superfici possano contribuire anche pressioni di valori minori, quali quelli raggiungibili con le semplici risalite capillari. 62
63 LINEE GUIDA Il fenomeno della sbollatura dei rivestimenti resinosi si verifica sui sistemi fino a 2-3 mm massimi di spessore, o anche più nel caso dei sistemi elastici. Può presentarsi con qualche sporadica bolla sparsa sulla superficie o molto più intensamente e diffusamente interessando complete aree di pavimentazione fino a compromettere seriamente la funzionalità del rivestimento. Il fenomeno di osmosi avviene quando si ha presenza di: 1. Acqua nel sottofondo cementizio, oltre un certo valore percentuale, nella quale sono disciolti numerosi sali 2. Un rivestimento resinoso impermeabile ai liquidi e al vapore acqueo, applicato in superficie 3. Una specifica interiezione all interfaccia tra sistema resinoso e sottofondo cementizio chiamata barriera semipermeabile. L umidità presente in un sottofondo cementizio, prima della posa del sistema resinoso, può essere dovuta ai processi lavorativi che vi si svolgono (es. pavimentazione lavata tutti i giorni) o può derivare da una non completa maturazione del getto cementizio di pavimentazioni appena realizzate. In quest ultimo caso si ha anche una fortissima presenza di alcali disciolti. L umidità è misurabile con opportuni igrometri, sia elettronici con sensori a contatto, sia reattivi (es. igrometro a carburo). Il valore massimo normalmente accettato è il 4% in peso, salvo diversa indicazione del produttore. Nel caso dell umidità di risalita capillare, invece, non si ha la possibilità di verificarne la presenza con un semplice igrometro. L umidità di risalita può essere in equilibrio con l ambiente, cioè tanta ne risale e tanta ne evapora, ma comincerebbe ad accumularsi sotto il rivestimento resinoso una volta che questo abbia coperto l intera superficie della pavimentazione. Il metodo a oggi utilizzato per valutare la presenza di umidità di risalita è quello del foglio di politene, secondo ASTM D 4263, 63
64 che ha il pregio di essere facile e veloce da eseguire ma non può prevedere eventuali diversi comportamenti stagionali delle risalite di umidità. Nel caso quindi si tema che il risultato del test, pur se negativo, non dia ampi margini di sicurezza di assenza di umidità di rislaita capillare anche per il futuro, alora si dovrà valutare una soluzione di sistema resinoso compatibile con i fondi umidi come spiegato più avanti. Per applicare un rivestimento impermeabile ai liquidi e al vapore acqueo, entro certi limiti di spessore, è condizione necessaria che il sottofondo non contenga più umidità di quanta non ne possa tollerare il rivestimento e che non ci sia presenza di risalita capillare di umidità. Affinché il fenomeno di osmosi, e di conseguente formazione delle bolle, non abbia luogo è sufficiente eliminare una delle tre cause prima citate. Ad esempio, in caso di sottofondi umidi e/o in presenza di umidità di risalita, l utilizzo di specifici formulati con buona permeabilità al vapore acqueo e/o che interferiscano con la formazione di una membrana semi-permeabile impedisce la formazione di bolle. 9.4 L indurimento dei materiali Il sistema resinoso, una volta ultimate le operazioni di posa, deve essere lasciato indurire secondo le prescrizioni del produttore. Salvo formulati particolarmente rapidi quali i PMMA, in genere sono necessari 1-3 giorni di indurimento e maturazione a +15 /+20 C prima che il sistema resinoso raggiunga resistenze sufficienti a sopportare un traffico pedonale o leggere sollecitazioni meccaniche, e da 3 a 7 giorni, sempre a +15 /+20 C, per raggiungere le massime resistenze chimiche e meccaniche. Prima di porre il sistema resinoso a contatto con liquidi, per qualsiasi motivo, è opportuno attendere che esso abbia raggiunto le sue resistenze massime. Fatta esclusione per i PMMA, che possono indurire anche fino a -25 C, l indurimento dei prodotti al di sotto dei +10 C risulta particolarmente lento e vi è il rischio che la reticolazione dei formulati resinosi avvenga irreversibilmente in maniera incompleta, con conseguente perdita di prestazioni finali anche nel caso in cui la temperatura dovesse infine rialzarsi. L indurimento a basse temperature è inoltre particolarmente difficile e complicato in caso di elevata umidità relativa dell aria, per valori maggiori del 75-80%, in cui la quasi certa formazione di condensa comporterebbe sbiancamenti e opacizzazione della superficie e ridotte prestazioni finali del sistema resinoso. 9.5 L organizzazione, l igiene e la sicurezza del cantiere I prodotti che si utilizzano per la realizzazione dei sistemi resinosi vengono preparati, poco prima dell uso, miscelando con cura i vari componenti. Dopo tale operazione comincia la reazione chimica tra base e indurente; il prodotto rimane lavorabile per un tempo limitato, dopodiché comincia la sua fase di indurimento e non è più applicabile. L organizzazione del cantiere rappresenta il punto di partenza per ottenere e portare a buon esito l applicazione, senza rischi e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. 64
65 È necessario procedere preordinando le varie fasi applicative fin dall inizio dell attività lavorativa. In un cantiere, come è noto, potrebbero operare altre ditte, e pertanto sarà ragionevole applicare tutti gli opportuni dispositivi affinché si possa lavorare senza ostacolarsi a vicenda, delimitando l area interessata all applicazione con nastri bianco-rosso o, laddove necessario, con reti metalliche o di plastica. I prodotti resinosi sono sostanze chimiche di sintesi potenzialmente pericolose e pertanto richiedono adeguati presidi protettivi individuali. Molti degli effetti negativi dovuti alla manipolazione dei prodotti resinosi sono generalmente legati alla sensibilizzazione personale a tali prodotti. Sono caratteristiche le reazioni allergiche con sintomatologia tipica quale gonfiore della pelle o degli occhi, arrossamenti, eczemi da contatto o da inalazione. Il contatto diretto e l inalazione dei vapori devono essere evitati. Idonei indumenti o specifici presidi personali devono essere indossati per evitare i possibili rischi dovuti alla manipolazione durante le fasi di apertura delle confezioni, miscelazione dei componenti, applicazione dei prodotti miscelati. Anche gli attrezzi devono essere curati, in particolar modo i manici e le aste dei pennelli o rulli, che dovranno essere puliti dopo l uso, evitando che i detergenti, generalmente solventi organici, vengano a contatto con la pelle, gli occhi, la bocca. Il corredo minimo di protezione personale prevede: scarpe antinfortunistiche; guanti di sicurezza in gomma nitrilica o butilica. I guanti in lattice non sono adatti perché permeabili ad alcune sostanze presenti in alcuni prodotti; occhiali e maschere con filtri appropriati per solventi; elmetto; ginocchiere. L uso di racle o spatole con manico lungo è da preferirsi per la tutela della salute dell operatore. Questa tecnica applicativa consente di stare lontani con il viso dal prodotto, e inoltre permette l applicazione stando eretti. Per garantirsi condizioni atte a svolgere in sicurezza le varie fasi applicative è necessario attuare una buona organizzazione del cantiere. In particolare è necessario: preparare il cantiere in modo da agevolare tutte le movimentazioni e gli spostamenti delle attrezzature; sistemare in ordine di applicazione, accoppiando base e indurente relativo, i vari prodotti, in modo da non sbagliare durante la fase di miscelazione; sistemare il sito di miscelazione dei prodotti proteggendo il supporto con un telo in plastica; la scelta del sito va fatta in relazione alle fasi lavorative e alle vie d uscita; prevedere i contenitori dei rifiuti, lattine sporche, carta, plastica, pallet ecc.; curare la pulizia del cantiere, prima, durante e dopo la posa è sinonimo di professionalità, molto apprezzato dal cliente; rispettare le Norme di Legge relative alla sicurezza in cantiere; rispettare le misure di sicurezza e igiene degli ambienti durante l applicazione dei prodotti in fase solvente; impedire l accesso agli estranei con nastri o recinzioni. Il Dlgs del 3 febbraio 1997 n. 52, in attuazione della direttiva europea 92/32/CEE, disciplina l uso di alcune sostanze chimiche e dei prodotti con esse preparati o in essi presenti. Tutte le sostanze chimiche individuate dal decreto legge e i prodotti in cui esse sono presenti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), elaborata a cura e sotto la responsabilità di chi li immette sul mercato. 65
66 La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) che accompagna i prodotti chimici fornisce risposte a domande come: Quali sono le sostanze pericolose presenti nel prodotto? Come manipolare e stoccare il prodotto al fine di evitare pericoli? Quali presidi devo adottare per proteggere me stesso e l ambiente? Cosa devo fare in caso di incidente nonostante le precauzioni prese? Come utilizzare il prodotto in modo sicuro? L utilizzatore dei prodotti chimici pericolosi deve leggere, prima dell uso, le indicazioni riportate nella SDS. L applicatore è obbligato a adottare tutti i presidi e le prescrizioni riportate nella SDS e a conservare, presso il luogo di lavoro, tutte le SDS relative ai prodotti da lui applicati ed esibirle in caso di richiesta, controlli da parte degli Organi di Vigilanza o dell Istituto Assicuratore o, comunque, ogniqualvolta sia necessario. Il datore di lavoro deve obbligare i suoi lavoratori al rispetto delle indicazioni riportate nelle SDS, e inoltre formare e informare i suoi dipendenti sui pericoli legati all uso dei prodotti e sul comportamento da tenere in caso di incidenti, e fornirli di presidi idonei alla protezione personale. 9.6 La durata La durata di un sistema resinoso è valutata e definita in relazione a tutti i parametri e a tutte le variabili che potrebbero agire sul sistema stesso. Gli agenti che innescano il degrado di un sistema resinoso applicato sono molteplici e mutevoli nel tempo e non sempre valutabili preventivamente. È quindi più corretto parlare di vita utile di un rivestimento resinoso, cioè l arco temporale entro il quale saranno garantite le prestazioni richieste in base alla tipologia di sistema, alla destinazione d uso e alle sollecitazioni presenti. Un sistema resinoso necessita di manutenzione ordinaria, quale ad esempio lavaggi e pulizia, cerature, piccole riparazioni localizzate ecc., in modo che mantenga inalterate il più a lungo possibile le prestazioni iniziali. Nel caso di sistemi resinosi decorativi si deve accettare, perché caratteristica intrinseca della tipologia di soluzione, che siano visibili i segni della normale usura da utilizzo del pavimento. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ad esempio l applicazione di nuovi strati di finitura superficiali, si rendono necessari quando l usura o il degrado conseguenti all utilizzo del pavimento sono tali per cui il sistema resinoso non fornisce più alcune prestazioni marginali, rimanendo però inalterate le prestazioni minime essenziali per le quali il sistema era stato progettato. Prolungare eccessivamente i tempi di intervento per la manutenzione straordinaria può portare a un eccessivo degrado del sistema, fino a renderlo inidoneo allo scopo per il quale era stato realizzato. In tal caso i costi successivi di manutenzione possono essere tali da rendere più consigliabile, e/o tecnicamente realizzabile, il rifacimento totale. La velocità con cui si degrada un sistema resinoso dipende da innumerevoli fattori, tra cui intensità e frequenza del traffico pedonale e di mezzi, tipo di ruote utilizzate, velocità e peso dei mezzi, temperatura di utilizzo, presenza di liquidi, shock termici, urti, abrasioni ecc. Maggiori saranno le sollecitazioni, più frequenti e ravvicinati dovranno essere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si possono idealmente suddividere gli ambienti in cui vengono realizzati i sistemi resinosi in funzione dell intensità e della frequenza delle sollecitazioni a carico della pavimentazione: locali interni con traffico leggero e ruote gommate, assenza di sostanze corrosive, senza azioni usuranti, con frequenza lavaggi normale. Abitazioni civili; 66
67 locali interni con traffico intenso su ruote gommate o non molto inteso su ruote piene, con alta frequenza di lavaggi, e presenza di limitate azioni usuranti (trascinamenti, urti ecc.), presenza saltuaria e per breve tempo di sostanze chimiche corrosive. Locali pubblici; locali interni con forte traffico su ruote piene o presenza di versamenti di sostanze chimiche corrosive permanenti per tempi medio-lunghi, o presenza di percorsi con passaggi obbligati e frequenti di persone o mezzi, o alta frequenza di lavaggi con sistemi abrasivi, o presenza di azioni usuranti (urti, cadute di oggetti pesanti, trascinamenti ecc.); applicazioni in esterni. 67
68 10 VERIFICHE PRESTAZIONALI E CRITERI DI ACCETTAZIONE 10.1 Le verifiche prestazionali La verifica prestazionale di un rivestimento resinoso è un processo di controllo e di riscontro documentato della qualità del rivestimento stesso, con riferimento ai requisiti prestazionali, estetici e funzionali che il rivestimento dovrebbe avere, in rispondenza agli accordi contrattuali stipulati e accettati dalle parti. La verifica prestazionale può essere: parziale-temporanea, se effettuata durante i lavori, e sarà riferita, quindi, solo a una o più fasi esecutive; collaudo, se effettuata a lavori completati e per verificare la rispondenza di quanto realizzato con quanto riportato negli accordi contrattuali, nei limiti definiti dai criteri d accettazione; verifica tecnica, se effettuata dopo che il rivestimento è stato utilizzato: in questo caso, oltre ai criteri di accettazione, devono essere verificate anche la correttezza della scelta del sistema e la perfetta esecuzione. Il collaudo deve essere fatto il più presto possibile dopo il completamento del rivestimento, in ogni caso prima che il rivestimento venga utilizzato. La consegna lavori deve essere fatta dall applicatore alla presenza del Committente o di un tecnico, o persona, da questi delegata. Durante le operazioni di consegna lavori o di verifica tecnica, devono essere disponibili i seguenti documenti: contratto stipulato tra le parti; scheda processo esecutivo (vedi appendice A); prestazioni del ciclo applicato (nella verifica tecnica). La verifica prestazionale parziale o temporanea viene eseguita direttamente dal Committente o da un suo tecnico delegato, e ha lo scopo di controllare la qualità dei prodotti e la loro rispondenza a quanto riportato in contratto, le quantità impiegate e quindi gli spessori ottenuti, il rispetto dei tempi esecutivi e delle norme di igiene, pulizia e sicurezza del luogo di lavoro e delle maestranze impiegate in cantiere e/o di altre ditte presenti in ambienti limitrofi Criteri di accettazione Indipendentemente dal tipo di sistema resinoso, la verifica ha come punto di partenza l esame visivo del rivestimento e il rilievo fotografico delle eventuali problematiche, difetti o discordanze rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti. I rivestimenti resinosi sono considerati un manufatto artigianale e di conseguenza i criteri di accettazione del prodotto finito devono tener conto di tale caratteristica, ovviamente entro certi ben definiti limiti che dipendono dal tipo di rivestimento, dalla sua destinazione d uso (locali industriali, commerciali, abitazioni) e dalle caratteristiche prestazionali primarie che lo qualificano (resistenza chimica, resistenza meccanica, funzionalità, impermeabilità, estetica ecc.). 68
69 Criteri di accettazione per i vari tipi di sistema resinoso Di seguito sono riportati i criteri di accettazione per ogni singolo tipo di rivestimento. I criteri si riferiscono a sistemi ben progettati in relazione alla destinazione d uso dei locali nei quali saranno realizzati e alle esigenze prestazionali richieste. I criteri di accettazione, quindi, rappresentano i limiti propri del rivestimento e non sono difetti o errori esecutivi se le scelte del tipo di sistema e dei relativi prodotti da utilizzare sono state fatte in base alle richieste prestazionali valutate in funzione dei dati e delle informazioni raccolte dall applicatore, o da un suo incaricato, insieme all utilizzatore finale o a un suo rappresentante (progettista, general contractor ecc.). A tale scopo si rivelerebbe utile per l applicatore adottare lo specifico formulario Modulo di Raccolta delle Informazioni di Cantiere che dovrà essere compilato e controfirmato insieme all utilizzatore finale o a un suo rappresentante. I criteri di accettazione sono anche un valido strumento preliminare per la scelta e la valutazione del sistema più idoneo a ogni specifica situazione. Ad esempio, il fatto che nei criteri d accettazione sia indicato che un certo sistema non può garantire l impermeabilità non significa che il Committente debba accettare il rivestimento così com è; dovrà invece valutare tale caratteristica ed eventualmente richiedere soluzioni alternative che soddisfino quella proprietà nel caso fosse necessaria per il suo utilizzo. Per i sistemi impregnazione i criteri di accettazione sono riportati solo per il sistema impregnazione a saturazione, in quanto l impregnazione semplice è un trattamento della superficie abbastanza limitato e per il quale non è possibile definire criteri di accettazione, tenuto anche conto che in genere viene utilizzato come primerizzazione della superficie di posa. Per i sistemi pellicolari, i criteri di accettazione sono essenzialmente legati al ridotto spessore del sistema e di conseguenza alle limitate caratteristiche prestazionali. Con i sistemi a più alto spessore, si incrementano le caratteristiche prestazionali e i criteri di accettazione assumono la specificità di limiti minimi prestazionali in mancanza dei quali il sistema non è accettabile. IMPREGNAZIONE A SATURAZIONE Caratteristica Criterio di accettazione Spessore Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale Non è un parametro da verificare, in quanto non valutabile Il trattamento riduce l assorbimento di liquidi e conferisce una migliore resistenza allo sfarinamento (anti-polverosità). Si percepisce l effetto estetico tipo bagnato. Non può essere richiesta omogeneità estetica superficiale, poiché il trattamento mette in evidenza microfessure e differenze di colorazione della superficie del sottofondo. A causa del diverso assorbimento della superficie possono essere presenti aree più lucide e aree opache. Pulizia Il rivestimento consente una più agevole pulizia per effetto del ridotto assorbimento di liquidi; si tenga tuttavia conto che possono rimanere alcune tracce di sporco per la presenza di porosità non perfettamente chiuse che possono assorbire inquinanti. 69
70 PELLICOLARE A FILM SOTTILE Caratteristica Criteri di accettazione Spessore Fino a 300 µm Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale Pulizia La superficie può presentare imperfezioni dovute a irregolarità della superficie di posa, ai giunti di contrazione (spesso visibili) e anche qualche segno di rullata, specialmente per prodotti all acqua. Il rivestimento può garantire un iniziale impermeabilità, che con l uso si ridurrà fino a non essere più garantita. Il rivestimento può usurarsi nel tempo per il ridotto spessore, ma non sono ammissibili distacchi, rigonfiamenti (bolle), soffiature, vaiolature, cavillature. Il colore deve essere uniforme. Il rivestimento, per il ridotto spessore, non può nascondere tutte le imperfezioni della superficie di posa. La pulizia deve risultare agevole, particolarmente per sistemi con spessori maggiori di 250 µm. Nelle aree con maggior traffico, in particolare rivestimenti lisci e con spessori bassi, è possibile riscontrare, anche dopo un limitato tempo, usura, anche marcata, del rivestimento. L usura causa opacizzazione del rivestimento. PELLICOLARE A FILM SPESSO Caratteristica Criteri di accettazione Spessore Compreso tra 300 µm 1000 µm Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale Pulizia La superficie deve presentarsi, in particolare per i sistemi a più alto spessore, omogenea e con uniformità cromatica. I prodotti in emulsione acquosa possono dare diversi gradi di brillantezza o opacità a seconda delle condizioni ambientali durante la posa e l indurimento. Possono essere visibili i giunti di contrazione della superficie se non sono stati ripresi e riportati a vista. Sono visibili i giunti di costruzione e dilatazione se presenti e anche qualche segno di rullata, specialmente per prodotti all acqua. Il rivestimento deve garantire l impermeabilità (per rivestimenti con spessore di almeno 500 µm). Resistenza all abrasione. Non sono accettabili distacchi, rigonfiamenti (bolle), soffiature, cavillature, vaiolature. La pulizia deve essere agevole in particolare per i sistemi lisci lucidi. Per tali sistemi sono accettabili effetti legati alla graffiatura e opacizzazione per usura delle parti particolarmente trafficate. 70
71 MULTISTRATO Caratteristica Spessore Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale. Pulizia Criteri di accettazione Maggiore di 1,5 mm La superficie finita, con diversi gradi di rugosità, deve essere uniforme e può presentare lievi e sporadici segni di spatolata o di rullate della mano di finitura. L incremento della rugosità migliora le caratteristiche antiscivolo. Resistenza all abrasione e agli urti. Non devono essere visibili i giunti statici di contrazione della superficie di posa, salvo che non siano stati ripresi e riportati a vista. Sono visibili i giunti di costruzione e dilatazione se presenti. Il rivestimento deve garantire l impermeabilità. Non sono accettabili distacchi, rigonfiamenti (bolle), soffiature. Il colore deve essere omogeneo e uniforme. Sono accettabili leggere impronte di spatolate, più o meno visibili in funzione del colore e dell angolo della luce incidente. La pulizia deve essere agevole in particolare per i sistemi con bassa rugosità superficiale. La pulizia diviene più difficoltosa e richiede macchinari idonei e frequenza giornaliera con l incremento della rugosità superficiale. AUTOLIVELLANTE Caratteristica Spessore Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale. Pulizia Criteri di accettazione Maggiore di 2,0 mm Superficie lucida o opaca, omogenea senza difformità cromatica o discontinuità superficiali evidenti, salvo nel caso di rivestimenti decorativi in cui le discontinuità estetiche siano volute e appositamente realizzate. Bassa resistenza al graffio, in particolare i sistemi epossidici. Resistenza agli urti. Non devono essere visibili i giunti statici di contrazione della superficie di posa, salvo che non siano stati ripresi e riportati a vista. Sono visibili i giunti di costruzione e dilatazione se presenti. Il rivestimento deve garantire l impermeabilità. Non sono accettabili distacchi, rigonfiamenti (bolle), soffiature. Sono accettabili leggere impronte di spatolate, più o meno visibili in funzione del colore e dell angolo della luce incidente. Facilmente pulibili, decontaminabili e sanificabili. 71
72 MALTA RESINOSA Caratteristica Spessore Proprietà conferite alla superficie e aspetto estetico finale Pulizia Note: 1)La pulizia di una pavimentazione in resina dipende da molteplici fattori, dal sistema utilizzato, dal tipo di sporco, dalla frequenza dei lavaggi, dalla adeguata programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. 2)Le bruciature del sistema resinoso causate dallo slittamento delle ruote dei carrelli che provocano forti innalzamenti delle temperature superficiali, lasciano spesso segni scuri sulla superficie, a volte anche a rilievo, generalmente permanenti. Non possono essere rimosse dalle operazioni di pulizia. Vedere Capitolo La verifica tecnica I criteri di accettazione definiscono i limiti propri del sistema. Immediatamente dopo il primo periodo d uso, o anche dopo qualche mese, possono manifestarsi problematiche, difetti o vizi che, nel caso siano riconducibili ai limiti definiti dai criteri di accettazione, renderebbero opportuno verificare se al momento della scelta del tipo di rivestimento l applicatore e l utilizzatore finale, o loro rappresentanti, abbiano raccolto tutte le informazioni necessarie durante le prime fasi o durante la compilazione del formulario Modulo di Raccolta delle Informazioni di Cantiere. Le problematiche che possono insorgere sono diverse e molteplici; di seguito analizziamo le più comuni, quelle che costituiscono spesso motivo di contestazioni La determinazione dello spessore finale realizzato Lo spessore di un sistema resinoso può essere valutato e controllato durante tutte le fasi applicative, in base alla quantità di prodotto applicato tenendo conto della densità [kg/l] e del contenuto in solidi in volume del prodotto, secondo la relazione: che diventa: Criteri di accettazione Spessore secco maggiore di 5 mm Impermeabilità, facilità di pulizia con ottima resistenza agli urti, ai frequenti lavaggi e ai detergenti, uniformità cromatica, resistenza all usura, meccanica e chimica. Resistenza all abrasione. Con opportuni accorgimenti, è possibile eseguire leggere correzioni di planarità. Colorato, lucido, opaco, liscio o ruvido. Facilmente pulibili, decontaminabili e sanificabili. La pulizia deve essere garantita da opportuna saturazione delle porosità superficiali del massetto di malta resinosa ed più agevole in particolare per i sistemi con bassa rugosità superficiale. s m = δ x ξ x [(Q/A)/ds] s m = δ x ξ x s t [1] 72
73 s m è lo spessore teorico finale espresso in mm, ricordando che un litro di sostanza liquida sparso su una superficie di 1 m 2 realizza uno spessore di 1 mm. ξ è un fattore numerico che tiene conto del contenuto in solidi in volume del prodotto, se il prodotto è senza sostanze volatili (100% in solidi), ξ= 1; s t è lo spessore teorico espresso in mm; st = [(Q/A)/ds] con ξ = 1 e δ = 1 Q è la quantità in kg di prodotto applicato (al lordo dell eventuale carica); A è l area della superficie trattata espressa in m 2 ; ds è la densità espressa in kg/l o kg/dm 3 ; se il prodotto non è 100% in solidi, ξ 1. Quindi per ottenere lo spessore finale è necessario moltiplicare il valore ottenuto con la [1] per la percentuale in volume del contenuto di solidi presenti; δ è un fattore correttivo che tiene conto se al prodotto sono state aggiunte cariche (quarzo, marmo) prima o durante l applicazione (spolvero a saturazione). δ = 1 quando il prodotto viene impiegato così come fornito dal produttore. Altri valori di δ sono riportati in tabella relativamente all uso della carica (quarzo o marmo). Valori di δ in relazione alla densità del prodotto densità prodotto [kg/l o kg/dm 3 ] r = rapporti in peso resina/carica r = 1/0,5 r = 1/1 r = 1/2 r = 1/10 r = 1/12 1,0 δ = 0,79 δ = 0,69 δ = 0,59 δ = 0,44 δ = 0,43 1,1 δ = 0,81 δ = 0,71 δ = 0,61 δ = 0,47 δ = 0,46 1,2 δ = 0,82 δ = 0,73 δ = 0,64 1,3 δ = 0,83 δ = 0,75 δ = 0,66 1,4 δ = 0,84 δ = 0,76 δ = 0,69 Il valore di δ quando si semina quarzo a saturazione è valutabile in relazione alla densità del prodotto applicato. Nella tabella che segue vengono forniti alcuni valori di δ in relazione alla densità dei prodotti. I valori di δ sono stati desunti da applicazioni pratiche su prodotti di varia densità. Valori di δ in relazione alla densità del prodotto per spolvero a saturazione densità prodotto [kg/l o kg/dm 3 ] 1,0 1,98 1,1 1,82 1,2 1,66 1,3 1,54 1,4 1,42 δ Per determinare lo spessore finale si applica sempre la [1] dove Q è la quantità di prodotto applicato prima dello spolvero. 73
74 Esempio 1 Su una superficie di 20 m 2 sono stati applicati 100 kg di prodotto, al 100% in solidi, con densità 1,30 kg/l, senza aggiunta di quarzo, lo spessore finale medio è: s m = st = 1 x 1 x [ 100/20 ]/ 1,30 = 3,80 mm Se il prodotto è in fase solvente con contenuto in solidi pari al ξ = 85% in volume, senza aggiunta di quarzo, lo spessore finale medio sarà, invece: s m = 1 x 0,85 x st = 3,23 mm Se al prodotto viene aggiunto quarzo in rapporto resina/quarzo = 1/0,5, e si sono applicati 100 kg di miscela resina-quarzo lo spessore finale medio sarà: s m = 0,83 x 0,85 x st = 2,68 mm Lo spessore è stato ottenuto utilizzando 67 kg di resina e 33 kg di quarzo. Per ottenere lo stesso spessore con la sola resina occorrerebbero (20x1,3x2,68)/0,85 = 82 kg di resina. Esempio 2 Su una superficie di 200 m 2 sono stati applicati 100 kg di prodotto, al 100% in solidi, con densità 1,30 kg/l, e dopo la rasatura, sul prodotto ancora fresco, si è seminato a saturazione quarzo granulometria 0,06 0,25. Quale spessore si è realizzato? Applicando la [1] abbiamo: s m = [(100/200)/1,30] x δ dalla tabella per d=1,3 kg/l δ = 1,54 quindi s m = 0,590 mm In mancanza di dati certi e attendibili in merito ai consumi dei singoli prodotti impiegati per la realizzazione del rivestimento, e a una distribuzione sufficientemente omogenea degli stessi sulla superficie, la determinazione dello spessore finale avviene mediante carotaggio. I prelievi vanno eseguiti come indicato in figura, sulla base di almeno 5 prelievi secondo uno schema che tenga conto della geometria della superficie trattata. Si consiglia di operare lungo diagonali, come indicato in figura per il caso di un locale rettangolare. Le carote devono avere sia diametro sia profondità di almeno20 mm. 74
75 s m = ( s i )/n i s m = spessore medio valutato [mm] s i = valori dello spessore rilevato nei singoli prelievi (almeno 5) n i = numero dei prelievi eseguiti (almeno 5) Eseguire almeno 5 prelievi. Il numero totale dei prelievi (n i ), dipenderà da quanta rispondenza si verifica, nei primi 5 prelievi, tra il valore dello spessore medio misurato e il valore dello spessore concordato. Sono ammessi scostamenti del valore desunto da quello concordato contrattualmente nel rispetto delle seguenti limitazioni: Il valore medio valutato dello spessore, calcolato o misurato, non deve risultare minore dello spessore concordato contrattualmente (s c ) con uno scostamento del -10%. s m s c -10% In nessun punto di misura (s pm ), nel caso di rivestimento con spessori concordati maggiori di 2 mm, lo scostamento dal valore definito contrattualmente deve eccedere le seguenti tolleranze: o per i rivestimenti autolivellanti: spessore rilevato mai minore del -50% di s c o s pm s c -50% per rivestimenti a malta: spessore rilevato mai minore del -25% di s c s pm s c -25% Eventuali zone con spessori maggiori di quello contrattualmente definito non devono influire negativamente sulla planarità e/o sulle pendenze della superficie richieste. 75
76 Vizi e/o difetti di un rivestimento finito I vizi e i difetti delle pavimentazioni resinose possono interessare superfici puntuali e limitate o superfici ampie, a seconda delle reali condizioni operative e di contorno. L aspetto quantitativo, oltre che qualitativo, deve essere considerato come elemento determinante per la classificazione del vizio o del difetto. In tabella vengono elencati alcuni difetti (quelli più comuni), come si presentano, le probabili cause. Tabella difetti/cause dei rivestimenti finiti Definizione Aspetto visivo Cause Sfiammature. Schivature. Carbonatazione. Marcata evidenziazione delle rullate. Chiazze di colore o di tonalità tali da creare un aspetto finale macchiato o a strisce, a volte poco evidente, a volte fortemente antiestetico. Depressioni più o meno marcate della superficie del rivestimento, di forma lenticolare. Nel caso di rivestimenti a basso spessore, tali fenomeni determinano l aprirsi del rivestimento lasciando aree non coperte. L effetto finale che ne deriva viene comunemente chiamato occhi o occhi di pernice o pelle di leopardo, volendo descrivere l effetto finale di come si presenta la superficie. La superficie si presenta opaca con presenza di una patina sottilissima. Si evidenziano marcatamente le varie rullate e in particolare le zone di sovrapposizione del prodotto (riprese). L uniformità del colore, l impronta del rullo e dei sormonti fanno scartare l ipotesi di sfiammature. Flottazione dei pigmenti all interno del prodotto. Carenza o ridotta funzionalità dei bagnanti presenti nel formulato. In questo caso le cause possono essere dovute sia al prodotto, sia a inquinamenti della superficie di posa o dell ambiente con sostanze grasse, oli, o comunque incompatibili con il prodotto applicato. Per determinare con certezza la causa, è opportuno riapplicare lo stesso prodotto su una diversa superficie pulita e non contaminata. Se il fenomeno non si verifica, il difetto è dovuto a inquinamento della superficie di posa, dell ambiente o delle attrezzature impiegate. Fenomeno collegato alle condizioni ambientali, in particolare al grado di umidità, durante le fasi di posa e indurimento, specialmente delle resine epossidiche. Le ammine dell indurente, reagendo con la CO 2 dell aria e in presenza d umidità, formano in superficie uno strato opaco sul quale si ha scarsa adesione. Il fenomeno è più evidente per le finiture all acqua e per le finiture opache o satinate. Le cause sono legate spesso all applicazione in condizioni ambientali non idonee, che hanno modificato i tempi di sovrapposizione. Anche il prodotto può essere causa di tale fenomeno, in quanto poco distendibile o con basso pot-life oppure uno scarso spessore applicato. Anche un applicazione non corretta, ad esempio evitando di incrociare il verso della rullata in ogni singola mano, può causare evidenti segni di rullature. 76
77 Definizione Aspetto visivo della superficie Cause Scarsa distensione. Bassa tendenza a rilasciare l aria. Soffiature. Distacchi. Per prodotti di finitura, l aspetto tipico è una goffratura a buccia d arancia superficiale (a meno che non sia una caratteristica voluta e dichiarata dal produttore) e l evidenziazione delle rullate. Per prodotti ad alto spessore applicati a spatola diritta o dentata, si evidenziano le varie riprese e/o i segni dei denti della spatola. Presenza in superficie di tanti piccoli crateri, fori a testa di spillo, molto ravvicinati, spesso a chiazze. Piccoli rigonfiamenti del rivestimento generalmente a forma di crateri con la presenza di un foro centrale. Spesso si presentano anche come semplici fori, sparsi. Si manifestano dopo qualche giorno, spesso dopo un ciclo di temperatura (caldo/freddo); in alcuni casi possono manifestarsi anche dopo 1-2 mesi. Possono presentarsi come rigonfiamenti di media e ampia grandezza, lesioni, distacchi del rivestimento con o senza asportazione di parte della zona corticale della superficie di posa. Le cause possono essere essenzialmente due: prodotto mal formulato, poco fluido o disomogeneo; prodotto applicato con temperature ambientali e soprattutto della superficie di posa troppo alte, e quindi con indurimento troppo rapido che non consente una corretta distensione, o troppo basse, e quindi con prodotto eccessivamente viscoso. Ridotta capacità di alcuni additivi a rilasciare l aria inglobata durante la miscelazione; l aria resta bloccata in superficie sotto forma di piccole bollicine. Temperatura del supporto troppo bassa. Trattamento preliminare della superficie di posa non adeguato, in quanto non ha saturato completamente la porosità del sottofondo. Il fenomeno si manifesta su superfici particolarmente porose. L aria contenuta nei pori, anche per effetto del riscaldamento della resina durante l indurimento, risale verso la superficie creando rigonfiamenti che in parte scoppiano e in parte lasciano solo il foro di sfiato. a) Senza asportazione di parte del supporto In questi casi la causa più probabile è la non perfetta, o assente, preparazione della superficie di posa, con conseguente presenza di sostanze o altri elementi che hanno compromesso l adesione (vedi 7.3) b) Con presenza di parte del supporto in adesione con il rivestimento In questi casi si evidenzia un possibile cedimento della parte corticale del sottofondo, conseguenza di scelte errate della tipologia del sistema (con relative tensioni non sostenibili), o preparazione della superficie di posa non adeguata, o sottofondo non dotato delle minime resistenze meccaniche richieste. 77
78 Definizione Aspetto visivo della superficie Cause Rigonfiamenti per osmosi (*). Lesioni. Bruciature/usura con ruote piene. Macchie da pneumatici nuovi. Si manifestano di solito dopo mesi, anche dopo il primo anno, dall applicazione e spesso in corrispondenza della prima variazione termica di riscaldamento della pavimentazione (inizio primi caldi, riscaldamento locali). Altro aspetto caratterizzante è rappresentato dalla loro grandezza; il diametro varia da 2,5 3 mm fino a un massimo di mm. Sono spesso molto dure, difficili da rompere e presentano all interno un liquido giallognolo/bruno. Si manifestano dopo un periodo di qualche mese o anche dopo giorni. Hanno grandezza variabile da cavillature a vere e proprie crepe larghe anche 2 3 mm. Le lesioni possono interessare solo il rivestimento o anche la superficie di posa. Presenza sul rivestimento in modo casuale di aree concave corrose di larghezza di circa 5 7 cm Presenza di macchie, normalmente giallo-brune, sulla superficie del rivestimento resinoso quando viene a contatto prolungato con pneumatici nuovi. La macchia riporta l esatta sagoma del battistrada del pneumatico. Causa unica la presenza eccessiva d acqua nel supporto, di solito dovuta a: ü assenza di barriera vapore; ü canalizzazioni, tubazioni, rotte da cui fuoriesce acqua; ü presenza di barriera vapore, ma o lacerata o non ben applicata con sormonti che lasciano passare l umidità; ü risalite capillari di umidità dal sottofondo; ü vecchio sottofondo umido in conseguenza di contatti con acqua quando in esercizio; ü nuovi sottofondi non completamente stagionati. La verifica deve stabilire se le lesioni sono nate nel supporto o viceversa. Nel caso interessino solo il rivestimento, la causa principale possono essere le sollecitazioni che si trasmettono all interfaccia superfice di posa e rivestimento, generalmente dovute a deformazioni termiche per shock termici o eccessivi sbalzi di temperatura Effetto della molatura delle ruote motrici di muletti. Si produce quando la ruota motrice del muletto non ha la perfetta aderenza col pavimento e pertanto slitta. Ciò avviene quando i carichi non sono equilibrati sulle forche, o per manovre troppo rapide (sgommate). La ruota gira a vuoto e per attrito surriscalda la superficie che si indebolisce e per azione meccanica (rotazione) viene asportata lasciando l aspetto tipico concavo di larghezza pari alla larghezza della ruota o poco più. Vedasi per un approfondimento il paragrafo Il fenomeno è causato dalla migrazione di plastificanti e nerofumo dalla mescola del pneumatico, in particolar modo quando è nuovo, alla superficie del rivestimento. La macchia è spesso molto difficile da togliere. Non tutti i formulati resinosi si macchiano allo stesso modo. (*) L impiego di sistemi resinosi traspiranti permeabili al vapore o di sistemi resinosi che includono anche alcune tipologie di prodotti epossi-cementizi consente interventi su supporti cementizi nuovi o con elevata presenza di umidità, e interventi riparatori di precedenti applicazioni interessate dal fenomeno osmotico. 78
79 10.4 Il problema delle bruciatura da frizione delle ruote La temperatura di transizione vetrosa Una proprietà tipica e caratteristica dei polimeri amorfi è la temperatura di transizione vetrosa, generalmente rappresentata con T g. Questo valore indica la temperatura al di sotto della quale il polimero si comporta da solido rigido e vetroso. Al di sopra di essa il materiale assume un comportamento più morbido e gommoso. Il valore di T g può cambiare drasticamente da un materiale all altro; si va da alcune decine di gradi sotto lo zero per alcuni elastomeri fino ad alcune centinaia di gradi sopra zero per altri polimeri. Lo stesso tipo di materiale può avere T g diverse in base a come è avvenuto il suo processo di polimerizzazione. In linea di massima, quindi, polimeri che devono avere caratteristiche di flessibilità, morbidezza, deformabilità ecc. possiedono T g molto più bassa della temperatura ambiente; sul fronte opposto, polimeri che devono essere caratterizzati da elevate prestazioni meccaniche e di rigidezza devono avere T g molto più elevata della temperatura ambiente. È questo il caso, ad esempio, delle resine epossidiche. Quando una resina epossidica raggiunge la sua T g, che nel caso dei formulati per rivestimenti di pavimentazioni e dell ordine del centinaio di gradi centigradi, comincia a evidenziare un decadimento delle prestazioni meccaniche. Essendo un polimero termoindurente non è rimodellabile e ogni sollecitazione meccanica che dovesse avvenire in questa fase potrebbe danneggiare la struttura macro e microscopica del polimero. Inoltre se il materiale dovesse scaldarsi troppo si spezzerebbero i suoi legami chimici con conseguente carbonizzazione. Una volta raffreddatosi il materiale, il danno sarebbe permanente con conseguente perdita irreversibile di prestazioni e resistenze La bruciatura dei sistemi resinosi causata dalla frizione delle ruote Che due corpi solidi si riscaldino sfregandosi l uno con l altro è un fatto noto che non necessita di alcuna ulteriore spiegazione. La temperatura che raggiungono i due corpi è proporzionale al calore sviluppato che a sua volta dipende da tanti fattori, quali la durezza reciproca dei materiali, la scabrosità delle superfici, il coefficiente di attrito tra le stesse, la velocità a cui avviene la frizione, il carico per unità di superficie, ecc. Lo sfregamento delle ruote gommate o di teflon dei muletti o dei transpallet sulla superficie di un rivestimento resinoso è una situazione molto frequente e il conseguente innalzamento di temperatura è quindi tanto maggiore quanto maggiori sono il carico gravante abbinato alla velocità di rotazione e l eventuale movimento di torsione della ruota stessa, oltre ad altri fattori meno rilevanti. In situazioni estreme, ad esempio quando sulla ruota motrice e sterzante grava un peso di molti quintali e la stessa gira velocemente da ferma in fase di partenza, si raggiungono temperature sulla superficie del sistema resinoso di elevata entità, ben superiori alla T g del materiale costituente il rivestimento. Per quanto si tratti di un fenomeno di breve durata, il decadimento delle prestazioni meccaniche del polimero causato dal forte e improvviso riscaldamento associato all aggressione meccanica della ruota volvente o sterzante comporta una rimozione di parte di rivestimento che nei casi più lievi si manifesta con graffi superficiali e nei casi più drastici con l asportazione in profondità del rivestimento resinoso che apparirà anche di colore nerastro per l avvenuta carbonizzazione dei suoi legami chimici. Il nero che rimane sulla superficie è anche causato dall altrettanto rapido consumo della gomma della ruota, e non è raro vedere gomma e resina fondersi tra loro una volta raffreddatasi l area. 79
80 I successivi lavaggi della pavimentazione possono in parte rimuovere i segni neri, ma difficilmente si potrà avere una pulitura perfetta della superficie. Le bruciature da gomme non possono essere riconducibili a carenza di qualità dei materiali utilizzati, indipendentemente dal fatto che si tratti di resine epossidiche o poliuretaniche o polimetilmetacrilato o a errori di posa degli stessi. Sono causate da un evento fisico che coinvolge molti fattori diversi, non tutti perfettamente controllabili, e quando si verificano le dovute condizioni ambientali e di utilizzo della pavimentazione è inevitabile che il fenomeno avvenga. Si possono tuttavia adottare opportuni accorgimenti, che coinvolgono tutte le parti interessate, utili ed efficaci per ridurre drasticamente il problema: modifica e/o calibrazione della parte elettronica dei carrelli elevatori che comanda la velocità della ruota in fase di partenza, programmandola perché avvenga senza una rapida e brusca rotazione della ruota motrice; corretta disposizione e distribuzione dei cariche sui carrelli elevatori; adottare uno stile di guida e movimentazione dei carrelli elevatori che non sia brusco; scegliere e usare materiali di finitura del sistema resinoso tra i più resistenti e meno soggetti al fenomeno; attendere il completo indurimento del rivestimento prima di utilizzarlo; utilizzare ruote in gomma bianca; eseguire la regolare manutenzione dei carrelli elevatori; mantenere pulita la superficie del pavimento. 80
81 10.5 Le macchie da ritenzione di sporco Un fenomeno analogo, o comunque correlato, alla bruciatura del rivestimento in conseguenza della frizione delle ruote è la formazione e ritenzione di macchie superficiali di sporco, soprattutto sui rivestimenti a base di poliuretano-cemento, in conseguenza di una scarsa o inadeguata manutenzione ordinaria e semplice pulizia della superficie. Va ricordato che un sistema resinoso è per sua natura impermeabile o poco assorbente, pertanto ogni traccia di sporco, polvere, particelle di varia natura ecc. deve essere rimossa mediante opportuni e adeguati sistemi di pulizia e lavaggio della superficie (vedi in proposito Cap. 11). Sporco, polveri, sostanze chimiche aggressive, grassi, sostanze organiche ecc., possono essere sollecitati dalle ruote di carrelli elevatori, traffico pedonale, veicoli vari, ecc. L abrasione sulla superficie del rivestimento sarà maggiore e lo sporco, grazie alla combinata azione meccanica delle ruote, potrà penetrare in micro graffi superficiali o, in alcuni casi, nelle micro porosità dello strato resinoso, penetrandovi a formare chiazze più scure poi difficili da rimuovere. Una frequente e corretta pulizia della pavimentazione riduce drasticamente la formazione di macchie di sporco La verifica delle caratteristiche prestazionali La verifica tecnica di un rivestimento è un processo documentato della qualità e delle caratteristiche prestazionali del rivestimento stesso, con riferimento ai requisiti concordati tra le parti e riportati, oltre che nella documentazione oggetto dell appalto (offerta, contratto, schede tecniche ecc.), anche nella Scheda processo esecutivo. La verifica tecnica deve includere: 81
82 esame visivo del rivestimento; verifica dell adesione; controllo delle prestazioni richieste e verifica delle prestazioni intrinseche del rivestimento; test analitici mediante prelievi di campionature o prove in sito non distruttive; relazione, con i risultati delle osservazioni e misure effettuate, e il giudizio conclusivo sulla qualità del rivestimento per quanto attiene alla scelta dei materiali e del tipo di rivestimento, sull esecuzione e sulla sua rispondenza ai requisiti prestazionali richiesti e riportati nei documenti oggetto dell appalto L esame visivo L esame visivo del rivestimento è teso a verificare essenzialmente l aspetto estetico, la funzionalità in relazione anche all eventuale segnaletica orizzontale per la sicurezza se esistente, le rifiniture, la presenza di imperfezioni superficiali legate alla posa o ai prodotti impiegati. L esame va eseguito osservando il rivestimento a occhio nudo da una distanza di 1,5 m entro la quale è possibile il rilievo delle imperfezioni contestabili, fermi restando i criteri di accettazione citati al par La verifica dell adesione Inizialmente la verifica può essere condotta in modo qualitativo mediante l uso di una barra metallica da appoggiare sul rivestimento; mediante la variazione di rumore durante lo strisciamento sulla superficie è possibile verificare la presenza di distacchi incipienti. Nel caso di dubbi si potrà ricorrere a una valutazione analitica dell adesione che deve essere eseguita con una prova puntuale distruttiva utilizzando un Adhesion Tester secondo ASTM D 4541 Si deve verificare che dopo lo strappo del dolly la rottura sia sempre di tipo coesivo (distacco del rivestimento con parte del sottofondo) e che tale presenza di parte della superficie di posa (a), aderente alla superficie del dolly, sia maggiore del 50% della superficie del dolly (A): a 0,5 A Altre caratteristiche e prestazioni richiedibili Un sistema resinoso può presentare caratteristiche fisiche e chimiche diverse a seconda di come viene realizzato e dei componenti che lo costituiscono. Può essere più o meno resistente agli agenti aggressivi, può essere più o meno elastico, avere caratteristiche meccaniche di resistenza agli urti e all usura più o meno marcate. Il grado di finitura superficiale può essere liscio o marcatamente ruvido per conferirgli proprietà antiscivolo. Può essere elettricamente isolante o conduttivo. 82
83 Resistenza chimica Una delle caratteristiche che fa preferire l impiego dei sistemi resinosi ai rivestimenti tradizionali è certamente la loro capacità di resistenza agli agenti chimici, che non necessariamente sono costituiti da sostanze particolarmente corrosive. Il degrado può avvenire attraverso l uso quotidiano di detergenti o semplicemente per la permanenza continua di acqua sulla superficie. La resistenza chimica di un rivestimento dipende dalla natura della sostanza aggressiva, dalla sua concentrazione, dalla sua temperatura e dal tempo di contatto con la superficie del rivestimento. Un rivestimento resinoso è chimico resistente quando garantisce continuità e protezione in ogni punto in cui viene applicato. Deve pertanto essere costituito da uno strato continuo di adeguato spessore. Poiché i pavimenti sono soggetti a frequenti movimentazioni di mezzi e persone, che potrebbero localmente degradare o graffiare o incidere la superficie, un rivestimento resinoso che debba anche garantire protezione chimica non può avere uno spessore secco finito inferiore a 0,8 mm. Un rivestimento resinoso può contribuire a rafforzare e/o migliorare le caratteristiche di resistenza della superficie di posa che parzialmente già possiede, resistenza chimica collaborativamigliorativa, oppure assolvere direttamente la funzione protettiva, resistenza chimica protettiva diretta. Parametri essenziali Resistenza chimica Collaborativa-migliorativa Protettiva diretta Impermeabilizzazione Fondamentale Fondamentale Scelta dei prodotti Determinante in relazione alla natura delle sostanze chimiche, alla loro concentrazione, alla loro temperatura di esercizio e ai tempi di contatto (saltuario, permanente). Scelta del sistema Quelli con spessore minimo che garantisca l impermeabilità Aspettativa di durata Fasi applicative che potrebbero compromettere la resistenza chimica Rispetto del tempo di completo indurimento s 500 µm Resistenza alla temperatura 2 anni, con monitoraggio, comunque in funzione delle reali condizioni d utilizzo. Non corretta e/o completa miscelazione e condizioni di temperatura e umidità del supporto non idonee. Fondamentale per l ottenimento della effettiva resistenza chimica in fase di esercizio. Determinante in relazione alla natura delle sostanze chimiche, alla loro concentrazione, alla loro temperatura di esercizio e ai tempi di contatto (saltuario, permanente). Spessori adeguati alle esigenze prestazionali richieste s 800 µm 5 anni, con monitoraggio, comunque in funzione delle reali condizioni d utilizzo. Non corretta e/o completa miscelazione e condizioni di temperatura e umidità del supporto non idonee. Fondamentale per l ottenimento della effettiva resistenza chimica fase di esercizio. La temperatura può influire sui sistemi resinosi non solo durante la fase applicativa, ma anche dopo che gli stessi sono stati applicati e perfettamente induriti. I formulati resinosi utilizzati per i rivestimenti di pavimentazioni, esclusi alcuni prodotti misti organico-cementizi (vedi cap. 6.2), cominciano a perdere le loro prestazioni generalmente a partire dai +60 /+80 C. 83
84 Nel settore delle pavimentazioni ciò accade molto di rado e in zone limitate. Ne sono esempio i locali dove possono verificarsi sversamenti di liquidi molto caldi o ambienti con pavimentazioni prossime a fonti di calore come, ad esempio, forni o caldaie. Un sistema resinoso trova limitazioni applicative anche nel caso di basse temperature, come nelle celle frigorifere. Può accadere che la variazione di temperatura sia molto forte ma limitata nel tempo, ad esempio la caduta accidentale di acqua bollente o lavaggi effettuati con vapore in pressione a più di +100 C. In questo caso il rivestimento resinoso sarà sottoposto a una repentina variazione di temperatura (shock termico) che indurrà una brusca variazione dimensionale dello stesso. La temperatura massima di esercizio o dello shock termico è in realtà anche funzione della tipologia di sistema realizzato, dello spessore, dell inerzia termica, del tipo e quantità di cariche utilizzate ecc. Alcuni sistemi, ad esempio quelli realizzati con formulati poliuretano-cementizi, grazie alla loro proprietà di inerzia, modulo elastico e alto spessore realizzato, possono sopportare temperature di esercizio e shock termici fino a +100 C e oltre Dilatazioni termiche La deformazione di una sostanza per effetto della temperatura viene determinata mediante la formula: L = λ L (T 2 T 1 ) dove: λ= coefficiente di dilatazione termica lineare [K -1 ]*; L = lunghezza [ m ] L = variazione di lunghezza [m] (T 2 T 1 ) = variazione della temperatura [ C] * talvolta il simbolo λ, soprattutto nel mondo delle pavimentazioni, viene sostituito dal simbolo α, anche se quest ultimo dovrebbe indicare, più correttamente, il coefficiente di dilatazione volumetrica. Valori di λ per alcune sostanze Coefficiente di dilatazione [ C -1 ] Calcestruzzo 1,0 x 10-6 K -1 Resina epossidica (valore indicativo) 1,0 x 10-4 K -1 Acciaio 1,2 x 10-5 K -1 Alluminio 2,4 x 10-5 K -1 PVC 7,0 x 10-5 K Colore, brillantezza, aspetti generali del grado di finitura Il colore dei prodotti resinosi viene ottenuto con l aggiunta di pigmenti direttamente nella base o nel formulato neutro mediante paste colorate. Il non ingiallimento del colore per effetto dei raggi UV dipende dalla natura chimica del formulato e dei pigmenti. Non vi sono in commercio prodotti che non virano in assoluto nel tempo. Si possono ottenere prodotti con un ottima resistenza all azione dei raggi UV, ma certamente non totale. I raggi UV, oltre al viraggio dei colori (ingiallimento), determinano, se i prodotti non sono stati specificamente formulati, sfarinamento e quindi opacizzazione superficiale. 84
85 Si tenga altresì presente che la superficie del rivestimento resinoso può virare di colore a seguito del contatto con sostanze chimiche; questo fenomeno è spesso un fatto isolato e non è necessariamente indice di un avvenuta aggressione chimica. I rivestimenti resinosi di pavimentazioni si possono graffiare. La presenza di graffi sulla superficie del rivestimento resinoso e conseguente opacizzazione a seguito dell usura dovuta all utilizzo è quindi un fatto del tutto normale. Qualora, a seguito di azioni meccaniche particolarmente severe, il graffio dovesse attraversare tutto lo spessore del rivestimento (si parla in questo caso di incisione) si dovrà intervenire quanto prima con una riparazione localizzata per evitare che attraverso tale lesione possano infiltrarsi nel sottofondo liquidi o sostanze aggressive, sporco e batteri ecc. L eventuale strato di finitura di un sistema resinoso, normalmente applicato a rullo, presenta uno spessore secco variabile tra 40 µm e 100 µm. L applicazione dello strato di finitura può conferire alla superficie del rivestimento caratteristiche più elevate di resistenza chimica e/o all abrasione, migliorandone la facilità di pulizia e sanificazione e l aspetto estetico finale. L applicazione a rullo della finitura può essere causa dei classici segni visibili delle rullate. Per ridurre e limitare tale effetto è importante, nell effettuare tale operazione, che il rullo perda la quantità in eccesso di prodotto. L operazione di incrociare le rullate durante la posa consente una migliore distensione del prodotto e riduce i segni dei sormonti dei vari passaggi del rullo Proprietà antiscivolo La superficie di un sistema resinoso può essere liscia o con vari gradi di rugosità. Passando da superficie liscia a rugosa, e quindi antisdrucciolevole, la stessa risulterà sempre meno pulibile. Non possono però essere eluse le prescrizioni previste dalla normativa vigente in merito allo scivolamento sui luoghi di lavoro o in locali pubblici. La normativa italiana, relativamente a tale argomento, non da indicazioni definite in merito. Gli unici riferimenti legislativi sono il D.lgs. 9, aprile, 2008 n.81 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori, allegato XIII, punto 4.1: I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Inoltre il D.M. 14, giugno, 1989 n. 236, art. 8, punto 8.2.2: Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard, su pavimentazione bagnata. Le tabelle riportano i valori secondo le norme DIN tedesche, DIN e DIN Germania DIN piedi nudi Angolo scivolamento Classificazione Campo di applicazione α < 12 non classificate 12 α < 18 A deambulazione a piedi scalzi 18 α < 24 B zone lavaggi docce piscine α 24 C scale che conducono in acqua, bordi inclinati di piscine 85
86 Germania DIN scarpe antinfortunistiche angolo scivolamento classificazione α < 3 non classificate 3 α 10 R9 10 < α 19 R10 19 < α 27 R11 27 < α 35 R12 α > 35 R13 Una prova molto semplice e veloce da eseguire è quella del pendolo, secondo la norma UN EN , che misura l attrito opposto dalla superficie del pavimento all oscillazione di un particolare pendolo su cui viene montato un pattino di gomma che sarà la parte sfregante sul pavimento. Tale prova si può realizzare sia su superfici bagnate sia asciutte. Lo strumento è facilmente trasportabile in cantiere, pertanto risulta estremamente comodo e pratico in quanto si possono avere i reali valori del rivestimento in opera. Di seguito viene riportata una tabella di classificazione secondo UNI EN in funzione del valore del pendolo rilevato secondo UNI EN , di cui si dovrà tenere conto relativamente alla destinazione d uso prevista della pavimentazione. Test al pendolo EN classi di resistenza allo scivolamento Resistenza allo scivolamento o strisciamento Tipo e locazione superficie Classificazione > 40 Interna umida Classe I > 40 Interna asciutta Classe II > 55 Esterna umida Classe III Oppure in conformità a regolamentazioni nazionali. Va sottolineato che la EN prescrive i sopra elencati valori minimi, ma ai fini pratici nei casi reali valori inferiori a quelli indicati, ma con uno scarto irrisorio, non sono segno di sostanziali scostamenti del grado di scivolosità della superficie. 86
87 Proprietà antistatica, conducibilità elettrica Nel caso di sistemi resinosi antistatici la misurazione del valore di resistenza elettrica opposta dal rivestimento alla presa di terra, detta Resistance to Earth e indicata con Re, può essere rilevata anche in cantiere, a lavori ultimati, con apposita strumentazione che consenta rilievi in conformità a IEC I valori devono essere misurati tra la superficie del rivestimento, su cui verrà posizionato un elettrodo, alla presa di terra più vicina, cui verrà collegato il secondo cavetto. I risultati ottenuti devono riportare il valore in Ohm della Re e il voltaggio cui sono stati ottenuti, 10 V o 100 V Le problematiche relative alla valutazione della qualità estetica dei sistemi decorativi La valutazione dell aspetto di un rivestimento diviene importante nel caso di sistemi decorativi, dove il design è uno degli elementi essenziali della pavimentazione. L uso dei sistemi resinosi nell ambito delle pavimentazioni decorative nasce dall esigenza di architetti, progettisti, utilizzatori, committenti, di personalizzare ambienti come: abitazioni, hall di alberghi, uffici, negozi, centri commerciali, palestre, edifici pubblici, grandi magazzini ecc. La scelta e l uso dei sistemi resinosi consente una notevole libertà di progettazione e un ampia gamma di soluzioni. Non va dimenticato che i sistemi resinosi decorativi possono essere soggetti a traffico pedonale o di mezzi. Pertanto l aspetto estetico della superficie potrebbe subire sensibili modifiche derivanti dalla naturale e normale usura cui è sottoposta la pavimentazione. Questo fatto non costituisce un difetto del sistema resinoso (vedi par ). L applicazione di cere protettive o l adozione di adeguati sistemi di pulizia, atti spesso e rimuovere semplicemente la polvere o altre micro particelle che potrebbero avere effetto abrasivo sulla superficie del pavimento, aiutano a ridurre il degrado dell aspetto estetico. Tutte le altre problematiche sono riconducibili a quelle possibili dei sistemi resinosi. Spesso sono le stesse che si riscontrano nei sistemi multistrato, autolivellante, malta spatolata, e quindi eccessiva rugosità superficiale, presenza di spatolate troppo evidenti, scarso livellamento. 87
LINEE GUIDA per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI Rev. 02/2016
 per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI Rev. 02/2016 La Revisione 02 del documento è stata messa a punto dalla Sezione Resine CONPAVIPER.
per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI CONTINUI Rev. 02/2016 La Revisione 02 del documento è stata messa a punto dalla Sezione Resine CONPAVIPER.
Sistema 1a - Impregnazione semplice
 Sistema a - Impregnazione semplice Trattamento trasparente finalizzato ad ottenere una idrorepellente Scheda n.. della mediante carteggiatura o idrolavaggio. Dopo la carteggiatura eseguire un'accurata
Sistema a - Impregnazione semplice Trattamento trasparente finalizzato ad ottenere una idrorepellente Scheda n.. della mediante carteggiatura o idrolavaggio. Dopo la carteggiatura eseguire un'accurata
PAVIMENTI IN RESINA E CEMENTO
 PAVIMENTI IN RESINA E CEMENTO Pavimenti Industriali Pavimenti Autolivellanti Cementizi Pavimenti Industriali Verniciature RESIN SYSTEM ITALIA Resinsystem italia Srl è un azienda che si occupa di pavimentazioni
PAVIMENTI IN RESINA E CEMENTO Pavimenti Industriali Pavimenti Autolivellanti Cementizi Pavimenti Industriali Verniciature RESIN SYSTEM ITALIA Resinsystem italia Srl è un azienda che si occupa di pavimentazioni
MASSETTO EPOSSIDICO. cementizi tradizionali e pavimentazioni in ceramica.
 INDUSTRIA Rivestimento in resina epossidica di spessore compreso tra i 6 e i 15 mm ad alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli aggressivi chimici, impermeabile ad oli e vapori, resistente
INDUSTRIA Rivestimento in resina epossidica di spessore compreso tra i 6 e i 15 mm ad alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli aggressivi chimici, impermeabile ad oli e vapori, resistente
DUROGLASS CRETE Cod.
 Prodotto Cod. MALTA AD ALTA RESISTENZA PER AUTOLIVELLANTI E MULTISTRATO A BASE DI RESINE POLIURETANICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E LEGANTI IDRAULICI Caratteristiche Rapido indurimento. Ottime resistenze
Prodotto Cod. MALTA AD ALTA RESISTENZA PER AUTOLIVELLANTI E MULTISTRATO A BASE DI RESINE POLIURETANICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E LEGANTI IDRAULICI Caratteristiche Rapido indurimento. Ottime resistenze
tel/fax Ingegneria\Edilizia Davinson I Pavimenti in RESINA
 www.davinson.it info@davinson.it tel/fax 050 62.00.525 Ingegneria\Edilizia Davinson I Pavimenti in RESINA I PAVIMENTI IN RESINA Esistono numerose tipologie di pavimentazioni in resina, con caratteristiche,
www.davinson.it info@davinson.it tel/fax 050 62.00.525 Ingegneria\Edilizia Davinson I Pavimenti in RESINA I PAVIMENTI IN RESINA Esistono numerose tipologie di pavimentazioni in resina, con caratteristiche,
di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E RESINA
 D voci di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E D.1 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
D voci di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E D.1 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
APSELIV 30. resine APSELIV 30 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE FINO A 3 MM DI SPESSORE PER PAVIMENTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
 RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE FINO A 3 MM DI SPESSORE INDICATO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI RESISTENZA MEDIA ALL'AGGRESSIONE CHIMICA BUONA RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE
RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE FINO A 3 MM DI SPESSORE INDICATO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI RESISTENZA MEDIA ALL'AGGRESSIONE CHIMICA BUONA RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE
Epoxycover 150 IMPIEGHI. Rivestimento epossidico autolivellante trasparente
 Epoxycover 150 Rivestimento epossidico autolivellante trasparente è un rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, indurente cicloalifatico ed additivi per la finitura trasparente a spessore
Epoxycover 150 Rivestimento epossidico autolivellante trasparente è un rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, indurente cicloalifatico ed additivi per la finitura trasparente a spessore
UCRETE UD C
 UCRETE UD200 Pavimentazione in poliuretano-cemento per uso industriale, di tipo continuo, da 6 a 12 mm di spessore, resistente ad attacchi chimici severi e impatti sino a 150 C Definizione del materiale
UCRETE UD200 Pavimentazione in poliuretano-cemento per uso industriale, di tipo continuo, da 6 a 12 mm di spessore, resistente ad attacchi chimici severi e impatti sino a 150 C Definizione del materiale
MEMBRAPOL PRIMER 900 RAPIDO
 RIVESTIMENTO EPOSSI-CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI ANCHE UMIDI. DESCRIZIONE PRODOTTO è un rivestimento epossi-cementizio, a basso spessore, tixotropico, appositamente formulato
RIVESTIMENTO EPOSSI-CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI ANCHE UMIDI. DESCRIZIONE PRODOTTO è un rivestimento epossi-cementizio, a basso spessore, tixotropico, appositamente formulato
LINEE GUIDA prima edizione
 LINEE GUIDA prima edizione Ottobre 2014 LINEE GUIDA per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI Cap. 1 SCOPO E CONTENUTI Lo scopo principale di queste
LINEE GUIDA prima edizione Ottobre 2014 LINEE GUIDA per la PRESCRIZIONE, POSA, CONTROLLI, VERIFICA FINALE e MANUTENZIONE dei RIVESTIMENTI RESINOSI Cap. 1 SCOPO E CONTENUTI Lo scopo principale di queste
di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E RESINA
 D voci di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E D.1 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
D voci di capitolato di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CEMENTO E D.1 REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
OVER-EX. Caratteristiche del prodotto. A base di acril-isocianato (poliuretano).
 Finitura poliuretanica bicomponente all acqua, trasparente protettiva, per interni ed esterni. Idonea sia per la protezione di supporti in muratura verniciata che come protezione per pavimentazioni, idonea
Finitura poliuretanica bicomponente all acqua, trasparente protettiva, per interni ed esterni. Idonea sia per la protezione di supporti in muratura verniciata che come protezione per pavimentazioni, idonea
Ciclo di rivestimento protettivo elastico per pavimenti in calcestruzzo RIVESTIMENTO PROTETTIVO AUTOLIVELLANTE RESISTENZA FISICA
 Ciclo di rivestimento protettivo elastico per pavimenti in calcestruzzo Tecnopav EPU FLEX-1 Ral (vedi cartella colori) RIVESTIMENTO PROTETTIVO AUTOLIVELLANTE RESISTENZA FISICA CYCLE approved Certificato
Ciclo di rivestimento protettivo elastico per pavimenti in calcestruzzo Tecnopav EPU FLEX-1 Ral (vedi cartella colori) RIVESTIMENTO PROTETTIVO AUTOLIVELLANTE RESISTENZA FISICA CYCLE approved Certificato
Betongrip IMPIEGHI. Primer epossidico bicomponente per riprese di getto
 Betongrip Primer epossidico bicomponente per riprese di getto BETONGRIP è un primer bicomponente epossidico esente da solventi, adatto come mano di ancoraggio per malte cementizie e ponte d adesione per
Betongrip Primer epossidico bicomponente per riprese di getto BETONGRIP è un primer bicomponente epossidico esente da solventi, adatto come mano di ancoraggio per malte cementizie e ponte d adesione per
Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento
 Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Gennaio 2017 I sistemi radianti a pavimento possono essere suddivisi in due categorie:
Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento Ing. Clara Peretti Segretario Generale Consorzio Q-RAD Gennaio 2017 I sistemi radianti a pavimento possono essere suddivisi in due categorie:
SILFLEX P. Caratteristiche tecniche. Campi di applicazione. Sigillante poliuretanico per giunti di dilatazione.
 Sigillante poliuretanico per giunti di dilatazione. Caratteristiche tecniche è un sigillante poliuretanico bicomponente autolivellante e facilmente colabile con ottime caratteristiche di elasticità. Da
Sigillante poliuretanico per giunti di dilatazione. Caratteristiche tecniche è un sigillante poliuretanico bicomponente autolivellante e facilmente colabile con ottime caratteristiche di elasticità. Da
INDIVIDUAL CREATION. No limit...
 DRAGO F.LLI SRL VIA YURI GAGARIN 6/A 42123 REGGIO EMILIA TEL 0522 327660 / FAX 0522 327552 P.IVA 002240803 www.creativewall.it info@creativewall.it www.facebook.com/individualcreation No limit... Rivestimenti
DRAGO F.LLI SRL VIA YURI GAGARIN 6/A 42123 REGGIO EMILIA TEL 0522 327660 / FAX 0522 327552 P.IVA 002240803 www.creativewall.it info@creativewall.it www.facebook.com/individualcreation No limit... Rivestimenti
Epofix 300 R IMPIEGHI. Primer epossidico bicomponente
 Epofix 300 R Primer epossidico bicomponente EPOFIX 300 R è un primer bicomponente epossidico esente da solventi. EPOFIX 300 R si applica a rullo o pennello su tutte le superfici assorbenti e non assorbenti.
Epofix 300 R Primer epossidico bicomponente EPOFIX 300 R è un primer bicomponente epossidico esente da solventi. EPOFIX 300 R si applica a rullo o pennello su tutte le superfici assorbenti e non assorbenti.
Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento
 Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento Gennaio 2017 Ing. Clara Peretti Libera professionista, Segretario Generale Consorzio Q RAD I sistemi radianti a pavimento possono essere suddivisi
Lo spessore dei massetti per i sistemi radianti a pavimento Gennaio 2017 Ing. Clara Peretti Libera professionista, Segretario Generale Consorzio Q RAD I sistemi radianti a pavimento possono essere suddivisi
EXTREMA TRASPARENTE. Caratteristiche del prodotto. A base di resine epossidiche e addotto poliammidico. Peso specifico medio Componente A 1,10 Kg/l;
 EXTREMA TRASPARENTE Fondo/finitura trasparente, epossidico, bicomponente, all acqua, per interni, esente da solventi, a basso spessore, per pavimenti in cemento con leggero traffico gommato e pareti. è
EXTREMA TRASPARENTE Fondo/finitura trasparente, epossidico, bicomponente, all acqua, per interni, esente da solventi, a basso spessore, per pavimenti in cemento con leggero traffico gommato e pareti. è
pavimentazioni sine materiali protettivi milano
 www.mpmsrl.com pavimentazioni re sine materiali protettivi milano Tradizione, esperienza, innovazione tecnologica. mpm - Materiali Protettivi Milano - s.r.l. è un azienda italiana, presente sul mercato
www.mpmsrl.com pavimentazioni re sine materiali protettivi milano Tradizione, esperienza, innovazione tecnologica. mpm - Materiali Protettivi Milano - s.r.l. è un azienda italiana, presente sul mercato
Primer per supporti umidi Blocca Umidità
 BARRIER EP 117 Primer per supporti umidi Blocca Umidità BARRIER EP 117 è un primer per superfici umide formato da: Componente A: miscela di prepolimeri epossidici a base acqua, cariche e additivi; DESCRIZIONE
BARRIER EP 117 Primer per supporti umidi Blocca Umidità BARRIER EP 117 è un primer per superfici umide formato da: Componente A: miscela di prepolimeri epossidici a base acqua, cariche e additivi; DESCRIZIONE
sistema applicativo Spatolato Outdoor Rivestimento in resina per esterno
 sistema applicativo 04.16 Spatolato Outdoor Rivestimento in resina per esterno Allarga i tuoi orizzonti. Spatolato Outdoor, il sistema ErreLAB che conquista nuove aree da dedicare alle superfici in resina.
sistema applicativo 04.16 Spatolato Outdoor Rivestimento in resina per esterno Allarga i tuoi orizzonti. Spatolato Outdoor, il sistema ErreLAB che conquista nuove aree da dedicare alle superfici in resina.
MASSETTO RIVESTIMENTO A MASSETTO CON FINITURA EPOSSIDICA
 CICLO - MAS 01 01/06/2015 MASSETTO RIVESTIMENTO A MASSETTO CON FINITURA EPOSSIDICA Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: pallinatura o fresatura. Su pavimenti in cemento vecchi, ammalorati
CICLO - MAS 01 01/06/2015 MASSETTO RIVESTIMENTO A MASSETTO CON FINITURA EPOSSIDICA Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: pallinatura o fresatura. Su pavimenti in cemento vecchi, ammalorati
I MATERIALI PER FUGHE
 IL POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Modulo Teorico N. 3 - Corso di Base Rev. 01 del 10/01/2012 I MATERIALI PER FUGHE A cura di: Centro Ceramico Bologna Consorzio Universitario
IL POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Modulo Teorico N. 3 - Corso di Base Rev. 01 del 10/01/2012 I MATERIALI PER FUGHE A cura di: Centro Ceramico Bologna Consorzio Universitario
Caratteristiche un estrema reattività aderisce in modo monolitico un elevatissima resistenza gli urti; all irraggiamento UV risponde UNI EN 1504/2
 CONIROOF 2110 Sistema impermeabilizzante ad alte prestazioni, di tipo continuo, specifico per coperture pedonali, basato su una membrana poliuretanica ad indurimento istantaneo applicata a spruzzo Definizione
CONIROOF 2110 Sistema impermeabilizzante ad alte prestazioni, di tipo continuo, specifico per coperture pedonali, basato su una membrana poliuretanica ad indurimento istantaneo applicata a spruzzo Definizione
WOOD MAT H 2 O SCHEDA TECNICA
 Descrizione prodotto Finitura poliuretanica a base acquosa, bicomponente, trasparente satinata non ingiallente. Elevata resistenza all'ambiente marino. Particolarmente indicata per il trattamento di paratie,
Descrizione prodotto Finitura poliuretanica a base acquosa, bicomponente, trasparente satinata non ingiallente. Elevata resistenza all'ambiente marino. Particolarmente indicata per il trattamento di paratie,
Trasparente (tendente all ingiallimento) A base di resine epossidiche e addotto poliammidico. Peso specifico medio Componente A 1,10 Kg/l; In volume
 EXTREMA TRASPARENTE Fondo/finitura trasparente all acqua, a base epossidica, bicomponente, per interni, esente da solventi, a basso spessore, per pavimenti in cemento e pareti. presenta un ottima resistenza
EXTREMA TRASPARENTE Fondo/finitura trasparente all acqua, a base epossidica, bicomponente, per interni, esente da solventi, a basso spessore, per pavimenti in cemento e pareti. presenta un ottima resistenza
Mapetherm AR1 Light DALLA LEGGEREZZA SUPERIORE E DALLE PRESTAZIONI SORPRENDENTI PER UN ISOLAMENTO TERMICO MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ALLEGGERITA
 Mapetherm AR1 Light MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ALLEGGERITA PER UN ISOLAMENTO TERMICO DALLA LEGGEREZZA SUPERIORE E DALLE PRESTAZIONI SORPRENDENTI LEGGERO Mapetherm AR1 Light Malta cementizia monocomponente
Mapetherm AR1 Light MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ALLEGGERITA PER UN ISOLAMENTO TERMICO DALLA LEGGEREZZA SUPERIORE E DALLE PRESTAZIONI SORPRENDENTI LEGGERO Mapetherm AR1 Light Malta cementizia monocomponente
Manuale d uso TECSIT PRO
 Manuale d uso TECSIT PRO PRODOTTI CHIMICI PER L EDILIZIA Manuale d Uso - TECSIT PRO Tecsit Pro è un prodotto monocomponente pronto all uso dopo omogeneizzazione a mezzo trapano a bassi giri. PREPARAZIONE
Manuale d uso TECSIT PRO PRODOTTI CHIMICI PER L EDILIZIA Manuale d Uso - TECSIT PRO Tecsit Pro è un prodotto monocomponente pronto all uso dopo omogeneizzazione a mezzo trapano a bassi giri. PREPARAZIONE
LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA. cls normale
 1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
Prof. Ing. Luigi Coppola. L. Coppola Cum Solidare Introduzione al restauro delle strutture in calcestruzzo
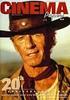 INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
Sistemi Epossidici Avanzati. Rendono il tuo pavimento un pezzo d'arte unico!
 Sistemi Epossidici Avanzati Rendono il tuo pavimento un pezzo d'arte unico! INDICE: Floor Expert EP 101...08 Floor Expert EP 1013...09 Floor Expert EP 310W... 10 Floor Expert EP 311...11 Floor Expert EP
Sistemi Epossidici Avanzati Rendono il tuo pavimento un pezzo d'arte unico! INDICE: Floor Expert EP 101...08 Floor Expert EP 1013...09 Floor Expert EP 310W... 10 Floor Expert EP 311...11 Floor Expert EP
POLISEAL AL. POLISEAL AL resine SRL SISTEMA AUTOLIVELLANTE ELASTICO REALIZZATO CON RESINE POLIURETANICHE 1/5 SCHEDA TECNICA N REV.
 DESCRIZIONE formulato poliuretanico bicomponente (A+B), fluido, colorato ed esente da solventi. I componenti sono forniti predosati, e' possibile aggiungere la parte C. CAMPI DI IMPIEGO Pavimentazioni
DESCRIZIONE formulato poliuretanico bicomponente (A+B), fluido, colorato ed esente da solventi. I componenti sono forniti predosati, e' possibile aggiungere la parte C. CAMPI DI IMPIEGO Pavimentazioni
SCHEDA TECNICA PIASTRE CON GRANULO PFU
 SCHEDA TECNICA PIASTRE CON GRANULO PFU TIPO DI PIASTRA: ottenuta con granuli di gomma ricavati da pneumatici usurati, compattati a caldo e sotto pressione mediante utilizzo di legante e pigmentati. PRODOTTI
SCHEDA TECNICA PIASTRE CON GRANULO PFU TIPO DI PIASTRA: ottenuta con granuli di gomma ricavati da pneumatici usurati, compattati a caldo e sotto pressione mediante utilizzo di legante e pigmentati. PRODOTTI
EPOPRIMER BT 50. Scheda Tecnica
 Rev. A EPOPRIMER BT 50 Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni e avvertenze DESCRIZIONE Sistema epossi-poliammidico
Rev. A EPOPRIMER BT 50 Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni e avvertenze DESCRIZIONE Sistema epossi-poliammidico
LE SCHEDE TECNICHE CICLO ELASTOMERICO CICLO ELASTOMERICO. Caratteristiche principali. Preparazione del supporto
 E un ciclo elastico costituito da un fondo a base di specifici polimeri elastomerici ed un intonachino elastomerico a base acril-silossanica da utilizzare come finitura colorata in mano unica su supporti
E un ciclo elastico costituito da un fondo a base di specifici polimeri elastomerici ed un intonachino elastomerico a base acril-silossanica da utilizzare come finitura colorata in mano unica su supporti
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008
 page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
EPOXIDIM Smalto epossidico bicomponente a solvente
 Smalto epossidico bicomponente a solvente Descrizione Smalto epossidico a solvente bicomponente con un elevata resistenza all usura. Ideale per pavimenti con leggero traffico gommato. Composizione Impieghi
Smalto epossidico bicomponente a solvente Descrizione Smalto epossidico a solvente bicomponente con un elevata resistenza all usura. Ideale per pavimenti con leggero traffico gommato. Composizione Impieghi
VIVAPIU FONDO UNIFORMANTE
 VIVAPIU FONDO UNIFORMANTE Fondo riempitivo minerale a base di grassello di calce per il trattamento preliminare di supporti esterni poco assorbenti (intonaci compatti, pitture sintetiche, ecc.), e con
VIVAPIU FONDO UNIFORMANTE Fondo riempitivo minerale a base di grassello di calce per il trattamento preliminare di supporti esterni poco assorbenti (intonaci compatti, pitture sintetiche, ecc.), e con
FIBRODUR SCHEDA TECNICA
 Descrizione prodotto Primer turapori poliuretanico bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità. Da impiegare principalmente su legno
Descrizione prodotto Primer turapori poliuretanico bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità. Da impiegare principalmente su legno
Purtop System Deck. Il sistema PURTOP SYSTEM DECK si articola quindi nei seguenti sottosistemi: 1. CALCESTRUZZO
 Purtop System Deck SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE POLIUREICO IBRIDO O A BASE DI POLIUREA PURA A SPRUZZO PER COPERTURE CARRABILI, IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI PRODOTTI DA UTILIZZARE: Purtop 400 M - Purtop
Purtop System Deck SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE POLIUREICO IBRIDO O A BASE DI POLIUREA PURA A SPRUZZO PER COPERTURE CARRABILI, IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI PRODOTTI DA UTILIZZARE: Purtop 400 M - Purtop
CARATTERISTICHE TECNICHE
 11 AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato. Anisotropo. Utilizzo Civile ed industriale. Caratteristiche Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato,
11 AQUAFIRE Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato. Anisotropo. Utilizzo Civile ed industriale. Caratteristiche Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato,
RAPPORTO DI PROVA N
 Il presente rapporto di prova consta di: 9 pagine Data di emissione: 20/07/15 Cliente: Heres srl Vicolo Mattei 10 31055 Quinto di Treviso (TV) Luogo di svolgimento della prova: Vicenza Via dei Montecchi
Il presente rapporto di prova consta di: 9 pagine Data di emissione: 20/07/15 Cliente: Heres srl Vicolo Mattei 10 31055 Quinto di Treviso (TV) Luogo di svolgimento della prova: Vicenza Via dei Montecchi
SISTEMA DRACOFLOOR MD
 SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA A SPESS OTTIMA RESISTENZA chimico-fisica e AL traffico elevato DRACOFLOOR MD è un sistema epossidico a spessore per la realizzazione
SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA A SPESS OTTIMA RESISTENZA chimico-fisica e AL traffico elevato DRACOFLOOR MD è un sistema epossidico a spessore per la realizzazione
RESIN FLOOR. PARchEggI
 TM RESIN FLOOR PARchEggI RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune l utilizzo della resina. Il nostro
TM RESIN FLOOR PARchEggI RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune l utilizzo della resina. Il nostro
applicare applicare 2 mani
 applicare 2 mani LA SOLUZIONE FACILE E SICURA PER IL FAI DA TE J-38 Garage paint è uno smalto per pavimenti a forte traffico. Dotato di ottima durezza e resistenza, trova impiego in luoghi commerciali,
applicare 2 mani LA SOLUZIONE FACILE E SICURA PER IL FAI DA TE J-38 Garage paint è uno smalto per pavimenti a forte traffico. Dotato di ottima durezza e resistenza, trova impiego in luoghi commerciali,
rivestimenti per PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE
 rivestimenti per PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE Univer è una società del gruppo multinazionale PPG, leader mondiale nella produzione di prodotti vernicianti. rivestimenti per PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE pavimenti
rivestimenti per PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE Univer è una società del gruppo multinazionale PPG, leader mondiale nella produzione di prodotti vernicianti. rivestimenti per PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE pavimenti
RESIN FLOOR INDUSTRIA
 TM RESIN FLOOR INDUSTRIA RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune l utilizzo della resina. Il nostro
TM RESIN FLOOR INDUSTRIA RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune l utilizzo della resina. Il nostro
BUILDING LISTINO APRILE
 BUILDING LISTINO APRILE 207 Fondata nel 92 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un azienda
BUILDING LISTINO APRILE 207 Fondata nel 92 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un azienda
EPACRETE OLV MON
 EPACRETE OLV 13.30 MON Primer poliuretanico con solventi a bassa viscosità PRODOTTO EPACRETE OLV 13.30 MONOCOMPONENTE è un primer poliuretanico monocomponente contenente solvente. DESCRIZIONE EPACRETE
EPACRETE OLV 13.30 MON Primer poliuretanico con solventi a bassa viscosità PRODOTTO EPACRETE OLV 13.30 MONOCOMPONENTE è un primer poliuretanico monocomponente contenente solvente. DESCRIZIONE EPACRETE
Sistema Bi-Flex COPRIGIUNTI E PROFILI PER GIUNTI. Il prodotto. Dove si impiega SCHEDA TECNICA 56 EY-EW S /13
 Sistema Bi-Flex Per giunti elastici impermeabili Il prodotto è una combinazione di elementi impermeabili per il trattamento dei giunti e delle fessure composto da un NASTRO ELASTICO a base di polimeri
Sistema Bi-Flex Per giunti elastici impermeabili Il prodotto è una combinazione di elementi impermeabili per il trattamento dei giunti e delle fessure composto da un NASTRO ELASTICO a base di polimeri
ARDESIA SISTEMA. BUILDING TECHNOLOGIES COMPOSIZIONE DEL SISTEMA
 SISTEMA REV.04/APR.2014 Euwork Ardesia è un sistema di rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di speciali resine. Per facilità di posa, buona elasticità, eccellente resistenza meccanica
SISTEMA REV.04/APR.2014 Euwork Ardesia è un sistema di rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di speciali resine. Per facilità di posa, buona elasticità, eccellente resistenza meccanica
4224 RAPID LUX 2900 BRILLANTE
 NOME CONVERTER R12 DESTINAZIONE Finitura protettiva e decoratica per diversi tipi di superfici metalliche purchè adeguatamente preparate. Idoneo all esposizione agli agenti atmosferici in ambienti industriali
NOME CONVERTER R12 DESTINAZIONE Finitura protettiva e decoratica per diversi tipi di superfici metalliche purchè adeguatamente preparate. Idoneo all esposizione agli agenti atmosferici in ambienti industriali
Super Mix 10 IMPIEGHI. Adesivo Cementizio C2T conforme alla norma EN 12004
 Super Mix 10 Adesivo Cementizio C2T conforme alla norma EN 12004 SUPER MIX 10 è un adesivo cementizio migliorato e con scivolamento limitato, contenente sabbie silicee selezionate, speciali resine ed additivi
Super Mix 10 Adesivo Cementizio C2T conforme alla norma EN 12004 SUPER MIX 10 è un adesivo cementizio migliorato e con scivolamento limitato, contenente sabbie silicee selezionate, speciali resine ed additivi
WOOD GLOSS SCHEDA TECNICA
 Descrizione prodotto Vernice trasparente poliuretanica bicomponente brillante. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Esalta
Descrizione prodotto Vernice trasparente poliuretanica bicomponente brillante. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Esalta
Planitop Rasa & Ripara
 Planitop Rasa & Ripara MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R2 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO C.P. MK690910 (I) 10/14 solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo
Planitop Rasa & Ripara MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R2 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO C.P. MK690910 (I) 10/14 solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo
GLI ADESIVI IL POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE. Modulo Teorico N. 2 - Corso di Base Rev.
 IL POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Modulo Teorico N. 2 - Corso di Base Rev. 01 del 10/01/2012 GLI ADESIVI A cura di: Centro Ceramico Bologna Consorzio Universitario Centro
IL POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE Modulo Teorico N. 2 - Corso di Base Rev. 01 del 10/01/2012 GLI ADESIVI A cura di: Centro Ceramico Bologna Consorzio Universitario Centro
RISANAMENTO DI FACCIATE AMMALORATE E CAVILLATE ANTIRISS ORGANICO
 WALER Srl Via Leonardo da Vinci 5 20020 Solaro (MI) Italy P.IVA 00698220969 Tel. 02/969.0167 Fax 02/967.99.251 www.waler.it waler@waler.it Cap.Soc. 100.000,00 i.v. R.E.A. n.820452 Reg.Imp. e C.F. 00864560156
WALER Srl Via Leonardo da Vinci 5 20020 Solaro (MI) Italy P.IVA 00698220969 Tel. 02/969.0167 Fax 02/967.99.251 www.waler.it waler@waler.it Cap.Soc. 100.000,00 i.v. R.E.A. n.820452 Reg.Imp. e C.F. 00864560156
A base di resine epossidiche e addotto poliamminico, speciali cariche e additivi che ne facilitano l applicazione e ne aumentano la durezza.
 EVOQUE Smalto epossidico bicomponente ad acqua Descrizione Composizione Peso specifico medio Resa Smalto epossidico all acqua bicomponente, con un bassissimo contenuto di solventi. Il prodotto può essere
EVOQUE Smalto epossidico bicomponente ad acqua Descrizione Composizione Peso specifico medio Resa Smalto epossidico all acqua bicomponente, con un bassissimo contenuto di solventi. Il prodotto può essere
iglidur H4: Lo standard per l industria automobilistica
 iglidur : Lo standard per l industria automobilistica Produzione standard a magazzino Bassi coefficienti di attrito Buona resistenza all abrasione Temperature operative da 40 C a +200 C Ottima resistenza
iglidur : Lo standard per l industria automobilistica Produzione standard a magazzino Bassi coefficienti di attrito Buona resistenza all abrasione Temperature operative da 40 C a +200 C Ottima resistenza
SISTEMA DRACOFLOOR LD
 SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI Sistema di pavimentazione resinosa a film sottile Buona resistenza chimicofisica e al traffico DRACOFLOOR LD è un sistema resinoso a film sottile per la realizzazione
SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI Sistema di pavimentazione resinosa a film sottile Buona resistenza chimicofisica e al traffico DRACOFLOOR LD è un sistema resinoso a film sottile per la realizzazione
T F
 Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Coatings Via Pascoli 11 28040 Dormelletto (No) T + 39 0322 401611 F + 39 0322 401607 Versione aprile 2011 ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER Fondo incolore di aspetto satinato,
Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Coatings Via Pascoli 11 28040 Dormelletto (No) T + 39 0322 401611 F + 39 0322 401607 Versione aprile 2011 ALPHA ANTI-GRAFFITI PRIMER Fondo incolore di aspetto satinato,
Le pavimentazioni epossidiche MASTERTOP 1200
 Le pavimentazioni epossidiche MASTERTOP 1200 Le pavimentazioni epossidiche ad alte prestazioni del sistema Mastertop 1200 Indice: 1. Introduzione 2. Campi di applicazione 3. Le pavimentazioni in resina
Le pavimentazioni epossidiche MASTERTOP 1200 Le pavimentazioni epossidiche ad alte prestazioni del sistema Mastertop 1200 Indice: 1. Introduzione 2. Campi di applicazione 3. Le pavimentazioni in resina
Purtop System Deck. Il sistema PURTOP SYSTEM DECK si articola quindi nei seguenti sottosistemi: 1. CALCESTRUZZO
 Purtop System Deck SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE POLIUREICO IBRIDO O A BASE DI POLIUREA PURA A SPRUZZO PER COPERTURE CARRABILI, IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI PRODOTTI DA UTILIZZARE: Purtop 400 M - Purtop
Purtop System Deck SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE POLIUREICO IBRIDO O A BASE DI POLIUREA PURA A SPRUZZO PER COPERTURE CARRABILI, IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI PRODOTTI DA UTILIZZARE: Purtop 400 M - Purtop
Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi
 2 FASCIATURA CON TESSUTI UNIDIREZIONALI E QUADRIASSIALI IN FIBRA DI CARBONIO: NODI TRAVE PILASTRO IN C.A. INDICE ANALITICO DELLE OPERE a) Preparazione del supporto comprese eventuali iniezioni consolidanti
2 FASCIATURA CON TESSUTI UNIDIREZIONALI E QUADRIASSIALI IN FIBRA DI CARBONIO: NODI TRAVE PILASTRO IN C.A. INDICE ANALITICO DELLE OPERE a) Preparazione del supporto comprese eventuali iniezioni consolidanti
sistema applicativo 09.15
 sistema applicativo 09.15 CEMENTO MADRE Cemento Madre è il nuovo rivestimento ErreLAB per pavimenti e pareti. Un materiale naturale, versatile e ricercato, che consente di creare superfici continue di
sistema applicativo 09.15 CEMENTO MADRE Cemento Madre è il nuovo rivestimento ErreLAB per pavimenti e pareti. Un materiale naturale, versatile e ricercato, che consente di creare superfici continue di
4752 CLASSIC PRIMER FONDO. Primer alchidico monocomponente base solvente. Presenta modifica fenolica ed essica rapidamente all aria.
 NOME CONVERTER - DESTINAZIONE Primer Utilizzabile su strutture metalliche di varia foggia ed uso finale. Garantisce una buona verticabilità anche sugli spigoli. Sovraverniciabile con finiture rapida essiccazione,
NOME CONVERTER - DESTINAZIONE Primer Utilizzabile su strutture metalliche di varia foggia ed uso finale. Garantisce una buona verticabilità anche sugli spigoli. Sovraverniciabile con finiture rapida essiccazione,
STARFLEX HR cod M100 / M
 Prodotto cod. 6200 M100 / M300 9200 0000 SISTEMA POLIUREICO AD ALTE PRESTAZIONI APPLICABILE ALLO STATO FLUIDO A BASE DI PREPOLIMERI ISOCIANICI E MISCELA DI PARTICOLARI POLIAMMINE MODIFICATE, ESENTE DA
Prodotto cod. 6200 M100 / M300 9200 0000 SISTEMA POLIUREICO AD ALTE PRESTAZIONI APPLICABILE ALLO STATO FLUIDO A BASE DI PREPOLIMERI ISOCIANICI E MISCELA DI PARTICOLARI POLIAMMINE MODIFICATE, ESENTE DA
POSA DEI RIVESTIMENTI IN PIETRA RICOSTRUITA
 68 POSA DEI RIVESTIMENTI IN PIETRA RICOSTRUITA 69 INTRODUZIONE Le pietre ricostruite sono un materiale innovativo, leggero ed ecologico: dato il loro modesto peso non appesantiscono le strutture; inoltre
68 POSA DEI RIVESTIMENTI IN PIETRA RICOSTRUITA 69 INTRODUZIONE Le pietre ricostruite sono un materiale innovativo, leggero ed ecologico: dato il loro modesto peso non appesantiscono le strutture; inoltre
Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi
 3 FASCIATURA CON TESSUTI UNIDIREZIONALI E QUADRIASSIALI IN FIBRA DI CARBONIO: NODI TRAVE PILASTRO IN C.A. INDICE ANALITICO DELLE OPERE a) Preparazione del supporto comprese eventuali iniezioni consolidanti
3 FASCIATURA CON TESSUTI UNIDIREZIONALI E QUADRIASSIALI IN FIBRA DI CARBONIO: NODI TRAVE PILASTRO IN C.A. INDICE ANALITICO DELLE OPERE a) Preparazione del supporto comprese eventuali iniezioni consolidanti
SUPER QUARZO SIGILLO ORO PUTZ
 Rivestimento a effetto rustico granulato elastomerico, idoneo su sistemi d isolamento termico a cappotto, su supporti nuovi o vecchi, cavillati e in fase di assestamento o sottoposti a vibrazioni e sbalzi
Rivestimento a effetto rustico granulato elastomerico, idoneo su sistemi d isolamento termico a cappotto, su supporti nuovi o vecchi, cavillati e in fase di assestamento o sottoposti a vibrazioni e sbalzi
Spolveri per pavimentazioni industriali
 Spolveri per pavimentazioni industriali Lo strato antiusura ad alte prestazioni per i pavimenti industriali in c.a Indice: 1. Introduzione 2. Gli spolveri e le normative europee 3. Lo spolvero di quarzo
Spolveri per pavimentazioni industriali Lo strato antiusura ad alte prestazioni per i pavimenti industriali in c.a Indice: 1. Introduzione 2. Gli spolveri e le normative europee 3. Lo spolvero di quarzo
1113 NITRO PRIMER FONDO. Antiruggine nitro universale rapida essiccazione A SOLVENTE SCHEDA TECNICA NOME CONVERTER
 NOME CONVERTER DESTINAZIONE Antiruggine nitro universale con ottima adesione su supporti ferrosi. PROPRIETA' Rapidità di essiccazione Buone proprietà anticorrosive Buon potere coprente Ottima adesione
NOME CONVERTER DESTINAZIONE Antiruggine nitro universale con ottima adesione su supporti ferrosi. PROPRIETA' Rapidità di essiccazione Buone proprietà anticorrosive Buon potere coprente Ottima adesione
Sistema di isolamento elettrico Vernice di impregnazione
 Sistema di isolamento elettrico Vernice di impregnazione Vernice Universale ad aria ottime resistenze agli agenti chimici, all umidità e all acqua, tropicalizzante e antitraccia. Consigliato per applicazione
Sistema di isolamento elettrico Vernice di impregnazione Vernice Universale ad aria ottime resistenze agli agenti chimici, all umidità e all acqua, tropicalizzante e antitraccia. Consigliato per applicazione
Professional Grade Epoxy Coating
 R Professional Grade Epoxy Coating MILAN MIAMI LONDON MILAN MIAMI LONDON AZIENDA Seventy Srl è uno tra i più stimati e storici produttori ed installatori di soluzioni resinose epossidiche in campo internazionale!
R Professional Grade Epoxy Coating MILAN MIAMI LONDON MILAN MIAMI LONDON AZIENDA Seventy Srl è uno tra i più stimati e storici produttori ed installatori di soluzioni resinose epossidiche in campo internazionale!
ardelast grana fine finitura elastomerica acrilsilossanica antialga ad effetto intonaco fine
 SERIE 0.568. ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti SCHEDA TECNICA N 104 ardelast grana fine finitura elastomerica acrilsilossanica antialga ad effetto intonaco fine CARATTERISTICHE ARDELAST
SERIE 0.568. ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti SCHEDA TECNICA N 104 ardelast grana fine finitura elastomerica acrilsilossanica antialga ad effetto intonaco fine CARATTERISTICHE ARDELAST
Capitolato PANDOMO Floor / FloorPlus PANDOMO K1 (bianco) e PANDOMO K3 10/3.1 (grigio) Autolivellante decorativo
 Capitolato PANDOMO Floor / FloorPlus PANDOMO K1 (bianco) e PANDOMO K3 10/3.1 (grigio) Autolivellante decorativo trattamento di superficie con PANDOMO SP-CEE (emulsione poliuretanica bicomponente a base
Capitolato PANDOMO Floor / FloorPlus PANDOMO K1 (bianco) e PANDOMO K3 10/3.1 (grigio) Autolivellante decorativo trattamento di superficie con PANDOMO SP-CEE (emulsione poliuretanica bicomponente a base
EPACRETE EPAPOX 22. Primer epossidico esente da solventi PRODOTTO
 EPACRETE EPAPOX 22 Primer epossidico esente da solventi PRODOTTO EPACRETE EPAPOX 22 è un sistema epossidico bicomponente caricato promotore di adesione e di consolidamento, a base di resine epossidiche
EPACRETE EPAPOX 22 Primer epossidico esente da solventi PRODOTTO EPACRETE EPAPOX 22 è un sistema epossidico bicomponente caricato promotore di adesione e di consolidamento, a base di resine epossidiche
Sistema Bi-Flex PROFILI PER GIUNTI ED ACCESSORI. Il prodotto COPRIGIUNTI, Dove si impiega SCHEDA TECNICA 56 EY-EW S W 08/15
 Sistema Bi-Flex Il prodotto è una combinazione di elementi impermeabili per il trattamento dei giunti e delle fessure composto da un NASTRO ELASTICO a base di polimeri elastomerici TPE e da un ADESIVO
Sistema Bi-Flex Il prodotto è una combinazione di elementi impermeabili per il trattamento dei giunti e delle fessure composto da un NASTRO ELASTICO a base di polimeri elastomerici TPE e da un ADESIVO
SCHEDA TECNICA. KLABER RAX 200 Rasante cementizio extra fine
 KLABER RAX 200 Rasante cementizio extra fine SCHEDA TECNICA Utilizzo KLABER RAX 200: rasante premiscelato ad elevata adesione, di colore bianco o grigio, base cemento Portland, inerti selezionati ed additivi
KLABER RAX 200 Rasante cementizio extra fine SCHEDA TECNICA Utilizzo KLABER RAX 200: rasante premiscelato ad elevata adesione, di colore bianco o grigio, base cemento Portland, inerti selezionati ed additivi
POLIWOOD. Scheda Tecnica
 Rev. A POLIWOOD Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni e avvertenze DESCRIZIONE Smalto poliuretanico
Rev. A POLIWOOD Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni e avvertenze DESCRIZIONE Smalto poliuretanico
Mapefloor I 500 W. Formulato epossidico bicomponente idrodisperso, multiuso e permeabile al vapore, per pavimentazioni industriali, di colore neutro
 SR RESINE SINTETICHE B2,0 AR0,5-IR20-Bfl-s1 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA Mapefloor I 500 W EN 13813 Formulato epossidico bicomponente idrodisperso, multiuso e permeabile al vapore, per pavimentazioni industriali,
SR RESINE SINTETICHE B2,0 AR0,5-IR20-Bfl-s1 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA Mapefloor I 500 W EN 13813 Formulato epossidico bicomponente idrodisperso, multiuso e permeabile al vapore, per pavimentazioni industriali,
Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi
 2251 Analisi E.21.10.05.a Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2 livello - ora 0,020000 23,76 0,48 28,40 livello - ora 0,040000
2251 Analisi E.21.10.05.a Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2 livello - ora 0,020000 23,76 0,48 28,40 livello - ora 0,040000
iglidur H2: Soluzione economica per le alte temperature
 iglidur : Soluzione economica per le alte temperature Per applicazioni immerse Soluzione economica Ottima resistenza agli agenti chimici Idoneo a lavorare ad alte temperature 335 iglidur Soluzione economica
iglidur : Soluzione economica per le alte temperature Per applicazioni immerse Soluzione economica Ottima resistenza agli agenti chimici Idoneo a lavorare ad alte temperature 335 iglidur Soluzione economica
12 mesi (teme il gelo)
 decorativa naturale materica all acqua a base di grassello di calce a lunga stagionatura. Prestigio è applicabile in 4 effetti: marmorino, travertino, cemento o pietra viva. Prestigio consente la massima
decorativa naturale materica all acqua a base di grassello di calce a lunga stagionatura. Prestigio è applicabile in 4 effetti: marmorino, travertino, cemento o pietra viva. Prestigio consente la massima
IMPIEGHI. Rasante adesivo fibrato per sistemi termici a cappotto
 Rasante adesivo fibrato per sistemi termici a cappotto è un rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati ed additivi speciali. è particolarmente
Rasante adesivo fibrato per sistemi termici a cappotto è un rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati ed additivi speciali. è particolarmente
RISANAMENTO DI FACCIATE AMMALORATE E CAVILLATE ANTIRISS MINERALE
 WALER Srl Via Leonardo da Vinci 5 20020 Solaro (MI) Italy P.IVA 00698220969 Tel. 02/969.0167 Fax 02/967.99.251 www.waler.it waler@waler.it Cap.Soc. 100.000,00 i.v. R.E.A. n.820452 Reg.Imp. e C.F. 00864560156
WALER Srl Via Leonardo da Vinci 5 20020 Solaro (MI) Italy P.IVA 00698220969 Tel. 02/969.0167 Fax 02/967.99.251 www.waler.it waler@waler.it Cap.Soc. 100.000,00 i.v. R.E.A. n.820452 Reg.Imp. e C.F. 00864560156
DEFINIZIONE DEL MATERIALE
 DEFINIZIONE DEL MATERIALE Finitura poliuretanica bicomponente a finitura lucida, UV resistente. Disponibile nella versione sia colorata che trasparente. PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE è indicato ad esempio:
DEFINIZIONE DEL MATERIALE Finitura poliuretanica bicomponente a finitura lucida, UV resistente. Disponibile nella versione sia colorata che trasparente. PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE è indicato ad esempio:
REPOFLEX PVB. Scheda Tecnica
 Rev. A REPOFLEX PVB Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni ed avvertenze Via Gitafranco, 43 03017 Morolo
Rev. A REPOFLEX PVB Descrizione Caratteristiche generali Campi di applicazione Proprietà fisiche Preparazione Applicazione Confezioni Conservazione Precauzioni ed avvertenze Via Gitafranco, 43 03017 Morolo
RESINPAV RIVESTIMENTO PER PAVIMENTAZIONI
 Scheda Informativa Revisione 31-07-2015 RESINPAV RIVESTIMENTO PER PAVIMENTAZIONI Malta a base di resine sintetiche in dispersione acquosa indicata per rivestire superfici in conglomerato bituminoso, destinate
Scheda Informativa Revisione 31-07-2015 RESINPAV RIVESTIMENTO PER PAVIMENTAZIONI Malta a base di resine sintetiche in dispersione acquosa indicata per rivestire superfici in conglomerato bituminoso, destinate
ardelast quarzo pittura elastomerica al quarzo acrilsilossanica antialga
 SERIE 0.563. ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti SCHEDA TECNICA N 101 ardelast quarzo pittura elastomerica al quarzo acrilsilossanica antialga CARATTERISTICHE ARDELAST QUARZO, grazie
SERIE 0.563. ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti SCHEDA TECNICA N 101 ardelast quarzo pittura elastomerica al quarzo acrilsilossanica antialga CARATTERISTICHE ARDELAST QUARZO, grazie
MasterInject Resina epossidica bicomponente, a bassissima viscosità, priva di solventi, colabile ed iniettabile a bassa pressione
 DEFINIZIONE DEL MATERIALE MasterInject 1360 è una resina epossidica bicomponente, a bassissima viscosità, priva di solventi, caratterizzata da una elevata capacità di penetrazione PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
DEFINIZIONE DEL MATERIALE MasterInject 1360 è una resina epossidica bicomponente, a bassissima viscosità, priva di solventi, caratterizzata da una elevata capacità di penetrazione PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTop Pavimentazione continua epossidica all acqua di tipo autolivellante.
 DEFINIZIONE DEL MATERIALE è un sistema autolivellante epossidico all acqua per ottenere pavimentazioni continue epossidiche ad elevate caratteristiche meccaniche. PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE è impiegato
DEFINIZIONE DEL MATERIALE è un sistema autolivellante epossidico all acqua per ottenere pavimentazioni continue epossidiche ad elevate caratteristiche meccaniche. PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE è impiegato
