Dante Alighieri Commedia Inferno
|
|
|
- Serafina Romani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dante Alighieri Commedia Inferno a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi
2 Dante Alighieri Commedia Inferno a cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi
3 Copyright 2012 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6187der] I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L acquisto della presente copia dell opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico o commerciale) l editore potrà concedere a pagamento l autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi) Corso di Porta Romana, n Milano autorizzazioni@clearedi.org e sito web L editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, non essendo concorrenziale all opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all art ter legge diritto d autore. Maggiori informazioni sul nostro sito: Il testo seguito nella presente edizione è quello della SDI (Società Dantesca Italiana) Le introduzioni, le note e il commento sono di Riccardo Bruscagli. Gli apparati critici e didattici sono di Gloria Giudizi. Realizzazione editoriale: Coordinamento editoriale: Sandro Invidia Coordinamento redazionale: Silvia Doffo Redazione: Studio redazionale Maddali & Bruni, Firenze Segreteria di redazione: Rossella Frezzato Progetto grafico e impaginazione: Chialab, Bologna Disegni: Angelo Monne Composizione: Belle Arti, Bologna La foto di Ivano Marescotti nell ultima pagina del volume è di Donata Cucchi. Gli Autori e l Editore desiderano ringraziare Ivano Marescotti e Massimo Piani per la pazienza, la passione e la professionalità dimostrate nella realizzazione della Commedia in versione audio. Copertina: Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna Realizzazione: Roberto Marchetti Immagine di copertina: Angelo Monne Prima edizione: gennaio 2012 L impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) è comunicato nel catalogo Zanichelli, disponibile anche online sul sito ai sensi del DM 41 dell 8 aprile 2009, All. 1/B. File per diversamente abili L editore mette a disposizione degli studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con disturbi specifici di apprendimento i file pdf in cui sono memorizzate le pagine di questo libro. Il formato del file permette l ingrandimento dei caratteri del testo e la lettura mediante software screen reader. Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito Suggerimenti e segnalazione degli errori Realizzare un libro è un operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. L esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: lineadue@zanichelli.it Le correzioni di eventuali errori presenti nel testo sono pubblicati nel sito Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità certificato CertiCarGraf n. 477 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
4 III Indice 1 Introduzione Commedia o Divina Commedia? Inferno 2 Introduzione L orrore e la pietà 4 canto I 17 Forum critico Come va letta la Commedia? B. Croce, M. Barbi, E. Auerbach 23 canto II 28 canto III 39 Forum critico Perché tanto disprezzo di Dante per gli ignavi, ovvero i pusillamini? B. Nardi, G. Padoan, F. Mazzoni 43 canto IV 48 canto V 61 Forum critico Il canto V dell Inferno è canto della passione d amore o della tradizione letteraria che celebra tale passione? F. De Sanctis, L. Caretti, G. Contini 68 canto VI 79 Forum critico Che rapporto può esserci tra un misero uomo come Ciacco e la situazione politica di Firenze ai tempi di Dante? A. Vallone, A. Piromalli, I. Del Lungo 84 canto VII 90 canto VIII 101 Forum critico ll canto VIII dell Inferno è canto della vendetta politica, di un inqualificabile contegno di Dante o di un giusto commento morale? U. Bosco, P. Nicosia, G. Pischedda 106 canto IX 117 Forum critico Virgilio è veramente in grado di far proseguire il viaggio di Dante nell Inferno? M. Marcazzan, S. Santangelo, G. Severino 122 canto X 135 Forum critico Un dannato può essere un grande? F. De Sanctis, M. Casella, E. Parodi 140 canto XI 145 canto XII 150 canto XIII 163 Forum critico Il suicidio di Pier delle Vigne è frutto di confusione morale, disprezzo o sdegno civile? S. Aglianò, L. Spitzer, U. Bosco 170 canto XIV 176 canto XV 187 Forum critico Brunetto Latini può essere un maestro di moralità? U. Bosco, F. Salsano, M. Pastore Stocchi 195 canto XVI 200 canto XVII 205 canto XVIII 210 canto XIX 215 canto XX 220 canto XXI 233 Forum critico Perché i diavoli di Dante fanno ridere? L. Pirandello, M. Principato, R. Montano 242 canto XXII 248 canto XXIII 254 canto XXIV 260 canto XXV 266 canto XXVI 279 Forum critico Per Dante Ulisse è veramente un eroe della conoscenza? M. Fubini, E. Sanguineti, C. G. Ballerini 288 canto XXVII 293 canto XXVIII 298 canto XXIX 303 canto XXX 308 canto XXXI 313 canto XXXII 318 canto XXXIII 331 Forum critico L Ugolino di Dante è soltanto un padre straziato dal dolore delle sofferenze ingiustamente patite dai figli? F. De Sanctis, P. A. Perotti, J. Freccero 340 canto XXXIV 345 Indice dei nomi
5 1 La Commedia Introduzione Commedia o Divina commedia? Qual è il vero titolo del poema di Dante? Un antica e nobile tradizione, inaugurata dal Boccaccio, vuole che lo si indichi come Divina commedia; ma quel divina è aggiunta degli ammiratori, e non è parola di Dante. Aggiunta, beninteso, molto bella, che voleva sottolineare non soltanto la tematica religiosa dell opera (un viaggio nell aldilà, verso la finale visione di Dio), ma la qualità stessa dell impresa dantesca, che sembrava quasi andare oltre l umano, sfidare le possibilità poetiche ed espressive della comune lingua umana. Per questo, modernamente non si usa più intitolare l opera dantesca Divina commedia, ma, semplicemente, Commedia. A questo siamo incoraggiati dal poeta stesso, che in due luoghi dell opera parla della sua «commedia», o meglio, comedìa: in Inferno XVI, vv (per le note / di questa comedìa, lettor, ti giuro) e XXI, vv. 1-2 (Così di ponte in ponte, altro parlando / che la mia comedìa cantar non cura). Ancora più precisamente, inviando al suo protettore Cangrande della Scala, signore di Verona, la terza cantica del Paradiso, Dante l accompagna con una Epistola latina, in cui dice esplicitamente: «Libri titulus est: Incipit Comedia Dantis Alagherii, florentini natione, non moribus», «Il libro porta come titolo Comincia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi»; e più avanti: «comedia dicitur presens opus», la presente opera si chiama Commedia. Ma che cosa significa, per Dante, commedia? Evidentemente, qualcosa di molto diverso da quello che intendiamo noi moderni; per noi una commedia è un genere teatrale caratterizzato da uno stile divertente, brillante ( comico appunto) e dal lieto fine. Cosa c entra tutto questo con un poema narrativo che tratta di un viaggio nell oltretomba, attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso? Cosa intenda Dante per commedia egli lo spiega nella Epistola a Cangrande sopra citata. Egli ha ben presente la commedia come genere drammaturgico, e confrontandola con la tragedia ne nota debitamente le differenze. «Tragedia in principio est admirabilis et quieta, in fine seu exitu est fetida et horribilis», la tragedia all inizio è ammirabile e placida, alla fine o conclusione fetida e orribile ; invece «Comedia vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur», La commedia invece introduce all inizio qualche acerba difficoltà, ma la sua trama va poi a finire felicemente. Inoltre, fra tragedia e commedia c è una netta differenza di stile: «Similiter differunt in modo loquendi: elate et sublime tragedia; comedia vero remisse et humiliter», Analogamente i due generi differiscono nel linguaggio: la tragedia si esprime in modo elevato e sublime, la commedia in modo piano e umile. E questo, secondo Dante, dovrebbe bastare a spiegare il suo titolo: «Nam si ad materiam respiciamus, a principio horribilis et fetida est, quia Infernus, in fine prospera, desiderabilis et grata, quia Paradisus; ad modum loquendi, remissus est modus et humilis, quia locutio vulgaris, in qua et muliercule comunicant», E infatti, se si guarda alla materia, è orribile e fetida all inizio, perché si tratta dell Inferno; prospera, desiderabile e accetta alla fine, perché si tratta del Paradiso; se si bada poi al linguaggio, quello della commedia è piano e umile, perché è la lingua volgare in cui discorrono anche le donnette. Dunque, dimentichiamoci la natura teatrale dei due generi qui a confronto: d altronde, le tragedie e commedie antiche che Dante conosceva (soprattutto, rispettivamente, quelle di Seneca e quelle di Terenzio) erano ormai lette come testi di scuola, al di fuori di ogni pratica rappresentativa. E infatti, non solo il suo poema potrà essere chiamato Commedia, ma quello del suo venerato modello e maestro, l Eneide di Virgilio, potrà essere designato come «tragedia», anzi tragedìa, a causa della sua altezza di stile: così l canta / l alta mia tragedìa in alcun loco, Dante fa dire a Virgilio (Inferno XX, vv ), in riferimento appunto all Eneide. Questo contrasto fra comedìa e tragedìa, fra la Commedia e l Eneide, fra Dante e Virgilio, ci fa capire ancora meglio il significato del titolo dantesco. Evidentemente, siamo di fronte a due modi di vedere la realtà che si fronteggiano. In Dante il comico oppone all alta sublimità epica delle azioni eroiche la propria bassezza, la propria impurità, la propria abiezione: ma senza nessuna deferenza verso gerarchie di stile consacrate. Il che è quanto dire che in Dante è una visione del mondo inclusiva, scandalosamente aperta verso il reale, che si oppone alla sublime sì, ma angusta e selettiva visione tragica; vuol dire che la comedìa dantesca niente rifiuterà dell umano e del divino e degli infiniti linguaggi del mondo; significa che per Dante non c è nulla di non poetabile, e che nella sua opera anche il deforme, l osceno, il brutto, sono prepotentemente legittimati alla poesia.
6 2 Inferno Introduzione L orrore e la pietà La discesa nell abisso infernale costituisce il primo tratto del viaggio di Dante nell aldilà. Qui egli incontra le anime dannate, che scontano per l eternità le conseguenze, non tanto dei loro peccati, ma del non essersi voluti pentire dei loro peccati. Infatti, anche in Purgatorio, e poi in Paradiso, Dante incontrerà dei peccatori (e chi, fra noi uomini, può dirsi senza colpa?); ma saranno peccatori che hanno fatto ricorso in tempo alla misericordia divina. Dal punto di vista fisico, l Inferno è una sorta di voragine a forma di imbuto, sprofondata fino al centro della Terra. Sulle sue pareti corrono, a spirale, dei gradoni (cerchi, o gironi, li chiama Dante) dove trovano posto i peccatori, distribuiti secondo schiere che seguono le sofisticate e talvolta molto sottili distinzioni della morale cattolica, filtrata e raffinata attraverso i dettami dell aristotelismo antico e della filosofia scolastica, specie di san Tommaso, che è per Dante il filosofo, teologo, e moralista di riferimento. La mappa dei peccati infernali viene analiticamente illustrata da Dante (o meglio da Virgilio a Dante) nel canto XI; qui basti ricordare la divisione cruciale di questo ordinamento, che taglia in due l imbuto infernale: quella fra i peccati di incontinenza, che coinvolgono soltanto i sensi, e che costituiscono colpe d ordine istintuale (lussuria, gola, ira, e così via), e peccati di malizia, più gravi, che coinvolgono ciò che di più proprio è della specie umana, ovvero il cervello, la ragione. Ne risulta che il primo peccato incontrato da Dante il più lieve dunque, o almeno il meno grave è quello di lussuria; mentre l ultimo, in fondo all Inferno, è quello del tradimento dei propri benefattori, inteso come la cosciente, calcolata risposta del disamore all offerta gratuita d amore che si è ricevuta. L Inferno, insomma, mette di fronte il lettore moderno a un universo morale e a una gerarchia di colpe che possono talvolta sconcertare per la loro distanza rispetto alle percezioni e alle sensibilità del nostro tempo. Lo scopo di questa discesa di Dante nel regno del male è didattico e conoscitivo. Dante deve rendersi conto dei criteri che la giustizia divina adopera nel comminare le sue pene; deve per prima cosa istruirsi anche lui sul sistema giudiziario e morale a cui deve rispondere la vita di un cristiano. Tuttavia, non si tratta evidentemente di un viaggio soltanto intellettuale, ma di una esperienza altamente emotiva. Il Dante scrittore si oggettiva e si proietta in un Dante personaggio che si comporta come un vero carattere narrativo, romanzesco, all interno del racconto, e che non è soltanto il pretesto o portavoce di una lezione di catechismo. Dante, nel testo, agisce pertanto con grande e anche contraddittoria libertà: simpatizza, si irrita, si sdegna, compatisce, sviene, impreca Ma i due sentimenti e le due esperienze morali su cui si fonda tutto l impianto dell Inferno dantesco sono l orrore e la pietà. Ambedue intendono avere una funzione didattica e pedagogica: il contatto col peccato e con la sua punizione deve far scattare nel visitatore una repulsione educativa, che lo ammonisca a non commettere lui quelle colpe che vede così orrendamente castigate. Il primo sentimento di reazione è dunque, deve essere, l orrore. Un orrore spesso anche fisico, di fronte a un Inferno che si presenta come una sterminata camera di tortura: dove i dannati sono sottoposti alle pene fisiche più sanguinarie, talvolta, e ripugnanti (immersi nel sangue bollente, nello sterco, nella pece, mutilati di continuo da un diavolo squartatore, infettati delle malattie più schifose ). Ma l orrore non basta. Connaturata non occasionale, connaturata all esperienza dell Inferno è la pietà. Talvolta questo sentimento, che Dante anche qui si prende la libertà di provare in modo vario a seconda dei peccati e dei peccatori, ma che è sempre virtualmente presente, è sembrato contraddittorio con l intenzione e il senso dell opera. Perché Dante sviene di fronte a Paolo e Francesca? Perché esibisce tanta affettuosa solidarietà di fronte a Brunetto Latini? Perché gli viene da piangere di fronte alla pena degli indovini? Certo non perché egli sia in disaccordo con la giustizia divina che ha condannato quei peccatori a quella punizione. Ma, molto più semplicemente, perché l Inferno è per Dante l esperienza del male. E il male non fa solo paura e orrore. Perché la lezione dell Inferno possa essere efficace, bisogna che Dante si identifichi parzialmente, potenzialmente con i peccati che vede, con le condanne di cui è testimone. Bisogna che egli si identifichi, almeno un po con i dannati e il loro destino; bisogna che egli li compatisca, che ne abbia compassione e pietà. Solo così quel male e quel peccato non saranno solo un esperienza aliena, incomprensibile, che non lo tocca: ma un pericolo imminente, da cui guardarsi. Sarebbe facile respingere lontano da noi il male come cosa che non ci appartiene e che non ci riguarda. La pietà di Dante all Inferno significa invece che il male è vicino a ciascuno di noi, e nessuno può sentirsene esente. Che in ciascuno di noi si annida, forse, un dannato. Che le anime d Inferno erano e sono ancora, in fondo come noi.
7 3 Canti Peccatori Luoghi selva porta Gerusalemme I, II III ignavi ANTINFERNO Acheronte IV non battezzati I CERCHIO (LIMBO) V VI VII VIII IX, X, XI XII XIII XIV, XV, XVI, XVII XVIII XVIII XIX XX XXI, XXII XXIII XXIV, XXV XXVI, XXVII XXVIII, XXIX XXIX, XXX XXXI XXXII XXXII, XXXIII XXXIII XXXIV INCONTINENTI VIOLENTI FRAUDOLENTI TRADITORI lussuriosi golosi avari e prodighi iracondi e accidiosi eretici omicidi e predoni suicidi e scialacquatori bestemmiatori, sodomiti, usurai ruffiani e seduttori adulatori simoniaci indovini barattieri ipocriti ladri consiglieri fraudolenti seminatori di discordia falsari traditori dei parenti traditori della patria traditori degli ospiti traditori dei benefattori VII CERCHIO VIII CERCHIO IX CERCHIO (COCITO) palude stigia II CERCHIO III CERCHIO IV CERCHIO V CERCHIO VI CERCHIO I girone II girone III girone I bolgia II bolgia III bolgia IV bolgia V bolgia VI bolgia VII bolgia VIII bolgia IX bolgia X bolgia I zona Caina II zona Antenora III zona Tolomea IV zona Giudecca pozzo dei giganti Flegetonte cascata del Flegetonte città di Dite Lucifero CENTRO DELLA TERRA
8 4 tracce 1-2 Inferno canto I > Luogo selva oscura; pendio verso il colle > Figure allegoriche tre fiere: lonza, leone, lupa Il primo canto della Commedia serve da prologo all intero poema, e non a caso può considerarsi fuori numerazione, all interno del sistema simbolico dell opera. Essa infatti è composta di 100 canti, così distribuiti: Inferno 34, Purgatorio 33, Paradiso 33; ma i 34 dell Inferno vanno considerati, appunto, come 1 più 33. Questo primo canto, dunque, complica la numerologia dantesca, aggiungendo all ossessione del tre e dei suoi multipli, allusiva al mistero centrale della fede cristiana quello della Trinità la suggestione armonica dell unità e della cifra perfettamente squadrata. Come la divinità cristiana, la Commedia si presenta subito, insomma, una e trina, specchio umano e poetico della misteriosa perfezione divina. In questo canto proemiale Dante dispone schematicamente, ma con grande efficacia, le pedine essenziali del suo racconto. Fin dall inizio capiamo che sarà un racconto allegorico, in cui dietro ogni cosa narrata potrà celarsi un senso ulteriore, simbolico, segreto: la selva su cui si apre il poema è sì una selva, ma anche il simbolo di un fatale smarrimento nel peccato, e così via. Fin dall inizio è chiaro che il protagonista è Dante, lo scrittore stesso; siamo dunque di fronte a un racconto autobiografico che l autore pretende che noi consideriamo vero, anche se le cose narrate saranno davvero dell altro mondo. Sarà il racconto della conversione di Dante dal male al bene: dai vizi, simboleggiati nelle tre bestie feroci che qui gli sbarrano la strada, alla riconquista della grazia divina e alla visione stessa di Dio, in Paradiso. Ma questo cammino di conversione non si consumerà nell interiorità dell animo del poeta: esso si svolgerà attraverso un viaggio vero e proprio nei tre regni ultramondani dell Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in modo che Dante el mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. 3 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura! 6 1 Nel mezzo di nostra vita: all età di trentacinque anni. Secondo la Bibbia, infatti, l età tipica dell uomo è di settanta anni (Salmo 89, 10: «dies annorum nostrorum septuaginta anni»), e Dante aveva già affermato (Convivio IV, xxiii, 6-10) che il «punto sommo di questo arco [dell esistenza umana]» doveva ravvisarsi «tra il trentesimo e il quarantesimo anno», e «ne li perfettamente naturati [cioè negli individui di natura più perfetta] [ ] possa ritornare sulla retta via a contatto con l esperienza della dannazione, della penitenza e della beatitudine paradisiaca. A contatto, insomma, con la vicenda drammatica dell uomo e della sua storia, di peccato e di grandezza. Perché, infine, questo non sarà solo il racconto della conversione di Dante, ma sarà insieme anche la parabola esemplare di un itinerario morale, valida per chiunque voglia passare dal buio del peccato allo splendore della Grazia. Che cosa accade in questo primo canto? Dante si trova solo, di notte, smarrito in una selva paurosa, incapace di trovare una via d uscita. Non sa rendersi conto neanche lui di come e quando vi sia capitato. Con le sue sole forze, vincendo i terrori notturni, egli riesce comunque a districarsene: di fronte a lui, oltre il margine di quella paurosa foresta, si erge un colle appena baciato dai primi raggi del sole, e il suo cuore subito si rinfranca. Ma per poco. La strada gli viene subito sbarrata da tre belve feroci: una lonza (una sorta di leopardo), un leone e una lupa. Specie quest ultima appare così aggressiva che Dante comincia a retrocedere. Ma ecco che qualcuno appare a soccorrerlo. È Virgilio, il famoso poeta latino autore dell Eneide, l idolo letterario di Dante. Ma Virgilio non è qui come poeta; o almeno, non solo come poeta. Egli è qui per salvare Dante dalla ferocia delle tre belve, e specie della lupa. È qui, anche, come profeta, visto che egli predice la prossima sconfitta di tale bestia, che sarà, egli assicura, ricacciata all Inferno da un veltro, un levriero da caccia provvisto di tutte le virtù contrarie ai nel trentacinquesimo anno». Dante era nato nel 1265, quindi l inizio della Commedia viene collocato dall autore nel 1300; più precisamente, come si ricava da altri passi del poema, nella primavera di quell anno, o la sera del Venerdì Santo (8 aprile) o più probabilmente del 25 marzo (che era il Capodanno fiorentino, detto ab incarnatione, nove mesi esatti prima del Natale). 2-3 selva oscura diritta via: simboli, rispettivamente, del peccato e della via del bene. 4 dura: ardua. 5 esta forte: l insistita allitterazione (esta Selva Selvaggia e aspra) vuole sottolineare la difficoltà e l intrico della selva (selva selvaggia è anche figura etimologica e replicazione); forte: compatta, impossibile a penetrare. 6 nel pensier paura: «solo a ripensarci fa rinascere il terrore di quella esperienza». vizi della lupa. Soprattutto, però, Virgilio si offre a Dante come guida. Per sconfiggere la lupa e guadagnare la luce che adesso invade il colle al di là della selva, Dante dovrà affrontare un lungo pellegrinaggio attraverso l Inferno, il Purgatorio e il Paradiso: viaggio certo fuori dell ordinario, ma come rifiutare? Il canto si chiude con Dante che si affida, senza riserve, alla protezione di Virgilio. Questi gli eventi, ovvero il racconto letterale di questo primo canto. Il suo sovrasenso allegorico è, sotto vari aspetti particolari, di ardua e controversa decifrazione (la profezia del veltro, per esempio), ma il disegno generale è assai chiaro. Il canto presenta lo smarrimento di un anima nel buio del peccato (la selva tenebrosa), il suo desiderio di cambiare vita e di ritornare alla luce del vero e del giusto (l uscita dalla selva, il colle solatìo), il riemergere delle inveterate abitudini peccaminose (le tre fiere, allegorie della lussuria, della superbia e della cupidigia), lo scoramento (il retrocedere verso la selva), l intervento di un soccorso esterno (Virgilio) e l inizio di un lungo percorso di conoscenza e di docile accettazione della grazia divina (il viaggio ultramondano). Virgilio, in particolare, rappresenta in questo disegno le risorse della ragione umana che, come qui viene subito precisato, saranno capaci di accompagnare Dante fino alla soglia del Paradiso, ma non oltre. Per penetrare nella beatitudine di Dio occorrerà un guida più alta (Beatrice), ovvero, occorreranno le risorse della fede, della speranza e della carità che Virgilio, in quanto pagano, non ha potuto conoscere.
9 1 La selva oscura, la paura, la notte 5 La Commedia comincia di botto, senza preamboli: «Verso i miei trentacinque anni, nell età che si considera metà della vita umana, mi trovai nel mezzo di una selva spaventosa, incapace di trovare la via giusta per uscirne. Ancora adesso, a ripensarci, provo gli stessi brividi, se devo dire quanto irta, impenetrabile e selvaggia era quella selva». Così inizia Dante, ed è un inizio peculiare. Basta confrontarlo con l inizio delle altre due cantiche (Purgatorio e Paradiso) dove Dante si presenterà in veste di poeta, lieto di potersi lasciare alle spalle la crudele materia infernale (Purgatorio) e ben consapevole della sfida espressiva che lo attende, al momento di ridire le cose viste nel Regno celeste (Paradiso). Lì, sulla soglia delle altre due cantiche, Dante invocherà in suo aiuto, come i poeti classici, le muse, Calliope in particolare, e Apollo stesso, padre di ogni poesia. È ben vero che anche qui, nella prima cantica, Dante premette un proemio, ma nel secondo canto: O muse, o alto ingegno, or m aiutate; / o mente che scrivesti ciò ch io vidi, / qui si parrà la tua nobilitate (vv. 7-9).Il che ribadisce che l Inferno veramente ha una scansione peculiare (1 + 33) e che il suo primo canto va considerato d introduzione a tutta l opera, mentre è il secondo che apre veramente la prima cantica. Tuttavia, l effetto narrativo non cambia: il racconto della Commedia parte amputato di ogni preambolo, di ogni dichiarazione poetica, di ogni avviso al lettore. Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura. Sembra che l unica preoccupazione sia quella di cominciare, e alla svelta, trascinando noi lettori nel cuore di una situazione narrativa angosciosa, carica di ansia e di spavento. D altronde, che cosa c è di più elementare, per cominciare un racconto, di un protagonista smarrito in un bosco? È l archetipo delle fiabe ancestrali; è anche, per un poeta nutrito di cultura francese come Dante, un archetipo dei racconti di cavalleria da lui tanto amati, dove lo smarrirsi del cavaliere nella foresta è circostanza narrativa assai tipica. Tanto più che, lo capiremo subito, è notte: trovarsi solo, di notte, in una foresta senza uscita Dante non spiega come è entrato in questa selva, anzi, dice che «ci si è ritrovato» e, più precisamente ancora, che non saprebbe ridire come vi era entrato, tanto era pien di sonno quando smarrì la giusta direzione. La Commedia dunque comincia con una specie di soprassalto: come se uno, uscito di strada senza accorgersene, come un sonnambulo, improvvisamente si riscuotesse e si guardasse intorno realizzando, con terrore, di trovarsi in un luogo sconosciuto e pericoloso. Un inizio di racconto così impressionante (e, non a caso, rimasto così impresso nella memoria dei lettori di Dante) è anche, allo stesso tempo, una scena allegorica. Che cos è una «allegoria» per Dante e per gli uomini del suo tempo? In generale, tenendo presente l etimologia stessa del termine (che deriva dal greco allos, altro, e rein, dire ), allegoria significa parlare d altro, ovvero che in un discorso, oltre al senso letterale immediatamente comprensibile, ve ne sono altri («sovrasensi») nascosti, e di meno immediata comprensibilità. Dante stesso nel Convivio, a proposito della lettura delle Sacre Scritture, propone di applicare ai testi biblici tre diversi livelli di senso: allegorico, morale e anagogico. In seguito, scrivendo a Cangrande della Scala a proposito del suo Paradiso, egli semplifica il discorso, distinguendo fra l allegoria dei teologi, più sottilmente complicata, e quella dei poeti, che consiste semplicemente nel rivestire di belle immagini messaggi morali più profondi. Per quanto riguarda l inizio della Commedia, e per tutto questo primo canto, il sovrasenso allegorico del testo è, nelle sue linee generali, molto evidente, quasi schematico: la selva in cui Dante si smarrisce è allegoria della vita di peccato, da cui è così arduo uscire; la diritta via è insieme un sentiero vero, concreto, che non si riesce a ritrovare e, allegoricamente, la via del bene smarrita; solo il sorgere del sole su un colle, oltre la selva, significherà per Dante la speranza di uscire dall oscurità del vizio verso la luce della virtù. D altronde, se si guarda un poco più a fondo in questa allegoria, si vedrà che essa non è poi così schematica. Che cosa significa, infatti, esattamente, il soprassalto di paura su cui si apre la Commedia? Che cosa vuol dire essere entrati nella I
10 6 7 amara: tormentosa; poco morte: la morte è appena poco più angosciosa di quella selva. 8 ben: il ben che Dante troverà nella selva oscura è Virgilio, e, attraverso lui, la via d uscita dalla selva, verso la salvezza. Ma prima dell incontro con Virgilio, Dante dovrà dire dell altre cose (v. 9), ovvero degli ostacoli da lui «scorti» (visti, incontrati) in quella selva tant era verace via: il sonno simboleggia lo stato di assenza e cecità della ragione, ottenebrata dal peccato; era: ero (comune nella lingua antica, fino all Ottocento); la verace via è, al solito, la via del vero, del bene. 15 compunto: punto in profondità, trafitto vidi le sue spalle calle: «vidi i pendii del colle illuminati dai raggi del sole, l astro che guida l uomo nella giusta direzione (dritto), qualunque via egli prenda». Il sole è detto pianeta perché nella cosmologia tolemaica è un corpo celeste che ruota anch esso intorno alla Terra; qui è simbolo della luce di Dio, che illumina tutti sulla retta via. 19 queta: acquietata. 20 nel lago del cor: nel profondo del cuore. Il lago è, nella lingua antica, la cavità interna dove il sangue si raccoglie e da dove viene reimmesso in circolo. 21 pieta: tormento, angoscia (dal latino pietas); nella lingua antica era comunemente usato come alternativa a «pietà» (che, in genere, però ha il significato moderno di compassione ) E come quei guata: «E come un naufrago che ancora col fiato corto, scampato dalle onde e approdato sulla spiaggia, si volge verso il mare pericoloso e lo contempla intensamente». «Guatare», nell uso antico e dantesco, è più intenso del semplice «guardare». 25 l animo fuggiva: vuole dire che il corpo si era fermato (a contemplare la selva da cui era appena uscito), ma l animo aveva ancora l impressione di fuggire, a malapena credeva di essere scampato al pericolo lo passo viva: è la selva stessa, da cui nessuno era uscito vivo. Vuole significare che, dallo stato di peccato in cui si trova Dante a metà della sua vita, non è possibile tornare alla via del bene; almeno non da soli, come il resto del canto dimostrerà. 28 Poi ch èi posato: Dopo che ebbi riposato. 29 piaggia: il declivio intermedio fra la pianura e l altura vera e propria; qui, fra la selva che giace in basso, al buio, e il colle visto di sopra, baciato Tant è amara che poco è più morte; ma per trattar del ben ch i vi trovai, dirò de l altre cose ch i v ho scorte. 9 Io non so ben ridir com i v intrai, tant era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. 12 Ma poi ch i fui al piè d un colle giunto, là dove terminava quella valle che m avea di paura il cor compunto, 15 guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogne calle. 18 Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m era durata la notte ch i passai con tanta pieta. 21 E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago a la riva, si volge a l acqua perigliosa e guata, 24 così l animo mio, ch ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. 27 Poi ch èi posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che l piè fermo sempre era l più basso. 30 Ed ecco, quasi al cominciar de l erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta; 33 e non mi si partia dinanzi al volto, anzi mpediva tanto il mio cammino, ch i fui per ritornar più volte vòlto. 36 dai raggi del primo sole. 30 sì che l piè basso: «il piede più saldo era quello più basso, su cui si appoggiava il peso del corpo, mentre l altro piede procedeva in avanti». Verso molto discusso, ma che sembra alludere semplicemente al fatto che Dante sta affrontando l inizio della salita più ripida (il cominciar de l erta, v. 31) forse con troppa ingenua baldanza, senza tenere conto della sua forte consuetudine ad abbandonarsi ai peccati, simboleggiati dalle tre fiere che gli sbarrano subito il passo. 32 una lonza molto: la lonza, agile e molto svelta, è un felino simile al leopardo (più avanti si alluderà alla sua pelle maculata: pel macolato, v. 33); si credeva che nascesse dall accoppiamento di un leopardo e una leonessa; il termine lonza è un francesismo (da lonce). Simboleggia il peccato di lussuria, evidentemente il primo e più grave impedimento per il riscatto spirituale di Dante. 36 ch i fui vòlto: «mi volsi più d una volta indietro, per ritornare nella selva».
11 7 13 Il colle, il sole, la speranza 31 Primo ostacolo: la lonza selva senza neanche accorgersene? E anche non riuscire a trovare la via d uscita, è poi un elemento così banale di questo racconto? In realtà, qui Dante stringe in pochi versi una rappresentazione del peccato che noi moderni, forse, potremmo definire dipendenza dal male. Dante sa bene (dalla lezione della sua principale guida teologica, san Tommaso) che il peccato non consiste tanto in singole azioni malvagie ma in un habitus, una pratica inveterata, radicata, del male. Di questo egli si accorge nella selva oscura: di essere ormai in trappola, soffocato da una situazione di oscurità morale, e di non sapere neanche bene, esattamente, come sia arrivato fino a quel punto. Accorgersi, comunque, della propria crisi esistenziale è il punto di partenza; cercare disperatamente una via d uscita, la prima mossa verso la salvezza. Ma come il seguito del canto ci insegnerà la forza inveterata delle abitudini cattive è troppo forte. Da soli non ce la facciamo. Occorre l intervento di un aiutante esterno (Virgilio) e un lungo cammino di rigenerazione interiore per approdare, finalmente, alla luce. La notte sembra dileguata e Dante scorge, oltre il limite della selva, un colle baciato dai raggi del primo sole. Basta questo per calmare un poco l angoscia della spaventosa notte appena trascorsa; nel profondo del cuore la paura si placa, la salvezza sembra a portata di mano; anzi, Dante si può guardare indietro, verso il passo pericoloso appena superato, con il sollievo del naufrago appena scampato sulla riva, che, sia pure ancora ansimante, si volge a contemplare i marosi che stavano per inghiottirlo, anche se l animo ancora quasi non crede di essere davvero in salvo. E dopo un po di riposo, su per le prime alture del colle, a passo spedito, verso la luce del mattino! È un illusione, naturalmente. Fosse così facile, uscire dalla selva del male Bastasse soltanto rendersi conto della propria situazione di peccato, provarne terrore e decidere di liberarsene La volontà di salire all erta del colle illuminato dal sole (facile allegoria della salvezza morale, della luce della Grazia, di Dio stesso) non basta. La vita passata, con i suoi vizi, interviene a tagliare la strada all ascesa baldanzosa del nostro protagonista. Si parano improvvisamente di fronte a Dante tre fiere, o belve feroci: una lonza, un leone e una lupa, che impediscono al poeta l ascesa a quel colle, allietato dai primi raggi del sole, che sembra così vicino, a portata di mano, di fronte a lui. Le fiere sono allegorie di altrettanti vizi che sbarrano la strada verso la luce della salvezza morale e della Grazia; ma più ancora che la loro identificazione con questo o quel peccato, ciò che conta qui è il meccanismo narrativo, morale ed esistenziale di questo passo. Perché intervengono queste fiere? Che cosa significa il loro intervento? Perché non hanno assalito Dante nella selva oscura ma lo hanno, invece, aspettato in quel margine (piaggia diserta, erta) fra la selva e il colle? La risposta può essere questa: le tre fiere non appartengono evidentemente al mondo del male vissuto come oscurità della ragione, sonno della coscienza; esse si risvegliano quando Dante peccatore si indirizza al bene, nel momento in cui egli comincia a prendere consapevolezza degli ostacoli che si frappongono fra lui e una piena conversione morale. Sono creature non della notte ma, purtroppo, della luce che comincia a rischiarare l anima, e nel cui chiarore la natura dei propri peccati si rivela vivida e distinta. Così, il primo ostacolo incontrato qui da Dante è la lonza, una sorta di leopardo maculato in cui si riconosce, tradizionalmente, il peccato di lussuria: evidentemente, il primo vizio da superare, in questa sorta di allegorico esame di coscienza. Dante sentirebbe quasi di farcela: è vero che la fiera non gli si leva dinanzi agli occhi e gli impedisce tanto ostinatamente il cammino, che più d una volta egli si sente riprecipitare all indietro verso la selva, ma il sole sta sorgendo nel cielo, la luce invade il paesaggio, e per di più è l inizio della primavera, la stagione in cui tutto l universo fu creato dall amore di Dio; la lussuria, forse, sarebbe un ostacolo superabile I
12 e l sol montava cose belle: «il sole stava sorgendo congiunto con la costellazione dell Ariete, come all inizio della creazione». Infatti si credeva che Dio (l amor divino) avesse dato il primo moto agli astri (quelle cose belle) all inizio della primavera, che si inaugura appunto sotto il segno dell Ariete sì ch a bene sperar la dolce stagione: «sì che l ora del giorno (l alba) e la dolcezza del clima primaverile mi incoraggiavano a sperar bene davanti al pericolo di quella fiera dal pelo screziato»; gaetta, francesismo da gai, significa propriamente leggiadro ; insomma, la screziatura rendeva grazioso il pelo della lonza. 45 un leone: la seconda fiera che si para davanti a Dante simboleggia la superbia; altro vizio, evidentemente, inveterato nel poeta peccatore. 48 parea tremesse: «sembrava che anche l aria intorno ne tremasse di paura». 49 una lupa: la terza fiera simboleggia l avarizia o, più in generale, la cupidigia. È di gran lunga la fiera (e il vizio) più temibile: quella che rischia davvero di far precipitare di nuovo Dante nella selva oscura (v. 60); Dante la definisce al singolare (la bestia, v. 58) come quella che gli fa più spavento (vv ); l unica a cui sembra riferirsi Virgilio (v. 94 e vv. ss.), e contro la quale egli scaglia la profezia del veltro (vv ) che di tutte brame magrezza: «che sembrava portare, impressi nella sua magrezza, i segni di tutte le sue cupidigie, della sua insaziabile avidità». 51 grame: afflitte. 52 questa: riprende con effetto di enfasi il soggetto già espresso (Ed una lupa); mi porse gravezza: mi angosciò talmente con la paura altezza: «...col terrore che ispirava il suo aspetto, che perdetti la speranza di poter salire sulla cima del colle» E qual è quei s attrista: «E come colui (un avaro o un giocatore) che si allieta delle sue vincite e, quando viene invece il momento di perdere ciò che ha guadagnato, si dispera profondamente». 58 sanza pace: che non dà requie, implacabile. 60 tace: non si fa sentire, non penetra. Efficace traslato, a significare il buio della selva oscura. 61 rovinava: stavo precipitando. 62 mi si fu offerto: nella lingua antica, il trapassato remoto è usato per indicare la fulmineità dell azione, già successa, per così dire, quando il soggetto senziente se ne accorge. Temp era dal principio del mattino, e l sol montava n sù con quelle stelle ch eran con lui quando l amor divino 39 mosse di prima quelle cose belle; sì ch a bene sperar m era cagione di quella fiera a la gaetta pelle 42 l ora del tempo e la dolce stagione; ma non sì che paura non mi desse la vista che m apparve d un leone. 45 Questi parea che contra me venisse con la test alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l aere ne tremesse. 48 Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame, 51 questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch uscia di sua vista, ch io perdei la speranza de l altezza. 54 E qual è quei che volontieri acquista, e giugne l tempo che perder lo face, che n tutti suoi pensier piange e s attrista; 57 tal mi fece la bestia sanza pace, che, venendomi ncontro, a poco a poco mi ripigneva là dove l sol tace. 60 Mentre ch i rovinava in basso loco, dinanzi a li occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. 63 Quando vidi costui nel gran diserto, «Miserere di me», gridai a lui, «qual che tu sii, od ombra od omo certo!» chi fioco: è Virgilio, come si dirà subito. Egli sembra fioco, senza voce, per essere stato a lungo senza parlare. Si può intendere che Virgilio ha taciuto dai tempi dell antichità classica; Dante sembra rivendicare qui il merito di ridargli la parola dopo tanto tempo. Si potrebbe intendere fioco anche come scolorito : in questo caso l espressione vorrebbe dire che l apparizione di Virgilio ha l evanescenza di un fantasma (ma in questo caso il lungo silenzio che cosa significherebbe? forse la lunga assenza della luce del sole?). Il passo rimane comunque di difficile interpretazione. 64 nel gran diserto: diserto non nel senso propriamente geografico (siamo nella piaggia alle soglie della selva oscura), ma inteso come luogo solitario ; forse ancora migliore il significato che il termine ha nella tradizione del romanzo arturiano: luogo deputato alle avventure e alle prove dei cavalieri. 65 «Miserere di me»: «Abbi pietà di me». La schietta forma latina, resa familiare dalla sua frequenza nella liturgia cristiana, era d uso comune ai tempi di Dante. 66 omo certo: uomo in carne e ossa.
13 45 Secondo ostacolo: il leone 49 Terzo ostacolo: la lupa 61 Comparsa di un aiutante: Virgilio 9 Se non fosse che, immediatamente dopo la lonza, ecco comparire un leone a testa alta, criniera ritta, ferocemente affamato, che non si limita a impedire il passo a Dante, come l agile lonza, ma gli viene proprio addosso; sembra che anche l aria, intorno, ne abbia paura. È il secondo ostacolo, il secondo vizio, comunemente identificato con il peccato di superbia; un peccato di cui Dante apertamente si accuserà in Purgatorio (canto XIII, vv ) e che quindi dobbiamo considerare tristemente caratteristico della sua vita morale. Ma il colpo di grazia è la comparsa di una lupa, il terzo e ultimo ostacolo all ascesa di Dante verso la luce: magra, divorata dalla sua stessa avidità, abituata ad affliggere l esistenza di tanta gente e paurosa all aspetto, essa sgomenta tanto il nostro peccatore da fargli perdere del tutto la speranza di raggiungere il sommo del colle. Ormai la troppo facile sicurezza di averla vinta sui suoi spaventi notturni abbandona Dante, che si sente come un giocatore, o un avaro, che di colpo abbia perso i suoi guadagni o i suoi averi; la lupa, bestia sanza pace, lo aggredisce apertamente, e a poco a poco lo respinge inesorabilmente verso il buio, là dove non arriva più la luce del sole. La lupa è allegoria della cupidigia: un vizio che rappresenta un salto di qualità decisivo, per così dire, in questa analisi dantesca della propria corruzione morale. Infatti, la lonza e il leone, ovvero la lussuria e la superbia, rappresentavano peccati individuali, più legati al personale vissuto del poeta; la cupidigia, invece, fin dall inizio si presenta come una sorta di sciagura collettiva (molte genti fé già viver grame), come una specie di peste sociale. Per questo d ora in avanti lonza e leone praticamente spariscono dal canto e la bestia per antonomasia, nelle parole di Dante e di Virgilio, sarà sempre la sola lupa; anzi, sembra proprio che la comparsa di Virgilio sia resa necessaria dall aggressività di questa fiera, più che da quella delle altre due. D altronde, già san Paolo aveva bollato la cupidigia come radice di ogni altro peccato; Dante, dal canto suo, nel corso della Commedia riporterà proprio a questo vizio non tanto la sua personale vita morale (che invece sembra esserne alquanto immune), ma la corruzione del proprio tempo e delle sue principali istituzioni, specie della Chiesa. Mentre Dante, sotto l incalzare della lupa, sta rovinando verso il basso, verso la selva oscura, ecco comparire in scena, finalmente, un soccorritore. All inizio è delineato in modo enigmatico, e comunque appare una figura sfumata: chi per lungo silenzio parea fioco. Che s intenda fioco in senso vocale (uno che a forza di tacere a lungo aveva perso la voce) o in senso visivo (uno che appariva scolorito, come un fantasma, per la lunga assenza dalla luce del sole), si tratta comunque di un personaggio sbiadito: come se Dante volesse presentarcelo, da principio, roco ed evanescente, salvo fargli acquistare subito voce, riconoscibilità e importanza attraverso il suo rapporto con lui. Il misterioso soccorritore, a cui Dante si rivolge subito con accenti disperati («Che tu sia uomo in carne e ossa o fantasma, abbi pietà di me!») è niente meno che Virgilio, il poeta dell Eneide, come egli si presenta in una sorta di succinta scheda anagrafica: «non più vivo, ma vissuto un tempo; figlio di genitori del Nord Italia, anzi, per la precisione, mantovani; nato sotto Giulio Cesare, ma troppo tardi per acquistare fama sotto di lui; suddito di Augusto; pagano, purtroppo; di professione poeta, e, anzi, autore dell Eneide». E poi, quasi che egli non fosse al corrente della situazione di Dante: «Ma tu perché torni indietro verso l angoscia della selva? Perché non ascendi il dilettoso monte che conduce al gioioso possesso di Dio?». Strana domanda per uno che come si vedrà è stato appositamente inviato per prendersi cura di Dante In realtà, proprio perché si sa che Dante non ce la farebbe mai da solo ad ascendere al dilettoso monte, la domanda, si può supporre, è provocatoria, fatta apposta perché il poeta riconosca a chiare note la propria impotenza e la propria necessità di un soccorso. Virgilio, per consenso comune dei critici, è nella Commedia l allegoria della ragione umana. Con i suoi limiti e la sua grandezza: la ragione, infatti, può condurre I
14 10 67 Non omo fui: Virgilio dichiara che egli non è più tra gli uomini viventi, ma che egli lo fu, in un passato remoto parenti: genitori (dal latino parentes); lombardi, mantoani: la patria tradizionale di Virgilio è Andes (odierna Pietole), piccolo villaggio nei pressi di Mantova; terra lombarda nel senso antico, quando per Lombardia si intendeva generalmente tutta l Italia settentrionale. Virgilio (Publius Vergilius Maro) vi nacque nel 70 a.c.; morì a Brindisi nel 19 d.c., avendo appena terminato (ma non perfezionato) il suo capolavoro, l Eneide, qui ricordato anche da Dante. 70 sub Iulio tardi: «sotto Giulio Cesare, benché fosse tardi». A dire il vero nel 70 a.c., data di nascita di Virgilio, Cesare aveva solo trent anni e non aveva ancora preso il potere a Roma; per questo Virgilio aggiunge ancor che fosse tardi, volendo dire che egli era nato troppo tardi per farsi conoscere e apprezzare da Cesare, che infatti cadde assassinato nel 44 a.c., quando Virgilio non si era ancora affermato come poeta. 71 buono Augusto: buono nel senso di prode, valoroso. Augusto fu il vero protettore di Virgilio, e a lui (e alla sua stirpe) è infatti dedicata l Eneide. 72 nel tempo bugiardi: cioè in pieno Paganesimo. È proprio questo essere nato troppo presto per conoscere il Cristianesimo che condanna Virgilio (vv ) al primo cerchio infernale, quello del Limbo. 75 poi che combusto: «dopo che l eccelsa potenza di Troia fu distrutta dalle fiamme». 76 noia: angoscia. Nella lingua antica, non ha mai il significato attuale di tedio, ma indica sempre dolore, tormento quella fonte fiume: l eloquenza della poesia virgiliana è paragonata a un fiume sgorgante da una fonte, a significare l abbondanza, la ricchezza e la naturalezza delle risorse espressive del poeta latino. Rispuosemi: «Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patrïa ambedui. 69 Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto l buono Augusto nel tempo de li dèi falsi e bugiardi. 72 Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d Anchise che venne di Troia, poi che l superbo Ilïón fu combusto. 75 Ma tu perché ritorni a tanta noia? perché non sali il dilettoso monte ch è principio e cagion di tutta gioia?». 78 «Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume?», rispuos io lui con vergognosa fronte. 81 «O de li altri poeti onore e lume, vagliami l lungo studio e l grande amore che m ha fatto cercar lo tuo volume. 84 Tu se lo mio maestro e l mio autore, tu se solo colui da cu io tolsi lo bello stilo che m ha fatto onore lui: a lui. Il dativo senza preposizione era abbastanza comune nella lingua antica; con vergognosa fronte: con aspetto di reverenza; quasi vergognoso, intimidito, nel trovarsi davanti al suo idolo letterario. 83 vagliami: mi sia di giovamento (per trovare ascolto e aiuto presso di te). 84 che m ha fatto volume: «che mi ha spinto a leggere e rileggere il tuo poema, l Eneide». 85 l mio autore: il mio auctor (dal latino), l esempio da seguire. 87 lo bello stilo onore: Dante riconosce in Virgilio il modello di stile alto (bello, cioè eccellente sopra ogni altro) di cui egli ha già dato prova e che gli ha già procurato onore, fama di poeta. Dante qui si riferisce alle poesie d amore e morali composte prima del 1300, data del viaggio della Commedia.
15 11 79 Dante stupisce e chiede aiuto Dante alla riconquista di una salute morale naturale, ma non lo può far penetrare nel mondo della grazia divina, cioè della rivelazione cristiana. Per questo Virgilio accompagnerà Dante solo fino al Paradiso Terrestre, collocato sulla cima della montagna purgatoriale; in Paradiso, guida di Dante non sarà più Virgilio, ma Beatrice. Il poeta latino d altronde non rappresenta solo la ragione individuale dell uomo, che gli permette di superare il vizio e di attingere a una perfezione etica pari a quella goduta prima del peccato originale dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Virgilio, il più grande poeta di Roma, è considerato da Dante anche come l incarnazione della ragione umana nell impero, nella cultura e nella storia di Roma. Tutto ciò di bello e di buono che l umanità, anche in assenza della rivelazione divina e senza conoscere il messaggio cristiano, può realizzare (e ha storicamente realizzato nella civiltà romana) è simboleggiato secondo Dante in Virgilio. Infatti, ci si potrebbe chiedere: come mai proprio Virgilio? Non c erano figure più adatte a condurre Dante attraverso i regni oltremondani dell Inferno e del Purgatorio? Non sarebbe stato più adatto un santo, una figura biblica o un angelo cristiano? E invece Dante sceglie Virgilio come guida del suo viaggio, non nonostante egli sia pagano, ma proprio perché egli è un pagano che non ha conosciuto Cristo. Così facendo, Dante vuole sottolineare l autonomia della ragione umana e le sue capacità di giungere da sola al bene; allo stesso tempo, ne vuole marcare, con assoluto rigore, i limiti. La perfezione puramente umana del Paradiso Terrestre è ciò a cui Virgilio può pervenire; più su, egli il più perfetto degli antichi non può andare. Anche in questo caso bisogna sottolineare con forza che Virgilio, però, non è una pura e semplice allegoria. Dante fa di lui, e in modo sempre più vivido col procedere del racconto, un personaggio vero; anzi, trasforma le contraddizioni della sua funzione simbolica in tratti caratteriali. Questo vuol dire, cioè, che la contraddizione fra i poteri e i limiti della ragione umana, di cui Virgilio è allegoricamente portatore, si trasforma in una caratteristica del personaggio, via via sempre più accentuata nel vario sviluppo del racconto. Infatti, se all Inferno Virgilio appare guida (quasi) sempre sicura di sé, e ostenta superiorità morale rispetto al mondo di vizio e di dannazione che egli attraversa insieme a Dante, in Purgatorio la sua posizione si farà sempre più scomoda e le sue emozioni più ambigue. Egli infatti si troverà di fronte ad anime destinate a un futuro di salvezza che a lui, pagano, rimane negato. E negato solo per un accidente cronologico: per avere avuto la sfortuna di nascere nel tempo de li dèi falsi e bugiardi, prima cioè della venuta di Cristo. Di fronte alla rivelazione che la misteriosa figura apparsa dal nulla è Virgilio, Dante è sopraffatto dalla sorpresa e da un senso di vergogna: che emozione, trovarsi improvvisamente davanti al suo idolo letterario! E infatti, le sue prime parole sembrano quasi dimenticare le drammatiche circostanze in cui egli si trova, per riconoscere innanzitutto la grandezza del poeta antico: fiume di eloquenza, onore e lume di ogni altro poeta e oggetto di idolatrica ammirazione da parte di Dante, che si è rovinato gli occhi sulla sua Eneide; infine, maestro e modello di stile per le rime già composte da Dante stesso, e che gli hanno già procurato onorata reputazione. E qui occorrerà una precisazione. In che senso Virgilio può essere stato maestro di stile per Dante? Non dimentichiamoci che siamo nell anno 1300 e che Dante, per ora, ha composto essenzialmente la Vita nuova e altre rime di carattere amoroso e morale. Si tratta di opere quindi molto lontane da quelle di Virgilio che, oltre all Eneide, resta famoso per il suo poema agricolo, le Georgiche, e per le sue egloghe pastorali (Bucoliche). Eppure Dante parla di un bello stilo di cui il poeta latino gli è stato maestro. Bisogna allora intendere che Dante si riferisca non al contenuto della poesia, né ai generi letterari praticati, ma al livello stilistico dell espressione poetica: evidentemente egli sente di dovere a Virgilio l esempio di uno stile alto, nobile, adatto a sentimenti profondi e a tematiche comunque impegnative. Virgilio ha indicato a Dante, insomma, l altezza di stile a cui egli ha sempre aspirato a conformarsi. I
Dante Inferno I canto
 Times New Roman Font ImpReading Font Dante Inferno I canto Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta
Times New Roman Font ImpReading Font Dante Inferno I canto Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta
DANTE INFERNO canto 1. DANTE INFERNO canto 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.
 Arial Font DANTE INFERNO canto 1 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra
Arial Font DANTE INFERNO canto 1 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra
La selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita.
 LUCA CURCIO 3D 1999-2000, Steiner Dante Alighieri La selva oscura Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita. Dante a trentacinque anni si trova
LUCA CURCIO 3D 1999-2000, Steiner Dante Alighieri La selva oscura Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era smarrita. Dante a trentacinque anni si trova
IN VIAGGIO CON DANTE
 IN VIAGGIO CON DANTE LA SELVA OSCURA E IL BENE CHE DANTE VI HA TROVATO Io non so ben ridir com i v intrai, tant era piendi sonno a quel punto che la verace via abbandonai Ma proprio in quella selvaselvaggia
IN VIAGGIO CON DANTE LA SELVA OSCURA E IL BENE CHE DANTE VI HA TROVATO Io non so ben ridir com i v intrai, tant era piendi sonno a quel punto che la verace via abbandonai Ma proprio in quella selvaselvaggia
DIVINA COMMEDIA COMMENTO. Canto I RAUCCI BIAGIO. 15 febbraio 2014
 DIVINA COMMEDIA COMMENTO Canto I RAUCCI BIAGIO 15 febbraio 2014 IL primo canto della Commedia serve da prologo all intero poema, e non a caso può considerarsi fuori numerazione, all interno del sistema
DIVINA COMMEDIA COMMENTO Canto I RAUCCI BIAGIO 15 febbraio 2014 IL primo canto della Commedia serve da prologo all intero poema, e non a caso può considerarsi fuori numerazione, all interno del sistema
Inferno. La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri. con le splendide illustrazioni di Gustave Doré
 Inferno La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri con le splendide illustrazioni di Gustave Doré Libro e audiolibro Acquista il libro completo in versione cartacea o digitale: www.caffescuola.com/inferno-libro-e-audiolibro/
Inferno La prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri con le splendide illustrazioni di Gustave Doré Libro e audiolibro Acquista il libro completo in versione cartacea o digitale: www.caffescuola.com/inferno-libro-e-audiolibro/
Opere di Dante. Convivio E un opera nella quale Dante esalta la filosofia e la sapienza. E composto da prose e poesie.
 Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
Contesto storico L epoca in cui vive Dante (XIII secolo) è caratterizzata da profonde contraddizioni e contrasti tra le tre grandi forze che dominano l Europa: il papato, l impero e i Comuni. La Chiesa
Dante Alighieri. La Commedia II C
 Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
Dante Alighieri La Commedia STRUTTURA 14.223 endecasillabi in 100 canti 3 cantiche di 33 canti l una (+ 1 introduttivo) metro: terzina a rima incatenata ABA-BCB-CDC simmetria costruita sulla combinazione
BOTTICELLI PITTORE DELLA DIVINA COMMEDIA
 Divina Commedia illustrata da Sandro Botticelli fac-simile 29 la voragine infernale 30 Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dante e Virgilio
Divina Commedia illustrata da Sandro Botticelli fac-simile 29 la voragine infernale 30 Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dante e Virgilio
 DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10
 L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
L ANNUNCIO DI PASQUA Luca 24, 1-10 Arcabas - Chiesa della Risurrezione - Comunità Nazareth - Torre de Roveri (Bg) Buio e luce Di buon mattino.... Sul fondo della valle la notte lotta contro il giorno.
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
CANTO 1 DELL inferno
 CANTO 1 DELL inferno Il cronotopo Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. La metà ideale della vita sono i 35 anni: siamo nel 1300, il primo
CANTO 1 DELL inferno Il cronotopo Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. La metà ideale della vita sono i 35 anni: siamo nel 1300, il primo
Il biglietto di sola andata
 Il biglietto di sola andata Daniela Demontis IL BIGLIETTO DI SOLA ANDATA racconto www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Daniela Demontis Tutti i diritti riservati A mia madre, perché il modo migliore
Il biglietto di sola andata Daniela Demontis IL BIGLIETTO DI SOLA ANDATA racconto www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Daniela Demontis Tutti i diritti riservati A mia madre, perché il modo migliore
La spiritualità dell animatore. Giacomo Prati
 + La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
+ La spiritualità dell animatore Giacomo Prati + La spiritualità dell animatore Ponte tra Dio ed i ragazzi + Cos è la spiritualità? La spiritualità è fare esperienza di Dio, un modo per essere cristiani
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina?
 Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità
 Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità primo giorno Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Novena all Immacolata Concezione si recita dal 29 novembre al 7 dicembre o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità primo giorno Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL
 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
Le poesie del divino amore
 Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
DANTE ALIGHIERI INFERNO
 DANTE ALIGHIERI INFERNO STRUTTURA Vestibolo e 9 cerchi Peccatori divisi secondo tre disposizioni al vizio individuate da Aristotele nell'etica nicomachea: incontinenza, malizia e la matta /bestialitade
DANTE ALIGHIERI INFERNO STRUTTURA Vestibolo e 9 cerchi Peccatori divisi secondo tre disposizioni al vizio individuate da Aristotele nell'etica nicomachea: incontinenza, malizia e la matta /bestialitade
Parrocchia Maria Ss. Immacolata. Pontecagnano Faiano (Sa) Aspettando il Natale
 Parrocchia Maria Ss. Immacolata Pontecagnano Faiano (Sa) Aspettando il Natale LA CORONA DELL AVVENTO Una tradizione che i bambini non dimenticheranno La Corona dell Avvento è una bella tradizione per preparare
Parrocchia Maria Ss. Immacolata Pontecagnano Faiano (Sa) Aspettando il Natale LA CORONA DELL AVVENTO Una tradizione che i bambini non dimenticheranno La Corona dell Avvento è una bella tradizione per preparare
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO
 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO Anno scolastico 2013-2014 Perché questo progetto? Per il semplice motivo che l amicizia rimane uno dei valori più nobili dell essere umano. L uomo è per sua
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CLIC SUL MONDO Anno scolastico 2013-2014 Perché questo progetto? Per il semplice motivo che l amicizia rimane uno dei valori più nobili dell essere umano. L uomo è per sua
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno
 Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA. del.
 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
Giuliani. Santa. via Crucis con. eronica 2,00. «La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore,
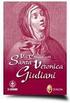 «La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore, misericordia, perdono. La parola della croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire
«La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo, una parola che è amore, misericordia, perdono. La parola della croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire
C R I S T I A N E S I M O
 CRISTIANESIMO «La fede domanda» Il 22 febbraio ricorre l anniversario della morte di don Luigi Giussani. Ricordandolo con gratitudine e speranza, pubblichiamo alcune sue frasi sulla preghiera. Si potrebbero
CRISTIANESIMO «La fede domanda» Il 22 febbraio ricorre l anniversario della morte di don Luigi Giussani. Ricordandolo con gratitudine e speranza, pubblichiamo alcune sue frasi sulla preghiera. Si potrebbero
PASSI BIBLICI DIFFICILI
 Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
Anselm Grün PASSI BIBLICI DIFFICILI Interpretati in chiave spirituale Queriniana Introduzione La Bibbia è la base essenziale del cristianesimo. E a volte non è per niente facile. Nel l Antico Testamento,
PREGHIERA DELL ARCIVESCOVO METROPOLITA ALLA MADONNA DELLE ROSE. Chiesa Parrocchiale di S. Vittoria in Carsoli, 21 Agosto 2010
 PREGHIERA DELL ARCIVESCOVO METROPOLITA ALLA MADONNA DELLE ROSE Chiesa Parrocchiale di S. Vittoria in Carsoli, 21 Agosto 2010 1. O Madonna delle Rose ci rivolgiamo a Te, oggi, nel giorno della Tua festa.
PREGHIERA DELL ARCIVESCOVO METROPOLITA ALLA MADONNA DELLE ROSE Chiesa Parrocchiale di S. Vittoria in Carsoli, 21 Agosto 2010 1. O Madonna delle Rose ci rivolgiamo a Te, oggi, nel giorno della Tua festa.
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
secondo i nuovi programmi
 Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese il nuovo LETTERATURA STORIA immaginario secondo i nuovi programmi Antologia della Commedia a cura di Graciela Müller Pozzebon E 27 canti corredati
Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese il nuovo LETTERATURA STORIA immaginario secondo i nuovi programmi Antologia della Commedia a cura di Graciela Müller Pozzebon E 27 canti corredati
LITANIE MARIANE DOMENICANE. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi
 LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
Il signor Rigoni DAL MEDICO
 5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
5 DAL MEDICO Per i giornali, Aristide Rigoni è l uomo più strano degli ultimi cinquant anni, dal giorno della sua nascita. È un uomo alto, forte, con due gambe lunghe e con una grossa bocca. Un uomo strano,
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci
 Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
Presentazione realizzata dalla docente Rosaria Squillaci Presentazione dei canti a cura dei bambini di classe prima. Canti per coro e solisti eseguiti dagli alunni di seconda,
L amore che il Padre ha per noi è lo stesso che scorre anche nel cuore di Gesù
 Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Il Padre ci ha tanto amato, tanto ci ama ora, da dare il suo Figlio per noi, perché avessimo la vita. Quale grande amore ha Dio Padre per noi
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Il Padre ci ha tanto amato, tanto ci ama ora, da dare il suo Figlio per noi, perché avessimo la vita. Quale grande amore ha Dio Padre per noi
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
Francesco Petrarca ( )
 Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
La maschera del cuore
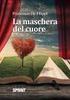 La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
INFERNO, la figura di Ulisse e gli ultimi peccatori
 INFERNO, la figura di Ulisse e gli ultimi peccatori INFERNO, CANTO XXVI In questo canto Dante incontra Ulisse ULISSE è...(descrizione) È un canto molto importante perchè : Descrive l immaginario incontro
INFERNO, la figura di Ulisse e gli ultimi peccatori INFERNO, CANTO XXVI In questo canto Dante incontra Ulisse ULISSE è...(descrizione) È un canto molto importante perchè : Descrive l immaginario incontro
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio
 LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
LA DIVINA COMMEDIA Prof.ssa Bosisio È UN OPERA FONDAMENTALE DELLA LETTERATURA ITALIANA: Si fondono (uniscono) in una sintesi straordinaria tutti gli aspetti del sapere medievale. Affronta temi e argomenti
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
Informazioni riguardanti l anno accademico 2015/2016 CALENDARIO
 Informazioni riguardanti l anno accademico 2015/2016 CALENDARIO GIUGNO 2015 1 L 2 M FESTA DELLA REPUBBLICA 3 M 4 G 5 V 6 S 7 D CORPUS DOMINI 8 L Esami Inizio degli esami - Sessione Estiva 9 M Esami 10
Informazioni riguardanti l anno accademico 2015/2016 CALENDARIO GIUGNO 2015 1 L 2 M FESTA DELLA REPUBBLICA 3 M 4 G 5 V 6 S 7 D CORPUS DOMINI 8 L Esami Inizio degli esami - Sessione Estiva 9 M Esami 10
all uomo il Mistero, la Storia della Salvezza. La risposta dell uomo è ascolto e docilità. La Lectio Divina ha quindi una sua dinamica: è ascolto,
 Presentazione «Quando, lo scorso anno, mi decisi per un serio cammino spirituale, il mio direttore spirituale mi condusse alla Lectio Divina quotidiana. Ero scettica ma lo feci fedelmente. Oggi posso testimoniare
Presentazione «Quando, lo scorso anno, mi decisi per un serio cammino spirituale, il mio direttore spirituale mi condusse alla Lectio Divina quotidiana. Ero scettica ma lo feci fedelmente. Oggi posso testimoniare
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE
 SOLTANTO ABBI FEDE - 72 - GUIDA PASTORALE 2012/13 GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e resta il segno della Croce. È una professione,
SOLTANTO ABBI FEDE - 72 - GUIDA PASTORALE 2012/13 GESTI E ATTEGIAMENTI DI FEDE: IL SEGNO DELLA CROCE Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e resta il segno della Croce. È una professione,
X AGOSTO. Giovanni Pascoli
 X AGOSTO Giovanni Pascoli INFORMAZIONI GENERALI SULLA POESIA Scritta da Pascoli nel 1896 Appartiene alla raccolta MYRICAE La poesia è composta da 6 quartine con schema ABAB Il titolo ha un rapporto diretto
X AGOSTO Giovanni Pascoli INFORMAZIONI GENERALI SULLA POESIA Scritta da Pascoli nel 1896 Appartiene alla raccolta MYRICAE La poesia è composta da 6 quartine con schema ABAB Il titolo ha un rapporto diretto
LOU PRIOLO. La rabbia nel cuore. Un aiuto pratico per la prevenzione e la cura della rabbia nei bambini. La famiglia cristiana
 LOU PRIOLO La rabbia nel cuore Un aiuto pratico per la prevenzione e la cura della rabbia nei bambini La famiglia cristiana ISBN 978-88-88747-89-7 Titolo originale: The Heart of Anger. Practical Help for
LOU PRIOLO La rabbia nel cuore Un aiuto pratico per la prevenzione e la cura della rabbia nei bambini La famiglia cristiana ISBN 978-88-88747-89-7 Titolo originale: The Heart of Anger. Practical Help for
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti
 Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia
 Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
Ambito di contenuto. Poesia FARE POESIA
 Destinatari Competenza Ambito di contenuto Contenuto Classe II Scuola Secondaria di primo grado Ricercare strategie per comporre testi poetici Poesia Fare poesia FARE POESIA Introduzione Tra la Prosa e
Destinatari Competenza Ambito di contenuto Contenuto Classe II Scuola Secondaria di primo grado Ricercare strategie per comporre testi poetici Poesia Fare poesia FARE POESIA Introduzione Tra la Prosa e
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
365 Volte NON TEMERE
 365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
portfolio Tanti tempi, una storia Antonio Brancati Trebi Pagliarani La Nuova Italia Progetto grafico e copertina: Mediastudio, Firenze
 La Nuova Italia Coordinamento editoriale: Francesca Magazzini Coordinamento redazionale: Daniela Francalanci Progetto grafico e copertina: Mediastudio, Firenze Redazione: Daniela Francalanci, Daniela Murgia
La Nuova Italia Coordinamento editoriale: Francesca Magazzini Coordinamento redazionale: Daniela Francalanci Progetto grafico e copertina: Mediastudio, Firenze Redazione: Daniela Francalanci, Daniela Murgia
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA
 CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CLASSI PRIMA SECONDA E TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA INDICATORI DI COMPETENZA PER
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CLASSI PRIMA SECONDA E TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA INDICATORI DI COMPETENZA PER
BENVENUTO IO HO UNA GIOIA NEL CUORE
 Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Grido di Vittoria.it
 LA PREGHIERA ARMA POTENTE IN DIO Infatti, anche se noi camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le
LA PREGHIERA ARMA POTENTE IN DIO Infatti, anche se noi camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le
5 gennaio Liturgia del giorno
 5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
Violetta di campo. È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo
 Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,
LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA
 JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
JEAN DANIÉLOU LA TRINITÀ E IL MISTERO DELL ESISTENZA Postfazione all edizione italiana di Piero Coda terza edizione Queriniana Premessa alla seconda edizione L accoglienza riservata a questo libriccino
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE. 27/10/2010 Parrocchia "Maria Ss. Assunta" - Biccari
 SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
SIMBOLOGIA DELL APOCALISSE 1 I simboli dell Apocalisse non sono nuovi nuovi ma sono presi dall A.T. soprattutto dal profeta Daniele. 1. Cfr. Dn 7: le 4 grandi bestie che salivano dal mare 2. Cfr. Ap 13,1.11:
CAPITOLO I. 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1?
 ESERCIZI FACILITATI IL FRANKENSTEIN PICCOLO PRINCIPE CAPITOLO I 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1? 3. Come reagivano
ESERCIZI FACILITATI IL FRANKENSTEIN PICCOLO PRINCIPE CAPITOLO I 1. Che cosa rappresentavano i due disegni fatti dal bambino? 2. Perché nessuno capiva il significato del disegno numero 1? 3. Come reagivano
Sogno di una speranza
 Sogno di una speranza Susanna Nicoletti SOGNO DI UNA SPERANZA poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Susanna Nicoletti Tutti i diritti riservati A volte vorrei cambiare tutto A volte vorrei non
Sogno di una speranza Susanna Nicoletti SOGNO DI UNA SPERANZA poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Susanna Nicoletti Tutti i diritti riservati A volte vorrei cambiare tutto A volte vorrei non
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
Lodi di Dio Altissimo
 Lodi di Dio Altissimo Tu sei Santo, Signore Dio Fai cose grandi, meravigliose, Tu sei il Bene, il sommo bene, Tu sei il Signore onnipotente Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l Altissimo, Onnipotente,
Lodi di Dio Altissimo Tu sei Santo, Signore Dio Fai cose grandi, meravigliose, Tu sei il Bene, il sommo bene, Tu sei il Signore onnipotente Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l Altissimo, Onnipotente,
Programma di italiano
 ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. S.BANDINI SIENA Programma di italiano Antologia: TITOLO = SCRITTORI e SCRITTURE Poesia e Teatro AUTORE = A. De Simone C. Gusmini EDIZIONE = Le Monnier La poesia: Gli strumenti
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2016/2017 Classe Prima INDICATORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.
 EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
Lu c i a n o Ma n i c a r d i è nato a Campagnola Emilia (RE) il 26 novembre Laureato in Lettere indirizzo Classico presso l Università degli
 Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
La Vocazione. Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016
 Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
Preghiera Ma.Gi. del 21 ottobre 2016 La Vocazione Iniziamo il percorso di preghiera 2016-2017 della Fraternità dei Ma.Gi., seguendo il tema delle vocazioni; religiose, sacerdotali, familiari, rispondono
RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI
 RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI 41. Quando il penitente si presenta per fare la sua confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali. 42. Quindi
RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI 41. Quando il penitente si presenta per fare la sua confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali. 42. Quindi
Una delle più classiche è quella della donna giovane e bella, in. abbigliamento belle epoque che convive con una donna anziana, dal naso e dai
 Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
LietoColle Michelangelo Camelliti. pordenonelegge Gian Mario Villalta ~ 7 ~ Gian Mario Villalta, Telepatia, pordenonelegge.
 La Gialla nata dall intuizione e dalla passione condivisa di LietoColle e pordenonelegge per la poesia non lascia e raddoppia: dopo due anni di valorizzazione di giovani poete e poeti, trova origine nel
La Gialla nata dall intuizione e dalla passione condivisa di LietoColle e pordenonelegge per la poesia non lascia e raddoppia: dopo due anni di valorizzazione di giovani poete e poeti, trova origine nel
LA SCUOLA IN FESTA. DESTINATARI Tutti gli alunni dell Istituto. TEMPO DI REALIZZAZIONE Intero anno scolastico
 LA SCUOLA IN FESTA PREMESSA Anche durante l anno 2014/2015, la PROGETTAZIONE scolastica vedrà la realizzazione di MANIFESTAZIONI che potranno arricchire l offerta formativa e favorire il raggiungimento
LA SCUOLA IN FESTA PREMESSA Anche durante l anno 2014/2015, la PROGETTAZIONE scolastica vedrà la realizzazione di MANIFESTAZIONI che potranno arricchire l offerta formativa e favorire il raggiungimento
Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio
 Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio ed Egli stesso fece alcuni apostoli; altri, profeti, ad altri ancora, evangelisti; altri, pastori e maestro al fine di perfezionare i santi per
Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio ed Egli stesso fece alcuni apostoli; altri, profeti, ad altri ancora, evangelisti; altri, pastori e maestro al fine di perfezionare i santi per
RICEVI LO SPIRITO SANTO
 RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il
 Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il bambino a pregare il Rosario in famiglia. 36 1 Credo in un
Pregare il Rosario, è cogliere dal giardino del proprio cuore delle belle rose per offrirle a Maria. Questo opuscolo ha lo scopo di aiutare il bambino a pregare il Rosario in famiglia. 36 1 Credo in un
OMELIA : NOTTE DI NATALE
 OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Traguardi delle competenze L alunno: Riconosce che la Bibbia
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Traguardi delle competenze L alunno: Riconosce che la Bibbia
Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio
 Ragno magico 11 Germana Bruno Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio e non il pelo Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it www.narrativaracne.it info@aracneeditrice.it via
Ragno magico 11 Germana Bruno Pierino e il lupo A volte il lupo perde il vizio e non il pelo Copyright MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it www.narrativaracne.it info@aracneeditrice.it via
Liceo G. Galilei Trento
 Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA
 Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA DALL ETICA VITA SOCIALE VITA PRIVATA
 PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)
1 Novembre - TUTTI I SANTI
 1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO
 III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
Il numero della Bestia
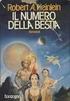 6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
Raccontar storie per dire esperienze
 Raccontar storie per dire esperienze - Raccontare storie è esperienza comune presso tutti i popoli e culture: poemi epici, miti, fiabe, racconti edificanti - dicono spezzoni di cultura e di vita, e rivestono
Raccontar storie per dire esperienze - Raccontare storie è esperienza comune presso tutti i popoli e culture: poemi epici, miti, fiabe, racconti edificanti - dicono spezzoni di cultura e di vita, e rivestono
Barbara Pozzo. La vita che sei. varia
 Barbara Pozzo La vita che sei varia Proprietà letteraria riservata 2014 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-07690-6 Prima edizione BUR settembre 2014 Realizzazione editoriale: Langue&Parole, Milano
Barbara Pozzo La vita che sei varia Proprietà letteraria riservata 2014 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-07690-6 Prima edizione BUR settembre 2014 Realizzazione editoriale: Langue&Parole, Milano
generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA
 generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA Testi di Carmelo Sambugar rivisti e aggiornati da Marta Sambugar e Gabriella Salà. 2004 RCS Libri S.p.A., Milano 1 a edizione: gennaio 2004 Coordinamento
generi autori opere temi RCS LIBRI EDUCATION SPA Testi di Carmelo Sambugar rivisti e aggiornati da Marta Sambugar e Gabriella Salà. 2004 RCS Libri S.p.A., Milano 1 a edizione: gennaio 2004 Coordinamento
