Qualità dell aria interna. arch. Sciurpi Fabio Dipartimento di Tecnologie dell Architettura e Design Pierluigi Spadolini Università di Firenze
|
|
|
- Bonifacio Filippi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Qualità dell aria interna arch. Sciurpi Fabio Dipartimento di Tecnologie dell Architettura e Design Pierluigi Spadolini Università di Firenze
2 Lo sviluppo sostenibile Le tematiche ambientali (ambiente esterno ed ambiente interno di vita delle persone) stanno guadagnando un ruolo decisamente di rilievo in riferimento ai target di sviluppo dell ambiente antropizzato. Lo sviluppo non può più prescindere da alcune priorità: - preservare e riqualificare gli ambienti ove l uomo interviene, - proteggere la salute delle persone, - preservare l uso delle risorse non rinnovabili, - ottimizzare lo sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili, Adottare uno Sviluppo Sostenibile. Lo sviluppo sostenibile rappresenta una forma di sviluppo non solo economico ma anche sociale dove la crescita economica avviene entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future; si propone quindi di conciliare lo sviluppo economico con l ambiente.
3 I principi di sostenibilità ambientale La gestione di questo complesso sistema di relazioni deve passare attraverso la definizione di principi di sostenibilità ambientale. PROTEZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SITO su cui sorge il complesso; questa sensibilità verso l ecosistema si traduce in una doppia linea di intervento: la protezione e riqualificazione dell ecosistema e il rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche dell area. PROTEZIONE DELLA SALUTE, intesa sia come valorizzazione delle potenzialità del microclima locale che come miglioramento della qualità ambientale degli edifici. GESTIONE DELLE RISORSE tramite l'adozione di una politica consapevole che preservi le risorse disponibili (aria, acqua, suolo, materiali, energia) e mediante l adozione di una politica energetica consapevole che massimizzi in primo luogo lo sfruttamento passivo delle risorse ma anche in maniera attiva l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
4 Sostenibilità e IAQ. La committenza richiede al progettista una maggiore attenzione verso la salvaguardia dell ambiente e l implementazione delle condizioni di comfort e fruibilità degli spazi => sviluppo sostenibile. Il progettista deve essere consapevole che la progettazione e la costruzione di edifici risulta essere un processo che ha lo scopo di offrire un prodotto finale di qualità, alla definizione del quale intervengono diverse figure specialistiche (sociologia, economia, ingegneria, ecc.) PROGETTAZIONE INTEGRATA La progettazione sostenibile dell ambiente costruito non può più prescindere dal considerare il problema della qualità dell aria interna come prioritario (richiesta sia dalle normative esistenti sia dalla committenza). Il problema della qualità dell aria interna va considerato fin dalle prime fasi del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, e deve necessariamente coinvolgere tutte le fasi di progettazione, realizzazione, utilizzo e dismissione dell edificio.
5 Benessere ambientale dell individuo Rappresenta la soddisfazione dell'utente nei confronti dell ambiente indoor in cui si trova; è determinato da condizioni fisiologiche e psicologiche che sono funzione dei valori assunti da un insieme di grandezze fisiche (luce, t, UR, ecc.) relative all ambiente. La sensazione di benessere è condizionata da fattori ambientali esterni (clima, sito), fattori ambientali interni (tipo di edificio e gestione), fattori individuali soggettivi (età, sesso, stato fisico e psichico, metabolismo, periodo della giornata, usi e abitudini, ecc.). Nella progettazione ci si riferisce ad una fascia rappresentativa (individuo medio sano nel corpo e nella mente). La qualità ambientale in una edificio fa riferimento a classi differenti, seppure fortemente interrelate, di comfort ambientale, e cioè: benessere termoigrometrico benessere respiratorio olfattivo benessere illuminotecnico benessere acustico..
6 . Benessere termoigrometrico Stato di neutralità termica, in cui il soggetto non sente né caldo né freddo. Benessere respiratorio olfattivo (Qualità dell'aria Interna) Stato di soddisfazione degli occupanti l ambiente confinato nei confronti dell'aria che respirano, in cui non sono presenti inquinanti in concentrazioni ritenute nocive per la salute dell uomo (ASHRAE 62/1999). Benessere illuminotecnico Può essere definito attraverso le condizioni che permettono all occhio di svolgere nel modo migliore i diversi compiti (attività) che è chiamato ad assolvere (visione generica, rilievo dei contrasti di luminosità e di colore, capacità di distinguere oggetti piccoli e lontani, capacità di osservare oggetti in movimento e di consentire percezioni in tempi brevi, ecc.). Benessere acustico Benessere acustico Condizione psicofisica in corrispondenza della quale un individuo, in presenza di un campo di pressione sonora (rumore), dichiara di trovarsi un una situazione di benessere, tenuto conto anche della particolare attività che sta svolgendo.
7 I.A.Q. alcuni concetti di base La qualità dell aria che respiriamo è di fondamentale importanza ai fini del benessere e della salute delle persone negli ambienti confinati. A tal fine è importante che l aria non sia inquinata Inquinamento interno Inquinamento interno Qualsiasi alterazione delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche dell aria, determinata sia da variazioni di concentrazione dei suoi normali costituenti sia e soprattutto, dalla presenza di sostanze estranee alla sua composizione normale in grado di determinare effetti di danno e/o molestia all uomo (Ministero dell Ambiente, 1991)
8 Breve storia. studio aria esterna in seguito al manifestarsi di patologie correlate all ambiente costruito, l attenzione si è rivolta all ambiente interno Building Related Illness (BRI) vere malattie le cui cause sono correlate all edificio (febbre da umidificatore, legionellosi, tumore dovuto al radon, ecc.) Sick Building Sindrome (SBS) insieme di sintomi generali (mal di testa, difficoltà di concentrazione, irritazione degli occhi, senso di malessere generale) che colpiscono la maggioranza delle persone che soggiornano in determinati edifici; i sintomi spariscono abbandonando l edificio. Cause dovute ad un senso di insoddisfazione generalizzato dell edificio cui concorrono fattori diversi (inquinamento dell aria interna, condizioni microclimatiche, illuminazione, rumore, stress, ecc.) studi hanno rilevato livelli di inquinamento interno >> esterno SORGENTI INTERNE
9 Principali cause. politiche di risparmio energetico uso di nuovi materiali di derivazione chimica contenenti sostanze nocive scarsa attenzione progettuale alle soluzioni tecniche diverse abitudini di vita delle persone, che tendono a trascurare le normali operazioni di pulizia uso di prodotti che aumentano il carico inquinante (deodoranti, insetticidi, ecc.) le persone passano l 80% del loro tempo in ambienti confinati
10 Principali effetti sull uomo uomo. Funzione della concentrazione dell inquinante, del tempo di esposizione dell individuo (dose), della suscettibilità e del tipo di sostanza; Il potere nocivo di un singolo inquinante viene potenziato dall associazione con altre sostanze (sinergia) Effetti irritativi su cute e mucose (laringiti, congiuntiviti,eritemi) Effetti sul sistema nervoso (emicranie) Effetti sensoriali (bruciore alla gola, lacrimazione, effetti neuropsichici) Effetti sul sistema riproduttivo cardiovascolare, gastrointestinale Effetti genotossici (alterazione delle cellule, cancro) Effetti respiratori (asma, allergie, bronchiti, infezioni)
11 Inquinanti dell aria indoor di natura chimica di natura fisica Biossido e monossido di carbonio (CO 2 CO) Biossido di azoto e di zolfo (NO 2 SO 2 ) Ozono (O 3 ) Composti Organici Volatili (VOC) Fumo di tabacco (ETS) Pesticidi (Pentoclorofenolo, ecc.).. Radiazioni ionizzanti: radon Radiazioni non ionizzanti Fibre minerali artificiali (lana di vetro e roccia) Fibre minerali naturali (amianto) Polveri.. di natura microbiologica Virus e batteri Funghi e muffe Pollini Acari..
12 Principali sorgenti degli inquinanti negli ambienti confinati Ambiente esterno Componenti dell edificio Attività degli occupanti
13 Descrizione, sorgenti ed effetti sulla salute dei principali inquinanti/1 Ventilazione degli ambienti Filtrazione aria esterna - filtri ad assorbimento Ventilazione degli ambienti - UNI CIG Rimozione della fonte Aspirazione forzata dell inquinante Ventilazione degli ambienti Uso materiali basso emissivi Filtrazione aria esterna - filtri ad assorbimento Corretta posa in opera Ventilazione degli ambienti Uso materiali basso emissivi Filtrazione dell aria Riduzione superfici assorbenti Ventilazione degli ambienti Materiali e Tecniche costruttive Pulizia ambienti (UV) manutenzione HVAC
14 Descrizione, sorgenti ed effetti sulla salute dei principali inquinanti/2 Inquinante Anidride solforosa (SO 2 ) Pentacloro fenolo ed altri biocidi (Ddt) Piombo ed altri metalli pesanti Descrizione Gas incolore, odore pungente, derivante dalla combustione di materiali contenenti zolfo (cherosene, olio) VOC con alta persistenza in ambiente, scarsa biodegradabilità; usato per trattamenti antiparassitari di legno, tessuti, nell industria conciaria, della carta, delle vernici (antimuffa) Piombo, Cromo, Manganese, Cadmio, Mercurio Sorgente impianti di riscaldamento, scarichi di auto, attività industriali Materiali per edilizia e arredamento trattati contro funghi ed insetti, tarmicidi per guardaroba, insetticidi e prodotti per l igiene della casa Vernici, smalti, prodotti di finitura, materiali in PVC, fumo di sigaretta, scarichi di auto Effetti Effetto irritante su mucose, occhi, naso, gola Effetto irritante su mucose, cute che può degenerare in forme tumorali Alterazioni sistema nervoso centrale, apparato digerente Ventilazione degli ambienti Filtrazione dell aria esterna - filtri ad assorbimento Uso materiali basso emissivi Corretto uso del prodotto Stoccaggio in ambienti chiusi lontani da alimenti Ventilazione degli ambienti No tarmicidi sintetici-canfora naturale, propoli, prodotti vegetali Uso materiali esenti da Pb Fibre minerali naturali (amianto) Basso λ, resistente agenti chimici e fuoco; fibre aerodinamiche e bassa velocità di sedimentazione; aerodisperse dal degrado dell amianto e poi inalate attraverso la respirazione Materiali da costruzione isolanti e antincendio (cemento amianto per tetti, tubazioni acqua, pavimenti), vernici antifiamma, rivestimenti condotti di aerazione Fibre inalate provocano tumori Rimozione (rifiuti speciali) Incapsulamento Fibre minerali artificiali Silicati che si presentano in fibre Lana di roccia, lana di vetro, materiali fibrosi, feltri Irritazioni di cute, mucose, occhi, prime vie respiratorie Evitare materiali fibrosi liberi o usarli confinati (muri)
15 Catena di decadimento del radon Il Radon a contatto con l aria decade rapidamente formando altri prodotti radioattivi (figli( del radon) che si possono attaccare alla polvere e formare un aerosol radioattivo respirabile. Durante tale decadimento vengono emesse particelle α, β e raggi γ (radiazioni ionizzanti).
16 Le sorgenti principali di radon FATTORI CHE INFLUISCONO SUL RADON INDOOR: Diffusione interna: le aperture attraverso i piani favoriscono la distribuzione del gas ad opera di correnti d aria calda, più leggera, che tende a risalire verso l alto SUOLO MATERIALI DA COSTRUZIONE ACQUA - caratteristiche del suolo - permeabilita dei suoli - tipologia di costruzione - stile di vita degli occupanti -condizioni metereologiche - microclima interno
17 Unità di misura dell inquinamento indoor ppm = parti per milione µg/m 3 = microgrammi su m 3 di aria CFU/m 3 = unità formanti colonie per m 3 Bq/m 3 = bequerel su m 3 fibre/litro
18 .. come si può definire l accettabilitl accettabilità dell aria interna? la qualità dell aria interna è considerata accettabile quando in essa non sono presenti contaminanti conosciuti in concentrazioni dannose, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti, e rispetto alla quale una notevole quantità di persone, almeno l 80%, non esprime insoddisfazione Standard ASHRAE 62/99 Ventilation for acceptable indoor air quality
19 La normativa: effetti sul comfort (indicativa) Report prenv 1752 Ventilation for Buildings: Design Criteria for the Indoor Environment olf capacità inquinante di una sorgente. Un olf rappresenta il tasso di sostanze inquinanti emesso da una persona normale (adulto, attività sedentaria, condizioni di benessere termico, standard igienico); tutte le sorgenti possono essere espresse in persone equivalenti. 15% 1 decipol decipol Inquinamento dell aria percepito dalle persone. Viene definito come l inquinamento causato da una persona normale (1 olf) in un ambiente con ricambio d aria di 10 l/s.
20 La normativa italiana: effetti sulla salute D.P.R. 246/ 93 Direttiva CEE 89/106 Direttiva CEE 89/106 Prodotti da costruzione Requisito igiene salute ambiente: L edificio deve essere concepito e costruito in modo da non costituire una minaccia per l igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell aria di particelle o di gas pericolosi, dall emissione di radiazioni pericolose, dall inquinamento o dalla contaminazione dell acqua o del suolo, da difetti nell evacuazione delle acque, dei fumi e dei residui solidi o liquidi, e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell opera Tale requisito si applica a tutti i prodotti da costruzione fabbricati al fine di essere incorporati o assemblati in modo permanente nell edificio. Circ. Min. Sanità n. 57/ 83 Concentrazione max ammissibile di Formaldeide: 0,1 ppm Tale limite si applica sia alla nuova edilizia che a quella esistente. L. n. 257/92 Concentrazione max ammissibile di fibre di Amianto: assente Tale limite si applica sia alla nuova edilizia che a quella esistente. Raccomandazione Euratom n. 143/90 Concentraz. max ammissibile di Radon in ambienti chiusi: 400 Bq/m Bq/m 3 DPCM , DM n. 381/1998 Inquinamento elettromagnetico: Valori limite di campo elettrico e magnetico Circ. Min. Sanità n. 23/ 91 Corretto uso delle fibre di vetro isolanti
21 Standard per il controllo della qualità dell aria indoor
22 Materiali e prodotti per l edilizial Rilasciando direttamente sostanze pericolose (VOC, Radon, ecc.); Adsorbendo e poi rilasciando sostanze presenti nell aria e derivanti da altre sostanze; Favorendo l accumulo di sporco e la crescita di microrganismi; Emissione dipende dal materiale stesso (età, superficie emittente, stoccaggio, materiale naturale o artificiale, ecc.), da fattori ambientali (t, UR, ventilazione, ecc.), dalla posizione del materiale, dal volume dell ambiente, dalle modalità di posa in opera, ecc. Materiali ecocompatibili - Requisiti ecologici Durevoli ed idonei all applicazione Non pericolosi in caso di incendio La loro produzione e lavorazione non deve comportare rischi per l ambiente e per i lavoratori Ottenuti da materie prime rigenerabili Prodotti e distribuiti con poco dispendio di energia, acqua ed altre risorse Privi di sostanze tossiche ed inquinanti; salubri e sicuri per gli utenti Applicabili con tecniche sicure per i lavoratori Riutilizzabili, riciclabili o smaltibili senza causare alti impatti ambientali
23 Materiali ecocompatibili Non esistono materiali che rispondano contemporaneamente a tutte queste caratteristiche, quindi la scelta va fatta in base alle priorità che si vogliono avere!! Difficile scelta in quanto dati non sempre certi!! CERTIFICAZIONE Ecolabel marchio di qualità ecologica europeo (Reg. 880/92) Blauer Engel Germania (1978); NF Environnement Francia (1992); Baume Austria (1994); Ecomark Giappone (1988) Ecocerto - Italia (1994) - solo per prodotti da costruzione e impianti degli edifici Marchio ANAB Italia
24 Ciclo di vita dei materiali L analisi del ciclo di vita degli oggetti, dalla culla alla tomba, è indispensabile per fare un bilancio dell impatto che l oggetto causa sull ambiente, dal punto di vista di sfruttamento delle risorse, di inquinamento dell ambiente, ecc. valutato in tutte le fasi, dalla estrazione delle materie prime al trasporto in loco fino alla dismissione ed eventuale riciclaggio. PRODUZIONE DISMISSIONE UTILIZZO Requisiti ecologici ed analisi dell impatto sull ambiente e sulla salute delle persone valutati in ogni fase La durata ed i requisiti ecologici di ogni fase dipendono dal tipo di materiale
25 Alcuni materiali usati in bioedilizia. Laterizio Terra cruda Legno Argilla abbondante in tutte le regioni Trasporti brevi Elevate qualità fisico tecniche Riciclabile per sottofondi di strade, come inerte Smaltibile in discariche per inerti Argilla e sabbia impastate ed essiccate Uso di paglia come inerte Per piccoli o grandi elementi Uso dell argilla del posto Elevate qualità fisico tecniche Basso consumo di energia No problemi per lo smaltimento Materiale naturale, riciclabile Facile lavorazione La produzione non comporta notevole dispendio di energia né emissioni nocive Necessita di trattamenti antiparassitari Sali di boro.
26 . Sughero Granulato o a pannelli Materiale rigenerabile Resina stessa che si produce riscaldando il sughero a 380 C e poi pressandolo usata come legante Attenzione a umidità permanente Riciclabile senza problemi di smaltimento Trucioli di legno demineraliz zati Fibra di cocco (lana) Canna Trucioli + legante (gesso) Rigidi e facilmente lavorabili Elevate qualità fisico tecniche Smaltibili in discarica o riutilizzabili come inerti Emissioni non note Importato Riciclabile e smaltibile Biodegradabile Può essere incenerito Infiammabile protetto (intonacato, ecc.)
27 Il sughero: isolamento " a cappotto" di un solaio al di sopra di un porticato o di una cantina non riscaldata
28 Isolamento in intercapedini con pannelli in sughero 1. Pilastro 2. Cordolo 3. Muro esterno 4. Parete interna 5. Sughero 6. Rete in fibra di vetro 7. Sughero 1cm 8. Intonaco esterno 9. Tubazioni (già fasciate) 10. Sottofondo pavim. 11. Cls. alleggerito con granuli di prodotto a base di sughero Rapidità di messa a regime, perché non è necessario riscaldare tutta la massa per raggiungere condizioni di regime Nella migrazione attraverso la parete il vapore d acqua incontra presto strati a temp. minore con rischi di condensazione all interno della muratura uso di barriera al vapore sulla faccia calda dell isolante muratura non traspirante Ponti termici condensa (temperatura di rugiada) muffe
29 Isolamento a cappotto esterno con pannelli in sughero 1. Finitura 2. Rasatura 3. Rete in fibra di vetro 4. Sughero 5. Pasta adesiva traspirante 6. Intonaco esterno 7. Muro esterno 8. Cordolo solaio 9. Tubazioni (già fasciate) 10. Sottofondo pavim. 11. Cls. alleggerito con granuli di prodotto a base di sughero Eliminazione dei ponti termici Eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale ed interna alla parete Massimo sfruttamento della massa termica della muratura con conseguenti valori maggiori della temp. di parete.
30 Sistema di copertura: Isolamento con pannelli in sughero Isolamento sotto il manto = non risolve il problema dell isolamento dal caldo estivo, in quanto l aumento di temperatura del manto di copertura e quindi dell isolante porta ad una notevole diminuzione delle caratteristiche di isolamento di tutto il pacchetto. Tetto ventilato = nel caso di forte irraggiamento solare la camera di ventilazione, realizzata tra il manto di copertura e lo strato di materiale coibente, consente di smaltire rapidamente il calore accumulato dagli strati superficiali del tetto impedendone la trasmissione verso l interno dell edificio.
31 La qualità dell aria nei musei Danno all uomo Danno ai beni storico artistici
32 Inquinanti ed effetti sugli oggetti
33 Qualità dell aria interna: il controllo
34 Strategie di controllo della iaq Le strategie di bonifica si possono suddividere in due grandi categorie: - tecniche che intervengono sulla fonte inquinante; - tecniche che intervengono sull aria ambiente. Fra le prime si ricordano: la rimozione della fonte, il suo confinamento, l esalazione localizzata, il trattamento della fonte (incapsulamento), la modifica d uso Fra le seconde si ricorda il controllo della ventilazione degli ambienti ed il condizionamento ambientale nonché l adozione di appropriate tecniche di filtrazione dell aria.
35 Incapsulamento dell amianto Incapsulamento mediante spruzzatura di materiali sintetici che solidificano imprigionando al loro interno le fibre. Preferibili i trattamenti caratterizzati da due strati di colore diverso: l affiorare del colore nascosto segnala la necessità di un uovo intervento di manutenzione.
36 Amiche piante Dracaena marginata, Chamaedorea elegans (palmetta), Chlorophytum comosum (falangio), Ficus benjamina formaldeide Gerbera jamesonii, Sanseviera trifasciata, Sphathiphyllum wallissi, Dracaena marginata tricloroetilene e benzene
37 TIPOLOGIE DI VENTILAZIONE: Naturale Meccanica (VMC) Ibrida
38 Sistema di VMC con recupero di calore (mod. Aldes) Ventilazione a doppio flusso con recupero di calore: rinnovo dell'aria a portata costante con recupero delle calorie dell'aria estratta inquinata per preriscaldare l'aria nuova immessa nei locali.
39 Sistema di VMC per abitazione individuale (mod. Aldes) Ventilazione semplice flusso autoregolabile: ricambio dell'aria a portata costante Ventilazione semplice flusso modulata: igroregolabile: rinnovo dell'aria a portata variabile in funzione del tasso di umidità dell'alloggio a rivelazione di occupazione: rinnovo dell'aria a portata variabile in funzione dell'occupazione dei locali.
Qualità ambientale : inquinanti indoor e controllo
 Qualità ambientale : inquinanti indoor e controllo Prof. Ing. Giorgio Raffellini Dip. di Tecnologie dell architettura e Design P. Spadolini Università di Firenze L isolamento termico Utilizzo di vetrocamera
Qualità ambientale : inquinanti indoor e controllo Prof. Ing. Giorgio Raffellini Dip. di Tecnologie dell architettura e Design P. Spadolini Università di Firenze L isolamento termico Utilizzo di vetrocamera
BENESSERE ACUSTICO. Rumore ambientale
 BENESSERE ACUSTICO Rumore ambientale Rumore ambientale fondamentale ai fini del comfort globale e non deve mai essere trascurato nella progettazione degli edifici così come l impatto acustico sul territorio
BENESSERE ACUSTICO Rumore ambientale Rumore ambientale fondamentale ai fini del comfort globale e non deve mai essere trascurato nella progettazione degli edifici così come l impatto acustico sul territorio
VENTILAZIONE
 VENTILAZIONE 1 Sensibilizzare i Professionisti RISPARMIO ENERGETICO Le problematiche attuali: il clima ed il consumo energetico degli edifici COME FARE? Strategie per i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento:
VENTILAZIONE 1 Sensibilizzare i Professionisti RISPARMIO ENERGETICO Le problematiche attuali: il clima ed il consumo energetico degli edifici COME FARE? Strategie per i sistemi di riscaldamento e di raffrescamento:
BELLO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE: Profilegno ha il pavimento PERFETTO
 BELLO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE: Profilegno ha il pavimento PERFETTO Premessa: il comfort abitativo Il Comfort abitativo in edilizia è direttamente legato ai parametri di: CALORE LUMINOSITÀ GIUSTO GRADO
BELLO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE: Profilegno ha il pavimento PERFETTO Premessa: il comfort abitativo Il Comfort abitativo in edilizia è direttamente legato ai parametri di: CALORE LUMINOSITÀ GIUSTO GRADO
Corso avanzato CasaClima per progettisti
 Corso avanzato CasaClima per progettisti Introduzione Modulo 1 Fisica tecnica pratica Modulo 2 Materiali Modulo 3 Tipi di costruzione per una CasaClima Modulo 4 Tecnica degli impianti domestici 1 Modulo
Corso avanzato CasaClima per progettisti Introduzione Modulo 1 Fisica tecnica pratica Modulo 2 Materiali Modulo 3 Tipi di costruzione per una CasaClima Modulo 4 Tecnica degli impianti domestici 1 Modulo
metti al sicuro il tuo Confort abitativo!
 Buono per ogni s tagione metti al sicuro il tuo Confort abitativo! Il piacere di vivere in una casa ben isolata, calda e asciutta, ben protetti ed isolati dall'esterno, quindi il primo, grande vantaggio
Buono per ogni s tagione metti al sicuro il tuo Confort abitativo! Il piacere di vivere in una casa ben isolata, calda e asciutta, ben protetti ed isolati dall'esterno, quindi il primo, grande vantaggio
Report mensile sulla qualita dell aria
 Sezione provinciale di Report mensile sulla qualita dell aria provincia: periodo di riferimento: 01/01/2017 - Stazioni di monitoraggio stazioni di monitoraggio 1 2 3 Flaminia 4 5 2 3 5 1 4 zone Appennino
Sezione provinciale di Report mensile sulla qualita dell aria provincia: periodo di riferimento: 01/01/2017 - Stazioni di monitoraggio stazioni di monitoraggio 1 2 3 Flaminia 4 5 2 3 5 1 4 zone Appennino
6,4 0,1 0, ) B-C IMPIEGO SFUSO: INTERCAPEDINI DI PARETI COPERTURE SOLAI E SOTTOTETTI NON PRATICABILI
 Materiali Isolanti SUGHERO ORIGINE VEGETALE STRUTTURA CELLULARE Buone CAPACITA DI ACCUMULO di calore e PROPRIETA TERMOISOLANTI e ACUSTICHE TRASPIRANTE - SCHERMA le ONDE ELETTROMAGNETICHE. I pannelli sono
Materiali Isolanti SUGHERO ORIGINE VEGETALE STRUTTURA CELLULARE Buone CAPACITA DI ACCUMULO di calore e PROPRIETA TERMOISOLANTI e ACUSTICHE TRASPIRANTE - SCHERMA le ONDE ELETTROMAGNETICHE. I pannelli sono
Valutazione di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale CCA
 Valutazione di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale CCA SCHEDA PRODOTTO: SUBERIT Data compilazione def.: 6/09/2010 A) DATI RELATIVI ALL AZIENDA A.1 Produttore: Peppino Molinas & figli S.p.A.
Valutazione di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale CCA SCHEDA PRODOTTO: SUBERIT Data compilazione def.: 6/09/2010 A) DATI RELATIVI ALL AZIENDA A.1 Produttore: Peppino Molinas & figli S.p.A.
Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause
 Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause degli NOx I principali NOx presenti nell'atmosfera sono
Questa presentazione verterà sugli NOx e in particolare: -cosa sono gli NOx -effetti sulla salute e alla vegetazione -dove si trovano -le concause degli NOx I principali NOx presenti nell'atmosfera sono
TECNOLOGIE PER L EFFICIENTAMENTO DELLE ABITAZIONI LUCA GARELLI Studio Tecnico Garelli, Club Eccellenza Energetica
 Medicina, 22 aprile 2014 TECNOLOGIE PER L EFFICIENTAMENTO DELLE ABITAZIONI LUCA GARELLI Studio Tecnico Garelli, Club Eccellenza Energetica Riqualificare la propria abitazione: incentivi, tecnologie e progetti
Medicina, 22 aprile 2014 TECNOLOGIE PER L EFFICIENTAMENTO DELLE ABITAZIONI LUCA GARELLI Studio Tecnico Garelli, Club Eccellenza Energetica Riqualificare la propria abitazione: incentivi, tecnologie e progetti
RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA
 RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA 1. Obiettivi di progettazione sostenibile. Il progetto del nuovo fabbricato residenziale, in località Cervia, Centro Storico, verrà sviluppato in alcune sue parti secondo
RELAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA 1. Obiettivi di progettazione sostenibile. Il progetto del nuovo fabbricato residenziale, in località Cervia, Centro Storico, verrà sviluppato in alcune sue parti secondo
CHIUSURE VERTICALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
 CHIUSURE VERTICALI In generale si definisce CHIUSURA l insieme delle unità tecnologiche e degli elementi del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio
CHIUSURE VERTICALI In generale si definisce CHIUSURA l insieme delle unità tecnologiche e degli elementi del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio
La Qualità dell aria. Corso di IMPIANTI TECNICI per l EDILIZIAl. Prof. Paolo ZAZZINI Dipartimento INGEO Università G. D AnnunzioD.
 Corso di IMPIANTI TECNICI per l EDILIZIAl La Qualità dell aria Prof. Paolo ZAZZINI Dipartimento INGEO Università G. D AnnunzioD Annunzio Pescara www.lft.unich.it Secondo lo Standard 62/04 ASHRAE: «La qualità
Corso di IMPIANTI TECNICI per l EDILIZIAl La Qualità dell aria Prof. Paolo ZAZZINI Dipartimento INGEO Università G. D AnnunzioD Annunzio Pescara www.lft.unich.it Secondo lo Standard 62/04 ASHRAE: «La qualità
Ruredil. Isolamento termico a cappotto un sistema certificato. Isolamento a cappotto
 Ruredil Isolamento termico a cappotto un sistema certificato Isolamento a cappotto Meglio isolati... Quando si costruisce o si ristruttura un edificio, uno degli aspetti da non sottovalutare è sicuramente
Ruredil Isolamento termico a cappotto un sistema certificato Isolamento a cappotto Meglio isolati... Quando si costruisce o si ristruttura un edificio, uno degli aspetti da non sottovalutare è sicuramente
ARTVERTE ISOLVERTE TRASSVERTE PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI
 ARTVERTE ISOLVERTE TRASSVERTE PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI data ultima revisione 7 aprile 2010 SISTEMISISTEMISISTEMI SYSTEMVERTE KAPVERTE INFISSVERTE 2. Prodotti ARTVERTE Linea di intonaci e finiture naturali
ARTVERTE ISOLVERTE TRASSVERTE PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI data ultima revisione 7 aprile 2010 SISTEMISISTEMISISTEMI SYSTEMVERTE KAPVERTE INFISSVERTE 2. Prodotti ARTVERTE Linea di intonaci e finiture naturali
Qualità dell'aria negli spazi confinati Claudio Buttà Dir. Relazioni Esterne Aldes spa
 Qualità dell'aria negli spazi confinati Claudio Buttà Dir. Relazioni Esterne Aldes spa 1 Principali inquinanti indoor (Fonte: Ministero della Salute, 2001) A VOC (composti organici volatili): benzene,
Qualità dell'aria negli spazi confinati Claudio Buttà Dir. Relazioni Esterne Aldes spa 1 Principali inquinanti indoor (Fonte: Ministero della Salute, 2001) A VOC (composti organici volatili): benzene,
PERCHÉ UN SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON SCAMBIATORE DI CALORE
 Air - Sisthema PERCHÉ UN SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON SCAMBIATORE DI CALORE Oggi a causa dell iperisolamento e della tenuta all aria dei serramenti, l aria confinata favorisce la
Air - Sisthema PERCHÉ UN SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON SCAMBIATORE DI CALORE Oggi a causa dell iperisolamento e della tenuta all aria dei serramenti, l aria confinata favorisce la
Thermo Rock. Lana di roccia. Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico
 Thermo Rock Thermo Rock Lana di roccia Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico La lana di roccia Thermo Rock è un materiale naturale e sostenibile ottenuto dalla roccia vulcanica basaltica.
Thermo Rock Thermo Rock Lana di roccia Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico La lana di roccia Thermo Rock è un materiale naturale e sostenibile ottenuto dalla roccia vulcanica basaltica.
IL COMFORT ABITATIVO
 IL COMFORT ABITATIVO ( sui concetti e sulle definizioni di base ) I RIFERIMENTI NORMATIVI legge 373 del 30/04/76 legge 10 del 09/01/91 direttiva 93/76 CEE del 13/09/93 direttiva 2002/91/CE D.L. 19/08/2005
IL COMFORT ABITATIVO ( sui concetti e sulle definizioni di base ) I RIFERIMENTI NORMATIVI legge 373 del 30/04/76 legge 10 del 09/01/91 direttiva 93/76 CEE del 13/09/93 direttiva 2002/91/CE D.L. 19/08/2005
IUAV - VENEZIA BIBLIOTECA CENTRALE
 IUAV - VENEZIA N 1835 BIBLIOTECA CENTRALE r AS,)S A cura di Carlo M anna eald o Fanchiotti ISTITUTO UN~~R~TEARIO ARCHITETTURA AREA SERVIZ Z I A BI B]. OITB~l~O~AF~I E DOCUMENTALI INV I }D 1 E N T R A L
IUAV - VENEZIA N 1835 BIBLIOTECA CENTRALE r AS,)S A cura di Carlo M anna eald o Fanchiotti ISTITUTO UN~~R~TEARIO ARCHITETTURA AREA SERVIZ Z I A BI B]. OITB~l~O~AF~I E DOCUMENTALI INV I }D 1 E N T R A L
IL RISPARMIO ENERGETICO L USO EFFICIENTE DELLE RISORSE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI LA SALUBRITA DEGLI AMBIENTI
 lo Stato dell Arte orienta il Progetto Sostenibile secondo questi paradigmi di carattere generale IL RISPARMIO ENERGETICO L USO EFFICIENTE DELLE RISORSE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI LA SALUBRITA DEGLI AMBIENTI.
lo Stato dell Arte orienta il Progetto Sostenibile secondo questi paradigmi di carattere generale IL RISPARMIO ENERGETICO L USO EFFICIENTE DELLE RISORSE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI LA SALUBRITA DEGLI AMBIENTI.
Building Innovation, CNA BARI - 10 giugno 2016
 : Sensore ad IA per il controllo e l'ottimizzazione della qualità dell'aria e del comfort climatico negli ambienti indoor (domotica, building automation e retail) Building Innovation, CNA BARI - 10 giugno
: Sensore ad IA per il controllo e l'ottimizzazione della qualità dell'aria e del comfort climatico negli ambienti indoor (domotica, building automation e retail) Building Innovation, CNA BARI - 10 giugno
Progettare il comfort: IL COMFORT TERMICO
 Convegno SICUREZZA E COMFORT NELLE ABITAZIONI CON STRUTTURE DI LEGNO Verona, 16 Giugno 2001 Progettare il comfort: IL COMFORT TERMICO Immagine: www.sips.org Dr. Paolo LAVISCI LegnoDOC srl Sommario Il comfort
Convegno SICUREZZA E COMFORT NELLE ABITAZIONI CON STRUTTURE DI LEGNO Verona, 16 Giugno 2001 Progettare il comfort: IL COMFORT TERMICO Immagine: www.sips.org Dr. Paolo LAVISCI LegnoDOC srl Sommario Il comfort
La popolazione trascorre il 87% della propria vita in ambienti chiusi.
 La popolazione trascorre il 87% della propria vita in ambienti chiusi. Anche gli ambienti chiusi possono essere considerati microclimi con le loro caratteristiche di: 1) illuminazione 2) umidità 3) ventilazione
La popolazione trascorre il 87% della propria vita in ambienti chiusi. Anche gli ambienti chiusi possono essere considerati microclimi con le loro caratteristiche di: 1) illuminazione 2) umidità 3) ventilazione
NATURTHERM-KE NATURTHERM-KE ISOLANTI FIBROSI TERMOACUSTICI. Fibra naturale vegetale. Fibra naturale vegetale
 NATURTHERM-KE ISOLANTI FIBROSI TERMOACUSTICI NATURTHERM-KE NATURTHERM KE Il Kenaf NATURTHERM KE è un innovativo isolante termoacustico in Kenaf, una fibra vegetale simile alla canapa usata dall uomo fi
NATURTHERM-KE ISOLANTI FIBROSI TERMOACUSTICI NATURTHERM-KE NATURTHERM KE Il Kenaf NATURTHERM KE è un innovativo isolante termoacustico in Kenaf, una fibra vegetale simile alla canapa usata dall uomo fi
MYBOX SOPRATTUTTO NOVITÀ COMFORT. PER LA FAMIGLIA, PER LA CASA.
 NOVITÀ SOPRATTUTTO MYBOX COMFORT. PER LA FAMIGLIA, PER LA CASA. MYBOX, il cassonetto per ristrutturazioni ad alto isolamento. Anche con ventilazione meccanica. all around the window L IMPORTANZA DEL CASSONETTO
NOVITÀ SOPRATTUTTO MYBOX COMFORT. PER LA FAMIGLIA, PER LA CASA. MYBOX, il cassonetto per ristrutturazioni ad alto isolamento. Anche con ventilazione meccanica. all around the window L IMPORTANZA DEL CASSONETTO
PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE. Autore - Affiliazione
 PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE EFFICIENZA ENERGETICA per edifici adibiti ad uso civile Minima energia da utilizzare per mantenere le condizioni di benessere EE = ---------------------------------------------
PROF. ING. FLAVIO FUCCI UNIVERSITÀ DEL MOLISE EFFICIENZA ENERGETICA per edifici adibiti ad uso civile Minima energia da utilizzare per mantenere le condizioni di benessere EE = ---------------------------------------------
Esempio di Valutazione ambientale (sintesi)
 Esempio di Valutazione ambientale (sintesi) attraverso l applicazione delle linee guida della regione a cura di: INBAR Toscana sez. Lucca, Rodolfo Collodi architetto 2 4 6 7 8 9 SISTEMA DI PESATURA DELLE
Esempio di Valutazione ambientale (sintesi) attraverso l applicazione delle linee guida della regione a cura di: INBAR Toscana sez. Lucca, Rodolfo Collodi architetto 2 4 6 7 8 9 SISTEMA DI PESATURA DELLE
ARIA PULITA E ARIA INQUINATA. naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile
 Parametri meteorologici e inquinanti atmosferici ARIA PULITA E ARIA INQUINATA L aria naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile Azoto, ossigeno, argon e vapore
Parametri meteorologici e inquinanti atmosferici ARIA PULITA E ARIA INQUINATA L aria naturale è composta da un miscuglio di gas e particelle con concentrazione variabile Azoto, ossigeno, argon e vapore
Cinque prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa
 Comfort abitativo Cinque prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa www.tecnovagroup.it Per il comfort abitativo e la salubrità ambientale indoor la soluzione più completa ed efficace
Comfort abitativo Cinque prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa www.tecnovagroup.it Per il comfort abitativo e la salubrità ambientale indoor la soluzione più completa ed efficace
Corso di Fisica Te T cnica Ambientale Benessere nesser termico Benessere nesser integr ato integr Il b enessere termico
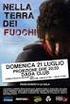 Benessere integrato Il benessere termico Il benessere integrato Quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell ambiente termico acustico luminoso Stato di neutralità termica, in cui il soggetto
Benessere integrato Il benessere termico Il benessere integrato Quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell ambiente termico acustico luminoso Stato di neutralità termica, in cui il soggetto
Volume Riscaldabil e BR-GB x 90 cm 9 kg 600W 0,5 kwh 1,01 30 m 3 BR-GB x 120 cm 14 kg 800W 0,8 kwh 1,40 40 m 3.
 Prestazioni Tecniche Modello Dimensioni Peso Potenza Massima Consumo Medio* Costo per 8 Ore di Utilizzo** Volume Riscaldabil e BR-GB-600 60 x 90 cm 9 kg 600W 0,5 kwh 1,01 30 m 3 BR-GB-800 60 x 120 cm 14
Prestazioni Tecniche Modello Dimensioni Peso Potenza Massima Consumo Medio* Costo per 8 Ore di Utilizzo** Volume Riscaldabil e BR-GB-600 60 x 90 cm 9 kg 600W 0,5 kwh 1,01 30 m 3 BR-GB-800 60 x 120 cm 14
NUOVI CRITERI PROGETTUALI DELL INVOLUCRO EDILIZIO
 D.LGS 192/05 e D.LGS 311/06 Novità legislative e certificazione energetica: implicazioni sulla progettazione e sui costi di costruzione NUOVI CRITERI PROGETTUALI DELL INVOLUCRO EDILIZIO 1 ARGOMENTI Sistema
D.LGS 192/05 e D.LGS 311/06 Novità legislative e certificazione energetica: implicazioni sulla progettazione e sui costi di costruzione NUOVI CRITERI PROGETTUALI DELL INVOLUCRO EDILIZIO 1 ARGOMENTI Sistema
SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Un'occasione per risparmiare isolando in modo 100% naturale ed eco-sostenibile. LA SITUAZIONE ITALIANA Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli
SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Un'occasione per risparmiare isolando in modo 100% naturale ed eco-sostenibile. LA SITUAZIONE ITALIANA Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli
SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. Proteggi la tua casa con il sistema NUOVA SIGA THERM
 SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO Proteggi la tua casa con il sistema NUOVA SIGA THERM NUOVA SIGA THERM SUGHERO Il sughero viene ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, una pianta che
SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO Proteggi la tua casa con il sistema NUOVA SIGA THERM NUOVA SIGA THERM SUGHERO Il sughero viene ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, una pianta che
borghi ed edifici rurali
 borghi ed edifici rurali un patrimonio da salvare mercoledì 18 maggio 2011 Pianoro Conservazione della tradizione, antisismica ed efficienza energetica: un connubio possibile i n g. M i r k o C i o n i
borghi ed edifici rurali un patrimonio da salvare mercoledì 18 maggio 2011 Pianoro Conservazione della tradizione, antisismica ed efficienza energetica: un connubio possibile i n g. M i r k o C i o n i
EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO
 ECO-CASE EDILCLIMA EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO PLANIMETRIA PRELIMINARE Tenendo conto dei vincoli legati al lotto si è definita una soluzione planimetrica di massima. SCELTA DELLA TIPOLOGIA
ECO-CASE EDILCLIMA EDIFICI A CONSUMO ENERGETICO QUASI ZERO PLANIMETRIA PRELIMINARE Tenendo conto dei vincoli legati al lotto si è definita una soluzione planimetrica di massima. SCELTA DELLA TIPOLOGIA
EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI: UN OPPORTUNITÀ Isolamento della copertura
 EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI: UN OPPORTUNITÀ Isolamento della copertura - CELENIT SPA 2 CELENIT da oltre 50 anni, nello stabilimento sito ad Onara di Tombolo (PD), produce pannelli in lana di legno
EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI: UN OPPORTUNITÀ Isolamento della copertura - CELENIT SPA 2 CELENIT da oltre 50 anni, nello stabilimento sito ad Onara di Tombolo (PD), produce pannelli in lana di legno
PURITII.COM. Sistema di Purificazione dell Aria ad Altissima Efficienza
 PURITII.COM Sistema di Purificazione dell Aria ad Altissima Efficienza 111 Il sistema Puritii per la purificazione dell aria ha dimensioni ridotte ma è estremamente potente. Può trattare sino a 8,6 m 3
PURITII.COM Sistema di Purificazione dell Aria ad Altissima Efficienza 111 Il sistema Puritii per la purificazione dell aria ha dimensioni ridotte ma è estremamente potente. Può trattare sino a 8,6 m 3
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AD ALTA RESA ESTETICA. BIOCASA FELICE Ing. Cristiano Vassanelli FIRENZE 29 Marzo 2104
 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AD ALTA RESA ESTETICA LA MANCANZA O L ERRATA L PROGETTAZIONE DELL ISOLAMENTO TERMICO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO E E CAUSA DI NOTEVOLI DISCOMFORT ABITATIVI. CENNI STORICI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AD ALTA RESA ESTETICA LA MANCANZA O L ERRATA L PROGETTAZIONE DELL ISOLAMENTO TERMICO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO E E CAUSA DI NOTEVOLI DISCOMFORT ABITATIVI. CENNI STORICI
SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Un'occasione per risparmiare isolando in modo 100% naturale ed eco-sostenibile. LA SITUAZIONE ITALIANA Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli
SUGHERO CORKPAN E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Un'occasione per risparmiare isolando in modo 100% naturale ed eco-sostenibile. LA SITUAZIONE ITALIANA Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI Erlacher Peter Naturno (BZ) La situazione edilizia in Italia è particolarmente anziana. Circa due terzi degli edifici esistenti sono antecedenti al 1973;
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI Erlacher Peter Naturno (BZ) La situazione edilizia in Italia è particolarmente anziana. Circa due terzi degli edifici esistenti sono antecedenti al 1973;
11 CHIUSURE VERTICALI
 Materiali per l architettura B (6CFU) Prof. Alberto De Capua, coll. Arch. Valeria Ciulla 11 CHIUSURE VERTICALI OPACHE TRASPARENTI Accademia di scienze della California Renzo Piano Università degli studi
Materiali per l architettura B (6CFU) Prof. Alberto De Capua, coll. Arch. Valeria Ciulla 11 CHIUSURE VERTICALI OPACHE TRASPARENTI Accademia di scienze della California Renzo Piano Università degli studi
Sei prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa
 Comfort abitativo Sei prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa www.tecnovagroup.it Mai più aria insalubre e inquinata L inquinamento dell aria interna rappresenta ormai un notevole
Comfort abitativo Sei prodotti per un unico obiettivo: la salute, tua e della tua casa www.tecnovagroup.it Mai più aria insalubre e inquinata L inquinamento dell aria interna rappresenta ormai un notevole
Costruzioni & Consulenze Soluzioni Sostenibili
 Costruzioni & Consulenze Soluzioni Sostenibili CCSS è una Azienda che propone una consulenza completa nella Costruzione, Ristrutturazione o Riqualificazione degli edifici. La nostra esperienza riguarda i
Costruzioni & Consulenze Soluzioni Sostenibili CCSS è una Azienda che propone una consulenza completa nella Costruzione, Ristrutturazione o Riqualificazione degli edifici. La nostra esperienza riguarda i
Misure di prevenzione primaria per la riduzione del rischio nella saldatura
 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO Direttore: Prof. Massimo Corradi Associazione Parmense dei Medici del Lavoro Seminari monografici di medicina del lavoro Edizione 2016 Rischio cancerogeno
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO Direttore: Prof. Massimo Corradi Associazione Parmense dei Medici del Lavoro Seminari monografici di medicina del lavoro Edizione 2016 Rischio cancerogeno
Inquinamento indoor: effetti della condensazione superficiale
 1) La Ventilazione meccanica applicazioni e normativa vigente 2) applicazione nella ristrutturazione 3) La classe A e la ventilazione meccanica i perchè della scelta. Umberto Buzzoni Inquinamento indoor:
1) La Ventilazione meccanica applicazioni e normativa vigente 2) applicazione nella ristrutturazione 3) La classe A e la ventilazione meccanica i perchè della scelta. Umberto Buzzoni Inquinamento indoor:
Le FAV: tipologie di utilizzo e settori di impiego [Stefano Cera Segretario generale FIVRA]
![Le FAV: tipologie di utilizzo e settori di impiego [Stefano Cera Segretario generale FIVRA] Le FAV: tipologie di utilizzo e settori di impiego [Stefano Cera Segretario generale FIVRA]](/thumbs/39/19119037.jpg) Le Fibre Artificiali Vetrose Linee Guida della Conferenza Stato/Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute Le FAV: tipologie di utilizzo e settori di impiego [Stefano Cera
Le Fibre Artificiali Vetrose Linee Guida della Conferenza Stato/Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute Le FAV: tipologie di utilizzo e settori di impiego [Stefano Cera
CHE COS È IL CELENIT?
 CHE COS È IL CELENIT? CERTIFICAZIONE ANAB ICEA Conformità ai requisiti dello Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia: RISORSE VEGINI RINNOVABILI: Legno da foreste gestite in modo sostenibile SALUTE
CHE COS È IL CELENIT? CERTIFICAZIONE ANAB ICEA Conformità ai requisiti dello Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia: RISORSE VEGINI RINNOVABILI: Legno da foreste gestite in modo sostenibile SALUTE
Qualità dell aria negli ambienti confinati: lo stato dell arte
 Qualità dell aria negli ambienti confinati: lo stato dell arte La qualità dell aria interna è considerata accettabile quando in essa non sono presenti inquinanti in concentrazioni dannose, secondo quanto
Qualità dell aria negli ambienti confinati: lo stato dell arte La qualità dell aria interna è considerata accettabile quando in essa non sono presenti inquinanti in concentrazioni dannose, secondo quanto
Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali
 Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali 20 febbraio 2010 Stefano Massera Patrizia Anzidei CONTARP INAIL Direzione Generale Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 1 In Cenni
Funzionalità degli impianti HVAC e indagini ambientali 20 febbraio 2010 Stefano Massera Patrizia Anzidei CONTARP INAIL Direzione Generale Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 1 In Cenni
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E BIOEDILIZIA
 Competitività e innovazione: le nuove opportunità a sostegno delle imprese Speciale Focus Risparmio energetico e bioedilizia: strumenti ed incentivi FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E BIOEDILIZIA Campobasso
Competitività e innovazione: le nuove opportunità a sostegno delle imprese Speciale Focus Risparmio energetico e bioedilizia: strumenti ed incentivi FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E BIOEDILIZIA Campobasso
INQUINAMENTO ATMOSFERICO URBANO E TRAFFICO VEICOLARE Problematiche attuali e prospettive future S. CERNUSCHI
 INQUINAMENTO ATMOSFERICO URBANO E TRAFFICO VEICOLARE Problematiche attuali e prospettive future S. CERNUSCHI INQUINANTI ATMOSFERICI Primari emessi come tali dalle sorgenti CO 2, CH 4, N 2 O SO 2 CO COV
INQUINAMENTO ATMOSFERICO URBANO E TRAFFICO VEICOLARE Problematiche attuali e prospettive future S. CERNUSCHI INQUINANTI ATMOSFERICI Primari emessi come tali dalle sorgenti CO 2, CH 4, N 2 O SO 2 CO COV
CATALOGO qualità dell aria salubrità dell ambiente risparmio energetico VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
 CATALOGO 2015 qualità dell aria salubrità dell ambiente risparmio energetico VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CAMBIAMO ARIA IL PIACERE DI VIVERE IN UN AMBIENTE
CATALOGO 2015 qualità dell aria salubrità dell ambiente risparmio energetico VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CAMBIAMO ARIA IL PIACERE DI VIVERE IN UN AMBIENTE
Isolamento a Cappotto
 Isolamento a Cappotto con pannelli minerali Calce Sabbia Aria Calce Legante naturale da migliaia di anni Sabbia Elemento minerale della terra Aria Salute nei milioni di micropori Il meglio per la vostra
Isolamento a Cappotto con pannelli minerali Calce Sabbia Aria Calce Legante naturale da migliaia di anni Sabbia Elemento minerale della terra Aria Salute nei milioni di micropori Il meglio per la vostra
Muffe e Muschi. SANICLEAN - il mangiamuffa Detergente liquido per la pulizia rapida delle muffe su superfici murali
 S.p.A. Muffe e Muschi Pulizia e protezione delle superfici Prodotti e soluzioni tecniche SANICLEAN - il mangiamuffa Detergente liquido per la pulizia rapida delle muffe su superfici murali SANIPROTECT
S.p.A. Muffe e Muschi Pulizia e protezione delle superfici Prodotti e soluzioni tecniche SANICLEAN - il mangiamuffa Detergente liquido per la pulizia rapida delle muffe su superfici murali SANIPROTECT
Progetto di residenze con l'utilizzo di sistemi solari passivi e di raffrescamento naturale. ad Alfonsine (RA)
 Giampaolo Silvestri & Cristina Bucchi Architetti UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Architettura Anno Accademico 1997-98 TESI DI LAUREA IN TECNOLOGIA Progetto di residenze con l'utilizzo di
Giampaolo Silvestri & Cristina Bucchi Architetti UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Facoltà di Architettura Anno Accademico 1997-98 TESI DI LAUREA IN TECNOLOGIA Progetto di residenze con l'utilizzo di
Corso di Pianificazione Energetica prof. ing. Francesco Asdrubali a.a. 2013-14
 Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Pianificazione Energetica prof. ing. Francesco Asdrubali a.a. 2013-14 Le interazioni tra i sistemi energetici e l ambiente Le interazioni
Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Pianificazione Energetica prof. ing. Francesco Asdrubali a.a. 2013-14 Le interazioni tra i sistemi energetici e l ambiente Le interazioni
Chiusure Verticali opache
 D.A.D.I. L. Vanvitelli Corso di Laurea Magistrale in Architettura Laboratorio di Costruzione dell Architettura I A a.a. 2015/16 Prof. Sergio Rinaldi sergio.rinaldi@unina2.it 15_04_2016 5 Chiusure Verticali
D.A.D.I. L. Vanvitelli Corso di Laurea Magistrale in Architettura Laboratorio di Costruzione dell Architettura I A a.a. 2015/16 Prof. Sergio Rinaldi sergio.rinaldi@unina2.it 15_04_2016 5 Chiusure Verticali
I rischi salute e sicurezza negli addetti del comparto produzione calzature. 19 novembre 2013 Dr. Aldo Fedi
 I rischi salute e sicurezza negli addetti del comparto produzione calzature 19 novembre 2013 Dr. Aldo Fedi CICLO PRODUTTIVO DEL COMPARTO CALZATURIERO MODELLERIA TAGLIO/TRANCERIA GIUNTERIA MONTAGGIO FONDO
I rischi salute e sicurezza negli addetti del comparto produzione calzature 19 novembre 2013 Dr. Aldo Fedi CICLO PRODUTTIVO DEL COMPARTO CALZATURIERO MODELLERIA TAGLIO/TRANCERIA GIUNTERIA MONTAGGIO FONDO
Realizzazione di impianti plasma prototipali per istituti di ricerca
 Chiara Pavan Realizzazione di impianti plasma prototipali per istituti di ricerca Realizzazione di impianti plasma per applicazioni industriali Il plasma è una tecnologia primaria per il trattamento di
Chiara Pavan Realizzazione di impianti plasma prototipali per istituti di ricerca Realizzazione di impianti plasma per applicazioni industriali Il plasma è una tecnologia primaria per il trattamento di
3 INCONTRO FORMATIVO. Soluzione progettuali e costruttive per il miglioramento dell efficienza energetica dell involucro opaco.
 3 INCONTRO FORMATIVO Soluzione progettuali e costruttive per il miglioramento dell efficienza energetica dell involucro opaco 09 dicembre 2010 Relatore arch. Giorgio Gallo IMPORTANZA DELLA COIBENTAZIONE
3 INCONTRO FORMATIVO Soluzione progettuali e costruttive per il miglioramento dell efficienza energetica dell involucro opaco 09 dicembre 2010 Relatore arch. Giorgio Gallo IMPORTANZA DELLA COIBENTAZIONE
Il rischio chimico ing. PASTA NICOLA
 Il rischio chimico Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria Corso Sicurezza nei Cantieri a.a. 2013 2014 Il rischio chimico Premessa Tutte le sostanze sono tossiche, solo la dose fa il veleno
Il rischio chimico Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria Corso Sicurezza nei Cantieri a.a. 2013 2014 Il rischio chimico Premessa Tutte le sostanze sono tossiche, solo la dose fa il veleno
Trasmittanza termica
 Trasmittanza termica Che cosa è la trasmittanza termica Trasmissione del calore e trasmittanza termica La trasmittanza termica secondo la norma UNI EN ISO 6946/2008 Il calcolo della trasmittanza secondo
Trasmittanza termica Che cosa è la trasmittanza termica Trasmissione del calore e trasmittanza termica La trasmittanza termica secondo la norma UNI EN ISO 6946/2008 Il calcolo della trasmittanza secondo
Costruire in Xlam La Casa di Monica : il primo edificio residenziale in Italia certificato GBC HOME
 Costruire in Xlam La Casa di Monica : il primo edificio residenziale in Italia certificato GBC HOME Come costruire una casa al TOP Struttura in legno, comfort e sicurezza in caso di sisma Protocollo GBC
Costruire in Xlam La Casa di Monica : il primo edificio residenziale in Italia certificato GBC HOME Come costruire una casa al TOP Struttura in legno, comfort e sicurezza in caso di sisma Protocollo GBC
SCHEDA INFORMATIVA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI presentata in base all art. 20 della Legge 833/78. Residente in. via. Ragione Sociale della Ditta
 Dipartimento Sanità pubblica Area di Igiene e Sanità Pubblica - Nuovi insediamenti produttivi SCHEDA INFORMATIVA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI presentata in base all art. 20 della Legge 833/78 RIQUADRO DA
Dipartimento Sanità pubblica Area di Igiene e Sanità Pubblica - Nuovi insediamenti produttivi SCHEDA INFORMATIVA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI presentata in base all art. 20 della Legge 833/78 RIQUADRO DA
Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche
 Parma, 6 giugno 2012 Auditorium Polifunzionale Università degli Studi di Parma INTERVENTO DI GIORGIO PAGLIARINI Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche Edificio a energia
Parma, 6 giugno 2012 Auditorium Polifunzionale Università degli Studi di Parma INTERVENTO DI GIORGIO PAGLIARINI Edifici a energia quasi zero: scelte progettuali e soluzioni tecnologiche Edificio a energia
L ambiente e la salute
 Con il Patrocinio dell Ordine dei Medici L ambiente e la salute Leila Fabiani e Domenico Pompei Per comparto ambientale o Aria, acqua, suolo, alimenti e bevande o ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela
Con il Patrocinio dell Ordine dei Medici L ambiente e la salute Leila Fabiani e Domenico Pompei Per comparto ambientale o Aria, acqua, suolo, alimenti e bevande o ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela
SFASAMENTO DELLE COPERTURE IN LEGNO E DI STRUTTURE LEGGERE. Ing. Michele Locatelli - Direttore Tecnico Esse Solai S.r.l.
 SFASAMENTO DELLE COPERTURE IN LEGNO E DI STRUTTURE LEGGERE Ing. Michele Locatelli - Direttore Tecnico Esse Solai S.r.l. PECULIARITA DELLE STRUTTURE LEGGERE DI CHIUSURA DELL INVOLUCRO EDILIZIO Negli ultimi
SFASAMENTO DELLE COPERTURE IN LEGNO E DI STRUTTURE LEGGERE Ing. Michele Locatelli - Direttore Tecnico Esse Solai S.r.l. PECULIARITA DELLE STRUTTURE LEGGERE DI CHIUSURA DELL INVOLUCRO EDILIZIO Negli ultimi
Tavola rotonda. Daniela Antonietti ISPRA
 Costruire una buona qualità dell'aria a scuola con un click. Airpack: l'ambiente lambiente per una scuola 2.0 0 Tavola rotonda Daniela Antonietti 17 febbraio 2016 USR Lazio Via Pianciani 32, Roma Conoscenza
Costruire una buona qualità dell'aria a scuola con un click. Airpack: l'ambiente lambiente per una scuola 2.0 0 Tavola rotonda Daniela Antonietti 17 febbraio 2016 USR Lazio Via Pianciani 32, Roma Conoscenza
Il Progetto internazionale SEARCH II : Premesse, Risultati e Attività Future
 http://search.rec.org/ Il Progetto internazionale SEARCH II : Premesse, Risultati e Attività Future F. De Maio, ISPRA francesca.demaio@isprambiente.it Workshop Inquinamento atmosferico interno e salute
http://search.rec.org/ Il Progetto internazionale SEARCH II : Premesse, Risultati e Attività Future F. De Maio, ISPRA francesca.demaio@isprambiente.it Workshop Inquinamento atmosferico interno e salute
IL MOBILE E LA QUALITA DEGLI AMBIENTI DI VITA L ESPERIENZA DEL CATAS
 IL MOBILE E LA QUALITA DEGLI AMBIENTI DI VITA L ESPERIENZA DEL CATAS IL CATAS Il CATAS è un centro di ricerca-sviluppo e laboratorio prove nel settore legno-arredo istituito nel 1969 dalla Camera di Commercio
IL MOBILE E LA QUALITA DEGLI AMBIENTI DI VITA L ESPERIENZA DEL CATAS IL CATAS Il CATAS è un centro di ricerca-sviluppo e laboratorio prove nel settore legno-arredo istituito nel 1969 dalla Camera di Commercio
Isolanti termoacustici in fibre tessili naturali e riciclate
 Isolanti termoacustici in fibre tessili naturali e riciclate Involucro edilizio Azione di agenti fisici ed atmosferici In assenza di un corretto isolamento Assenza di confort Normativa vigente Acustica
Isolanti termoacustici in fibre tessili naturali e riciclate Involucro edilizio Azione di agenti fisici ed atmosferici In assenza di un corretto isolamento Assenza di confort Normativa vigente Acustica
Thermo Dry. Fibra di legno. Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico
 Thermo Dry Thermo Dry Fibra di legno Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico La fibra di legno monostrato Thermo Dry è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall
Thermo Dry Thermo Dry Fibra di legno Soluzioni ecocompatibili di isolamento termico ed acustico La fibra di legno monostrato Thermo Dry è un materiale naturale e sostenibile, ricavato dal pino e dall
I materiali per l isolamento termico
 I materiali per l isolamento termico Per isolante si intende un materiale caratterizzato da una ridotta capacità di conduzione del calore, convenzionalmente con coefficiente di conducibilità termica, l,
I materiali per l isolamento termico Per isolante si intende un materiale caratterizzato da una ridotta capacità di conduzione del calore, convenzionalmente con coefficiente di conducibilità termica, l,
Rischi da uso di fotocopiatori
 Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Rischi da uso di fotocopiatori M2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX D.Lgs. 81/08 (art. 37) E ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011 RIFERIMENTI NORMATIVI
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Rischi da uso di fotocopiatori M2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX D.Lgs. 81/08 (art. 37) E ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011 RIFERIMENTI NORMATIVI
Ecocompatibilità della lana di vetro ISOVER
 Ecocompatibilità della lana di vetro ISOVER S.G.I.I. & PRODUZIONE DELLA LANA DI VETRO ISOVER IL BILANCIO ENERGETICO DELLA LANA DI VETRO ISOVER LCA - LIFE CYCLE ANALYSIS CARATTERISTICHE SANITARIE DELLA
Ecocompatibilità della lana di vetro ISOVER S.G.I.I. & PRODUZIONE DELLA LANA DI VETRO ISOVER IL BILANCIO ENERGETICO DELLA LANA DI VETRO ISOVER LCA - LIFE CYCLE ANALYSIS CARATTERISTICHE SANITARIE DELLA
E O E O VETROP VETRO. Prodotti Sistema Isolamento Lana di vetro. Prodotti del Sistema Isolamento. Descrizione
 Prodotti del Sistema Isolamento Prodotti Sistema Isolamento Lana di vetro VETROP Pannello in lana di vetro Knauf, conforme alla norma UNI EN 13162, prodotto con ECOSE Technology (resina di origine vegetale,
Prodotti del Sistema Isolamento Prodotti Sistema Isolamento Lana di vetro VETROP Pannello in lana di vetro Knauf, conforme alla norma UNI EN 13162, prodotto con ECOSE Technology (resina di origine vegetale,
nzeb NEARLY ZERO ENERGY BUILDING La scuola e l energia sostenibile, un primo passo verso il 2020
 I MATERIALI ISOLANTI POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO: XPS E OTTENUTO DA BENZOLO ED ETILENE RICAVATI A LORO VOLTA DA PETROLIO E METANO. IL PROPELLENTE UTILIZZATO PER L ESPANSIONE È LA CO2. HA UN ASSORBIMENTO
I MATERIALI ISOLANTI POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO: XPS E OTTENUTO DA BENZOLO ED ETILENE RICAVATI A LORO VOLTA DA PETROLIO E METANO. IL PROPELLENTE UTILIZZATO PER L ESPANSIONE È LA CO2. HA UN ASSORBIMENTO
PM10: GLI EFFETTI SULL UOMO E SULL AMBIENTE
 PM10: GLI EFFETTI SULL UOMO E SULL AMBIENTE Le particelle sono classificate secondo le loro dimensioni caratteristiche: le polveri sottili, dette anche PM10, includono tutte le particelle di dimensioni
PM10: GLI EFFETTI SULL UOMO E SULL AMBIENTE Le particelle sono classificate secondo le loro dimensioni caratteristiche: le polveri sottili, dette anche PM10, includono tutte le particelle di dimensioni
prof. ing. Anna Magrini Il progetto del recupero: problematiche
 prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
TAV MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI BIELLA - STAZIONI
 TAV. 9.1 - MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI BIELLA - STAZIONI Stazioni Altitudine Analizzatori Sensori meteorologici N 1 - Biella 405 m. Ossidi di Azoto (NOX) Pioggia c/o Centro Prevenzione
TAV. 9.1 - MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI BIELLA - STAZIONI Stazioni Altitudine Analizzatori Sensori meteorologici N 1 - Biella 405 m. Ossidi di Azoto (NOX) Pioggia c/o Centro Prevenzione
I concetti di rischio e pericolo
 I concetti di rischio e pericolo Durata: 12 26 La valutazione del rischio D.Lgs. 81/2008 Articolo 15 - Misure generali di tutela Nelle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
I concetti di rischio e pericolo Durata: 12 26 La valutazione del rischio D.Lgs. 81/2008 Articolo 15 - Misure generali di tutela Nelle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
 LANA di VETRO: presenta proprietà termoisolanti molto buone (λ=0,035-0,04 W/mK), una buona resistenza all invecchiamento e una stabilità di forma esauriente se il materiale isolante è protetto contro l
LANA di VETRO: presenta proprietà termoisolanti molto buone (λ=0,035-0,04 W/mK), una buona resistenza all invecchiamento e una stabilità di forma esauriente se il materiale isolante è protetto contro l
SOSTENIBILITA : CRONOLOGIA DELLA POLITICA AMBIENTALE. Candidata: Antonella Adduci # IL CONGLOMERATO DI CANAPA
 1 SOSTENIBILITA : CRONOLOGIA DELLA POLITICA AMBIENTALE Candidata: Antonella Adduci # 366300 IL CONGLOMERATO DI CANAPA 2 SISTEMA EDILIZIO: RESPONSABILITA e OPPORTUNITA SITUAZIONE ATTUALE: CONSUMI: 40% di
1 SOSTENIBILITA : CRONOLOGIA DELLA POLITICA AMBIENTALE Candidata: Antonella Adduci # 366300 IL CONGLOMERATO DI CANAPA 2 SISTEMA EDILIZIO: RESPONSABILITA e OPPORTUNITA SITUAZIONE ATTUALE: CONSUMI: 40% di
HOTEL MOUNTAIN EDEN SELVA Selva di Val Gardena
 HOTEL MOUNTAIN EDEN SELVA Selva di Val Gardena Bolzano 26 gennaio 2017 Paolo De Martin architetto Docente e consulente CasaClima Docente Master Lignius IL PROGETTO: concetto architettonico Nella tradizione
HOTEL MOUNTAIN EDEN SELVA Selva di Val Gardena Bolzano 26 gennaio 2017 Paolo De Martin architetto Docente e consulente CasaClima Docente Master Lignius IL PROGETTO: concetto architettonico Nella tradizione
La qualità alla base di tutto URSA XPS WALL-C PLUS
 La qualità alla base di tutto URSA XPS WALL-C PLUS 100% fatto in Italia Totalmente esente da HBCD, CFC, HCFC e gas a effetto serra Ottimizzazione dei costi di intervento Resistenza alla compressione Resistenza
La qualità alla base di tutto URSA XPS WALL-C PLUS 100% fatto in Italia Totalmente esente da HBCD, CFC, HCFC e gas a effetto serra Ottimizzazione dei costi di intervento Resistenza alla compressione Resistenza
Termoigrometria. Massimo Garai. DIN - Università di Bologna
 Termoigrometria Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Copyright (C) 2004-2014 Massimo Garai - Università di Bologna 1 Abitazione nella stagione fredda - Produzione di vapor
Termoigrometria Massimo Garai DIN - Università di Bologna http://acustica.ing.unibo.it Copyright (C) 2004-2014 Massimo Garai - Università di Bologna 1 Abitazione nella stagione fredda - Produzione di vapor
ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A
 ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A arch. Alessandro Panichi Docente di TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE Dipartimento TAeD Universita di Firenze D. LEG.VI 192 2005 / 311 2006 Allegato
ESEMPI COSTRUTTIVI CON SISTEMA A SECCO IN T O S C A N A arch. Alessandro Panichi Docente di TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE Dipartimento TAeD Universita di Firenze D. LEG.VI 192 2005 / 311 2006 Allegato
Co.in.tec. per una migliore qualità dell aria che respiriamo
 Co.in.tec. per una migliore qualità dell aria che respiriamo La seguente presentazione si intende strettamente confidenziale, non è permessa la divulgazione e la copia senza l espressa autorizzazione della
Co.in.tec. per una migliore qualità dell aria che respiriamo La seguente presentazione si intende strettamente confidenziale, non è permessa la divulgazione e la copia senza l espressa autorizzazione della
*** Scelta dei pannelli isolanti
 *** Scelta dei pannelli isolanti 1 Scelta dei pannelli isolanti Natura del pannello (prodotto di sintesi o naturale) Tecnologie costruttive specifiche del pannello Soluzioni dedicate a specifiche parti
*** Scelta dei pannelli isolanti 1 Scelta dei pannelli isolanti Natura del pannello (prodotto di sintesi o naturale) Tecnologie costruttive specifiche del pannello Soluzioni dedicate a specifiche parti
ENERGIA E RUMORE QUASI ZERO Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani
 Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani ECOBIOCOMPATIBILITA E CONFORT : Soluzioni per l involucro ad alte prestazioni Arch. Eddy Tiozzo CELENIT Spa Diritti d autore: la presente presentazione
Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani ECOBIOCOMPATIBILITA E CONFORT : Soluzioni per l involucro ad alte prestazioni Arch. Eddy Tiozzo CELENIT Spa Diritti d autore: la presente presentazione
04/05/2009 DEFINIZIONE DI RADIAZIONI. Corso di Igiene. Igiene delle radiazioni ionizzanti e non
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Corso di Igiene Igiene delle radiazioni ionizzanti e non Prof. P. Cavallo 1 DEFINIZIONE DI RADIAZIONI In fisica: particolare forma di energia, o di materia corpuscolare,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Corso di Igiene Igiene delle radiazioni ionizzanti e non Prof. P. Cavallo 1 DEFINIZIONE DI RADIAZIONI In fisica: particolare forma di energia, o di materia corpuscolare,
all aperto ci si riferisce all inquinamento outdoor mentre con inquinamento indoor si intende quello che interessa gli ambienti
 Codroipo, lì 15 luglio 2013 Prot. 9713LM Newsletter 07/2013 L INQUINAMENTO INDOOR NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Introduzione 1 parte Generalmente, per indicare l inquinamento dell aria presente all aperto ci
Codroipo, lì 15 luglio 2013 Prot. 9713LM Newsletter 07/2013 L INQUINAMENTO INDOOR NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Introduzione 1 parte Generalmente, per indicare l inquinamento dell aria presente all aperto ci
Casa del Giardinaggio di Roma: pavimentazione di tufo con parcelle di coltivazione
 3a. Parcelle di coltivazione realizzate con mattoni di tufo In aree di maggiori dimensioni oppure dove i coltivatori hanno difficoltà deambulatorie è consigliabile realizzare pavimentazioni continue in
3a. Parcelle di coltivazione realizzate con mattoni di tufo In aree di maggiori dimensioni oppure dove i coltivatori hanno difficoltà deambulatorie è consigliabile realizzare pavimentazioni continue in
Nuovi tecnici alla scoperta dell inquinamento indoor
 Nuovi tecnici alla scoperta dell inquinamento indoor L esperto in edificio salubre, nato in risposta alle direttive Ue che, nell ambito della strategia 2020, impongono una riconversione in chiave verde
Nuovi tecnici alla scoperta dell inquinamento indoor L esperto in edificio salubre, nato in risposta alle direttive Ue che, nell ambito della strategia 2020, impongono una riconversione in chiave verde
INSPIRARE. ESPIRARE. FUNZIONI VITALI, ANCHE PER LA CASA. Linea INGENIUS VMC. Monoblocco Presystem con VMC integrata, per un continuo ricambio d aria.
 INSPIRARE. ESPIRARE. FUNZIONI VITALI, ANCHE PER LA CASA. Linea INGENIUS VMC. Monoblocco Presystem con VMC integrata, per un continuo ricambio d aria. UNA NUOVA LINEA, PER ARRICCHIRE IL TUO COMFORT CON
INSPIRARE. ESPIRARE. FUNZIONI VITALI, ANCHE PER LA CASA. Linea INGENIUS VMC. Monoblocco Presystem con VMC integrata, per un continuo ricambio d aria. UNA NUOVA LINEA, PER ARRICCHIRE IL TUO COMFORT CON
FACCIALI FILTRANTI NORME TECNICHE UNI EN 149 RIF. LEGISLATIVI MARCATURA CE (D.P.R. 475/92) CATEGORIA III (D.P.R. 475/92)
 PVR-1 Pag. 1 di 6 TIPO A: respiratore per polveri nocive TIPO B: respiratore per fibre di amianto RIFERIMENTI NORMATIVI NORME TECNICHE UNI EN 149 RIF. LEGISLATIVI art. 21 D.P.R. 33/56 art. 387 D.P.R. 547/55
PVR-1 Pag. 1 di 6 TIPO A: respiratore per polveri nocive TIPO B: respiratore per fibre di amianto RIFERIMENTI NORMATIVI NORME TECNICHE UNI EN 149 RIF. LEGISLATIVI art. 21 D.P.R. 33/56 art. 387 D.P.R. 547/55
