L alleanza e il dono della legge (Es 19-24)
|
|
|
- Sofia Sabina Baldi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L alleanza e il dono della legge (Es 19-24) La nascita di Israele Tutto l Esodo è il racconto della nascita di un popolo prediletto per Dio, e certamente il Sinai è una tappa fondamentale di questa nascita. Qui Israele è chiamato a viere questa nascita da protagonista e non solo soggetto passivo di una relazione asimmetrica. La liberazione è opera di Jahvé, il miracolo del suo passaggio ha fatto iniziare la storia di salvezza; il deserto è il tempo in cui Israele muove i primi passi, come un bimbo che impara a camminare. Ora, giunto al Sinai è chiamato a decidere e a scegliere in libertà di servire il Signore. Questa nascita riguarda Israele come un popolo eletto e per questo unico. Ma l unicità non è esclusiva: se Dio elegge un popolo tra tutti, in realtà la cosa riguarda ogni popolo. Un midrash una narrazione della tradizione ebraica racconta con una parabola il senso e la destinazione di questa nascita: «Un re possedeva un giardino nel quale aveva piantato filari di fichi, di viti, di melograni, di mele. Egli ne affidò la coltivazione ad un mezzadro e se ne andò. Dopo qualche tempo il re tornò per vedere cosa aveva prodotto il suo giardino, ma lo trovò pieno di spine e di rovi. Allora fece venire dei tagliatori per rimuovere le spine, ma intanto scorse fra queste una rosa. La colse, ne gustò il profumo e se ne deliziò. Poi disse: Per questa rosa sarà risparmiato tutto il giardino. Analogamente tutto il mondo non fu creato se non in grazia della torah (cioè del dono della legge). Dopo 26 generazioni il Santo, benedetto Egli sia, osservò il mondo per rendersi conto di ciò che aveva prodotto, ma non vi trovò che acqua (il contrasto è con il vino, non era prodotto vino, c'era solo acqua). La generazione di Enoch, acqua; quella del diluvio, acqua; quella della torre di Babele, acqua; allora chiamò i distruttori perché venissero a demolire il mondo, ma in quel momento scorse una bella rosa, cioè Israele, la colse, ne gustò il profumo quando pronunciò le 10 parole, se ne deliziò quando tutto Israele disse: faremo e ascolteremo ciò che Dio ha comandato. Allora il Santo, benedetto Egli sia, disse: Per questa rosa sarà risparmiato il giardino, vale a dire: Per merito della Torah e di Israele il mondo sarà salvo». La vicenda del popolo di Israele è una parabola che racchiude un senso, una promessa di salvezza offerta a tutti. Vedremo come questa idea di elezione e di mediazione è profondamente iscritta nella tradizione dell Alleanza. l Alleanza che qui si instaura è inclusiva: uno a favore di tutti. Distribuzione del materiale I capitoli contengono alcuni elementi narrativi e una parte più ponderante di brani legislativi. Come sempre si tratta di una composizione articolata per cui anche la parte narrativa non scorre agevolmente (ad es. nel capitolo 19 sembra che Mosè salga e scenda continuamente, parlando di volta in volta con Dio o con il popolo). Ma possiamo riconoscere facilmente uno schema di composizione: il cap 19 presenta la preparazione all Alleanza (con protagonista assoluto Mosè, mentre il popolo rimane alle falde del monte) il cap 24 racconta la celebrazione dell Alleanza e il suo rituale in mezzo due blocchi autonomi il cap 20 con le dieci parole (il decalogo presenta una sintesi dell intera legge) il cap con il Codice dell Alleanza (si tratta di diritto consuetudinario, della codificazione di una tradizione giuridica che viene riconosciuta e assunta come prescrittiva) 1
2 Non ci soffermeremo sulle singole e differenti norme; qui ci sta a cuore cogliere il senso complessivo dell evento Sinai: la stipulazione di un patto di Alleanza nel quale ha un ruolo determinate il dono della Legge. Alleanza: trattati, documenti e riti Tutta la storia di Israele la potremmo riassumere come una storia di Alleanza o meglio di Alleanze: tentativi ripetuti di Dio di trovare un interlocutore. Dall alleanza con Adamo (la creazione) a quella Noachica, dall alleanza con Abramo (preistoria dell elezione) a quella con tutto il popolo. La parola Alleanza, in ebraico berit è fondamentale nella tradizione biblica (ricorre 287 volte!) e ha molteplici significati difficilmente traducibili: alleanza, patto, legame, obbligo, impegno. Dalla traduzione greca al passaggio al latino si è giunti a tradurlo con Testamentum da cui la distinzione tra Antico e Nuovo Testamento. Si tratta di un sistema che instaura un legame tra due soggetti liberi. Se osserviamo le ricorrenze nelle quali la bibbia utilizza questo termine berit possiamo scorgere due elementi differenti che ci possono essere utili. A volte l alleanza è stipulata tra due persone di pari grado (es. Abramo e Labano; Davide e Gionata ecc). Entrambi hanno i medesimi impegni reciproci. Ma altre volte indica un patto tra persone di grado diverso; delle volte si tratti di un impegno unilaterale, ma altre volte implica una partecipazione anche di chi pur essendo di grado inferiore viene chiamato a partecipare con un dovere. Di questa natura erano anche accordi giuridici, trattati utilizzati in campo politico tra un sovrano e un inferiore, una sorta di vassallaggio. «Questo modo di formulare un trattato politico di un superiore nei confronti di un inferiore, verrà utilizzato dagli autori biblici per spiegare l azione di Dio con il suo popolo. In genere il trattato viene preceduto dalla presentazione del soggetto e da un preambolo nel quale si richiama l antefatto storico. A questo seguono le norme che definiscono la relazione che si viene a stipulare. Possiamo riconoscere questa struttura proprio nell inizio del decalogo: «Io sono il Signore tuo Dio (presentazione) che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto (antefatto storico): non avrai altri dei all infuori di me (norme regolative). I trattati venivano redatti con documenti e celebrati con riti. L alleanza sinaitica è espressione di questa celebrazione di un patto. Il decalogo rappresenta il documento base, letto nel rito di alleanza e che poi rimane come segno del patto, che ogni volta viene riletto per confermarlo, in circostanza particolari, durante feste, anniversari o momenti critici della storia dell Alleanza tra Dio e il suo popolo». «Tutti questi elementi risultano molto opportuni per spiegare il senso della relazione del popolo di Israele con Dio e quindi qualcuno ebbe l'intuizione teologica, geniale - possiamo pensare proprio a Mosè e parlare anche di ispirazione - nello scegliere questo concetto politico, amministrativo del trattato di alleanza, per comprendere che cosa ha fatto Dio con il popolo e come questa relazione si mantiene nel tempo. Dio è il grande sovrano che è venuto incontro al popolo, si è preso un impegno, ecco che la Bibbia parla dell'alleanza di Dio con Abramo. Potete andare a leggere il cap.15 della Gn.: troverete il racconto dell'alleanza con Abramo, lì non troverete nessun obbligo per Abramo. Dio semplicemente s impegna a dare la terra ad Abramo, l'impegno lo prende su di sé il superiore. Nel caso di Israele, ormai popolo di Abramo è formato, in attesa di entrare a prendere possesso della terra (Dio si era impegnato) adesso subentra la seconda alleanza, il secondo trattato. Questa volta l'impegno viene chiesto all'inferiore, l'impegno viene chiesto al popolo come condizione per poter ottenere quella terra che Dio si era impegnato a donare. Il testo della alleanza viene messo per scritto ed è più che normale che, in un'epoca arcaica come quella di Mosè e del Sinai, si usino delle tavole di pietra su cui vengono incise della parole, non grandi discorsi, perché su una tavola di pietra non ci sta un romanzo, ci stanno poche, sintetiche formule che contengono le clausole di questo trattato: Dio è il nostro sovrano, noi siamo entrati in 2
3 relazione, in amicizia con lui. Egli è venuto incontro a noi, si è impegnato nei nostri confronti e ci chiede di impegnarci. Questo è il testo dell'alleanza che deve essere conservato in un santuario, ma un popolo nomade che si muove non ha un santuario fisso, ma ha un santuario mobile: ecco l'arca dell'alleanza, cioè una cassa, una cassetta ornata, decorata, abbellita, dove viene messo il testo dell'alleanza. Non è la presenza di Dio o l'immagine di Dio, è un santuario mobile che contiene il documento fondamentale dell'esistenza del popolo: il popolo esiste perché Dio lo ha fatto esistere con quel documento di fondazione e l'arca che contiene le tavole dell'alleanza si muove con il popolo e, a scadenze fisse - non abbiamo le indicazioni precise nel testo biblico - questo testo, questo trattato di alleanza verrà letto. Probabilmente si tratta delle feste dell'alleanza, in cui veniva rinnovata l'adesione del popolo a questo impegno di Dio e alla richiesta dell'impegno da parte del popolo» (Doglio). Il rito che troviamo in Es 24 è la celebrazione finale del patto stipulato tra Dio e il suo popolo. Esso prevede un banchetto di comunione e, infatti, troviamo un altare: Mosè con Aronne, Nadab, i figli di Aronne e i 70 anziani (in rappresentanza di tutto il popolo) salgono sul monte: «Essi videro Dio e mangiarono e bevvero» (Es 24,11). Anche tutto il popolo è chiamato a partecipare esprimendo la sua adesione. «Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: "Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!"» (Es, 24,3) celebrando poi un rito di comunione. Questo rito si conclude con un patto di sangue (l aspersione del popolo) che rende, potremmo dire, consanguinei i contraendi, in quanto partecipano dello stesso sangue, ovvero della stessa vita. Ora il popolo può continuare il viaggio verso la terra promessa, portando con sé, nell Arca dell Alleanza il documento che certifica il patto stipulato con Dio. La legge Il documento che redige l alleanza è quindi un corpo legislativo (le dieci parole in sintesi e il Codice dell Alleanza in esteso). Questo chiede di chiarire il senso della legge, della Torah in generale nella storia di Alleanza. La Torah prima di essere un codice di comportamento è il dono di una strada, l indicazione di uno stile di vita, quello che distingue Israele da ogni popolo, perché lo lega indissolubilmente alla storia che Dio sta scrivendo con lui (elezione). È certamente anche un codice morale, perché esplicita le conseguenze pratiche della relazione con Dio. Ma la legge senza la storia nella quale è rivelata perde la sua pregnanza. Anche nella loro formulazione i dettami, i precetti, rimandano costantemente a questa storia. Sia nei comandi che riguardano Dio, come la prima parola delle dieci (l unicità di Dio è legata al fatto che è Lui che ha liberato Israele dall Egitto) sia nelle pratiche che determinano le relazioni tra gli uomini; un esempio per tutti: il rispetto per lo straniero è un comando che ha la sua radice nel fatto che anche Israele è stato straniero nella sua storia («Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra di Egitto» Es 22,20). Solo all interno della cornice storica si comprende il comando. O detto altrimenti: l indicativo precede l imperativo. Ciò che Dio ha fatto, la storia di Alleanza, la liberazione ricevuta, la misericordia ricevuta, fondano il comportamento dell uomo e i suoi doveri nei confronti di Dio e degli altri uomini. In questo senso è limitativo intendere la Torah come comando, legge, precetto, nel senso legale che noi diamo ai termini. È più radicalmente un istruzione, una parola per la vita, l indicazione della via, per vivere secondo lo stile di Dio ed entrare così nella terra promessa, nella vita buona. Non dobbiamo pensare a questo documento come ad un testo piovuto dall alto, né alla sua ispirazione come una sorta di dettatura da parte di Dio al suo servo Mosè. L ispirazione è un concetto più raffinato. Dio parla attraverso la storia umana. Quelle norme sono l esito di un processo di sedimentazione della sapienza di vita di Israele. Vengono da Dio nel senso che Israele 3
4 ha la certezza che il suo percorso è stato guidato dal Signore e la sapienza di vita che ha elaborato è frutto del cammino intrapreso insieme a Dio; ma allo stesso tempo vengono dalla storia del popolo, sono frutto della sua pratica. I diversi precetti sono l esito di un diritto consuetudinario, la condensazione di una sapienza di vita che il popolo ha appreso cammin facendo (e certamente la redazione di gran parte dei precetti è successiva all evento del Sinai, perché riguarda problemi tipici di un popolo sedentario che non vive più nel deserto). Ma questa sapienza di vita ha la sua origine nell intervento di Dio, la sua parola precede quella degli uomini, ma anche la rende possibile, la autorizza. Così la legge è un dono, una grazia e insieme un compito. È dono che viene da Dio perché l iniziativa dell Alleanza parte da Dio: è Lui che si è scelto un popolo, che ha iniziato con un patto unilaterale (con Abramo prima e poi di seguito); ma non ha scelto un alleato semplicemente passivo, e quindi la legge nasce anche dalla sapienza di vita che Israele ha appreso nella sua storia, e i diversi precetti sono la condensazione di pratiche consuetudinarie. La relazione tra grazia e libertà, dono e risposta, trovano nel dono della Torah una loro singolare interpretazione: una non senza l altra. La legge senza la grazia diventa una maledizione, rischia sempre di fissarsi in norme esteriori che obbligano ma non liberano. Ma anche una libertà senza legge, senza una pratica di vita coerente con un senso, senza una indicazione di via da seguire, rischia di perdersi e restare indeterminata. Il testo 1 Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. 2 Levate le tende da Refidìm, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti al monte. 3 Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: "Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4 "Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. 5 Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! 6 Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa". Queste parole dirai agli Israeliti". 7 Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. 8 Tutto il popolo rispose insieme e disse: "Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!". Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. 9 Il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te". Mosè riferì al Signore le parole del popolo. 10 Il Signore disse a Mosè: "Va' dal popolo e santificalo, oggi e domani: lavino le loro vesti 11 e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo. 12 Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: "Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. 13 Nessuna mano però dovrà toccare costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo, non dovrà sopravvivere". Solo quando suonerà il corno, essi potranno salire sul monte". 14 Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece santificare il popolo, ed essi lavarono le loro vesti. 15 Poi disse al popolo: "Siate pronti per il terzo giorno: non unitevi a donna". 16 Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. 17 Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. 18 Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 19 Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 4
5 20 Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. 21 Il Signore disse a Mosè: "Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! 22 Anche i sacerdoti, che si avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!". 23 Mosè disse al Signore: "Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: "Delimita il monte e dichiaralo sacro"". 24 Il Signore gli disse: "Va', scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti egli si avventerà contro di loro!". 25 Mosè scese verso il popolo e parlò loro. Elezione e mediazione Ci soffermiamo in particolare sul capitolo 19, quello che prepara il dono della legge. Il popolo si è accampato alle falde del monte (Es 19,1). Da qui in avanti è un salire e scendere di Mosè che funge da mediatore tra Dio e il suo popolo. Con il popolo prende le parti di Dio e con Dio quelle del popolo. La prima parola che rivolge al popolo da parte di Dio è un richiamo alla storia e una promessa: «Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. 5 Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! 6 Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa» In principio sta l opera compiuta con amorevole delicatezza da Dio che ha sollevato su ali di aquile il popolo per farlo venire a Lui. Lo ha portato in braccio, lo ha scelto. L elezione è alla base della storia di salvezza. La promessa è quella di diventare la sua proprietà. «Il popolo di Israele è stato eletto, cioè scelto, per diventare la proprietà esclusiva. In Ebraico si utilizza il termine tecnico segullah, che indica proprio la proprietà particolare; è un termine legato all'ambiente dei pastori: un pastore che ha molte pecore al pascolo, magari le custodisce a nome di altri proprietari, poi ce n'è una parte che è proprio sua, è la sua segullah, è la sua parte, è la sua proprietà. Israele è questa proprietà particolare di Dio, cioè è strettamente legato a Dio perché da Dio è stato acquistato e da Dio è stato formato. Ma il concetto di proprietà, un popolo che diventa proprietà esclusiva di Dio, non è un concetto che esclude tutti gli altri popoli, è un concetto inclusivo, cioè comprende tutti gli altri popoli, tanto è vero che il versetto continua: "perché a me appartiene tutta la terra". Dio non dice: Voi, Israeliti, siete miei perché non ho nient'altro, il resto non è mio e almeno voi siete parte mia. No! Dice: Voi siete miei, ma mio è tutto il mondo. Quindi la dottrina della elezione di Israele non mette Israele sul piedistallo, escludendo gli altri popoli, ma sceglie una parte di umanità in funzione di tutta l'umanità. L'elezione di Israele include l'umanità intera che viene eletta attraverso Israele. Difatti continua il testo: Voi sarete per me un regno di sacerdoti e un popolo santo. Tema importantissimo, molto famoso in tutta la tradizione biblica, neotestamentaria e poi patristica e teologica. Il popolo viene costituito Regno di Sacerdoti. ( ) Escludiamo, prima di tutto, una interpretazione di tipo realista: qualche esegeta vorrebbe vedere in questo semplicemente un dato di fatto politico, amministrativo: Israele è un regno di sacerdoti in quanto governato dai sacerdoti, una struttura politica retta da sacerdoti. Io penso che il valore di questa affermazione sia molto più profondo e sia, soprattutto, simbolico. Si attribuisce, cioè, al popolo di Israele un ruolo sacerdotale; si intende dire che quel popolo è consacrato a Dio e, in quanto consacrato, diventa il sacerdote per i popoli. Ciò che è il sacerdote all'interno del popolo, così Israele è all'interno dell'umanità. Il popolo di Israele è concepito come il sacerdote dell'umanità, cioè il mediatore: ciò che Mosè è per Israele, Israele lo è per tutto il mondo, mediatore fra Dio e l'umanità» (Doglio). 5
6 La funzione di mediatore da parte di Mosè è centrale in tutto il libro dell Esodo ed emerge in modo significativo in questi capitoli. È lui che sale e scende, che parla prima con Dio, poi con il popolo e viceversa. Questa funzione di mediazione non è escludente ma inclusiva e simbolica. Abbiamo già visto che poi tutto il popolo dovrà partecipare all Alleanza e nel capitolo 24 prenderà parola e si dichiarerà a favore dell Alleanza. D altra parte una certa mediazione rimane sempre anche se in vista di una relazione diretta del popolo con Dio. Rimane sia perché occorre salvaguardare il carattere trascendente di Dio, sia perché il popolo si dimostrerà sempre inadeguato all Alleanza. Nel capitolo 24 avremo un gruppo (Mosè, Aronne i 70) che interpreta il ruolo di mediazione. Mosè stesso dovrà ancora e più volte intercedere per il popolo. Possiamo quindi riconoscere la necessità di una mediazione che si distende in forme e tempi diversi: Mosè è mediatore per il popolo; un drappello è mediatore per tutti gli altri; Israele stesso diventa mediatore per gli altri popoli. Questa mediazione è dunque simbolica: uno per tutti, uno a nome di tutti. Mosè a nome di Israele; Israele a nome di tutti i popoli, di tutta l umanità. Il tuono e la voce Il carattere trascendente della presenza di Dio è fortissimo in questo brano e si esprime attraverso le immagini cosmiche della teofania. «Gli elementi caratteristici sono quelli del temporale forse mescolati con un terremoto e qualcuno dice anche con fenomeni di eruzione vulcanica. "Al terzo giorno, sul far del mattino ci furono tuoni e lampi e una densa nube sul monte e un suono fortissimo di tromba e tutto il popolo nell'accampamento tremò." Le immagini che il narratore utilizza per presentare l'apparizione di Dio sono le immagini della tempesta: tuoni, lampi, nuvola molto densa ed un rumore strano che sembra simile ad un concerto di tromba. "Tutto il monte Sinai era in fumo, perché YHWH era sceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il popolo tremava forte." Questa seconda immagine sembra invece evocare un vulcano: la colonna di fumo, il fuoco sul monte. Può darsi che nella memoria storica del popolo si sia fissato un episodio di tempesta o una eruzione vulcanica. Nel momento dell'arrivo a questo santuario, a cui il popolo tendeva dal momento in cui era uscito dall'egitto, un evento naturale che ha del cataclisma ha segnato l'irruzione di Dio nella loro storia. Non si tratta propriamente di una visione, ma si tratta di un messaggio teologico. Di per sé si sottolinea chiaramente che non è stato visto nulla, cioè non c'era la forma di Dio chiaramente individuata, ma queste scene, questi eventi della natura sono una evocazione di Dio che rimane misterioso». Possiamo riconoscere in queste immagini della teofania da una parte la predominanza della voce (e correlativamente dell ascolto), e dall altra la promessa di una visione (ovvero di una comunione piena). «La solennità della scenografia sembra sottolineare in modo particolare certi poderosi effetti sonori, che si riassumono nel tuonare di una voce: Tutto il popolo che era nell accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fede uscire il popolo dall accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono ( 19,16-19). Il monte Sinai, dunque, è il luogo in cui Dio parla, in cui la sua voce rimbomba come il tuono; esso è quindi, corrispondentemente, il luogo dell ascolto, ed Israele può condensare la propria vocazione di popolo nell impegno ad ascoltare la voce di Jahwé, a custodirne le parole, a testimoniarne l efficacia. Si può dire che tutta la storia di Israele rientra nell ambito di una economia dell ascolto. Ma, in fondo, al pari la storia di Israele, è la storia di tutti i popoli e la nostra stessa storia di cristiani oggi, che si svolge in un arco di tempo definito dalla dimensione dell ascolto. E soltanto in una prospettiva escatologica ci è consentito di parlare di una economia della visione, la quale, sostituendosi all ascolto della parola, instaurerà un rapporto di definitiva appartenenza a Dio. A questo compimento di tutte le promesse allude già il rito dell alleanza, quando il racconto, 6
7 concentrando l attenzione su un piccolo drappello di privilegiati, dice che Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d Israele. Essi videro il Dio d Israele contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano; essi videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero (24,9-11). Il rito dell alleanza diventa così una promessa di comunione e di beatitudine per i puri di cuore a cui sarà manifestato il volto del Signore, perché vedranno Dio (Mt 5,8)» (Stancari). Approfondimenti Legge e Alleanza Merita approfondire il rapporto tra Alleanza e Legge, tra storia di salvezza e codice di vita, perché qui nella parabola esodica abbiamo in atto un dispositivo che sarà decisivo in tutta la storia e la teologia della tradizione biblica. La legge fa riferimento ad un evento che ne anticipa il senso, un beneficio accolto con stupita meraviglia; il carattere promettente di questa grazia preveniente chiede poi di essere non solo accolto ma anche voluto e deciso; l adesione alla legge, la risposta al patto che essa rappresenta è la condizione per il permanere nella grazia benefica sperimentata antecedentemente. La grazia potremmo sintetizzare precede la scelta dell uomo ma insieme la autorizza, la rende possibile, addirittura la esige: senza quella libertà che si decide non si permane nell orizzonte promettente che la grazia ha inaugurato. «Alla figura dell alleanza è strettamente legata quella della legge: i grandi codici legislativi sono iscritti appunto entro la cornice della grande pericope del Sinai. ( ) Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal pese di Egitto, dalla condizione di schiavitù: la formula stereotipa introduce le due redazioni del Decalogo e con lievi variazioni ritorna oltre cento volte nel Pentateuco; essa è oggi correntemente qualificata come formula di auto-presentazione del Dio legislatore. Essa riferisce con chiarezza la legge alla precedente iniziativa salvifica di Dio. Appunto attraverso l esodo Dio originariamente si manifesta: pronuncia una parola; dice che Egli è prima di tutto dice che Egli c è. Per riferimento all esodo trova giustificazione l autorità in forza della quale può imporre al popolo una legge. Tale rimando all esodo appare in forma più precisa ed esplicita in Esodo 19,1-8: il passo dedicato alla preparazione dell alleanza del Sinai. Il testo è di straordinaria pregnanza; ad esso ci riferiamo per una prima istituzione del senso sintetico dell alleanza. Viene lì proposta un immagine, che suggerisce efficacemente la qualità del nesso tra beneficio preveniente di Jahvé e il suo comandamento: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me (Es 19,4). Il cammino che ha condotto Israele fuori dall Egitto, sorprendentemente, subito convincente e per questo salutato dai figli di Israele come un beneficio, è paragonato al primo volo dell aquilotto sulle ali della madre, con il quale egli prende consuetudine con il cielo. L immagine torna in Dt 32,11; equivale nel senso all altra, usata da Osea, del bambino portato in braccio (cfr Os 11,1). Come ogni figlio di donna, anche il popolo di Dio inizia il proprio cammino in questo modo portato in braccio. L immagine descrive con efficacia una legge generale degli inizi della vita, e quindi anche delle forme che presiedono al primo apprezzamento del reale da parte del piccolo. Il suo consenso originario nei confronti della vita è propiziato dall esperienza dei benefici che suscitano l attitudine ad attendere e desiderare, poi anche a chiedere e addirittura a volere. Soltanto grazie a quei benefici il soggetto diventa capace di dire io, e insieme di fare io. Essi sono conosciuti senza la necessità che il minore ne abbia nozione già prima; senza necessità quindi che praticamente li persegua. Sono concessi a lui gratuitamente. Appunto attraverso l esperienza di tali benefici il bambino realizza la prima consapevolezza che c è chi lo conosce e provvede a lui, chi addirittura lo vuole; c è chi lo ha scelto. Realizza tale consapevolezza prima ancora di avere una 7
8 qualsiasi capacità di volere o anche solo di parlare, quando è ancora in-fans. Per tale esperienza originaria della vita appare già appropriato il termine teologico di grazia. Nel caso di Israele, il beneficio preveniente di Dio è identificato con l uscita meravigliosa dall Egitto. Quel cammino, compiuto senza necessità di scegliere e volere, è ulteriormente determinato per riferimento al suo primo termine:.e vi ho fatto venire fino a me. Il cammino, immediatamente apprezzato prima di sapere dove conduce, deve poi essere riconosciuto come prezioso perché consente di giungere fino alla presenza di Dio. Tale ulteriore determinazione riflette, ovviamente, una consapevolezza solo successiva: che il vantaggio di quell esodo fosse da scorgere appunto nella conseguente possibilità di stare alla presenza di Jahvé, Israele non lo sapeva ancora nel momento in cui viveva l evento. Lo scopre ai piedi del monte, nel momento in cui si produce la teofania del Sinai. Gravido di un significato, o più precisamente di una promessa, era però già lo stupore precedente. Di quel significato sfuggiva allora il senso, e tuttavia a proposito di quel significato già allora era viva l attesa. Anche in queste circostanze occorre leggere una legge universale: la meraviglia nella vita dell uomo ha questa funzione, suscitare un attesa e quindi anche una domanda: che cos è? Così sarà detto espressamente a proposito della meraviglia suscitata dalla manna. Sempre infatti la meraviglia è indice di una promessa: il contenuto di essa rimane in prima battuta soltanto implicito e nascosto; potrà essere rivelato soltanto dal seguito del cammino. Tale successiva esplicitazione non dovrà essere intesa, dunque, quasi fosse aggiunta surrettizia; essa determina la promessa fin dall inizio iscritta in un evento che suscita meraviglia. Consentire ad essa, nel momento in cui essa finalmente si rivela, è quanto impone la fedeltà al cammino precedente, che solo ci ha consentito di essere. Neppure la nuova condizione del popolo, quella cioè di chi sta alla presenza del Signore ai piedi del monte, può essere considerata la figura compiuta e sicura della promessa. Sul Sinai infatti Egli dà la legge, un istruzione dunque che si riferisce appunto a un cammino ulteriore. Soltanto al termine di quel cammino diventerà reale quella comunione tra Dio e il suo popolo, che Egli persegue fin dall inizio. Ai piedi del Sinai sussiste ancora una distanza tra Dio e il popolo; essa dovrà essere tolta attraverso la pratica effettiva della legge. Perché l originario beneficio possa trovare la conferma che ancora le manca, perché possa apparire come un beneficio effettivo per sempre, è necessario che il popolo finalmente faccia una scelta. Il beneficio accordato da Dio non diventa mai compiutamente proprio del popolo, o rispettivamente di ogni uomo, se non a condizione che questi lo voglia. Ora, se vorrete soltanto a condizione che davvero vogliate ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli (Es 19,5). La decisione chiesta al popolo, prima ancora d essere descritta in termini di berit, è descritta come decisione di ascoltare la sua voce. La voce a cui qui si allude è quella che pronuncia i comandamenti, certo; prima ancora è la voce che risuonava attraverso l esperienza del beneficio preveniente dell esodo. A meno di tanto, di udire una promessa attraverso quell esperienza e di dare ascolto ad essa, la figura originaria del beneficio è destinata a svanire. Non certo nel senso che l esodo possa cessare di essere un evento reale; piuttosto nel senso che esso cessa di apparire come un vantaggio. Il successivo cammino del deserto mostrerà in molti modi quanto ci fosse di ingenuo e inconsapevole nell iniziale apprezzamento dell esodo stesso da parte del popolo. Molte volte e in molti modi esso infatti si pentirà d aver iniziato il viaggio; riterrà addirittura d essere stato oggetto di un inganno da parte di Mosè, o forse di Dio stesso» (Angelini). Questa struttura della fede (atto preveniente di Dio, scoperta stupita della promessa iscritta nei primi passi, decisione di ascoltare e praticare le istruzioni iscritte in quella promessa e di vivere in obbedienza ad essa) plasmerà tutto il cammino di fede di Israele prima e dei discepoli poi. Anche i 8
9 discepoli, infatti, iniziano il cammino portati in braccio, scelti ed eletti dal Maestro. Dovranno poi riconoscere la legge iscritta in quell esperienza originaria e preveniente e decidere di fidarsi della sua promessa, quella che Gesù nelle beatitudini a riscritto come codice della nuova alleanza. Praticare e ascoltare Il legame tra alleanza e legge ci aiuta a riconoscere il carattere pratico della fede. Senza mettere in contrapposizione ascolto e messa in pratica, ma cogliendo il nesso profondo che li lega. Credere e ascoltare non sono un atto semplicemente mentale, ma una disposizione di sé che include l agire. Ascoltare e praticare sono in qualche modo interscambiabili. Infatti in Es 19 il comando fondamentale è quello di ascoltare («se ascolterete la mia voce»); l ascolto precede la messa in pratica e il popolo risponde dicendo: quanto il Signore ha detto noi lo faremo. In Es 24 invece la pratica precede l ascolto; il popolo aderisce all alleanza rispondendo: «Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto» (Es 24,7). Ascoltare ed eseguire, sono intimamente connessi. Non si ascolta se non si pratica, non si conosce la legge se non la si vive; non si pratica veramente il comando con una semplice esecuzione materiale, ma con l ascolto perdurante della sua voce. «In tutta la pericope di Es 19,3-8 la legge non viene neppure nominata. Ad essa fa però implicito riferimento l espressione: quanto il Signore ha detto noi lo faremo! (v 8). La legge con i suoi molti precetti, non si aggiunge al primo e più ovvio precetto, quello di ascoltare e credere. La legge non si aggiunge come altra cosa; determina invece il senso di quell unica cosa; il senso pratico (relativo all agire) che fin dall inizio la fede assume; essa indica dei comportamenti che corrispondono alla fede nella promessa. Credere infatti non è certo solo un modo di pensare, né tanto meno un modo di sentire; è invece un modo di agire, di disporre praticamente di sé. Il rilievo centrale della legge nella rivelazione biblica corrisponde appunto alla chiara percezione di questa consistenza pratica della fede». (Angelini) Cristo unico mediatore, la chiesa popolo sacerdotale In questo capitolo troviamo moltissimi temi che non sono che l inizio di un percorso che trova il suo compimento nel Nuovo Testamento (ovvero nella Nuova Alleanza). Possiamo solo allusivamente richiamarli per indicare un percorso che nell esperienza dell Esodo ha le sue radici e nella Pasqua di Gesù i suoi frutti più maturi. Alleanza. Dio in modo unilaterale ha dato inizio ad una storia di Alleanza. Con Adamo, con Noè (ovvero con tutti gli uomini), e poi con Abramo e Mosè (ovvero scegliendo un uomo e un popolo per far giungere la benedizione a tutti). Questa Alleanza ha la sua forza nella fedeltà di Dio alle sue promesse e la sua debolezza nella dura cervice del popolo. Dovrà attraversare molteplici momenti di crisi: da subito, proprio alle falde del monte dove si sta celebrando il rito di Alleanza, il popolo non regge l attesa di Mosè e costruirà il vitello d oro; entrato nella terra promessa il popolo non sarà fedele all Alleanza, ma incapace di vivere secondo quel codice di vita; il nuovo esilio segnerà l apice di questa crisi, ma anche il ritorno al deserto, la possibilità di una nuova Alleanza. Sarà la promessa di una nuova Alleanza quella che Gesù raccoglie e porta a compimento. Un patto non più scritto su tavole di pietra ma inciso nel cuore, il cui segno di appartenenza non è più la circoncisione del corpo ma un cuore circonciso, interamente segnato dal legame con il Signore. Il rito stesso dell Alleanza non è più il sacrificio di un agnello perché il Signore stesso sarà l Agnello immolato nel cui sangue siamo salvati. Diventiamo consanguinei di 9
10 Cristo, partecipiamo alla sua stessa vita. In Cristo l Alleanza si compie perché lui, assumendo la nostra umanità la rende capace di essere interlocutore del patto con Dio. Legge. Se la Legge è l indicazione, l istruzione per la via della vita, essa conosce fin dall inizio il rischio di essere una maledizione. La legge, nel suo carattere eteronomo chiede di essere assunta dalla libertà di chi le obbedisce. La tentazione è di confidare nell adesione materiale e formale del precetto per trovare in esso la propria giustizia. Ma un adesione letterale senza una comunione con lo spirito della legge è la morte della legge stessa, perché fa ricadere in una relazione con Dio di carattere padronale e non più sponsale. Cristo è l artefice di una nuova Alleanza anche perché scrive la legge nuova nei cuori dei suoi discepoli. La legge nuova come dice Tommaso è la legge dello Spirito che guida nel discernere il bene, nel vivere secondo Cristo. E l unico comandamento nuovo ma nel senso che svela il senso di tutti gli altri che Gesù lascia ai suoi è il comandamento dell amore: come io vi ho amati. Mediazione. Anche il tema della mediazione trova in Cristo una nuova interpretazione. Egli diventa l unico e ultimo mediatore, il solo nel quale troviamo salvezza: «Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù» (1Tm 2,5). Sarà soprattutto la lettera agli Ebrei a sviluppare questo tema in due direzioni. Cristo è mediatore perfetto perché ha assunto la nostra condizione umana. L incarnazione fonda la mediazione. E poi perché ha offerto un sacrificio per i peccati definitivo offrendo la propria vita. Dalla pasqua di Gesù non ci sono altre forme di mediazione fuori da questa: incarnazione e dono di sé diventano la ri-iscrizione esistenziale dell opera di mediazione. Popolo di sacerdoti. Entrando in Alleanza con Dio, diventando sua proprietà, Israele diventa il popolo di sacerdoti, quel popolo che custodendo la Legge, celebrando il culto che rende degni di stare alla sua presenza, offre a tutti i popoli la possibilità di accedere alla medesima Alleanza. Questa funzione di popolo sacerdotale non viene meno con Cristo: la chiesa incorporata con il suo Signore nel battesimo partecipa della sua funzione sacerdotale, profetica e regale. È sempre la lettera agli Ebrei a sviluppare il tema. Da una parte la lettera riconosce una cesura: Cristo è l unico sommo sacerdote, che offrendo se stesso mette fine agli antichi sacrifici. Dall altra noi possiamo ora in Cristo offrire il vero culto, una lode gradita, il dono della vita: «7 Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitatene la fede. 8 Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! 9 Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee, perché è bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne fanno uso. 10 Noi abbiamo un altare le cui offerte non possono essere mangiate da quelli che prestano servizio nel tempio. 11 Infatti i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per l'espiazione, vengono bruciati fuori dell'accampamento. 12 Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. 13 Usciamo dunque verso di lui fuori dell'accampamento, portando il suo disonore: 14 non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. 15 Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome» (Eb 13,7-15). L esodo come evento fondatore permette di cogliere il senso profondo del compimento che avviene in Cristo. Quanto è iniziato presso il Sinai, l Alleanza, la Legge, la funzione di mediazione, il sacerdozio del popolo, sono profezie che anticipano quello che Cristo svela compiutamente. Senza Cristo queste figure restano velate, ma senza l Esodo il compimento in Cristo rimane incomprensibile. 10
CORSO DI TEOLOGIA, SACRA SCRITTURA
 CORSO DI TEOLOGIA, SACRA SCRITTURA STRUTTURA DEL LIBRO DELL ESODO a) Es 1-2: Oppressione e sterminio dei bambini ebrei. Nascita e fuga di Mosè. Gemito e lamento del popolo oppresso b)es 3-4: Vocazione-missione
CORSO DI TEOLOGIA, SACRA SCRITTURA STRUTTURA DEL LIBRO DELL ESODO a) Es 1-2: Oppressione e sterminio dei bambini ebrei. Nascita e fuga di Mosè. Gemito e lamento del popolo oppresso b)es 3-4: Vocazione-missione
nell Antico Testamento
 Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna L uomo nell Antico Testamento appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2015/2016 V LEZIONE Sommario: - L uomoaimmaginedidio
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna L uomo nell Antico Testamento appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2015/2016 V LEZIONE Sommario: - L uomoaimmaginedidio
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
SOLTANTO ABBI FEDE GUIDA PASTORALE 2012/13 LA FEDE DI EZECHIELE
 SOLTANTO ABBI FEDE - 46 - GUIDA PASTORALE 2012/13 LA FEDE DI EZECHIELE ALZATI, TI VOGLIO PARLARE SOLTANTO ABBI FEDE - 48 - GUIDA PASTORALE 2012/13 Mi disse: Figlio dell uomo, àlzati, ti voglio parlare.
SOLTANTO ABBI FEDE - 46 - GUIDA PASTORALE 2012/13 LA FEDE DI EZECHIELE ALZATI, TI VOGLIO PARLARE SOLTANTO ABBI FEDE - 48 - GUIDA PASTORALE 2012/13 Mi disse: Figlio dell uomo, àlzati, ti voglio parlare.
DISCIPLINA: Religione Cattolica
 CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA
 BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
BREVI RIFLESSIONI SULLA PASSIONE DI GESU' SECONDO L'EVANGELISTA LUCA INTRODUZIONE Nei Vangeli Sinottici la passione viene predetta tre volte da Gesù, egli non si limita solo ad annunciarla ma ne indica
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
 OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Una delle più classiche è quella della donna giovane e bella, in. abbigliamento belle epoque che convive con una donna anziana, dal naso e dai
 Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Serie: Alberi di Giustizia. L uomo nato di Nuovo-2 1
 Serie: Alberi di Giustizia L uomo nato di Nuovo-2 1 NATO DI SPIRITO 2 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico, che chi non nasce di acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:5
Serie: Alberi di Giustizia L uomo nato di Nuovo-2 1 NATO DI SPIRITO 2 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico, che chi non nasce di acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:5
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Creatore, sui dati fondamentali della vita di Gesù. Individuare i tratti essenziali della
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Creatore, sui dati fondamentali della vita di Gesù. Individuare i tratti essenziali della
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA
 IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2016/2017 Classe Prima INDICATORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.
 EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
Scuola Primaria Longhena Bologna
 Scuola Primaria Longhena Bologna PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC A.S.2013/2014 1 CLASSE PRIMA Unità di Apprendimento Obiettivi Formativi Obiettivi Specifici Di Apprendimento Indicatori di Competenza LA CREAZIONE
Scuola Primaria Longhena Bologna PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC A.S.2013/2014 1 CLASSE PRIMA Unità di Apprendimento Obiettivi Formativi Obiettivi Specifici Di Apprendimento Indicatori di Competenza LA CREAZIONE
LA MONTAGNA NELLA BIBBIA. Distretto del turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile: la via dei parchi dei giovani di frontiera
 LA MONTAGNA NELLA BIBBIA Distretto del turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile: la via dei parchi dei giovani di frontiera Il libro della Genesi e il libro dell Esodo Genesi 8,4
LA MONTAGNA NELLA BIBBIA Distretto del turismo e del dialogo interreligioso e interculturale giovanile: la via dei parchi dei giovani di frontiera Il libro della Genesi e il libro dell Esodo Genesi 8,4
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA CONOSCENZE (I SAPERI) ABILITA' (SAPER FARE) DIO E L'UOMO DI COMPETENZA
 RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Gli Obiettivi di Apprendimento per ogni fascia di età sono articolati in quattro ambiti tematici : Dio e l uomo, con i principali riferimenti
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Gli Obiettivi di Apprendimento per ogni fascia di età sono articolati in quattro ambiti tematici : Dio e l uomo, con i principali riferimenti
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
- Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano)
 GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
VA DAI MIEI FRATELLI
 VA DAI MIEI FRATELLI SOLTANTO ABBI FEDE - 80 - GUIDA PASTORALE 2012/13 Maria invece stava all esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche
VA DAI MIEI FRATELLI SOLTANTO ABBI FEDE - 80 - GUIDA PASTORALE 2012/13 Maria invece stava all esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) Grado della Celebrazione: DOMENICA Colore liturgico: Viola Introduzione La quarta domenica di Avvento, per la sua vicinanza al Natale, ci invita a capire fino in fondo
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) Grado della Celebrazione: DOMENICA Colore liturgico: Viola Introduzione La quarta domenica di Avvento, per la sua vicinanza al Natale, ci invita a capire fino in fondo
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO
 III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI
 PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO
 ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
Riti di introduzione. Il Signore ci invita alla sua mensa. Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì.
 Riti di introduzione Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì Il Signore ci invita alla sua mensa E' il giorno del Signore: le campane ci invitano alla festa; Dio, nostro
Riti di introduzione Esercizi Spirituali - anno della Fede - Parrocchia SAN LORENZO -Lunedì Il Signore ci invita alla sua mensa E' il giorno del Signore: le campane ci invitano alla festa; Dio, nostro
La Chiamata di Dio e la risposta di Abramo Genesi 12,1-6
 La Chiamata di Dio e la risposta di Abramo Genesi 12,1-6 [1]Il Signore disse ad Abram:
La Chiamata di Dio e la risposta di Abramo Genesi 12,1-6 [1]Il Signore disse ad Abram:
PREGHIERA EUCARISTICA III
 PREGHIERA EUCARISTICA III Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello
PREGHIERA EUCARISTICA III Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello
Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio
 Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio ed Egli stesso fece alcuni apostoli; altri, profeti, ad altri ancora, evangelisti; altri, pastori e maestro al fine di perfezionare i santi per
Il servizio della Chiesa per compiere il Proposito di Dio ed Egli stesso fece alcuni apostoli; altri, profeti, ad altri ancora, evangelisti; altri, pastori e maestro al fine di perfezionare i santi per
PARTE BIBLICA. 1. La missione del Figlio. 2. La missione dello Spirito Santo
 PARTE BIBLICA Anticipazioni trinitarie nell AT 1. La missione del Figlio Padre nell AT. Dio Padre di Gesù. Gesù il Figlio di Dio. I misteri della vita di Cristo nella prospettiva trinitaria: l Incarnazione;
PARTE BIBLICA Anticipazioni trinitarie nell AT 1. La missione del Figlio Padre nell AT. Dio Padre di Gesù. Gesù il Figlio di Dio. I misteri della vita di Cristo nella prospettiva trinitaria: l Incarnazione;
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI
 CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 LAB. SCUOLA PRIMARIA GRUPPO 2: Marina Nazionale Antonia Di Giacinto Maddalena Recchiuti Donatella De Carolis A.Luisa Di Stefano Derna Gramenzi Rosella Polci Lucia Paoletti Teresina Orsatti. RELAZIONE Non
LAB. SCUOLA PRIMARIA GRUPPO 2: Marina Nazionale Antonia Di Giacinto Maddalena Recchiuti Donatella De Carolis A.Luisa Di Stefano Derna Gramenzi Rosella Polci Lucia Paoletti Teresina Orsatti. RELAZIONE Non
il commento di p. Maggi al vangelo della domenica
 il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58
il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58
LITURGIA DELLA PAROLA
 TUTTI I SANTI LITURGIA DELLA PAROLA PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14) Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Dal libro dell
TUTTI I SANTI LITURGIA DELLA PAROLA PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14) Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Dal libro dell
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana
 9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
Battesimo di Gesù / A
 Battesimo di Gesù / A Mt 3,13-17 Tu sei il mio figlio prediletto L attesa è finalmente compiuta e tutto accade al fiume Giordano. È lì che il cielo si apre e si unisce alla terra per generare il nuovo,
Battesimo di Gesù / A Mt 3,13-17 Tu sei il mio figlio prediletto L attesa è finalmente compiuta e tutto accade al fiume Giordano. È lì che il cielo si apre e si unisce alla terra per generare il nuovo,
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA
 CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai.
 I 10 COMANDAMENTI I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai. Vediamo quali sono i veri 10 Comandamenti che troviamo scritti sulla Bibbia in Esodo 20:1-17: 1. Io Sono il Signore,
I 10 COMANDAMENTI I 10 Comandamenti sono le Leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai. Vediamo quali sono i veri 10 Comandamenti che troviamo scritti sulla Bibbia in Esodo 20:1-17: 1. Io Sono il Signore,
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 RELIGIONE CLASSE2^ RELIGIONE CLASSE1^ RELIGIONE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA A.1 - Riconoscere che Dio è Creatore dell uomo e dell Universo. A.2 - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 RELIGIONE CLASSE2^ RELIGIONE CLASSE1^ RELIGIONE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA A.1 - Riconoscere che Dio è Creatore dell uomo e dell Universo. A.2 - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele
SAN GIOVANNI XXIII, papa
 11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
RELIGIONE CATTOLICA. Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione
 Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
il commento di p. Maggi al vangelo di natale
 il commento di p. Maggi al vangelo di natale IL VERBO SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI commento al vangelo del giorno di natale (25 dicembre 2016) di p. Alberto Maggi: Gv 1,1-18 In principio
il commento di p. Maggi al vangelo di natale IL VERBO SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI commento al vangelo del giorno di natale (25 dicembre 2016) di p. Alberto Maggi: Gv 1,1-18 In principio
Predicazione Crescere nella Conoscenza di Dio : L'intercessione Parte 2 - PdGToscana
 Predicazione del 14.11.2010 Redazione a cura di F.sca Lo Cascio Pastore Beniamino Cascio VERSO LA CONOSCENZA DI DIO : L'INTERCESSIONE (seconda parte) Il Pastore inizia questa predicazione esortandoci a
Predicazione del 14.11.2010 Redazione a cura di F.sca Lo Cascio Pastore Beniamino Cascio VERSO LA CONOSCENZA DI DIO : L'INTERCESSIONE (seconda parte) Il Pastore inizia questa predicazione esortandoci a
Approvato dall Episcopato italiano sarà obbligatorio per la Chiesa Italiana dal 28 novembre 2004, I domenica di Avvento
 Approvato dall Episcopato italiano sarà obbligatorio per la Chiesa Italiana dal 28 novembre 2004, I domenica di Avvento L edizione italiana del nuovo Rito del Matrimonio, rispettando le caratteristiche
Approvato dall Episcopato italiano sarà obbligatorio per la Chiesa Italiana dal 28 novembre 2004, I domenica di Avvento L edizione italiana del nuovo Rito del Matrimonio, rispettando le caratteristiche
MESSA IN COENA DOMINI Rito per la presentazione degli Oli santi
 MESSA IN COENA DOMINI DIOCESI DI TRAPANI Ufficio Liturgico MESSA IN COENA DOMINI DIOCESI DI TRAPANI UFFICIO LITURGICO Messa in Coena Domini RITO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI OLI SANTI SEGNO DI CROCE E
MESSA IN COENA DOMINI DIOCESI DI TRAPANI Ufficio Liturgico MESSA IN COENA DOMINI DIOCESI DI TRAPANI UFFICIO LITURGICO Messa in Coena Domini RITO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI OLI SANTI SEGNO DI CROCE E
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna. Introduzione
 Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 II LEZIONE BREVE STORIA DIISRAELE
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 II LEZIONE BREVE STORIA DIISRAELE
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. nel giorno in cui lo invocavo.
 SALMO 116 (CEI 2008) 1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 2 Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 3 Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli
SALMO 116 (CEI 2008) 1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 2 Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 3 Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli
UNITÀ DIDATTICA 1: LA BIBBIA
 UNITÀ DIDATTICA 1: LA BIBBIA - La Bibbia e l uomo - Ascoltare, leggere Bibbia; L alunno sa riconoscere la Bibbia quale fonte bibliche fondamentali tra cui le vicende e la figure principali del popolo d
UNITÀ DIDATTICA 1: LA BIBBIA - La Bibbia e l uomo - Ascoltare, leggere Bibbia; L alunno sa riconoscere la Bibbia quale fonte bibliche fondamentali tra cui le vicende e la figure principali del popolo d
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA
 CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CLASSI PRIMA SECONDA E TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA INDICATORI DI COMPETENZA PER
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CLASSI PRIMA SECONDA E TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA INDICATORI DI COMPETENZA PER
Sacra Scrittura e Simbolo
 Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
Sacra Scrittura e Simbolo La pagina biblica è un «grande codice» La Bibbia è costituita da tre lingue: 1. ebraico; 2. Aramaico; 3. Greco. Due mondi: 1. Semitico; 2. Greco. La Bibbia è CONTEMPORANEAMENTE
CONSOLARE GLI AFFLITTI
 CONSOLARE GLI AFFLITTI INTRODUZIONE: Il tema che mi è stato affidato è consolare gli afflitti, il più grande consolatore è lo Spirito Santo, mandato dal Signore dono della Pasqua, quindi prima di iniziare
CONSOLARE GLI AFFLITTI INTRODUZIONE: Il tema che mi è stato affidato è consolare gli afflitti, il più grande consolatore è lo Spirito Santo, mandato dal Signore dono della Pasqua, quindi prima di iniziare
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Padre e si confronta con l esperienza religiosa. della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale. della
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Padre e si confronta con l esperienza religiosa. della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale. della
Io sono con voi anno catechistico
 Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
RITI DI INTRODUZIONE
 RITI DI INTRODUZIONE Canto d ingresso: esprime la gioia di incontrare il Signore Il canto serve ad entrare nella celebrazione e a sentirci tutti uniti Segno di croce Nel nome del.... del... e dello.. Saluto:
RITI DI INTRODUZIONE Canto d ingresso: esprime la gioia di incontrare il Signore Il canto serve ad entrare nella celebrazione e a sentirci tutti uniti Segno di croce Nel nome del.... del... e dello.. Saluto:
CONSIGLIO. consigliare ed ascoltare col cuore
 CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
IL VANGELO DI MATTEO E' IL VANGELO DEL CATECHISTA
 IL VANGELO DI MATTEO E' IL VANGELO DEL CATECHISTA La Comunità Cristiana, dove è stato scritto il Vangelo di Matteo, probabilmente, si è posta questa domanda: come rafforzare la fede dei discepoli che hanno
IL VANGELO DI MATTEO E' IL VANGELO DEL CATECHISTA La Comunità Cristiana, dove è stato scritto il Vangelo di Matteo, probabilmente, si è posta questa domanda: come rafforzare la fede dei discepoli che hanno
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
NUCLEI FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
SCIENZA E FEDE un dialogo possibile
 Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
Le difficoltà del passato: La fede vedeva nella scienza la volontà dell uomo e della sua ragione di fare a meno Di Dio... SCIENZA E FEDE un dialogo possibile La scienza vedeva nella fede qualcosa di primitivo
 Sesto incontro Oggi vi parlerò del rito del Battesimo. Il battezzando viene accolto nella famiglia di Dio di cui entrerà a far parte. Il ministro chiede ai genitori il nome che gli vogliono dare. Con il
Sesto incontro Oggi vi parlerò del rito del Battesimo. Il battezzando viene accolto nella famiglia di Dio di cui entrerà a far parte. Il ministro chiede ai genitori il nome che gli vogliono dare. Con il
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa
 2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa Quando questa festa ricorre in domenica, si proclamano le tre letture qui indicate; se la festa ricorre in settimana, si sceglie come prima lettura una delle
2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa Quando questa festa ricorre in domenica, si proclamano le tre letture qui indicate; se la festa ricorre in settimana, si sceglie come prima lettura una delle
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
1 Novembre - TUTTI I SANTI
 1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
1 Novembre - TUTTI I SANTI Oggi la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Tale solennità ci invita a fare memoria non solo dei santi riportati nel calendario ma ricorda che ciascuno di noi è in cammino
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
Credo la Chiesa. Conversazioni sulla comunità credente. QUALE CHIESA? Introduzione alla questione.
 QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
Istituto Comprensivo Narcao. Scuola Primaria. Curricolo. Religione Cattolica
 Istituto Comprensivo Narcao Scuola Primaria Curricolo Religione Cattolica Scuola Primaria L insegnamento della Religione Cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola del ciclo primario.
Istituto Comprensivo Narcao Scuola Primaria Curricolo Religione Cattolica Scuola Primaria L insegnamento della Religione Cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola del ciclo primario.
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA. del.
 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale. S.Agostino
 Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale S.Agostino Cosa sono i Sacramenti I sacramenti sono segni efficaci del mistero di salvezza di Cristo: ne sono infatti l'attuazione nel "tempo
Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale S.Agostino Cosa sono i Sacramenti I sacramenti sono segni efficaci del mistero di salvezza di Cristo: ne sono infatti l'attuazione nel "tempo
Cos è il Battesimo? SECONDA CATECHESI
 Cos è il Battesimo? SECONDA CATECHESI Incontrare i genitori per: scoprire il Battesimo: Ecco gli obbiettivi impegnativi che questo secondo incontro ci pone di fronte Incontrare i genitori per: scoprire
Cos è il Battesimo? SECONDA CATECHESI Incontrare i genitori per: scoprire il Battesimo: Ecco gli obbiettivi impegnativi che questo secondo incontro ci pone di fronte Incontrare i genitori per: scoprire
QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE?
 QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di
QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di
Progetto di educazione religiosa anno 2017/2018 Custodi dell alleanza
 Progetto di educazione religiosa anno 2017/2018 Custodi dell alleanza Premessa Il progetto vuole far leva sulla capacità dei bambini di essere dei potenziali CUSTODI di ciò che li circonda. La motivazione
Progetto di educazione religiosa anno 2017/2018 Custodi dell alleanza Premessa Il progetto vuole far leva sulla capacità dei bambini di essere dei potenziali CUSTODI di ciò che li circonda. La motivazione
Le parti della Messa. (prima parte)
 Corso Chierichetti Secondo incontro: Le parti della Messa (prima parte) Cos è la Messa? La messa può essere definita come Memoriale della Pasqua del Signore Con queste parole intendiamo: 1. l ultima Cena;
Corso Chierichetti Secondo incontro: Le parti della Messa (prima parte) Cos è la Messa? La messa può essere definita come Memoriale della Pasqua del Signore Con queste parole intendiamo: 1. l ultima Cena;
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione Prima Parte
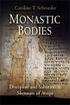 Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
GESÙ RISORTO PROMETTE LO SPIRITO SANTO AI SUOI AMICI
 ITINERARIO IN PREPARAZIONE ALLA CONFERMAZIONE LO SPIRITO SANTO SCENDE SU DI ME 1 GESÙ RISORTO PROMETTE LO SPIRITO SANTO AI SUOI AMICI DOPO LA SUA MORTE IN CROCE, GESÙ RISORTO INCONTRA PIÙ VOLTE I SUOI
ITINERARIO IN PREPARAZIONE ALLA CONFERMAZIONE LO SPIRITO SANTO SCENDE SU DI ME 1 GESÙ RISORTO PROMETTE LO SPIRITO SANTO AI SUOI AMICI DOPO LA SUA MORTE IN CROCE, GESÙ RISORTO INCONTRA PIÙ VOLTE I SUOI
CAPITOLO II FORMULARI PER MOMENTI PARTICOLARI DI VITA FRATERNA
 CAPITOLO II FORMULARI PER MOMENTI PARTICOLARI DI VITA FRATERNA NELLE MEMORIE DI NOSTRA SIGNORA E DEI FRATELLI SANTI Feste della Vergine P. O Dio, nostro Padre, che nella Vergine Maria hai dato alla Chiesa
CAPITOLO II FORMULARI PER MOMENTI PARTICOLARI DI VITA FRATERNA NELLE MEMORIE DI NOSTRA SIGNORA E DEI FRATELLI SANTI Feste della Vergine P. O Dio, nostro Padre, che nella Vergine Maria hai dato alla Chiesa
DELLA SCUOLA DEL SABATO
 LEZIONE 10 DELLA SCUOLA DEL SABATO I DUE PATTI 3 TRIMESTRE 2017 SABATO 2 SETTEMBRE 2017 In Galati 4:21-31, Paolo presenta la differenza tra la salvezza per fede e la salvezza per opere usando un allegoria:
LEZIONE 10 DELLA SCUOLA DEL SABATO I DUE PATTI 3 TRIMESTRE 2017 SABATO 2 SETTEMBRE 2017 In Galati 4:21-31, Paolo presenta la differenza tra la salvezza per fede e la salvezza per opere usando un allegoria:
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO PASSIRANO-PADERNO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA Revisione Curricolo di Istituto a.s. 2014-2015 Curricolo suddiviso in obiettivi didattici, nuclei tematici e anni
ISTITUTO COMPRENSIVO PASSIRANO-PADERNO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA Revisione Curricolo di Istituto a.s. 2014-2015 Curricolo suddiviso in obiettivi didattici, nuclei tematici e anni
Dio conosce il nome di tutti e ci chiama per nome. Egli chiamandoci per nome, conosce e svela la nostra vita, dipinge il nostro volto a sua immagine
 IL NOME Dio conosce il nome di tutti e ci chiama per nome. Egli chiamandoci per nome, conosce e svela la nostra vita, dipinge il nostro volto a sua immagine e somiglianza, con lineamenti unici e ben precisi.
IL NOME Dio conosce il nome di tutti e ci chiama per nome. Egli chiamandoci per nome, conosce e svela la nostra vita, dipinge il nostro volto a sua immagine e somiglianza, con lineamenti unici e ben precisi.
RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita
ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO.
 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano-
 Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
RELIGIONE. CLASSE PRIMA_Scuola Primaria Competenze Specifiche Abilità Conoscenze
 RELIGIONE CLASSE PRIMA_Scuola Primaria Colori, suoni, profumi, della natura religione cattolica e sa collegarli alle tradizioni ed espressioni culturali dell ambiente in cui vive Identifica l esperienza
RELIGIONE CLASSE PRIMA_Scuola Primaria Colori, suoni, profumi, della natura religione cattolica e sa collegarli alle tradizioni ed espressioni culturali dell ambiente in cui vive Identifica l esperienza
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE
 INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE Sorelle e fratelli, ci raduniamo in assemblea all inizio del nuovo anno che vogliamo porre sotto lo sguardo benedicente del Signore che nell incarnazione ha voluto condividere
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE Sorelle e fratelli, ci raduniamo in assemblea all inizio del nuovo anno che vogliamo porre sotto lo sguardo benedicente del Signore che nell incarnazione ha voluto condividere
LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I
 ANTONIO ROSMINI LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I Sulla vita perfetta in generale STRESA 2008 Trasposizione in lingua aggiornata di SUOR MARIA MICHELA RIVA Centro Internazionale di Studi Rosminiani STRESA (VB)
ANTONIO ROSMINI LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I Sulla vita perfetta in generale STRESA 2008 Trasposizione in lingua aggiornata di SUOR MARIA MICHELA RIVA Centro Internazionale di Studi Rosminiani STRESA (VB)
"Fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi. ha voluto assumere la nostra natura umana": è straordinariamente
 NATALE DEL SIGNORE 2015 Messa del giorno "Fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana": è straordinariamente bella la preghiera di Colletta
NATALE DEL SIGNORE 2015 Messa del giorno "Fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana": è straordinariamente bella la preghiera di Colletta
MARIA PRESENTA GESÙ AL TEMPIO
 Indice Prefazione ( Tommaso Caputo)... pag. 5 Capitolo I MARIA «MADRE DI DIO» (1 gennaio)...» 9 Solennità di Maria «Madre di Dio»...» 9 Il titolo di «Madre di Dio»...» 10 Maria «Madre» e «Vergine»...»
Indice Prefazione ( Tommaso Caputo)... pag. 5 Capitolo I MARIA «MADRE DI DIO» (1 gennaio)...» 9 Solennità di Maria «Madre di Dio»...» 9 Il titolo di «Madre di Dio»...» 10 Maria «Madre» e «Vergine»...»
nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione riconoscimento -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio
 RELIGIONE CATTOLICA nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione classe 1^ -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio sa riflettere -su Dio Creatore -su Dio Padre sa osservare
RELIGIONE CATTOLICA nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione classe 1^ -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio sa riflettere -su Dio Creatore -su Dio Padre sa osservare
ROSARIO DEI RAGAZZI MISSIONARI
 ROSARIO DEI RAGAZZI MISSIONARI CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO PREGHIERA INIZIALE: Come Maria percorriamo le strade del mondo. Come Maria portiamo Gesù che è il pane di vita; Con la fede di Maria affidiamo
ROSARIO DEI RAGAZZI MISSIONARI CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO PREGHIERA INIZIALE: Come Maria percorriamo le strade del mondo. Come Maria portiamo Gesù che è il pane di vita; Con la fede di Maria affidiamo
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA (I R C)
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA (I R C) ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROGRAMMAZIONE ANNUALE di RELIGIONE CATTOLICA (IRC) A.S. 2012/2013 L INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA (I R C) ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROGRAMMAZIONE ANNUALE di RELIGIONE CATTOLICA (IRC) A.S. 2012/2013 L INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE:
 RELIGIONE CATTOLICA CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi delle competenze L alunno: Comprende che il mondo è opera di
RELIGIONE CATTOLICA CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi delle competenze L alunno: Comprende che il mondo è opera di
