CAPITOLO 6 MISTERI INSOLUTI
|
|
|
- Leonora Mariotti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CAPITOLO MISTERI INSOLUTI 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
2 _capitolo.indd 1 1/0/ 1:
3 S tiamo per concludere il viaggio che abbiamo condotto attraverso lo spazio, tra pianeti, satelliti, asteroidi, galassie e stelle, e attraverso il tempo, all indietro fino all origine dell Universo, o almeno fino al punto in cui le nostre osservazioni, più o meno dirette, e le nostre conoscenze ci permettono di arrivare. Molti sono i problemi ancora aperti e per i quali i cosmologi stanno cercando una soluzione: la distribuzione spaziale degli ammassi di galassie, l esistenza della materia oscura, perché il nostro è un Universo di materia e non di antimateria e poi come si sono formate galassie e ammassi di galassie da un Universo primordiale, apparentemente uniforme; infine la sorprendente scoperta dell energia oscura. Ad alcuni di questi problemi abbiamo già avuto modo di accennare in altri capitoli, in queste ultime pagine cercheremo di approfondirli e svilupparli per quanto possibile sulla base delle conoscenze fin ora raggiunte. LA DISTRIBUZIONE DEGLI AMMASSI DI GALASSIE La distribuzione degli ammassi di galassie sulla volta celeste, cioè su una superficie, sembra del tutto casuale e uniforme, mentre conoscendo le distanze, si può ricostruire la loro distribuzione reale nello spazio a tre dimensioni. Ebbene, un risultato ottenuto in questi ultimi anni mostra che, almeno fino a una distanza di circa 1 miliardo di anni luce da noi (distanza a cui si estendono per ora le nostre più dettagliate osservazioni), gli ammassi di galassie e le galassie sono distribuiti nello spazio in modo tale da addensarsi sulle superfici di grandi volumi grosso modo sferici, a formare come delle enormi bolle praticamente vuote il cui diametro è dell ordine del centinaio di milioni di anni luce e il cui spessore è di circa milioni di anni luce. Dentro le bolle sembra non esserci nemmeno qualche debole galassia. La spiegazione di questa struttura a bolle è tuttora un mistero, ben più inspiegabile se si pensa che, a scala ancora più grande, l Universo sembra uniforme e le galassie e gli ammassi di galassie appaiono distribuiti uniformemente nello spazio Misteri insoluti 1 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
4 La distribuzione delle galassie nel cielo. Già nel 1 Shane e Wirtanen avevano compilato questa mappa, che raccoglie la posizione di galassie sulla volta celeste (visibile dall osservatorio Lick, il settore scuro è dovuto all orizzonte). L aspetto a «ragnatela» è evidente, stranamente però in quell epoca tale scoperta non suscitò grandissimo interesse nel pubblico. (LICK OBSERVATORY) CAPITOLO 0_capitolo.indd 1/0/ 1:
5 Un milione e mezzo di galassie in questa immagine. Si tratta di una mappa tridimensionale, dove il colore dal violetto al rosso indica la distanza fino a oltre 1 miliardo di anni luce, evidenziando la struttura a larga scala dell Universo (al centro domina la Via Lattea). Le galassie si raccolgono in gruppi più o meno numerosi, da alcune decine fino a migliaia di galassie, chiamati ammassi. A loro volta gli ammassi sono organizzati in superammassi, cioè gruppi di ammassi di galassie. Ammassi e superammassi non sono però distribuiti uniformemente nello spazio, ma si addensano sulla superficie di enormi bolle e sono separati da spazi vuoti immensi. La grande macchia violacea in alto al centro è l ammasso della Vergine. (MASS, XSCZ) LA MATERIA E L ENERGIA OSCURA Una delle recenti scoperte che ha messo in crisi gli scienziati è quella dell esistenza della materia oscura: è stato calcolato, infatti, che la maggior parte della materia si trova sotto una forma che non emette radiazioni elettromagnetiche e quindi risulta invisibile ai nostri strumenti. Ancora più misteriosa la presenza di un energia che si oppone alla forza di gravità e accelera l espansione dell Universo, scoperta recentemente e per cui nel è stato assegnato il premio Nobel per la fisica agli statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e all australiano Brian Schmidt. Prima di questa scoperta si pensava che l espansione dell Universo andasse decelerando per effetto della sua stessa gravità. Per determinare l entità di questo rallentamento, due gruppi di ricercatori, uno americano e uno australiano, avevano cominciato alla fine degli anni Ottanta a osservare una classe di supernove, note come SNIa, di cui si conosce con buona precisione lo splendore assoluto, per ottenere una più accurata relazione di Hubble fra spostamento verso il rosso e distanza estesa alle più lontane galassie raggiungibili con i moderni grandi telescopi, le quali ci avrebbero detto come avveniva l espansione nel lontano passato. La sorpresa è stata che invece di rallentare, l espansione risulta aver cominciato ad accelerare circa miliardi di anni fa come se ci fosse una energia che si oppone all energia gravitazionale. Dato che non si sa cosa sia, è stata chiamata «energia oscura». Non sappiamo se si tratta di una proprietà intrinseca dello spazio o se qualcosa di indipendente in esso contenuta. Nel primo caso la densità di energia rimarrebbe costante nel tempo, mentre nel secondo caso diminuirebbe la densità mentre la forza dell energia resterebbe costante con l aumentare dello spazio. Per ora sappiamo solo che questa «energia oscura» ha preso il sopravvento sulla gravità circa miliardi di anni fa a causa della diminuzione della gravità con l espansione. Oltre all energia oscura, abbiamo già visto nel capitolo terzo che in base ai dati ottenuti dalla misurazione della massa delle galassie, si può ipotizzare l esistenza di materia oscura. Per misurare la massa di una galassia, fino a poco tempo fa si contava il numero delle stelle e si moltiplicava questo numero per la massa di una stella media. In questo modo, ad esempio, la massa della nostra Galassia era pari a circa 0 miliardi di masse solari (prendendo il Sole come unità di misura). Un altro metodo di misura si basa sulle leggi della gravitazione: si studia il moto degli oggetti più periferici che gravitano attorno alla Galassia (ad esempio nubi gassose che emettono microonde). Da questo moto è possibile calcolare la massa della Galassia e si constata che è Misteri insoluti 0_capitolo.indd 1/0/ 1:
6 superiore di almeno cinque volte a quella visibile. Quindi la massa visibile, ricavata dagli oggetti che si vedono, è molto inferiore alla massa gravitazionale indicata dal moto dei corpi nella Galassia. Questo fatto vale per tutte le galassie di cui si possono contare le stelle e misurare i moti. Lo stesso risultato si ottiene per gli ammassi di galassie: dai moti delle galassie che compongono un ammasso, si vede che la massa visibile è circa un decimo della massa gravitazionale dell ammasso. Non sappiamo cosa sia la materia oscura, ma sono state fatte diverse ipotesi. Alcuni sostengono che si possa trattare di stelle molto numerose e molto deboli, o di un gran numero di pianeti molto grossi eppure poco o del tutto invisibili a grandi distanze. Ma se si ammette che la materia oscura sia formata da materia normale cioè di protoni, neutroni, elettroni nei primi tre minuti dopo il Big Bang non avrebbe potuto formarsi il deuterio, perché le condizioni fisiche sarebbero state tali da impedirlo. Il deuterio non ci dovrebbe essere o sarebbe talmente scarso da non essere misurabile, e questo contraddice i dati osservabili. Invece di essere materia normale, la materia oscura potrebbe essere costituita, quindi, da particelle che interagiscono pochissimo con la materia e che quindi risultano difficili da rilevare. Abbiamo già appreso che in natura si conosce solo un tipo di queste particelle, i neutrini. La massa dei neutrini è piccolissima tanto Universo oscuro. Sebbene sia ormai accertato che la materia visibile è soltanto una minima parte del contenuto dell Universo, ancora non v è certezza sulla vera natura della materia oscura e tantomeno si ha un idea di cosa sia davvero l energia oscura. CAPITOLO 0_capitolo.indd 1/0/ 1:
7 che non si è ancora riusciti a misurarla con precisione e per spiegare la massa mancante dovrebbero essere estremamente numerosi. In ogni caso i neutrini non potrebbero spiegare la massa mancante delle galassie, perché data la loro minuscola massa avrebbero velocità di gran lunga superiore alla velocità di fuga della galassia stessa e quindi sfuggirebbero nello spazio intergalattico. Non si può però escludere che in natura esistano altri tipi di particelle o, perlomeno, siano esistiti nei primi istanti di vita dell Universo. MATERIA E ANTIMATERIA Il problema dell asimmetria tra materia e antimateria nasce dalla constatazione che il nostro Universo è composto essenzialmente di materia. Particelle di antimateria, come il positrone e l antiprotone, si osservano nei raggi cosmici, ma nessuna antiparticella più pesante è stata trovata in natura. Eppure nell Universo primordiale esistevano probabilmente sia particelle che antiparticelle, in numero praticamente uguale. Perché allora questa asimmetria attuale? Si pensa che, come abbiamo accennato nel capitolo sulla cosmologia, per qualche motivo si fosse formato un piccolissimo eccesso di materia rispetto all antimateria. Tutte le coppie di particelle e antiparticelle si sarebbero annichilite una con l altra, dando luogo a un enorme produzione di energia (sotto forma di fotoni), e sarebbe rimasto solo quel piccolo eccesso di materia da cui avrebbe avuto origine il nostro Universo attuale. Una conferma di questa ipotesi è data dall osservato eccesso di fotoni rispetto alle particelle materiali: c è, infatti, un miliardo di fotoni per ogni particella. Inoltre, si conosce una particella instabile, il kaone, del quale abbiamo già parlato, la cui vita media è un centomilionesimo di secondo un po più lunga di quella dell antikaone. LA DISUNIFORMITÀ DELL UNIVERSO Che le galassie e le stelle ci siano è un fatto inconfutabile, ma perché e come si siano formate inizialmente è un problema aperto. La radiazione cosmica che pervade tutto l Universo attuale appare estremamente costante in tutte le direzioni. In qualunque direzione la si misuri si ottiene un valore di, K con un errore di misura di circa un decimillesimo di grado. Dato che tale radiazione testimonia com era l Universo primordiale, se ne deduce che anche l Universo oggi dovrebbe essere altrettanto uniforme. Sappia Misteri insoluti 1 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
8 mo, invece, che l Universo attuale è composto di stelle, galassie e ammassi di galassie separati da immensi spazi praticamente vuoti. Nella radiazione fossile dovrebbe esserci il seme di queste disuniformità. Per risolvere questo problema è necessario misurare la radiazione fossile con precisione ancora maggiore, alla ricerca di eventuali minime disuniformità. Proprio per questo scopo è stato stato dapprima costruito il satellite COBE (Cosmic Background Experiment), poi il WMAP (Wilkinson Anisotropy Probe) e infine il satellite Planck (le cui misurazioni sono ancora in corso). Perché dei satelliti? La radiazione emessa alla temperatura di, K ha un massimo a circa 1 millimetro di lunghezza d onda. Le microonde da qualche frazione di millimetro a qualche centimetro sono in gran parte assorbite dalla nostra atmosfera; di conseguenza, le osservazioni della radiazione cosmica si fanno preferibilmente da palloni in alta quota e, meglio ancora, da satelliti, che possono continuare le osservazioni anche per alcuni anni. Le prime misure effettuate con COBE (1) indicavano una temperatura costante in ogni direzione. Ma ulteriori misure () effettuate dopo aver apportato le correzioni per l effetto doppler dovuto al moto del Sistema solare nella Galassia e per la radiazione emessa dalla Galassia stessa, da altre galassie e da ammassi di Il fondo del cielo osservato dalla sonda WMAP. La radiazione cosmica a microonde, che vediamo in questo planisfero celeste, ci mostra l Universo primordiale. La colorazione dal blu al rosso evidenzia i deboli contrasti di luminosità, che corrispondono alle variazioni di temperatura della materia in formazione, quando l Universo era ancora incandescente (circa 000 gradi), mezzo milione di anni dopo il Big Bang. Le macchioline rosse rappresentano zone più calde e dense, da cui poi nasceranno gli ammassi di galassie; si può stimare che da ogni singola macchiolina si formeranno decine di migliaia di galassie. (NASA) 1 CAPITOLO 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
9 Il cielo di Planck. Dopo un anno di misurazioni, il satellite europeo Planck ha tracciato questa mappa completa del cielo a microonde. La Via Lattea domina in primo piano, ma sullo sfondo si vede con un colore più aranciato (ovvero a lunghezze d onda maggiori) la radiazione cosmica primordiale. Quando il contributo della Via Lattea verrà rimosso (sfruttando la differenza spettrale), apparirà la retrostante radiazione cosmica di fondo con una nitidezza senza precedenti. Nel momento in cui stiamo completando questo libro, la comunità scientifica è in grande attesa dei prossimi risultati. (ESA) galassie hanno dimostrato che ci sono delle piccolissime disomogeneità nella temperatura, con zone più calde o più fredde di 1, centomillesimi di grado del valore medio. Queste disuniformità indicano l esistenza di strutture immense, estese molto più di 0 milioni di anni luce, e rappresenterebbero l origine delle attuali strutture a grande scala (come i superammassi di galassie) osservati nell Universo oggi. COBE aveva il difetto di essere «miope», aveva un potere risolutivo di gradi d arco, cioè non era in grado di distinguere dettagli visti sotto un angolo più piccolo di gradi, pari a 1 diametri angolari del Sole o della Luna. Le immagini dell Universo primordiale apparivano molto «sfocate». I successivi esperimenti, il progetto BOOMERANG (in cui le osservazioni erano eseguite da un telescopio su pallone stratosferico che per le particolari condizioni atmosferiche dell Antartide orbitava attorno al polo sud), e poi le osservazioni dei satelliti WMap e Planck, hanno dato immagini molto più nitide, in cui si vedevano dettagli di dimensioni angolari inferiori al grado. Queste misurazioni hanno anche permesso di stabilire che il nostro Universo è piano, obbedisce cioè alla geometria euclidea, non è né curvo e chiuso (come l analogo della superficie della sfera), né curvo e aperto (come l analogo della superficie di un iperboloide) Misteri insoluti 1 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
10 Possiamo concludere questo viaggio attraverso un estensione di quasi 1 miliardi di anni luce e una durata temporale di quasi 1 miliardi di anni osservando quanto si sia dilatata la nostra conoscenza dell Universo nel corso del XX secolo, come oggi si sia coscienti di abitare un minuscolo pianeta fra miliardi di altri, di orbitare attorno a una comunissima stella fra miliardi di altre in una comune galassia fra centinaia di miliardi di altre galassie e ammassi di galassie, che costituiscono l Universo, cioè tutto ciò che esiste. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo sicuri che anche l Universo non sia uno fra tanti? Che esistano altri universi simili o diversi dal nostro? Possiamo solo immaginarlo. Sappiamo di essere fatti di materia prodotta dalle reazioni nucleari che avvengono nell interno delle stelle. Sappiamo di essere un prodotto dell evoluzione dell Universo che ha sviluppato la capacità di osservare, misurare e comprendere lo spazio intorno a noi. Forse in questo XXI secolo riusciremo a capire cosa sono la materia e l energia oscura e il loro ruolo nella formazione ed evoluzione delle galassie, a scoprire pianeti simili alla Terra e forse un giorno riceveremo un segnale radio modulato, non i soliti rumori emessi dal Sole e dalle galassie, ma un segnale chiaramente artificiale partito da un lontano pianeta anni e forse secoli fa da chi come noi si domanda: ma siamo soli nell Universo? Possibile che questo immenso Universo abbia generato una sola civiltà? 1 CAPITOLO 0_capitolo.indd 1 1/0/ 1:
Astrofisica e cosmologia
 Astrofisica e cosmologia Lezioni d'autore Claudio Cigognetti La radiazione cosmica di fondo (SuperQuark Rai) VIDEO L'energia oscura (parte prima) VIDEO L'energia oscura (parte seconda) VIDEO La misura
Astrofisica e cosmologia Lezioni d'autore Claudio Cigognetti La radiazione cosmica di fondo (SuperQuark Rai) VIDEO L'energia oscura (parte prima) VIDEO L'energia oscura (parte seconda) VIDEO La misura
Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione
 Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Brera Universo in fiore Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione Luigi Guzzo Luigi.guzzo@brera.inaf.it INAF-Osservatorio
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Brera Universo in fiore Il modello cosmologico standard e l enigma dell espansione Luigi Guzzo Luigi.guzzo@brera.inaf.it INAF-Osservatorio
Tutti i colori dell Universo. Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004
 Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia
 Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia l alba dell universo I primi risultati cosmologici del satellite Planck Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica 11 aprile 2013 Cosmologia
Modello Cosmologico Standard Paola M. Battaglia l alba dell universo I primi risultati cosmologici del satellite Planck Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica 11 aprile 2013 Cosmologia
Cartoline dal big bang. Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica
 Cartoline dal big bang Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica Contenuto Quanto è grande l Universo? La radiazione cosmica di fondo: : un fossile osservabile del Big Bang! Cosmologia di precisione
Cartoline dal big bang Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica Contenuto Quanto è grande l Universo? La radiazione cosmica di fondo: : un fossile osservabile del Big Bang! Cosmologia di precisione
5 CORSO DI ASTRONOMIA
 5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
4 CORSO DI ASTRONOMIA
 4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
Materia oscura nell Universo
 Materia oscura nell Universo Biblioteca Civica Archimede Settimo Torinese, aprile 2013 Alessandro Bottino Università di Torino/INFN Un viaggio in tre tappe nell Universo Pi Prima tappa: Le osservazioni
Materia oscura nell Universo Biblioteca Civica Archimede Settimo Torinese, aprile 2013 Alessandro Bottino Università di Torino/INFN Un viaggio in tre tappe nell Universo Pi Prima tappa: Le osservazioni
Stefano Borgani Dipartimento di Fisica Universita di Trieste (INAF & INFN - Trieste)
 Il Lato Oscuro dell Universo Stefano Borgani Dipartimento di Fisica Universita di Trieste (INAF & INFN - Trieste) Episodio 1: L Universo che osserviamo Episodio 2: I fondamenti della Cosmologia moderna
Il Lato Oscuro dell Universo Stefano Borgani Dipartimento di Fisica Universita di Trieste (INAF & INFN - Trieste) Episodio 1: L Universo che osserviamo Episodio 2: I fondamenti della Cosmologia moderna
Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad
 Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad una enorme quantità di altre cose che non vediamo)
Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad una enorme quantità di altre cose che non vediamo)
Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram
 Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram Alessandro De Angelis Dipartimento di Fisica dell Universita di Udine e INFN Trieste Giornate Scientifiche di Udine e Pordenone, Marzo 2002 Time
Si fuit aliquod tempus antequam faceres caelum et terram Alessandro De Angelis Dipartimento di Fisica dell Universita di Udine e INFN Trieste Giornate Scientifiche di Udine e Pordenone, Marzo 2002 Time
Ciao! Ma ricorda la cosa più importante:
 Ciao! La volta scorsa abbiamo parlato della radiazione che ci arriva dalla nostra galassia e a come possiamo raccoglierla per studiarla con sensori diversi che permettono di vedere aspetti diversi dello
Ciao! La volta scorsa abbiamo parlato della radiazione che ci arriva dalla nostra galassia e a come possiamo raccoglierla per studiarla con sensori diversi che permettono di vedere aspetti diversi dello
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
L Universo secondo la Fisica moderna
 Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
quando la vita di una stella sta per giungere al termine l'idrogeno diminuisce limitando le fusione nucleare all interno
 le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria hanno la forma di sfere luminose ed emettono radiazioni elettromagnetiche causate dalle reazioni nucleari che avvengono al loro interno (atomi
le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria hanno la forma di sfere luminose ed emettono radiazioni elettromagnetiche causate dalle reazioni nucleari che avvengono al loro interno (atomi
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
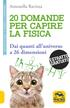 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
AMMASSI DI GALASSIE. Marco Castellano.
 AMMASSI DI GALASSIE Marco Castellano castellano@oa-roma.inaf.it AMMASSI DI GALASSIE Gli oggetti più grandi dell Universo: 1) Un breve viaggio verso l Ammasso più vicino a noi 2) Quanto sono grandi: la
AMMASSI DI GALASSIE Marco Castellano castellano@oa-roma.inaf.it AMMASSI DI GALASSIE Gli oggetti più grandi dell Universo: 1) Un breve viaggio verso l Ammasso più vicino a noi 2) Quanto sono grandi: la
Cosmologia Semplice: La Cosmologia Moderna. Stefano Spagocci GACB
 Cosmologia Semplice: La Cosmologia Moderna Stefano Spagocci GACB Cosmologia Classica Agli inizi degli anni '70, la cosmologia classica aveva ottenuto diversi successi teorici e sperimentali. Friedmann
Cosmologia Semplice: La Cosmologia Moderna Stefano Spagocci GACB Cosmologia Classica Agli inizi degli anni '70, la cosmologia classica aveva ottenuto diversi successi teorici e sperimentali. Friedmann
TEORIA DELLA RELATIVITA
 Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
Cenni sulle teorie cosmologiche TEORIA DELLA RELATIVITA Nasce dalla constatazione che il movimento è relativo, e dipende dal sistema di riferimento. La teoria è formulata da Einstein che coniuga la precedente
Misteri nell Universo
 Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
1. L ambiente celeste
 1. L ambiente celeste Arecibo (Puerto Rico, Antille), 12 ottobre 1992: cinquecentesimo anniversario della scoperta dell America. Il potente radiotelescopio, la cui parabola riveste un ampia cavità naturale,
1. L ambiente celeste Arecibo (Puerto Rico, Antille), 12 ottobre 1992: cinquecentesimo anniversario della scoperta dell America. Il potente radiotelescopio, la cui parabola riveste un ampia cavità naturale,
Big Bang, materia e antimateria
 Big Bang, materia e antimateria Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Physics Class, Modena 23/09/2015 Le domande fondamentali
Big Bang, materia e antimateria Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Physics Class, Modena 23/09/2015 Le domande fondamentali
IL DESTINO DELLA COSTANTE COSMOLOGICA L ERRORE PIÙ GRAVE DI EINSTEIN
 IL DESTINO DELLA COSTANTE COSMOLOGICA L ERRORE PIÙ GRAVE DI EINSTEIN La Relatività Generale Le forze di gravità sono associate a deformazioni dello spazio ed eventualmente del tempo ( Lo spazio si deforma
IL DESTINO DELLA COSTANTE COSMOLOGICA L ERRORE PIÙ GRAVE DI EINSTEIN La Relatività Generale Le forze di gravità sono associate a deformazioni dello spazio ed eventualmente del tempo ( Lo spazio si deforma
LE STELLE, LE GALASSIE, L UNIVERSO
 LE STELLE, LE GALASSIE, L UNIVERSO Una stella è un corpo celeste che brilla di luce propria : è un agglomerato di materia allo stato gassoso in grado di produrre una grandissima quantità di energia CARATTERISTICHE
LE STELLE, LE GALASSIE, L UNIVERSO Una stella è un corpo celeste che brilla di luce propria : è un agglomerato di materia allo stato gassoso in grado di produrre una grandissima quantità di energia CARATTERISTICHE
Salve ragazze e ragazzi!
 Salve ragazze e ragazzi! Bentornati nel nostro Osservatorio. In questa puntata continueremo a studiare la nostra Galassia e anche le altre galassie che popolano l Universo. Per studiare le galassie, quindi,
Salve ragazze e ragazzi! Bentornati nel nostro Osservatorio. In questa puntata continueremo a studiare la nostra Galassia e anche le altre galassie che popolano l Universo. Per studiare le galassie, quindi,
Un viaggio nel tempo di 14 miliardi di anni
 Un viaggio nel tempo di 14 miliardi di anni La formazione delle stelle La formazione degli elementi Il big bang La formazione dei pianeti Le origini della vita 1 Il big bang Avvenne proprio qui, circa
Un viaggio nel tempo di 14 miliardi di anni La formazione delle stelle La formazione degli elementi Il big bang La formazione dei pianeti Le origini della vita 1 Il big bang Avvenne proprio qui, circa
L origine dell universo
 LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
LE STELLE Le stelle sono corpi celesti luminosi, formati da enormi quantità di gas caldissimo (principalmente idrogeno ed elio), che producono energia attraverso un processo di fusione nucleare dove 4
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
Big Bang ed Evoluzione dell Universo. NUOVO ISTITUTO CARDUCCI SIENA 03 DICEMBRE 2010 DOCENTE : Angela Dami
 Big Bang ed Evoluzione dell Universo NUOVO ISTITUTO CARDUCCI SIENA 03 DICEMBRE 010 DOCENTE : Angela Dami Universo stazionario Redshift dello spettro delle radiazioni emanate dalle galassie Scoperta di
Big Bang ed Evoluzione dell Universo NUOVO ISTITUTO CARDUCCI SIENA 03 DICEMBRE 010 DOCENTE : Angela Dami Universo stazionario Redshift dello spettro delle radiazioni emanate dalle galassie Scoperta di
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Qualche cenno al Sole
 Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI
 Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI By Giuseppe Cutispoto Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una
Olimpiadi Italiane di Astronomia Preparazione alla fase interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia MAGNITUDINI By Giuseppe Cutispoto Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una
Unità 2 - L ambiente celeste
 Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Unità 2 - L ambiente celeste 1 1. La Sfera celeste Stelle in rotazione 2 1. La Sfera celeste Punti di riferimento sulla Sfera celeste 3 1. La Sfera celeste Individuare la Stella polare sulla Sfera celeste
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto
 Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
Magnitudini e Diagramma H-R Giuseppe Cutispoto INAF Osservatorio Astrofisico di Catania gcutispoto@oact.inaf.it Versione: 4 febbraio 018 Magnitudine apparente La magnitudine apparente (m) di una stella
M CR C O R MO M ND N O
 HIGGS DALL UNIFICAZIONE DELLA FISICA ALLA GRANDE ESPLOSIONE DELL'UNIVERSO Claudio Firmani UNAM-INAF uno sguardo al MICROMONDO Per unificazione della fisica si intende l unificazione delle quattro forze
HIGGS DALL UNIFICAZIONE DELLA FISICA ALLA GRANDE ESPLOSIONE DELL'UNIVERSO Claudio Firmani UNAM-INAF uno sguardo al MICROMONDO Per unificazione della fisica si intende l unificazione delle quattro forze
mercoledì 13 febbraio 2013 Universo Primitivo Adriano Fontana INAF - Osservatorio Astronomico di Roma Università La Sapienza - Roma
 Universo Primitivo Adriano Fontana INAF - Osservatorio Astronomico di Roma Università La Sapienza - Roma Nebbie cosmiche: le prime galassie dell'universo. Adriano Fontana INAF - Osservatorio Astronomico
Universo Primitivo Adriano Fontana INAF - Osservatorio Astronomico di Roma Università La Sapienza - Roma Nebbie cosmiche: le prime galassie dell'universo. Adriano Fontana INAF - Osservatorio Astronomico
Nane bianche e stelle di neutroni. di Roberto Maggiani
 Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
Lezione 7. Cenni di cosmologia (parte II osservazioni dell'universo lontano: due esempi)
 Lezione 7 Cenni di cosmologia (parte II osservazioni dell'universo lontano: due esempi) Esempio 1 Evidenze di energia oscura da osservazioni di supernove lontane La distanza di luminosità per oggetti distanti
Lezione 7 Cenni di cosmologia (parte II osservazioni dell'universo lontano: due esempi) Esempio 1 Evidenze di energia oscura da osservazioni di supernove lontane La distanza di luminosità per oggetti distanti
ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE
 ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE 1. Scrivi i nomi dei pianti del Sistema Solare che compaiono nell immagine Sole= 2. Dai le seguenti definizioni Pianeta terrestre= Satelliti galileiani= Pianeta nano= Stella=
ESERCIZI SCIENZE: SISTEMA SOLARE 1. Scrivi i nomi dei pianti del Sistema Solare che compaiono nell immagine Sole= 2. Dai le seguenti definizioni Pianeta terrestre= Satelliti galileiani= Pianeta nano= Stella=
Le nebulose. Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma.
 Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
(In Luce Visibile: nm)
 (In Luce Visibile: 300 700 nm) La fascia piu` chiara che attraversa il cielo notturno e` stata indicata in tutte le culture antiche con vari nomi che spesso fanno riferimento ai concetti di: Fiume Celeste
(In Luce Visibile: 300 700 nm) La fascia piu` chiara che attraversa il cielo notturno e` stata indicata in tutte le culture antiche con vari nomi che spesso fanno riferimento ai concetti di: Fiume Celeste
Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura?
 Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura? Seminari di Fisica Dipartimento di Fisica dell Universita di Torino 26 gennaio 2016 Alessandro Bottino Evidenze osservative di presenza di materia oscura
Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura? Seminari di Fisica Dipartimento di Fisica dell Universita di Torino 26 gennaio 2016 Alessandro Bottino Evidenze osservative di presenza di materia oscura
L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura
 L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura Prof. Armando Pisani, M. Peressi e G. Pastore I.S.I.S. (Lic. Classico) D. Alighieri (GO), A.S. 2013-14 Indice Introduzione Di che cosa è fatto l
L essenziale è invisibile agli occhi: la materia oscura Prof. Armando Pisani, M. Peressi e G. Pastore I.S.I.S. (Lic. Classico) D. Alighieri (GO), A.S. 2013-14 Indice Introduzione Di che cosa è fatto l
C.O.D.A.S. Centro Osservazioni e Divulgazione Astronomiche Siracusa. A cura di Sebastiano Leggio
 C.O.D.A.S. Centro Osservazioni e Divulgazione Astronomiche Siracusa A cura di Sebastiano Leggio Le Stelle per gli Antichi COSA E E UNA STELLA??? Per gli antichi esistevano diversi tipi di stelle Le Stelle
C.O.D.A.S. Centro Osservazioni e Divulgazione Astronomiche Siracusa A cura di Sebastiano Leggio Le Stelle per gli Antichi COSA E E UNA STELLA??? Per gli antichi esistevano diversi tipi di stelle Le Stelle
Il lato oscuro dell universo
 Gran Sasso Science Institute - L'Aquila 25-26 Ottobre 2018 Nuovi orizzonti di una scienza in divenire Il lato oscuro dell universo Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano
Gran Sasso Science Institute - L'Aquila 25-26 Ottobre 2018 Nuovi orizzonti di una scienza in divenire Il lato oscuro dell universo Marco Bersanelli Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano
Le Nubi di Magellano, illustrate al mio cane
 Le Nubi di Magellano, illustrate al mio cane @ Ing. Silvano D Onofrio resto di supernova nella Grande Nube la nebulosa NGC 346, nella Piccola Nube Sommario Le Nubi di Magellano, illustrate al mio cane...
Le Nubi di Magellano, illustrate al mio cane @ Ing. Silvano D Onofrio resto di supernova nella Grande Nube la nebulosa NGC 346, nella Piccola Nube Sommario Le Nubi di Magellano, illustrate al mio cane...
Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748
 Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748 Marco Berton, Liceo Scientifico U. Morin - Mestre Alessio Dalla Valle, Liceo Scientifico G. Bruno Mestre Luca Marafatto, Liceo Classico M. Foscarini
Determinazione della curva di luce e della massa di NGC 2748 Marco Berton, Liceo Scientifico U. Morin - Mestre Alessio Dalla Valle, Liceo Scientifico G. Bruno Mestre Luca Marafatto, Liceo Classico M. Foscarini
INTRODUZIONE. ...et semina rerum...quod ex illis sunt omnia primis... e semi delle cose, che gli elementi primi son essi, onde il tutto si forma.
 INTRODUZIONE Una relazione profonda collega i fenomeni su grande scala ai costituenti fondamentali della materia; La relazione tra le cose e i i semi delle cose, di cui ci parla Lucrezio. Questo legame
INTRODUZIONE Una relazione profonda collega i fenomeni su grande scala ai costituenti fondamentali della materia; La relazione tra le cose e i i semi delle cose, di cui ci parla Lucrezio. Questo legame
I buchi ne!: piccoli. e gran" cannibali
 I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
Docente: Alessandro Melchiorri Slides delle lezioni: oberon.roma1.infn.it/alessandro/astro2014
 Astronomia Lezione 11/12/2014 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides delle lezioni: oberon.roma1.infn.it/alessandro/astro2014 Quali sono i processi nucleari? Nucleosintesi:
Astronomia Lezione 11/12/2014 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides delle lezioni: oberon.roma1.infn.it/alessandro/astro2014 Quali sono i processi nucleari? Nucleosintesi:
Fondamenti di Astrofisica. Alessandro Marconi
 Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
Alessandro Marconi Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Largo E. Fermi 2 email: marconi@arcetri.astro.it, alessandro.marconi@unifi.it
La Terra nello spazio
 La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
 PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO La Terra: il nostro pianeta L uomo ha da sempre compreso l importanza di conoscere l ambiente in cui vive. Fin dall antichità, osservando
PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO La Terra: il nostro pianeta L uomo ha da sempre compreso l importanza di conoscere l ambiente in cui vive. Fin dall antichità, osservando
LHC e la struttura dell Universo. Luca Lista INFN
 LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania
 Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania EINSTEIN 1915 Nascita della Relatività Generale e della Cosmologia Moderna R - g R + g = (8 G/c 4 )T R tensore di curvatura di Ricci
Lucio Paternò Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Catania EINSTEIN 1915 Nascita della Relatività Generale e della Cosmologia Moderna R - g R + g = (8 G/c 4 )T R tensore di curvatura di Ricci
Filippo Mannucci Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri
 Filippo Mannucci Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri La scienza prima del 500 1. La Terra è comodamente al centro dell universo Voi siete qui Un formidabile sistema: astronomia
Filippo Mannucci Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di Arcetri La scienza prima del 500 1. La Terra è comodamente al centro dell universo Voi siete qui Un formidabile sistema: astronomia
L Universo Invisibile. Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico
 L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
Universo in evoluzione. Universo statico. modifica delle equazioni di campo della R.G. costante cosmologica. Albert Einstein
 1917 G µν = k T µν Universo in evoluzione Universo statico modifica delle equazioni di campo della R.G. Albert Einstein G µν Λ g µν = k T µν costante cosmologica 1922 G µν = k T µν Universo in espansione
1917 G µν = k T µν Universo in evoluzione Universo statico modifica delle equazioni di campo della R.G. Albert Einstein G µν Λ g µν = k T µν costante cosmologica 1922 G µν = k T µν Universo in espansione
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
Il nostro Universo. Che cos è il Big Bang? Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011
 Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera
 Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera TRAPPIST-1 ed i 7 pianeti Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta simile alla
Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera TRAPPIST-1 ed i 7 pianeti Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta simile alla
1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang
 1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang Le caratteristiche delle stelle le stelle sono lontanissime dalla Terra; le loro distanze
1. Le caratteristiche delle stelle 2. La vita e la morte delle stelle 3. Le galassie 4. L universo e il Big Bang Le caratteristiche delle stelle le stelle sono lontanissime dalla Terra; le loro distanze
Esplorando un piccolo Universo. Scritto da Marcello Veneziano
 Nell'articolo precedente abbiamo dimostrato come il neutrino potrebbe essere un piccolo buco nero. Ora esploreremo il vantaggio che offre, nel campo delle particelle, un neutrino quando e' esaminato nel
Nell'articolo precedente abbiamo dimostrato come il neutrino potrebbe essere un piccolo buco nero. Ora esploreremo il vantaggio che offre, nel campo delle particelle, un neutrino quando e' esaminato nel
Il Modello Standard delle particelle
 Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
Cosmologia. AA 2012/2013 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Cosmologia AA 2012/2013 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia, stanza 254 (2 o piano) Via
Cosmologia AA 2012/2013 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Contatti, Bibliografia e Lezioni Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia, stanza 254 (2 o piano) Via
L Effetto Sunyaev-Zel dovich
 L Effetto Sunyaev-Zel dovich Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrofisica e Particelle Elementari Motivazione Mostrare in modo introduttivo come dall effetto Sunyaev-Zel dovich termico si può ricavare la
L Effetto Sunyaev-Zel dovich Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrofisica e Particelle Elementari Motivazione Mostrare in modo introduttivo come dall effetto Sunyaev-Zel dovich termico si può ricavare la
Cosmologia. AA 2011/2012 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Cosmologia AA 2011/2012 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Contatti e Materiale Didattico Alessandro Marconi alessandro.marconi@unifi.it tel: 055 2055227 Largo Fermi 2 Porta Osservatorio
Cosmologia AA 2011/2012 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Contatti e Materiale Didattico Alessandro Marconi alessandro.marconi@unifi.it tel: 055 2055227 Largo Fermi 2 Porta Osservatorio
La strana storia del neutrino
 La strana storia del neutrino Antonio Ereditato Università di Berna con la collaborazione di Federico Scampoli Scuola Media Carducci-Purgotti, Perugia A.Ereditato - Perugia - 2011 1 Zoo delle particelle
La strana storia del neutrino Antonio Ereditato Università di Berna con la collaborazione di Federico Scampoli Scuola Media Carducci-Purgotti, Perugia A.Ereditato - Perugia - 2011 1 Zoo delle particelle
L Universo visto da Planck. Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica
 L Universo visto da Planck Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica Contenuti Lontano nello spazio, indietro nel tempo L eco del Big Bang L Universo neonato fotografato dai satelliti COBE, WMAP,
L Universo visto da Planck Carlo Baccigalupi SISSA, settore di Astrofisica Contenuti Lontano nello spazio, indietro nel tempo L eco del Big Bang L Universo neonato fotografato dai satelliti COBE, WMAP,
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO?
 MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
L origine degli elementi chimici: Le fornaci stellari. Lezioni d'autore
 L origine degli elementi chimici: Le fornaci stellari Lezioni d'autore VIDEO Introduzione La storia sull origine degli elementi chimici è strettamente intrecciata con l evoluzione del nostro universo.
L origine degli elementi chimici: Le fornaci stellari Lezioni d'autore VIDEO Introduzione La storia sull origine degli elementi chimici è strettamente intrecciata con l evoluzione del nostro universo.
Il nostro Universo. Ci sono tante domande di cui conosciamo la risposta. ... e tante altre di cui non la sppiamo
 Il nostro Universo Ci sono tante domande di cui conosciamo la risposta... e tante altre di cui non la sppiamo Scuola Primaria di Catena, Istituto Comprensivo «Mario Nannini», 17 novembre 2015 roberto spighi
Il nostro Universo Ci sono tante domande di cui conosciamo la risposta... e tante altre di cui non la sppiamo Scuola Primaria di Catena, Istituto Comprensivo «Mario Nannini», 17 novembre 2015 roberto spighi
. Esprimere il risultato in km, anni luce, parsec, unità astronomiche e raggi solari.
 Olimpiadi Italiane di Astronomia 018, INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania Corso di preparazione alla Finale Nazionale - Incontro 1: arzo 018 A cura di: Giuseppe Cutispoto e ariachiara Falco 8. KA
Olimpiadi Italiane di Astronomia 018, INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania Corso di preparazione alla Finale Nazionale - Incontro 1: arzo 018 A cura di: Giuseppe Cutispoto e ariachiara Falco 8. KA
Insegnare relatività. nel XXI secolo
 Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Insegnare relatività nel XXI secolo E s p a n s i o n e d e l l ' U n i v e r s o e l e g g e d i H u b b l e La legge di Hubble Studiando distanze e moto delle galassie si trova che quelle più vicine
Le Stringhe alla base del nostro Universo
 Le Stringhe alla base del nostro Universo Michele Cicoli DESY, Amburgo Pesaro, 17 Dicembre 2009 Sommario Stato della conoscenza attuale sulle leggi alla base del nostro Universo Problemi fondamentali Soluzione:
Le Stringhe alla base del nostro Universo Michele Cicoli DESY, Amburgo Pesaro, 17 Dicembre 2009 Sommario Stato della conoscenza attuale sulle leggi alla base del nostro Universo Problemi fondamentali Soluzione:
RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE
 RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE LEGGERE LE STELLE: MA QUANTE SONO? Le stelle visibili ad occhio nudo dalla superficie terrestre sono esattamente 5.780, anche se dal nostro emisfero se ne può
RICERCA di FABRIZIO PORTA LEGGERE LE STELLE LEGGERE LE STELLE: MA QUANTE SONO? Le stelle visibili ad occhio nudo dalla superficie terrestre sono esattamente 5.780, anche se dal nostro emisfero se ne può
Lezione 4. Vita delle Stelle Parte 2
 Lezione 4 Vita delle Stelle Parte 2 Fusione nucleare 4 atomi di idrogeno si uniscono per formare 1 atomo di elio e produrre energia nucleo H H H He H Due nuclei di idrogeno (due protoni) sospinti l'uno
Lezione 4 Vita delle Stelle Parte 2 Fusione nucleare 4 atomi di idrogeno si uniscono per formare 1 atomo di elio e produrre energia nucleo H H H He H Due nuclei di idrogeno (due protoni) sospinti l'uno
Ciao a tutti! Teorie Osservazione
 Ciao a tutti! L ultima volta abbiamo parlato delle distanze delle stelle, oggi studieremo la loro vita. Ricordiamo che l Astronomia è una scienza osservativa e non permette la sperimentazione. Si procede
Ciao a tutti! L ultima volta abbiamo parlato delle distanze delle stelle, oggi studieremo la loro vita. Ricordiamo che l Astronomia è una scienza osservativa e non permette la sperimentazione. Si procede
Fondamenti di Astrofisica
 Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Fondamenti di Astrofisica Lezione 12 AA 2010/2011 Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) Come visto nella prima lezione l HUDF è l esposizione più profonda
Astronomia Strumenti di analisi
 Corso facoltativo Astronomia Strumenti di analisi Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte E: Strumenti di analisi Radiazione elettromagnetica Interazione radiazione - materia Redshift Misura
Corso facoltativo Astronomia Strumenti di analisi Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte E: Strumenti di analisi Radiazione elettromagnetica Interazione radiazione - materia Redshift Misura
Il contenuto dell Universo. Lezioni d'autore di Claudio Censori
 Il contenuto dell Universo Lezioni d'autore di Claudio Censori INTRODUZIONE (I) VIDEO INTRODUZIONE (II) L Universo ha un età di circa 13,7 miliardi di anni e si sta attualmente espandendo con una velocità
Il contenuto dell Universo Lezioni d'autore di Claudio Censori INTRODUZIONE (I) VIDEO INTRODUZIONE (II) L Universo ha un età di circa 13,7 miliardi di anni e si sta attualmente espandendo con una velocità
TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI
 TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI Introduzione La teoria dell Inflazione venne proposta nel 1979 da A. H. Guth; con essa l autore ipotizza che l Universo abbia avuto origine da una zona dello Spazio
TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI Introduzione La teoria dell Inflazione venne proposta nel 1979 da A. H. Guth; con essa l autore ipotizza che l Universo abbia avuto origine da una zona dello Spazio
Oltre il Sistema Solare
 Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale. Enrico Degiuli Classe Terza
 Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
Le leggi di Keplero e la gravitazione universale Enrico Degiuli Classe Terza Giovanni Keplero Keplero è stato un astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Ha condotto lunghi studi sul
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior Variabili Cefeidi Le Cefeidi sono stelle variabili ( m ~ 1) di massa M > 5 M ed aventi periodo 1 < P
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova pratica - Categoria Senior Variabili Cefeidi Le Cefeidi sono stelle variabili ( m ~ 1) di massa M > 5 M ed aventi periodo 1 < P
L universo come laboratorio
 L universo come laboratorio Paolo de Bernardis Dipartimento di Fisica Sapienza Università di Roma Caffè Scienza 19/2/2013 LHC: scontri tra protoni Enormi Collisioni m = 1 GeV = 1.6x10-27 Kg E = 8 TeV =
L universo come laboratorio Paolo de Bernardis Dipartimento di Fisica Sapienza Università di Roma Caffè Scienza 19/2/2013 LHC: scontri tra protoni Enormi Collisioni m = 1 GeV = 1.6x10-27 Kg E = 8 TeV =
Cosmologia con la radiazione cosmica di fondo
 Cosmologia con la radiazione cosmica di fondo Paolo Natoli Università di Ferrara e INFN Nazzareno Mandolesi Copenahgen 9 th June 2011 Il Grande Carro, così come visibile ad Arles settembre 1888, alle
Cosmologia con la radiazione cosmica di fondo Paolo Natoli Università di Ferrara e INFN Nazzareno Mandolesi Copenahgen 9 th June 2011 Il Grande Carro, così come visibile ad Arles settembre 1888, alle
L astronomia che naviga
 L astronomia che naviga Astronomia moderna e navigazione Nico Cappelluti INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna Center for Space Science and Technology-University of Maryland Baltimore County, USA Introduzione
L astronomia che naviga Astronomia moderna e navigazione Nico Cappelluti INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna Center for Space Science and Technology-University of Maryland Baltimore County, USA Introduzione
Appunti di Cosmologia
 Appunti di Cosmologia Corso di Cosmologia AA 2013/2014 Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Firenze Dispense e presentazioni disponibili all indirizzo http://www.arcetri.astro.it/
Appunti di Cosmologia Corso di Cosmologia AA 2013/2014 Prof. Alessandro Marconi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Firenze Dispense e presentazioni disponibili all indirizzo http://www.arcetri.astro.it/
Stelle. - emette un flusso continuo di onde elettromagnetiche, che noi osserviamo in parte sotto forma di luce
 Stelle - corpo celeste di forma più o meno sferica - emette un flusso continuo di onde elettromagnetiche, che noi osserviamo in parte sotto forma di luce - il Sole è una stella - Quasi tutto ciò che sappiamo
Stelle - corpo celeste di forma più o meno sferica - emette un flusso continuo di onde elettromagnetiche, che noi osserviamo in parte sotto forma di luce - il Sole è una stella - Quasi tutto ciò che sappiamo
Quasar e Buchi Neri. Maria Massi (Max Planck Institut für Radioastronomie)
 Quasar e Buchi Neri Maria Massi (Max Planck Institut für Radioastronomie) I Quasar sono gli oggetti piu' luminosi dell' Universo I. Come sono stati scoperti i Quasar? II. Cosa e' un Quasar? III. Cosa resta
Quasar e Buchi Neri Maria Massi (Max Planck Institut für Radioastronomie) I Quasar sono gli oggetti piu' luminosi dell' Universo I. Come sono stati scoperti i Quasar? II. Cosa e' un Quasar? III. Cosa resta
I molti volti dell'universo
 I molti volti dell'universo L astronomia infrarossa Paolo Saracco INAF - Osservatorio Astronomico di Brera / DVWURQRPLDLQIUDURVVD 2OWUHLOLPLWL /DVFRSHUWD GHOOD UDGLD]LRQH,5 3URSULHWDC ILVLFKH GHOO,5 /
I molti volti dell'universo L astronomia infrarossa Paolo Saracco INAF - Osservatorio Astronomico di Brera / DVWURQRPLDLQIUDURVVD 2OWUHLOLPLWL /DVFRSHUWD GHOOD UDGLD]LRQH,5 3URSULHWDC ILVLFKH GHOO,5 /
The dark side of the Universe. Francesco Berrilli Dipartimento di Fisica Universita` di Roma Tor Vergata
 The dark side of the Universe Francesco Berrilli Dipartimento di Fisica Universita` di Roma Tor Vergata E spesso ha molto rilievo con quali altri elementi e in quale posizione si uniscano i corpuscoli
The dark side of the Universe Francesco Berrilli Dipartimento di Fisica Universita` di Roma Tor Vergata E spesso ha molto rilievo con quali altri elementi e in quale posizione si uniscano i corpuscoli
Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC
 Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC Valentina Zaccolo 26/03/19 e INFN Trieste Valentina Zaccolo Particelle e LHC Università 1 Dal mondo visibile... Dal macro al micro 26/03/19 Valentina
Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC Valentina Zaccolo 26/03/19 e INFN Trieste Valentina Zaccolo Particelle e LHC Università 1 Dal mondo visibile... Dal macro al micro 26/03/19 Valentina
GIOVE e l osservazione in banda radio
 GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI
 TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI Introduzione La teoria dell Inflazione venne proposta nel 1979 da A. H. Guth; con essa l autore ipotizza che l Universo abbia avuto origine da una zona dello Spazio
TEORIA DELL'INFLAZIONE I PRIMI 20 MINUTI Introduzione La teoria dell Inflazione venne proposta nel 1979 da A. H. Guth; con essa l autore ipotizza che l Universo abbia avuto origine da una zona dello Spazio
