JOHN BARROW A PORDENONELEGGE 2014
|
|
|
- Cristoforo Santi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia Anno XXII - n. 66 Ottobre - Dicembre 2014 JOHN BARROW A PORDENONELEGGE 2014 Per quanti s interessano di astronomia, ma non solo, la lettura dei libri di John Barrow rappresenta un imperdibile occasione per scoprire nuove frontiere della scienza, ma anche nuove modalità di divulgazione, viste le indubbie capacità di scrittura di questo eclettico professore di Oxford capace di passare da opere teatrali a universi multipli in un batter d occhio. Barrow è stato ospite dell edizione 2014 di Pordenonelegge e nella sala gremita di palazzo Montereale Mantica è riuscito ancora una volta a farci sognare senza per questo perdere il linguaggio rigoroso della scienza (photo Cozzarin, per gentile concessione). In questo numero ORIGINE DELLE AURORE 2 UN SESTANTE PORTATILE PER USO TERRESTRE SETTEMBRE 2014: 23 STAR PARTY DI SAINT BARHELEMY 8 CRESPANO, 7/9/2014: UN INCONTRO PER RICORDARE IL PROF. GIULIANO ROMANO 11 NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 1
2 ORIGINE DELLE AURORE «Deboli accenni di bande colorate appaiono nel buio cielo notturno. Si rovesciano pigramente qua e là, acquistando velocità, e i colori diventano più brillanti e pronunciati. I nastri increspati solcano il cielo in una rapida esultante danza» (da Nastri di luce danzante di Annalisa Ronchi) Abbiamo ricevuto questo interessante lavoro sulle aurore boreali scritto come approfondimento per l esame di stato da Tommaso Marsonet, studente del liceo scientifico di Maniago ed attualmente studente di fisica all Università di Trieste, che volentieri riproponiamo integralmente, preso atto che sullo stesso argomento abbiamo dedicato un altro articolo nel numero 64/2014 del Notiziario. L aurora polare è un fenomeno ottico dell atmosfera terrestre. Si manifesta ad altezze solitamente comprese tra i 100 e 200 km, alle volte raggiunge i 1000 Km sulla superficie terrestre e si forma a latitudini superiori ai 60. Le manifestazioni di questo fenomeno sono molto varie: l evento può presentarsi in forma di archi, bande e raggi luminosi, corone e luci diffuse che si muovono in cielo, i colori variano dal verde al rosso e a volte si possono sentire dei suoni elettrofonici simili a sibili. Le aurore polari si originano a causa del vento solare, un flusso che trasporta particelle quali elettroni e protoni; queste vengono deviate verso i poli dal campo magnetico terrestre. A questo punto avviene la riconnessione magnetica che forma dei buchi nel campo magnetico terrestre permettendo alle particelle di penetrarlo; quando queste raggiungono la ionosfera reagiscono con i gas dell atmosfera terrestre generando le aurore. Il campo magnetico terrestre. Nel 1600 William Gilbert suppose che la Terra fosse un grande magnete e che quindi avesse un campo magnetico bipolare che entra nell emisfero nord ed esce dall emisfero sud, in prossimità dei poli geografici. L asse del dipolo magnetico è inclinato rispetto all asse di rotazione terrestre di circa 11.5, angolo noto come declinazione magnetica, mentre forma con il piano dell equatore un angolo detto inclinazione magnetica. Il campo magnetico è circondato dalla magnetopausa che contiene la magnetosfera, la regione di spazio dove le particelle dotate di carica subiscono l effetto del campo magnetico terrestre; questo protegge il nostro pianeta dalla radiazioni provenienti dal Sole. Si crede che questo campo magnetico sia originato da un processo simile alla dinamo ad autoeccitazione: il nucleo interno della Terra, anche se si trova a temperature elevatissime è solido a causa dell alta pressione, mentre il nucleo esterno è liquido e costituito principalmente da ferro e nichel, che sono buoni conduttori elettrici; il nucleo esterno viene sottoposto all azione di un debole campo magnetico esterno che fa muovere i fluidi inducendo una corrente elettrica, che a sua volta genera il campo NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 2
3 magnetico. Il campo magnetico prodotto e la rotazione terrestre mantengono i fluidi del nucleo esterno in movimento, continuando ad alimentare il campo magnetico terrestre. E noto, grazie agli studi del paleomagnetismo che nel corso del tempo i poli magnetici si sono mossi o addirittura invertiti; esistono dei minerali accessori magnetici (come la magnetite) che sono sensibili al campo magnetico terrestre: questi minerali, al di sopra della temperatura di Curie perdono le loro proprietà fisiche, quindi sono smagnetizzati; quando la loro temperatura ridiscende, il campo magnetico del minerale tende ad orientarsi parallelamente alle linee di forza del campo magnetico terrestre. Questo processo si chiama registrazione e avviene negli strati di lava delle dorsali e dei vulcani. Ionosfera. Secondo il criterio della presenza degli strati ionizzati l atmosfera viene suddivisa in ozonosfera e ionosfera; l ozonosfera è la fascia più bassa, dai 25 ai 50 km di altitudine, dove avvengono le reazioni di distruzione e formazione dell ozono con l assorbimento di radiazioni ultraviolette. La ionosfera si trova sopra ai km di altezza dove avviene il fenomeno di ionizzazione: la radiazione ultravioletta, con elevata energia, va a colpire i gas atmosferici facendogli saltar via un elettrone. Più aumenta l altitudine, più i gas sono rarefatti; ciò comporta che negli strati più alti dell atmosfera ci sarà una densità di carica più elevata che negli strati inferiori perché gli elettroni liberi impiegheranno più tempo a rilegarsi ad un altro atomo. La ionosfera può essere ulteriormente suddivisa a seconda delle diverse proprietà elettriche; con l aumentare della quota e dell intensità della radiazione solare, che varia con l altezza del Sole e l attività solare, la densità ionica della ionosfera è sempre maggiore e si possono individuare tre regioni. La regione D tra i 60 e 90 km di altitudine, dove il gas ionizzato è l ossido di azoto; la regione E si estende tra i 90 e i 130 km di altezza e il gas principalmente ionizzato è l ossigeno molecolare; la regione F che si trova tra i 130 e i 450 km di altitudine e l ossigeno è il gas principalmente ionizzato. La regione F può essere divisa in regione F1 (fino a 240 km) dove si trovano ioni NO+, e la regione F2, contenente gli ioni O+. Inoltre in prossimità della regione E, esiste uno strato dalle caratteristiche irregolari, lo strato E sporadico (Es). Vento Solare. Il vento solare è un plasma di particelle, costituito principalmente da elettroni e da protoni (ioni H), nuclei di elio e tracce di altri nuclei più pesanti e varia di intensità a seconda dell attività solare. Sulla superficie del Sole possono verificarsi le tempeste solari e dalla corona vengono NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 3
4 emesse moltissime particelle; quando queste incontrano la magnetopausa possono creare delle perturbazioni nel campo geomagnetico che provocano le tempeste magnetiche e disturbi nelle comunicazioni radio. di van Allen: una più bassa costituita principalmente da protoni e una più alta di elettroni. Il vento solare si muove verso lo spazio interplanetario e verso la Terra, le particelle tendono a scivolare verso i poli e riescono a penetrare nella magnetosfera dove interagiscono con la ionosfera, ricca di particelle dotate di carica. Molte particelle vengono inoltre intrappolate nel campo magnetico terrestre per la forza di Lorentz e generano le fasce di van Allen. La forza di Lorentz è la forza subita da una carica che si muove in un campo magnetico o in un campo elettrico; nei campi magnetici la forza che si sviluppa è perpendicolare al moto e direttamente proporzionale alla velocità della carica. Inoltre il vento solare è la causa della deformazione del campo magnetico terrestre: questo infatti non è simmetrico, ma viene schiacciato nella parte rivolta verso il Sole, mentre sul lato opposto della Terra assume una forma allungata perché trascinato dal vento solare. Quando queste fasce vengono eccitate dalle particelle del vento solare, che può aumentare di intensità al variare dell attività solare e si spostano: i protoni si muovono verso l alto (polo negativo) e gli elettroni verso il basso (polo positivo) e si viene a creare una corrente elettrica; questo processo è detto generatore aurorale. A questo punto gli elettroni si scontrano con gli atomi della ionosfera, facendo avvenire i processi di dissociazione e di ionizzazione. Il primo consiste nel separare le molecole della ionosfera in singoli atomi, mentre il secondo fa staccare gli elettroni dai nuclei. In seguito gli elettroni si riassociano a nuclei e si riformano le molecole; per far sì che questi processi avvengano, viene persa energia dagli atomi sotto forma di fotoni di luce aurorale. Dinamica. Il vento solare arriva sulla Terra con elettroni e protoni, trascinando con se il campo magnetico interplanetario (del Sole). Questo entra in contatto con il campo magnetico terrestre e nei punti dove le linee di forza dei due campi magnetici sono opposte, quindi presso i poli magnetici terrestri, avviene la riconnessone magnetica: il campo magnetico in questi punti si annulla e le particelle del vento solare riescono quindi a penetrare nella magnetosfera. Gli elettroni e i protoni trattenuti nel campo magnetico terrestre si accumulano nelle fasce Studi sulle aurore. L origine delle aurore polari è stata sconosciuta fino al 1859 quando l astronomo inglese Richard Christopher Carrington ne attribuì la causa all attività solare. NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 4
5 Il 28 Agosto 1859 nei centri scientifici di tutto il mondo vennero registrate forti variazioni, si verificarono forti tempeste geomagnetiche e si formò un aurora abbastanza grande da poter essere osservata a latitudini molto basse. Questo fenomeno prese il nome di Evento di Carrington, dall astronomo inglese, e fu causato da una fortissima tempesta solare. Nei giorni seguenti Carrington notò sulla superficie del sole delle macchie di grandi dimensioni e in prossimità di queste delle luci abbaglianti, che superavano la luminosità del Sole; alcune ore dopo, si verificarono altri fenomeni aurorali: questo portò Carrington a pensare che la causa di questi fenomeni fosse legata all attività solare. Sulla superficie del Sole, la fotosfera, si formano quindi queste macchie solari aventi forte attività magnetica e che noi vediamo più scure poiché sono leggermente più fredde rispetto alle zone circostanti. Le macchie solari espellono il plasma, un insieme di protoni, elettroni, nuclei di elio e altri nuclei più pesanti che quando raggiunge la Terra da origine alle tempeste magnetiche, alle aurore e a interferenze nelle comunicazioni via radio. Le aurore sono comunque oggetto di studio fin dall antichità, ne abbiamo testimonianza da parte di alcuni autori del passato, come Seneca e Plinio. Nel passato le aurore erano dei fenomeni inspiegabili e quindi incutevano timore alla gente; Seneca nelle Naturales Questiones (Liber I, XV 5-6) scrive: «Tra questi fenomeni (meteore ingnee) puoi mettere anche ciò che spesso leggiamo nelle storie, cioè che il cielo è apparso infuocato e il suo fiammeggiare è talvolta così alto da sembrare proprio in mezzo alle stelle, talvolta così basso da avere l aspetto di un incendio lontano. Sotto il regno di Tiberio Cesare le coorti accorsero in aiuto alla colonia di Ostia come se fosse in fiamme mentre si trattava di una vampa celeste brillante durata gran parte della notte, di un fuoco grasso e fumoso. Per queste meteore nessuno dubita che posseggano realmente la fiamma che mostrano: esse sono fatte di una sostanza ben determinata.» Questo fenomeno era così insolito per gli antichi che talvolta veniva scambiato per un incendio in lontananza e la causa veniva attribuita ad un fuoco in cielo causato dal passaggio di qualche meteorite. Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, (Liber II, 27) dice: «... vi è qualcosa che pare sangue, e il più terribile fenomeno fra quelli che spaventano i mortali: un incendio che dal cielo cade sulla Terra, come avvenne al terzo anno della 107a Olimpiade (349 a.c.), mentre il re Filippo sconvolgeva la Grecia. Ora io penso che tutti questi eventi sorgano in tempi prefissati per forza naturale, come del resto ogni cosa, e non hanno quindi (come ritiene la maggior parte) motivazioni svariate, che si possono escogitare aguzzando la mente; è vero che sono stati forieri di disastri, ma io stimo non che i fatti siano accaduti perché quelle manifestazioni li avevano anticipati, ma, all opposto, che quei fenomeni sono nati perché quei fenomeni stavano per verificarsi. Comunque la loro rarità ne oscura la comprensione, ed è per questo che le meteore non si conoscono nella misura in cui sono noti il sorgere delle stelle e le eclissi... e varie altre cose...» L aurora è qui descritta da Plinio quasi come se fosse una catastrofe; lui, come Seneca, ritiene che l origine di questi eventi sia dovuta ai meteoriti e che quindi sia del tutto naturale, mentre la maggior parte delle persone del suo tempo pensavano fossero presagi di disgrazie. A distanza di secoli, anche se ormai si conosce quasi completamente il meccanismo di questi fenomeni, le aurore rimangono sempre dei fenomeni affascinanti e spettacolari, come lo erano state nel passato. NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 5
6 UN SESTANTE PORTATILE PER USO TERRESTRE Andrea Berzuini Circa 20 anni fa ho acquistato questo strumento in una bancarella dei mercatini dell antiquariato a Pordenone. La cifra non era modesta, mi pare di averlo pagato 250 mila lire, ma aldilà dell uso che ne avrei fatto, mi piaceva l oggetto in sé: tutto in ottone lavorato quasi come un prodotto di orologeria. Inoltre a prima vista era abbastanza misterioso. Infatti si presenta come una scatola circolare da cui nulla traspare come si può vedere dalla foto. Questo strumento è stato prodotto dalla soc. Stanley di Londra nel 1941, ha il numero di matr ed è simile ad un sestante costruito dalla società francese Lerebours et Secretan, nella seconda metà dell ottocento. Questa ditta costruiva pure Dagherrotipi ed altri strumenti di precisione. Curiosità: il cannocchiale Lerebours viene citato nel romanzo Dalla terra alla luna di J. Verne. A questo sestante si accompagnava anche un orizzonte artificiale, che era costituito da una lastra circolare di 6,5 cm di diametro di vetro scuro a superfice tersa incastonata in un anello cilindrico di ottone, legato a tre viti di livello disposte a 120 gradi per permetterne la posa in piano tramite una piccola bolla che veniva posizionata sul vetro stesso. Tornando al mio sestante, privo dell orizzonte artificiale, dalla foto si può osservare l arco graduato diviso in 140 parti (140 mezzi gradi) e la vite zigrinata che manovra lo specchio mobile e quindi l alidada per la misurazione dell angolo del sole con l orizzonte. Per l osservazione è previsto un cannocchialino di ca. 4 cm di focale. Una lente di ingrandimento permette di leggere il valore misurato tramite un nonio montato sulla estremità dell alidada con sensibilità di un primo. La stima della lettura sul nonio attraverso la lentina risulta comunque problematica. E prevista una seconda vite zigrinata che tolta dal tamburo diventa una chiave che serve per la correzione della verticalità dello specchio, azionando le apposite viti. Svitando il coperchio si presenta in tutta la sua funzionalità. Il coperchio si può riavvitare sul dorso del sestante per diventare una comoda impugnatura. Nell uso questo strumento si è rivelato difficoltoso. Sul sole la protezione fornita dallo schermo azzurrino non è molto efficace, e per motivi di NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 6
7 sicurezza, dopo la prima prova, ho rinunciato ad eseguire altri test. Ho provato con la luna piena: dal punto di vista della sicurezza non c erano problemi, ma la mancanza di un orizzonte ben definito mi ha fatto stimare delle letture con la precisione del mezzo grado, rendendo superflua la sensibilità del nonio di un primo di grado (Sulla sfera terrestre un primo di grado corrisponde ad una distanza di ca. 1,852 Km - miglio nautico). Quindi utilizzando come astro la luna la precisione che si ottiene non è il massimo. Nonostante abbia fatto diverse ricerche, non sono riuscito a trovare riferimenti su chi utilizzava questi strumenti, che non potevano competere per precisione con sestanti nautici. Poiché il venditore di questo sestante vendeva prodotti esotici provenienti dall India, mi piace pensare che fosse in dotazione ad ufficiali inglesi che lo usavano durante gli spostamenti in zone impervie per avere un minimo di orientamento. NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 7
8 26-28 SETTEMBRE 2014: 23 STAR PARTY DI SAINT BARHELEMY Dini Abate Anche quest anno sono andato, in compagnia dei miei amici astrofili di Ravenna, tra cui l immancabile Paolo Morini, all ormai consueto appuntamento di Saint Barthelemy, a Nus, in Val D Aosta, dove si tiene il primo e forse più importante star party italiano. Quest anno si è giunti alla 23 ma edizione e rispetto agli anni precedenti si è aggiunta una esposizione di strumentazione astronomica e una serie di convegni e seminari di argomenti scientifici. Sia l expo commerciale che i convegni si sono svolti sotto due tendoni appositamente allestiti, battezzati rispettivamente John Dobson e Richard Feynman. Durante la manifestazione sono state effettuate visite guidate sia all osservatorio astronomico che al planetario, a cura della Fondazione C. Fillietroz - ONLUS. Le aree osservative allestite quest anno dagli organizzatori erano ben quattro. Questo aspetto si è rivelato molto opportuno, dal momento che in questo modo i molti astrofili dotati di attrezzatura propria hanno potuto trovar tranquillamente posto, avendo prenotato la piazzola in anticipo, in siti preservati da luci casuali, senza gli affollamenti e le arrabbiature delle passate edizioni. Infatti gli astrofili registrati sono stati oltre 500, a conferma del successo della manifestazione, mentre le ditte presenti all Expo erano una quindicina. di cieli urbani pesantemente inquinati, è attorno a 17,00 mag/arcsec 2, all Osservatorio di Montereale, nelle notti più serene si arriva a 20,80 mag/arcsec 2, nei migliori siti osservativi si dovrebbero superare i 22,00 mag/arcsec 2 ). La notte di sabato, mi sono cimentato in qualche ripresa con la mia vecchia Digicam Canon EOS 300D, collegata al rifrattore TeleVue102 (al centro nella foto). La mia strumentazione (3 rifrattori) Il sabato, dopo aver osservato il Sole in luce bianca con schermo in proiezione e in luce H- alfa con il PST, abbiamo visitato l Expo commerciale. In evidenza il radiotelescopio Spider230, e i telescopi con ottica selezionata di PrimaLuceLab degli amici Bradaschia e Cauz. Il cielo. Altro fatto nuovo, particolarmente apprezzato da chi, come il sottoscritto, si è sorbito più di mille km di autostrada, è stato un bel cielo terso che ha caratterizzato la manifestazione per tutta la sua durata, come mai era accaduto negli anni scorsi, con la possibilità quindi di fare ottime osservazioni. Venerdì 26/09 ho misurato la brillanza del cielo notturno con il mio Sky Quality Meter, registrando un valore di 21,20 mag/arcsec 2 (tanto per avere un metro di confronto, la luminosità del cielo con Luna Piena, oppure L area osservativa del campo sportivo con i tendoni dell expo e dei seminari (a sinistra) NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 8
9 superato dall enorme 75 cm, dell immancabile astrofilo milanese Bertucci. Il crepuscolo di sabato 27/09, prima delle osservazioni notturne, con Luna crescente di pochi giorni d età Il sabato, dopo aver osservato il Sole in luce bianca con schermo in proiezione e in luce H- alfa con il PST, abbiamo visitato l Expo commerciale. In evidenza il radiotelescopio Spider230, e i telescopi con ottica selezionata di PrimaLuceLab degli amici Bradaschia e Cauz. Sotto il tendone Feynman abbiamo assistito all interessante seminario del CICAP intitolato Bufale volanti: inganni e falsi miti nell astronomia e nella esplorazione spaziale, successivamente alla assegnazione del Premio Le Stelle a Mario di Sora, attuale Presidente della UAI, per il suo impegno nella lotta contro l inquinamento luminoso. Ad assegnare il premio, il giornalista divulgatore Piero Bianucci, della Stampa di Torino. Il grande dobson di Reginato Dobson di Reginato con lo specchio da 600 mm Assegnazione premio le Stelle a Mario di Sora Notevole interesse ha suscitato l enorme dobsoniano realizzato da Reginato da 600 mm di diametro, che pure non era il più grande telescopio presente alla manifestazione, Il dobson Reginato con un originale tappo di chiusura! La liturgia degli astro imagers. Durante le osservazioni notturne, ho avuto modo di rendermi conto di una situazione strana, e, secondo me, un po buffa. Devo premettere che la piazzola osservativa a me assegnata, essendo dotata di corrente a 220 V, era quella riservata soprattutto ai cosiddetti astroimagers, coloro cioè che si dedicano alle NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 9
10 riprese digitali deep sky con ccd e computer. Mi ha colpito, man mano che progrediva l oscurità, il lavorio silenzioso e solitario degli astrofili (o, meglio, dei videoterminalisti) davanti ai monitor regolati al minimo di luminosità, quasi fossimo in qualche ced oscurato. I consigli che si scambiavano i presenti, nel silenzio rotto dal rumore dei motori dei dispositivi di puntamento computerizzati, erano esclusivamente tecnici e riguardavano i tempi di dark, oppure di come fare un flat efficace, avendo come obiettivo della serata solo un paio di oggetti da riprendere. I commenti sugli oggetti osservati erano rarissimi. Devo confessare che mi sono sentito un po fuori posto ma forse ho semplicemente sbagliato area osservativa! Riporto qualche immagine deep sky ripresa con rifrattore apocromatico Televue Ø 102 F 8.6, con riduttore 0.8X, e digicam Canon EOS 300 D, settata a 800 ASA, pose da 90 a 120 secondi. Galassia M33 M31, galassia di Andromeda Doppio ammasso di Perseo Nebulosa M27 Ammasso globulare M13 NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 10
11 CRESPANO DEL GRAPPA: UN INCONTRO PER RICORDARE IL PROF. GIULIANO ROMANO Stefano Zanut Domenica 7 settembre si è tenuto presso il Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci, a Crespano del Grappa (TV), una tavola rotonda per ricordare il prof. Giuliano Romano con le seguenti motivazioni: Il prof. Giuliano Romano è stato per molti anni un riferimento per l astronomia nel trevigiano e in particolare per il nostro Centro e per don Paolo Chiavacci. Grazie ai suoi suggerimenti e contributi il Centro ha sviluppato una passione astronomica che ha permesso a moltissime persone di avvicinarsi a questa disciplina. E un privilegio aver avuto un tale maestro e amico tra le nostre conoscenze e per questo motivo, mossi dalla profonda gratitudine verso la Sua persona, abbiamo ritenuto importante ricordarlo, ad un anno dalla sua scomparsa, con una tavola rotonda aperta al pubblico in alcuni tratti del suo cammino di astronomo con i suoi più vicini colleghi che l anno seguito per così tanti anni. Negli anni 80 sono stato anch io un assiduo frequentatore di quella struttura e della scuola estiva di astronomia, dove insegnavano molti astronomi proveniente dall Osservatorio di Asiago ma anche astrofili che avevano maturato esperienze in certi campi e che avevano certamente qualcosa da raccontare, per questo ho deciso di non perdermi l occasione di questo ricordo. D altra parte quei contesti erano delle vere e proprie scuole di vita astronomica, dove luminari e astrofili potevano passare assieme intere giornate parlando della comune passione per questa scienza. L argomento principale erano certamente le stelle variabili, sulle quali venivano svolte molte esercitazioni osservative, ma ricordo anche lezioni e discussioni su argomenti come planetologia e cosmologia. Insomma, un ambiente difficile da dimenticare! Il coagulatore di questo ambiente era proprio il prof. Giuliano Romano, che tutti chiamavano più semplicemente prof. Romano anche quando eravamo a pranzo assieme, come se Romano fosse il cognome e prof. il nome. Alla tavola rotonda, moderata da Gabriele Umbriaco, direttore del Centro, hanno partecipato nomi che non era difficile incontrare in quelle occasioni estive a partire da Francesco Bertola, dell Università di Padova, che ha ricordato Romano astronomo e archeoastronomo mettendo in luce il suo rapporto un po conflittuale con l Università e la ricerca ordinaria, a cui per un certo periodo aveva addirittura preferito l insegnamento al un liceo. Successivamente il prof. Giancarlo Favero, che tutti ricordiamo come astrofilo e coordinatore dei variabilisti triveneti, che ha parlato di Romano astronomo tra gli astrofili, seguito da Giancarlo Marcon, noto costruttore di telescopi (Marcon telescopes). Anche lui, come Favero, ha rispolverato episodi che al giorno d oggi potrebbero sembrare addirittura ridicoli, eppure di quei fermenti degli anni 60, 70 e 80 del secolo scorso ci sarebbero moltissime cose da raccontare. Una su tutte la realizzazione del primo specchio della ditta Marcon a cura di NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 11
12 Virgilio, padre di Giancarlo, utilizzando un oblo di nave lavorato con sabbia del Piave. Ha infine concluso gli interventi don Giovanni Scavezzon, presidente dell Associazione Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci ed ex direttore del Centro Chiavacci, che ha parlato di Romano e i 40 anni di scuola di astronomia al Pio X e al Centro Chiavacci, illustrando le attività svolte con continuità in quel periodo dal prof. Romano. Anche il suo intervento è stato ricco di ricordi ed emozioni, così come emozionante è stato vedere il filmato di una delle ultime conferenze di Romano (aveva già superato il 90 anni!) in cui parlava del rapporto tra la scienza e il vivere quotidiano di quest epoca. La tavola rotonda si è quindi sviluppata attorno al tema centrale dei possibili sviluppi futuri della didattica e della divulgazione dell astronomia, preso atto della mancanza di un forte elemento catalizzatore come il prof. Romano, che indubbiamente rendeva più facile ogni iniziativa Due ore passate a respirare astronomia ma finite con una triste presa d atto: guardandomi attorno ho ritrovato con piacere moltissime persone che non vedevo da anni e con cui ho svolto attività osservative d indubbio interesse, ma nessuna new entry, nessun giovane. Eppure chi come me ha conosciuto bene il prof. Romano ha visto com era facile per lui catalizzare proprio l attenzione dei giovani, benché sempre vestito in modo assolutamente austero e fuori moda e con quel suo amichevole distacco che gli imponeva di dare a tutti del lei. (Per saperne di più sul prof. Romano: I partecipanti alla tavola rotonda, partendo da destra: Umbriaco, Bertola, Favero, Scavezzon e Marcon. NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 12
13 ASSOCIAZIONE PORDENONESE DI ASTRONOMIA Inviare corrispondenza al seguente indirizzo: Associazione Pordenonese di Astronomia (A.P.A.) c/o Ditta "CAMU", Via Grandi n PORDENONE (PN) (Quota annua di iscrizione: 25,00) IL DIRETTIVO DELL ASSOCIAZIONE PER IL BIENNIO PRESIDENTE: Giampaolo Carrozzi 2. VICE PRESIDENTE: Stefano Zanut 3. SEGRETARIO E RESPONSABILE OSSERVATORIO: Dino Abate 4. MEMBRI: - Andrea Berzuini - Luigi De Giusti - Antonio Frisina - Vanzella Piermilo LO SCOPO DEL NOSTRO NOTIZIARIO Nel corso della storia dell umanità, la ricerca e il desiderio di sapere hanno condotto, attraverso varie strade, l uomo a conoscere sempre meglio la natura nelle sue molteplici espressioni. L ASTRONOMIA, intesa come studio dell Universo che ci circonda, si può considerare una delle più affascinanti e coinvolgenti. Per mezzo di questo NOTIZIARIO l A.P.A. si propone di estendere le conoscenze di questa affascinante scienza ai soci e simpatizzanti. Hanno collaborata alla realizzazione di questo numero: - Dino Abate - Vladimiro Giacomello - Tommaso Marsonet - Andrea Berzuini - Stefano Zanut NOTIZIARIO dell Associazione Pordenonese di Astronomia 13
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI
 IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
SOLE, struttura e fenomeni
 SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
SOLE, struttura e fenomeni Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione (I) Il Sole è la stella più vicina a noi, della quale possiamo pertanto ricavare in dettaglio informazioni dirette. Si
3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Il Sole: struttura e produzione di energia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni hanno comunque un indubbio valore storico/culturale, oltre a permettere un facile orientamento nel cielo
 LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
CORSO DI BIOFISICA IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTE DIAPOSITIVE E AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO PER L UNIVERSITA DI TERAMO
 CORSO DI IOFISICA IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTE DIAPOSITIVE E AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO PER L UNIVERSITA DI TERAMO LE IMMAGINE CONTENUTE SONO STATE TRATTE DAL LIRO FONDAMENTI DI FISICA DI D. HALLIDAY,
CORSO DI IOFISICA IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTE DIAPOSITIVE E AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO PER L UNIVERSITA DI TERAMO LE IMMAGINE CONTENUTE SONO STATE TRATTE DAL LIRO FONDAMENTI DI FISICA DI D. HALLIDAY,
LA TERRA. La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI.
 LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
Ciao! Ma puoi sapere qualcos altro dalla luce?
 Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra
 Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Osservando il Sole è possibile scorgere delle aree che appaiono più scure (macchie) rispetto al resto della fotosfera a causa della loro temperatura
 Osservando il Sole è possibile scorgere delle aree che appaiono più scure (macchie) rispetto al resto della fotosfera a causa della loro temperatura più "bassa" Il numero di macchie solari visibili sulla
Osservando il Sole è possibile scorgere delle aree che appaiono più scure (macchie) rispetto al resto della fotosfera a causa della loro temperatura più "bassa" Il numero di macchie solari visibili sulla
L illuminazione della Terra
 L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
MAGNETISMO. Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio).
 MAGNETISMO Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio). Le proprietà magnetiche si manifestano alle estremità del magnete, chiamate
MAGNETISMO Alcuni materiali (calamite o magneti) hanno la proprietà di attirare pezzetti di ferro (o cobalto, nickel e gadolinio). Le proprietà magnetiche si manifestano alle estremità del magnete, chiamate
Lo Spettro Elettromagnetico
 Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
Spettroscopia 1 Lo Spettro Elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico è costituito da un insieme continuo di radiazioni (campi elettrici e magnetici che variano nel tempo, autogenerandosi) che va dai
Azoto. La molecola di azoto e formata da due atomi di azoto, legati insieme con un triplo legame:
 Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
L ORIGINE DELLA LUNA
 LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
Gli indizi a favore di questa ipotesi erano molteplici:
 La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
Capitolo 2. Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo
 Master in Verifiche di qualità in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapiar Capitolo 2 Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo 24 Atomi, Molecole,, e Ioni L idea di Atomo è antica come
Master in Verifiche di qualità in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapiar Capitolo 2 Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo 24 Atomi, Molecole,, e Ioni L idea di Atomo è antica come
Proprietà elettriche della materia
 Proprietà elettriche della materia Conduttori Materiali in cui le cariche elettriche scorrono con facilità. In un metallo gli elettroni più esterni di ciascun atomo formano una specie di gas all interno
Proprietà elettriche della materia Conduttori Materiali in cui le cariche elettriche scorrono con facilità. In un metallo gli elettroni più esterni di ciascun atomo formano una specie di gas all interno
Il Cielo come Laboratorio
 Il Cielo come Laboratorio Progetto Educativo per le Scuole Superiori VI Edizione Promosso da Dipartimento di Astronomia Università degli Studi di Padova in collaborazione con Centro Servizi Amministrativi
Il Cielo come Laboratorio Progetto Educativo per le Scuole Superiori VI Edizione Promosso da Dipartimento di Astronomia Università degli Studi di Padova in collaborazione con Centro Servizi Amministrativi
La Terra nello spazio
 La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
IL PIANETA URANO. Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL.
 IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
Nane bianche e stelle di neutroni. di Roberto Maggiani
 Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
CORSI DI ASTRONOMIA 2010
 Rodolfo Calanca CORSI DI ASTRONOMIA 2010 PREMESSA Nel seguito propongo alcuni corsi di astronomia e di storia della scienza che possono essere svolti all interno di strutture pubbliche o private (Biblioteche
Rodolfo Calanca CORSI DI ASTRONOMIA 2010 PREMESSA Nel seguito propongo alcuni corsi di astronomia e di storia della scienza che possono essere svolti all interno di strutture pubbliche o private (Biblioteche
Tesi di Laurea I livello
 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÁ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN FISICA Tesi di Laurea I livello A.A. 2007/2008 Candidato: AGATIA LIBERTINO Relatore: Prof. LUCIO PATERNÓ
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÁ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN FISICA Tesi di Laurea I livello A.A. 2007/2008 Candidato: AGATIA LIBERTINO Relatore: Prof. LUCIO PATERNÓ
Corso di astronomia pratica
 Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO. Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011.
 Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Sfera Celeste e Coordinate Astronomiche. A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011
 Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
Scientifico Tecnologico
 Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle.
 1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
NAVIGAZIONE ASTRONOMICA parte 3. Circolo Astrofili di Mestre Guido Ruggieri
 parte 3 3 Novembre 2008, ore 21:00 Introduzione. Orientamento sulla Terra. Coordinate orizzontali degli astri, azimuth e altezza. Coordinate equatoriali degli astri, Ascensione Retta e Declinazione. 17
parte 3 3 Novembre 2008, ore 21:00 Introduzione. Orientamento sulla Terra. Coordinate orizzontali degli astri, azimuth e altezza. Coordinate equatoriali degli astri, Ascensione Retta e Declinazione. 17
Lassù qualcosa ci protegge
 E_Pannelli Magnetismo 20-02-2006 10:00 Pagina 1 01 Lassù qualcosa ci protegge C'è una presenza invisibile, intorno alla Terra, che è molto più importante di quanto immaginiamo. Ci racconta della vita nascosta
E_Pannelli Magnetismo 20-02-2006 10:00 Pagina 1 01 Lassù qualcosa ci protegge C'è una presenza invisibile, intorno alla Terra, che è molto più importante di quanto immaginiamo. Ci racconta della vita nascosta
IL MOTO di ROTAZIONE. CONSEGUENZE del MOTO di ROTAZIONE
 IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
1AEC 27/03/2014 MARIE CURIE IL SISTEMA SOLARE. Sistema solare al M. Curie
 IL SISTEMA SOLARE Sole Il Sole è la stella più vicina alla terra da cui dista dalla terra circa 149,6 milioni di Km, il nostro pianeta si muove intorno ad essa e ne riceve energia sotto forma di calore
IL SISTEMA SOLARE Sole Il Sole è la stella più vicina alla terra da cui dista dalla terra circa 149,6 milioni di Km, il nostro pianeta si muove intorno ad essa e ne riceve energia sotto forma di calore
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania. Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Il nostro Universo. Che cos è il Big Bang? Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011
 Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Le onde elettromagnetiche
 Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
Campi elettrici variabili... Proprietà delle onde elettromagnetiche L intuizione di Maxwell (1831-1879) Faraday ed Henry misero in evidenza che un campo magnetico variabile genera un campo elettrico indotto.
Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore
 Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore Cos'è la propagazione Nell'accezione classica radioamatoriale per "propagazione" si intende ogni fenomeno che estende la comunicazione
Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore Cos'è la propagazione Nell'accezione classica radioamatoriale per "propagazione" si intende ogni fenomeno che estende la comunicazione
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo. Seconda lezione. Antonio Maggio. INAF Osservatorio Astronomico di Palermo
 Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo Seconda lezione Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Argomenti e concetti già introdotti Astrometria: posizione
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo Seconda lezione Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Argomenti e concetti già introdotti Astrometria: posizione
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
D I V I S T A S U L L U N I V E R S O
 IL MIGLIOR PUNTO D I V I S T A S U L L U N I V E R S O 13 MILIARDI DI ANNI LUCE: la distanza dell oggetto più lontano osservato da un ricercatore INAF. È un record mondiale. È un lampo di raggi gamma prodotto
IL MIGLIOR PUNTO D I V I S T A S U L L U N I V E R S O 13 MILIARDI DI ANNI LUCE: la distanza dell oggetto più lontano osservato da un ricercatore INAF. È un record mondiale. È un lampo di raggi gamma prodotto
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti
 ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le
 1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le leggi di Keplero Il Sistema solare le orbite dei pianeti
1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le leggi di Keplero Il Sistema solare le orbite dei pianeti
Il campo magnetico. n I poli magnetici di nome contrario non possono essere separati: non esiste il monopolo magnetico
 Il campo magnetico n Le prime osservazioni dei fenomeni magnetici risalgono all antichità n Agli antichi greci era nota la proprietà della magnetite di attirare la limatura di ferro n Un ago magnetico
Il campo magnetico n Le prime osservazioni dei fenomeni magnetici risalgono all antichità n Agli antichi greci era nota la proprietà della magnetite di attirare la limatura di ferro n Un ago magnetico
AMMASSI DI GALASSIE. Marco Castellano.
 AMMASSI DI GALASSIE Marco Castellano castellano@oa-roma.inaf.it AMMASSI DI GALASSIE Gli oggetti più grandi dell Universo: 1) Un breve viaggio verso l Ammasso più vicino a noi 2) Quanto sono grandi: la
AMMASSI DI GALASSIE Marco Castellano castellano@oa-roma.inaf.it AMMASSI DI GALASSIE Gli oggetti più grandi dell Universo: 1) Un breve viaggio verso l Ammasso più vicino a noi 2) Quanto sono grandi: la
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari
 Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
GAIALAB:INCONTRIAMO L AMBIENTE IN LABORATORIO
 LABORATORIO DI FISICA Le forze che governano la natura La forza ha carattere vettoriale, cioè caratterizzata da un intensità, una direzione e un verso oltre che da un punto di applicazione. Rappresentazione
LABORATORIO DI FISICA Le forze che governano la natura La forza ha carattere vettoriale, cioè caratterizzata da un intensità, una direzione e un verso oltre che da un punto di applicazione. Rappresentazione
Salve ragazze e ragazzi!
 Salve ragazze e ragazzi! Bentornati nel nostro Osservatorio. In questa puntata continueremo a studiare la nostra Galassia e anche le altre galassie che popolano l Universo. Per studiare le galassie, quindi,
Salve ragazze e ragazzi! Bentornati nel nostro Osservatorio. In questa puntata continueremo a studiare la nostra Galassia e anche le altre galassie che popolano l Universo. Per studiare le galassie, quindi,
Oltre il Sistema Solare
 Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
10 7 metri Il nostro pianeta, la Terra, vista da una distanza di chilometri dalla sua superficie.
 10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
*COMUNICATO STAMPA* Almanacco astronomico del mese di giugno
 *COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
*COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
Vi propongo esempi di due serate osservative con relativa analisi dei dati ricavati.
 ESPERIENZE COL CCD Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, l'astronomia ha fatto passi da gigante (basti pensare alle immagini dell'hubble Space Telescope, ai dati raccolti dalle sonde interplanetarie,
ESPERIENZE COL CCD Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, l'astronomia ha fatto passi da gigante (basti pensare alle immagini dell'hubble Space Telescope, ai dati raccolti dalle sonde interplanetarie,
LE STELLE. LE DISTANZE ASTRONOMICHE Unità astronomica = distanza media Terra-Sole ( km)
 LE STELLE LE DISTANZE ASTRONOMICHE Unità astronomica = distanza media Terra-Sole (149 600 000 km) Anno luce = distanza percorsa in un anno dalla luce, che viaggia ad una velocità di 300 000 km/sec. (9
LE STELLE LE DISTANZE ASTRONOMICHE Unità astronomica = distanza media Terra-Sole (149 600 000 km) Anno luce = distanza percorsa in un anno dalla luce, che viaggia ad una velocità di 300 000 km/sec. (9
Le Coordinate Astronomiche
 Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
I buchi ne!: piccoli. e gran" cannibali
 I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola
 Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola CHE COS E IL MAGNETISMO Magnetismo Classe di fenomeni generati da cariche elettriche in movimento. Mentre una carica ferma genera intorno a sé un campo puramente
Progetto di scienze Pasquale,Gennaro e Nicola CHE COS E IL MAGNETISMO Magnetismo Classe di fenomeni generati da cariche elettriche in movimento. Mentre una carica ferma genera intorno a sé un campo puramente
Campo magnetico terrestre lezione 1. Gaetano Festa
 Campo magnetico terrestre lezione 1 Gaetano Festa Equazioni del campo magnetico Equazioni di Maxwell E = ρ ε 0 0 E = B = 1 B = µ 0j+ 2 te c t B Corrente di spostamento Corrente di spostamento in relazione
Campo magnetico terrestre lezione 1 Gaetano Festa Equazioni del campo magnetico Equazioni di Maxwell E = ρ ε 0 0 E = B = 1 B = µ 0j+ 2 te c t B Corrente di spostamento Corrente di spostamento in relazione
Storia delle scoperte del campo magnetico
 Storia delle scoperte del campo magnetico Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia VI secolo a.c. Talete osserva che la magnetite, un minerale composto al 72% di ferro, estratto
Storia delle scoperte del campo magnetico Prof. Daniele Ippolito Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia VI secolo a.c. Talete osserva che la magnetite, un minerale composto al 72% di ferro, estratto
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica
 Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
LUNA - Eclissi Totale
 DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO
 Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
Potenzialità dei Musei Scientifici per la Didattica dell Astronomia
 Raccontare e Insegnare il Cielo e le Stelle Bologna Fiere, 25-26 marzo 2014 Potenzialità dei Musei Scientifici per la Didattica dell Astronomia L esperienza del corso di Fondamenti e Didattica della Fisica
Raccontare e Insegnare il Cielo e le Stelle Bologna Fiere, 25-26 marzo 2014 Potenzialità dei Musei Scientifici per la Didattica dell Astronomia L esperienza del corso di Fondamenti e Didattica della Fisica
Qualche cenno al Sole
 Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
Qualche cenno al Sole Corso di Astronomia Daniele Gasparri Lezione 1, 25/11/2011: Breve viaggio attraverso l Universo - Sfera celeste ed orientamento - Cenni al Sistema Solare - Corpi e proprietà dell
Forza di Lorentz ( o. magnetica) I = qtx È. k : E = àxt. c ab Seno %ÈÈ : . imo
 Forza di Lorentz ( o magnetica). I = qtx È k : E = àxt :C =# ÙT = ; c ab Seno. imo %ÈÈ : F- QVB sono È t sia at che a È ( Io regola della mano deste casi particolari : $ 0=0 o T =/ 80 F = o feriti serrò
Forza di Lorentz ( o magnetica). I = qtx È k : E = àxt :C =# ÙT = ; c ab Seno. imo %ÈÈ : F- QVB sono È t sia at che a È ( Io regola della mano deste casi particolari : $ 0=0 o T =/ 80 F = o feriti serrò
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017. Scuola di Astronomia. Contenuti dei corsi e dei seminari.
 Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
NATURA DELL ENERGIA. L energia è tutta intorno a noi!
 NATURA DELL ENERGIA L energia è tutta intorno a noi! Si può ascoltare l'energia come suono Si può vedere l'energia come luce Si può sentire l energia come vento NATURA DELL ENERGIA Utilizzi l energia quando:
NATURA DELL ENERGIA L energia è tutta intorno a noi! Si può ascoltare l'energia come suono Si può vedere l'energia come luce Si può sentire l energia come vento NATURA DELL ENERGIA Utilizzi l energia quando:
Il campo magnetico. Lezioni d'autore
 Il campo magnetico Lezioni d'autore Introduzione: Satelliti che studiano le variazioni del campo magnetico terrestre VIDEO Il campo magnetico terrestre: la determinazione di un campo vettoriale (I) La
Il campo magnetico Lezioni d'autore Introduzione: Satelliti che studiano le variazioni del campo magnetico terrestre VIDEO Il campo magnetico terrestre: la determinazione di un campo vettoriale (I) La
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
4 FORZE FONDAMENTALI
 FORZA 4! QUANTE FORZE? IN NATURA POSSONO ESSERE OSSERVATE TANTE TIPOLOGIE DI FORZE DIVERSE: GRAVITA' O PESO, LA FORZA CHE SI ESERCITA TRA DUE MAGNETI O TRA DUE CORPI CARICHI, LA FORZA DEL VENTO O DELL'ACQUA
FORZA 4! QUANTE FORZE? IN NATURA POSSONO ESSERE OSSERVATE TANTE TIPOLOGIE DI FORZE DIVERSE: GRAVITA' O PESO, LA FORZA CHE SI ESERCITA TRA DUE MAGNETI O TRA DUE CORPI CARICHI, LA FORZA DEL VENTO O DELL'ACQUA
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote
 Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2014 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2014 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior 1. Le quattro stagioni Si scrivano gli intervalli entro cui variano l ascensione retta ( ) e la declinazione ( )
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2014 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Junior 1. Le quattro stagioni Si scrivano gli intervalli entro cui variano l ascensione retta ( ) e la declinazione ( )
IL SISTEMA SOLARE. Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da :
 IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da : IL SISTEMA SOLARE I pianeti sono Corpi celesti di forma sferica che non brillano di luce propria, ma
IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da : IL SISTEMA SOLARE I pianeti sono Corpi celesti di forma sferica che non brillano di luce propria, ma
Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO L. da Vinci-De Giorgio LANCIANO
 Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO L. da Vinci-De Giorgio LANCIANO LABORATORIO DI FISICA ELETTROMAGNETISMO ALUNNO: Di Giuseppe Orlando CLASSE: V LSTA DATA: 23/01/2013 Docenti:
Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO L. da Vinci-De Giorgio LANCIANO LABORATORIO DI FISICA ELETTROMAGNETISMO ALUNNO: Di Giuseppe Orlando CLASSE: V LSTA DATA: 23/01/2013 Docenti:
Astronomia Osservazione del cielo
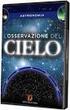 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
I LEGAMI CHIMICI. I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune
 I LEGAMI CHIMICI I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune alcuni elettroni con altri atomi, per completare il guscio elettronico più esterno. 1. LEGAME IONICO
I LEGAMI CHIMICI I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune alcuni elettroni con altri atomi, per completare il guscio elettronico più esterno. 1. LEGAME IONICO
Che cosa è la luce? 1
 Che cosa è la luce? 1 CAMPO ELETTROMAGNETICO 2 Onde Che cosa è un onda? Un onda è una perturbazione di un mezzo, dove il mezzo può essere un campo (es: il campo gravitazionale) o di una sostanza materiale
Che cosa è la luce? 1 CAMPO ELETTROMAGNETICO 2 Onde Che cosa è un onda? Un onda è una perturbazione di un mezzo, dove il mezzo può essere un campo (es: il campo gravitazionale) o di una sostanza materiale
La Luna e le sue fasi
 La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
3).
 3). http://sdo.gsfc.nasa.gov/ L'immagine è un mosaico di particolari della superficie e dell'atmosfera solari, ripresi dal Solar Dynamics Observatory nelle differenti lunghezze d'onda alle quali operano
3). http://sdo.gsfc.nasa.gov/ L'immagine è un mosaico di particolari della superficie e dell'atmosfera solari, ripresi dal Solar Dynamics Observatory nelle differenti lunghezze d'onda alle quali operano
L UNIONE ASTROFILI ITALIANI. la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano
 L UNIONE ASTROFILI ITALIANI la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano La Sede UAI è presso l Osservatorio Astronomico Fuligni a Rocca di Papa. Il fenomeno dell Astrofilia in Italia Si
L UNIONE ASTROFILI ITALIANI la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano La Sede UAI è presso l Osservatorio Astronomico Fuligni a Rocca di Papa. Il fenomeno dell Astrofilia in Italia Si
LA TERRA. Cosa vedete? Conosci il sistema solare? Da che cosa è formato il sistema solare? In quale posizione si trova la Terra?
 LA TERRA Cosa vedete? Conosci il sistema solare? Da che cosa è formato il sistema solare? In quale posizione si trova la Terra? IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è formato da 8 pianeti: in ordine di
LA TERRA Cosa vedete? Conosci il sistema solare? Da che cosa è formato il sistema solare? In quale posizione si trova la Terra? IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è formato da 8 pianeti: in ordine di
Unità 11: DIANMICA E TERMODINAMICA DELL ATMOSFERA FENOMENI PERICOLOSI PER IL VOLO
 Unità 11: DIANMICA E TERMODINAMICA DELL ATMOSFERA FENOMENI PERICOLOSI PER IL VOLO 1. Le meteore e le nubi Per meteora si intende un fenomeno osservato nell'atmosfera o sulla superficie terrestre. Tale
Unità 11: DIANMICA E TERMODINAMICA DELL ATMOSFERA FENOMENI PERICOLOSI PER IL VOLO 1. Le meteore e le nubi Per meteora si intende un fenomeno osservato nell'atmosfera o sulla superficie terrestre. Tale
LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE
 LC.06.02.06 LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE Prerequisiti: nozioni scientifiche e matematiche acquisite durante la scuola secondaria di primo grado Obiettivi: studio della latitudine e della longitudine
LC.06.02.06 LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE Prerequisiti: nozioni scientifiche e matematiche acquisite durante la scuola secondaria di primo grado Obiettivi: studio della latitudine e della longitudine
Attributi percettivi del colore
 Attributi percettivi del colore È possibile isolare delle caratteristiche della percezione di colore che consentono, in una certa misura, di descrivere, classificare, scomporre il colore percepito. Queste
Attributi percettivi del colore È possibile isolare delle caratteristiche della percezione di colore che consentono, in una certa misura, di descrivere, classificare, scomporre il colore percepito. Queste
Quesiti dell Indirizzo Tecnologico
 Quesiti dell Indirizzo Tecnologico 1) Sapendo che la massa di Marte é 1/10 della massa della Terra e che il suo raggio é ½ di quello della Terra l accelerazione di gravità su Marte è: a) 1/10 di quella
Quesiti dell Indirizzo Tecnologico 1) Sapendo che la massa di Marte é 1/10 della massa della Terra e che il suo raggio é ½ di quello della Terra l accelerazione di gravità su Marte è: a) 1/10 di quella
pianeta Terra caratteristiche generali
 pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
LARGE BINOCULAR TELESCOPE
 LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE. Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO. a.s.
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2O13-2014 Materia : Scienze integrate-scienze della terra Classe : I sez. G
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE Roberto Valturio RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2O13-2014 Materia : Scienze integrate-scienze della terra Classe : I sez. G
ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013
 ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013 Di seguito trovate un analisi dei dati raccolti dal 2008 ad oggi (Dicembre 2013), in tutti questi anni ho visto crescere l attività solare e ho raccolto molta esperienza
ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013 Di seguito trovate un analisi dei dati raccolti dal 2008 ad oggi (Dicembre 2013), in tutti questi anni ho visto crescere l attività solare e ho raccolto molta esperienza
Progetto Laboratori Lauree Scientifiche
 Progetto Laboratori Lauree Scientifiche Laboratorio sulle funzioni trigonometriche Le ore di insolazione giornaliera in funzione della latitudine Bozza di progetto Nel seguito verrà presentata la descrizione
Progetto Laboratori Lauree Scientifiche Laboratorio sulle funzioni trigonometriche Le ore di insolazione giornaliera in funzione della latitudine Bozza di progetto Nel seguito verrà presentata la descrizione
Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico
 Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico G. Bosia Universita di Torino G. Bosia Introduzione alla fisica del plasma Lezione 15 1 Disuniformità con gradiente in direzione del campo ( ) Una
Lezione 15 Geometrie lineari di confinamento magnetico G. Bosia Universita di Torino G. Bosia Introduzione alla fisica del plasma Lezione 15 1 Disuniformità con gradiente in direzione del campo ( ) Una
L ATMOSFERA TERRESTRE classe I sez. C allievo Gallo Giuseppe
 L ATMOSFERA TERRESTRE classe I sez. C allievo Gallo Giuseppe L ATMOSFERA TERRESTRE E UN INVOLUCRO CHE CIRCONDA LA TERRA, E COMPOSTA DA AZOTO,OSSIGENO,ARGON E ANIDRIDE CARBONICA. GLI STRATI DELL ATMOSFERA
L ATMOSFERA TERRESTRE classe I sez. C allievo Gallo Giuseppe L ATMOSFERA TERRESTRE E UN INVOLUCRO CHE CIRCONDA LA TERRA, E COMPOSTA DA AZOTO,OSSIGENO,ARGON E ANIDRIDE CARBONICA. GLI STRATI DELL ATMOSFERA
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
L elettrizzazione. Progetto: Istruzione di base per giovani adulti lavoratori 2 a opportunità
 1 L elettrizzazione Si può notare che corpi di materiale differente (plastica, vetro ecc.) acquisiscono la proprietà di attirare piccoli pezzetti di carta dopo essere stati strofinati con un panno di stoffa
1 L elettrizzazione Si può notare che corpi di materiale differente (plastica, vetro ecc.) acquisiscono la proprietà di attirare piccoli pezzetti di carta dopo essere stati strofinati con un panno di stoffa
Sorgenti di ioni negativi
 Sorgenti di ioni negativi Fabio Scarpa INFN Laboratori Nazionali di Legnaro Fabio Scarpa 1 Argomenti Trattati Cenni di richiamo sugli ioni Affinità elettronica Metodi e procedure di ionizzazione Sputtering
Sorgenti di ioni negativi Fabio Scarpa INFN Laboratori Nazionali di Legnaro Fabio Scarpa 1 Argomenti Trattati Cenni di richiamo sugli ioni Affinità elettronica Metodi e procedure di ionizzazione Sputtering
Alla ricerca di un altra Terra!
 Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE E FORMATO DA: -IL SOLE -I PIANETI -I SATELLITI -GLI ASTEROIDI -LE COMETE -I METEORITI/METEORE
 IL SISTEMA SOLARE HA AVUTO ORIGINE CIRCA 4 MILIARDI E MEZZO DI ANNI FA DA UNA NUBE DI GAS E MINUSCOLE PARTICELLE SOLIDE, CHIAMATE DAGLI SCIENZIATI POLVERE. A CAUSA DELLA FORZA DI GRAVITA QUESTE PARTICELLE
IL SISTEMA SOLARE HA AVUTO ORIGINE CIRCA 4 MILIARDI E MEZZO DI ANNI FA DA UNA NUBE DI GAS E MINUSCOLE PARTICELLE SOLIDE, CHIAMATE DAGLI SCIENZIATI POLVERE. A CAUSA DELLA FORZA DI GRAVITA QUESTE PARTICELLE
