COMUNE DI DORNO. Provincia di Pavia
|
|
|
- Agostina Perri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI DORNO Provincia di Pavia GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DORNO Iscritto nel Registro Regionale dal al numero e all'albo Nazionale Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2014 Adeguamento/Integrazione Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 9/04/2014 AGGIORNAMENTO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 1/08/2014 a cura di: Quaggio Mauro Referente Operativo Comunale hanno collaborato: I componenti l'ufficio Tecnico Comunale PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
2 Indice Capitolo 1. Riferimenti Normativi Capitolo 2. Individuazione dei Rischi Capitolo 3. Rischio Idrogeologico Capitolo 4. Rischio Incendio Boschivo Capitolo 5. Rischio Industriale Capitolo 6. Rischio Sismico Capitolo 7. Rischio Viabilistico Capitolo 8. Rischio Generico - Eventi di rilevante impatto locale Capitolo 9. Aree di Emergenza Capitolo 10. Strutture di Gestione dell emergenza Capitolo 11. Adempimenti Amministrativi Capitolo 12. Ricognizione e comunicazione dei danni Capitolo 13. PEWEB Mosaico dei Piani di Emergenza Comunali Allegati: Allegato 1 Schede di Informazione sui rischi di Incidente Rilevante per i cittadini e lavoratori della Ditta OLON S.p.A. Allegato 2 Numeri telefonici di reperibilità Ditta OLON S.p.A. Allegato 3 Planimetria dello Stabilimento Ditta OLON S.p.A. Allegato 4 Risorse Comunali Rubrica. Allegato 5 Cartografie: 5.1 Rete Idrica e Fognatura 5.2 Rete Enel, Gas, Oleodotto e Elettrodotto Allegato 6 Pianificazioni di Altri Enti - Raffineria ENI S.p.A. di Sannazzaro de' B.: Scheda di Informazione alla Popolazione. Allegato 7 Elaborati grafici costituenti il Piano di Emergenza Comunale in formato A3 N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy. 2
3 Capitolo 1. Riferimenti Normativi Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile. Riferimenti legislativi nazionali Norme generali Legge 225/92 e smi Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile D.M. 28 maggio 1993 Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Legge 9 novembre 2001, n. 401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile Legge 26 luglio 2005, n. 152 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile Rischio idrogeologico Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po Rischio sismico Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia O.P.C.M del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica O.P.C.M del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni Rischio incendio boschivo Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi Rischio industriale e Nucleare Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 3
4 controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e smi D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell emergenza esterna degli stabilimenti industriali e rischio d incidente rilevante Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" D.P.C.M , G.U Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti Direttive DPC Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1). Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile Direttiva 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile D.P.C.M. 06 aprile 2006 Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 02 maggio 2006 Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici Direttiva del 27 ottobre 2008: indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale Direttiva del 9 novembre 2012dirizzi operativi per assicurare l unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all attività di protezione civile Riferimenti legislativi Regione Lombardia Norme generali Legge regionale 22 maggio n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile e smi Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 legge per il governo del territorio D.G.R. n 8/4732 del 16 maggio 2007 Revisione della Deliberazione Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali L.R. 16/2004 Rischio idrogeologico D.G.R. n 3116 del 01 agosto 2006 Modifiche ed integrazioni alla D.G.R /2004 di approvazione del protocollo d intesa con le Province lombarde per l impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 4
5 Capitolo 2. Individuazione dei Rischi 2.1 Inquadramento Territoriale Il Comune di Dorno è ubicato sulla riva sinistra del torrente Terdoppio e confina a Nord con il Comune di Garlasco e Gropello Cairoli, ad Est con il Comune di Zinasco Nuovo a Sud con il Comune di Pieve Albignola e Scaldasole, ad Ovest con il Comune di Valeggio ed Alagna. Il territorio comunale è pianeggiante e destinato prevalentemente ad uso agricolo. Esso è attraversato dal torrente Terdoppio che, con le sue acque, alimenta la fitta rete di canali e rogge necessari all irrigazione. Breve descrizione del territorio da un punto di vista economico storico ambientale: Nel Comune di Dorno fino agli anni 50 l economia era prevalentemente basata sull agricoltura, dopo l insediamento di alcune piccole e medie industrie sul territorio si è avuto un notevole incremento del benessere per gli abitanti La prima scritta che riporta il toponimo di Duriis è considerato l'itinerarium Burdigalense o hierosolomytanum, del 333 dopo Cristo, che segnala la presenza, tra Pavia (Ticinum) e Lomello (Laumellum ), a 12 miglia dall'una e 9 dall'altra di una stazione di cambio per cavalli, appunto la "mutatio Duriis". Ammiano Marcellino, Storico tardo latino, ricorda l'esistenza sulla via per la Gallia a sud di Milano, di "un locum ad duabus columnis insignem qui Laumellum interiacet et Ticinum" (Rerum Gestariis). Ritrovamenti casuali, avvenuti nel 1975, di asce, ceramiche, coppe e fibule, risalenti al bronzo medio ( a c ), ora al museo civico di Pavia ed al museo preistorico Pigorini di Roma, testimoniano la presenza, in situ, di genti autoctone, forse di origine Ligure o di Golasecca,.stanziali, presumibilmente in piccoli accampamenti, a far tempo circa dal 2000 a.c., come testimoniato dal ritrovamento di una tazza e di fibule con ansa ad ascia, fino al 9 secolo a.c., periodo in cui è possibile far risalire l'ultimo reperto appartenente all'età del bronzo, rinvenuto nel Risalente al 5 secolo a.c. è invece una bocchetta di stile Etrusco probabilmente frutto del commercio tra i Tirreni e i Celti ( Insubri o più probabilmente Levi ) che proprio in quel periodo si affacciavano sulla pianura padana. Risalenti al 2 secolo a.c. e di provenienza e gusto Celtico sono invece i numerosi ritrovamenti in zona Batterra, dove vengono ritrovati i reperti risalenti al secolo successivo, ormai di origine romana ( la battaglia di Casteggio ha luogo infatti nel 222 a.c.). Fantasiose appaiono le teorie formulate nei secoli circa l'etimologia del nome di Dorno che deriverebbe dall'etrusco Horn (capo) o dal celtico Dur (argine), DURN (lino) o DURNA (curva). Vari documenti medievali, a partire dal 12 secolo attestano l'uso ormai comune del nome Durno. 5
6 Caduto l'impero Romano la Regione rimase in balia dei barbari, del Regno italico-gotico, dell'effimero Impero riunito da Giustiniano, per passare, dal 570 d.c. nel Regno longobardo e più tardi, dal 774, in quello franco e nel neo Sacro Romano Impero. Nell' 834 Dorno, infeudato nella Contea di Lomello venne da Lotario I assegnato a Manfredi d'orleans. Roberto dei Conti Palatini, di Lomello, viene citato dall'imperatore Enrico V, in un diploma del 1190, come Signore di Dorno. Nel 1266 Dorno era Castello dei marcabotti, cioè dei ghibellini di Pavia, per poi passare nello stato Visconteo. Nell abitato di Dorno è ben distinguibile il centro storico, porzione centrale della città identificabile soprattutto in rapporto alla caratterizzazione ad anelli e radiali dell impianto viario, dalla città consolidata di origine più recente. Per quanto riguarda il sistema dei vincoli paesistici e storico-architettonici, nel territorio comunale sono presenti differenti aree tutelate: il Torrente Terdoppio con relative fasce di rispetto, tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, che scorre da nord-ovest verso sud-est; tre aree a rischio archeologico (D.Lgs. 29/10/99 ex L.431/85), localizzate a sud est rispetto all abitato di Dorno; due edifici del centro storico e uno situato nei pressi del Cimitero, sottoposti a vincolo di tutela architettonica e paesaggistica ex Dlgs 42/2004 (L.1089/39). Inoltre, sono presenti alcune aree, denominate i Dossi, indicate nel PRG come zone di tutela geomorfologica delle emergenze geologiche ed evidenziate anche nel PTCP come emergenze naturalistiche, meritevoli di tutela in quanto di notevole significato ecologicoambientale. Inoltre, si segnala la presenza di rilevanze dell architettura religiosa (cimitero e cappella limitrofa), di architettura rurale (cascine) e attraversamenti del Torrente Terdoppio. Dati territoriali: INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI DORNO Provincia PAVIA CAP Superficie territoriale ETTARI Latitudine 45 9'24"84 N Longitudine 08 57'13"68 E Altitudine min 70 - max 94 m.s.l.m. DORNO 31/12/2013 n. abitanti e più Maschi Femmine TOTALE
7 RIFERIMENTI UFFICI COMUNALI Comune di Dorno Indirizzo P.zza G.Bonacossa 3 Telefono Fax Pec comune.dorno@pec.provincia.pv.it Il Comune rientra nel COM n. 32 di Sannazzaro de Burgundi come da aggiornamento con nota della Prefettura del 25/09/2013 a cui appartengono i seguenti comuni: DORNO FERRERA ERBOGNONE GALLIAVOLA MEZZANA BIGLI PIEVE ALBIGNOLA SANNAZZARO DE BURGONDI SCALDASOLE VALEGGIO LOMELLINA Il Comune fa parte dell Aggregazione dei Servizi sulla funzione Protezione Civile con i Comuni di: FERRERA ERBOGNONE PIEVE ALBIGNOLA VALEGGIO LOMELLINA come da Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/
8 PIANO COMUNALE GENERALITA L insieme dei servizi rivolti all integrità fisica degli individui, alla salvaguardia dei loro beni e all ambiente che li circonda, quando si verificano violenti ed improvvisi stravolgimenti territoriali ed ambientali, costituiscono gli interventi particolari attuati dal Servizio Nazionale della Protezione Civile. Per lo svolgimento delle finalità di tale servizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell art. 21 della Legge 400/88. Tale servizio risulta costituito da un complesso funzionalestrutturale di componenti e strutture operative. Le prime, svolgono attività di programmazione legislativa, di promozione, di indirizzo e coordinamento, sono cioè dei pubblici poteri che hanno titolarità a diversi livelli della funzione di Protezione Civile, Stato, Regioni; Province; Comuni; Comunità Montane. Le seconde, si configurano come organizzazioni specialistiche stabili, atte professionalmente ad attuare gli interventi di Protezione Civile e partecipano collaborando con tutte le componenti di Servizio, fornendo consulenza a svolgendo interventi di supporto inerenti a tutte le attività di protezione civile, Vigili del Fuoco; Forze Armate; Forze di Polizia; Corpo Forestale dello Stato; Servizi Tecnici Nazionali; Gruppi Nazionale di Ricerca Scientifica; Croce Rossa Italiana; Strutture del Servizio Sanitario Nazionale; Organizzazioni di Volontariato; Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSA-CAI). Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è costituito anche da: Organismi pubblici e privati (Enti pubblici, Istituti, Gruppi di ricerca scientifica, Istituzioni ed Organizzazioni private); da mezzi, strumenti, attività e risorse disponibili per l attuazione degli interventi di Protezione Civile. Sono considerate attività di Protezione Civile quelle volte a prevedere e prevenire ogni ipotesi di rischio, soccorrere la popolazione colpita ed ogni altra azione necessaria ed irrimandabile volta al superamento dell emergenza. Infatti la Protezione Civile non è soltanto organizzazione del soccorso ma, prima di tutto, deve essere previsione e prevenzione che ne costituiscono gli elementi centrali. L attività di Protezione Civile, pertanto, si snoda attraverso quattro distinte direttrici: 1. la Previsione che consiste in quella serie di attività che sono dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, la conoscenza dei rischi e l individuazione delle zone di territorio dove esse hanno incidenza. 2. la Prevenzione che scaturisce dalle conoscenze acquisite dallo studio previsionale e da tutte le altre attività volte ad evitare o ridurre al minimo i danni. 0. il Soccorso che riguarda l organizzazione degli interventi e la loro gestione, per assicurare alla popolazione colpita il salvataggio e la prima assistenza. 4. il Superamento dell Emergenza che consiste nell insieme di iniziative (coordinate con gli organi istituzionali competenti) necessarie ed irrimandabili, volte a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita. Gli strumenti giuridici di intervento delle componenti, ai diversi livelli della funzione di Protezione Civile, sono: 1. i programmi, 2. i piani 3. le ordinanze 8
9 Questi presuppongono la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e la successiva pianificazione degli interventi di soccorso, per l attuazione dei quali si ricorre al potere di ordinanza. La Programmazione è afferente alla fase di previsione dell evento, intesa come conoscenza dei rischi che gravano sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. A tale scopo i programmi devono essere ricognitivi delle problematiche che si riferiscono al territorio e devono, pertanto, prevedere l individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da reperire. In un contesto unitario, la programmazione deve riguardare scenari connessi a rischi che per la loro natura o estensione richiedono l intervento degli organi comunali. Dal momento che i pubblici poteri, titolari della funzione di direzione degli interventi di soccorso, devono operare celermente superando difficoltà operative, è previsto che gli stessi possano operare in regime eccezionale avvalendosi dello strumento giuridico dell Ordinanza, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico. L Ordinanza costituisce un provvedimento di necessità ed urgenza per dare attuazione agli interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Il potere di ordinanza compete al Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, al prefetto, al Sindaco, al Presidente della Giunta Regionale i quali, in via straordinaria, se ne servono per affrontare emergenze eccezionali. Lo Stato di Emergenza è una situazione di grave o gravissima crisi in un area determinata del territorio al seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, attraverso l emanazione di provvedimenti (ordinanze) anche in deroga all ordinamento vigente. Lo Stato di Calamità è una situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale, ma non gravissimo, che provocano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e dell agricoltura. Figura 7: Foglio 58 della Carta Geologica d'italia 9
10 LEGISLAZIONE APPLICABILE L art. 15 della Legge n.225 del 24 Febbraio 1992 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), recita testualmente: 1. Nell ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile. 2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l organizzazione di Strutture Comunali di Protezione Civile. 3. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale amministrativo, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. 4. Quando la calamità naturale o l evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell autorità comunale di Protezione Civile. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità dei cittadini; per l esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l assistenza della forza pubblica. Se l ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all ordine impartito, il Sindaco può provvedere di ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell azione penale per i reati in cui fossero incorsi. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. Nell ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall articolo 10, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio di Circoscrizione; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede l Ente interessato. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, in emergenza i compiti di direzione e coordinamento degli interventi sul territorio amministrato sono di sua competenza. Al momento dell emergenza, quando questa è fronteggiabile a livello comunale, il Sindaco, nell ambito del proprio territorio, coadiuvato dalla struttura comunale di Protezione Civile, provvede agli interventi necessari, raccordandosi con il Prefetto e con il Presidente della giunta Regionale. Qualora l emergenza non possa essere affrontata con i mezzi e le energie umane a disposizione, il Sindaco chiede l intervento del prefetto e del presidente della Giunta Regionale, per avere a disposizione altre forze e strutture. Quando l evento calamitoso non può essere fronteggiato nemmeno a livello prefettizio, l emergenza dovrà essere affrontata con mezzi e poteri straordinari (art. 2, lettera c, Legge 225/92 ) 10
11 con la conseguente deliberazione dello Stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, determina durata ed estensione territoriale dell emergenza, in stretto riferimento alla natura degli eventi ( art. 5, comma 1, Legge 225/92 ). In conseguenza della dichiarazione dello Stato di Emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può nominare anche un Commissario delegato per l attuazione degli interventi di emergenza, quando il coordinamento e la direzione delle Strutture di protezione civile appartiene a più ambiti provinciali, in questo caso, il Sindaco resta competente per ciò che riguarda la direzione degli interventi di emergenza relativamente al suo ambito territoriale. Più specificatamente l attività del Sindaco dovrebbe articolarsi attraverso le seguenti fasi: 1) Attività preparatoria 2) Attività nel periodo di intervento 3) Attività da sviluppare in caso di evento senza preannuncio 4) Attività per il superamento dell emergenza Tabella elenco attività del Sindaco in caso di. 1. Attività preparatoria (Periodo ordinario) Codice VERDE Il Sindaco provvede a: Informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza Rendere reperibile alla Prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile Procedura Periodicamente Costantemente Dotare il comune di una propria struttura di protezione civile (costituita da organi comunali, Polizia Municipale, Associazioni di Volontariato, ecc.) per espletare il servizio di vigilanza, di salvaguardia e per concorrere alle altre azioni di protezione civile Individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini durante la fase di allarme Organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili Mappatura Pianificare 11
12 12 Piano di Emergenza Comunale Tabella elenco attività del Sindaco in caso di. delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, telefoni, ecc.) Individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza Mantenere aggiornato un semplice piano di protezione civile nel quale sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra Non appena possibile Documento separato con gestione annuale Effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di protezione civile, adottando preferibilmente il criterio di effettuarle su allarme e non predisposte Sviluppare tutte le altre iniziative idonee all attuazione del modello di intervento Sviluppare tutte le altre iniziative idonee a favorire il successo dell intervento di protezione civile nei casi di emergenza Non appena possibile Non appena possibile 2. Attività nel periodo di intervento 2.1 Fase di Attenzione Codice GIALLO Il Sindaco (o suo sostituto) Comunica alla Prefettura di aver ricevuto l allarme a seguito di richiesta del Prefetto Invia presso il CCS (se attivato) il responsabile comunale che pone a disposizione per la gestione dell emergenza Attiva il servizio di vigilanza comunale Procedura con sollecitudine con sollecitudine
13 13 Piano di Emergenza Comunale 2.2 Fase di Pre-allarme Codice ARANCIO Il Sindaco dispone La delega del proprio rappresentante nel COM Procedura Con sollecitudine Tabella elenco attività del Sindaco in caso di. Attiva la Sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto. A ragion veduta 2.3 Fase di Allarme Codice ROSSO Il Sindaco: Procedura Attiva la struttura comunale di protezione civile, le forze dell ordine, le strutture sanitarie comunali, i Vigili del Fuoco per sviluppare le azioni di salvaguardia e di soccorso. Mette in atto i provvedimenti di salvaguardia delle persone e cose previste nel piano comunale di Protezione civile A ragion veduta A ragion veduta Disloca personale delle forze dell ordine o dei volontari sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere il traffico. Comunica ai cittadini le azioni intraprese secondo le procedure previste nel Piano Comunale di Protezione civile. Collabora con le strutture disponibili alle attività di soccorso alla popolazione. A ragion veduta Comunica l eventuale cessato allarme. Assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (alle Forze dell Ordine, ai Vigili del Fuoco, agli organi sanitari, alle Associazioni di Volontariato, ecc.). Dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone o cose), impiegando la struttura comunale di protezione civile. A ragion veduta A ragion veduta
14 14 Piano di Emergenza Comunale 3. Attività da sviluppare in caso di evento senza preannuncio Il Sindaco: Procedura Si collega con la Prefettura per segnalare con sollecitudinel evento. Attiva la Sala Operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto. Attiva, d intesa con il Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, le Forze dell Ordine, le strutture sanitarie comunali, i Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato etc. A ragion veduta Non appena possibile Dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni a persone o cose), impiegando la struttura comunale di Protezione Civile. Assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (alle forze dell ordine, ai Vigili del Fuoco, agli organi sanitari, alle Associazioni di Volontariato). A ragion veduta
15 15 Piano di Emergenza Comunale 4. Attività per il superamento dell emergenza Il Sindaco: Procedura Dispone per l accertamento dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per l istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità. FUNZIONI E STRUTTURA COMUNALE Il Sindaco esercita le funzioni attribuiti ai sensi ed agli effetti della citata legge 225/92. La costituzione della struttura di Protezione Civile deve essere permanente per poter pianificare gli interventi in relazione alle esigenze, per consentire al Sindaco lo svolgimento delle sue funzioni, nonché tutte le attività legate alla previsione, prevenzione, al soccorso ed assistenza nella predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Centro Operativo Comunale (COC), dovrebbe essere presidiato nell arco delle 24 ore, con predisposizione di turni di servizio e reperibilità del personale impegnato ( deve essere disponibile un elenco completo dei funzionari responsabili corredato dai rispettivi numeri telefonici per la simultanea reperibilità di emergenza). La Struttura Comunale di Protezione Civile necessita di un costante coordinamento con la Prefettura e con la struttura regionale di protezione civile per ciò che attiene la sfera di Programmazione e di Pianificazione. In emergenza scattano i coordinamenti speciali: a) con la Prefettura, per l assistenza operativa e l attivazione del livello superiore (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile); b) con la Regione, per quanto di competenza. I Settori o gli Assessorati interni al Comune con i quali la Struttura Comunale di Protezione Civile si deve collegare per reperire e trasmettere tutte le informazioni gestite dai diversi uffici sono: 1. Polizia Municipale 2. Ambiente 1. per l attività relativa all ordine pubblico; 2. per l attività relativa alla ricognizione; 3. per l attività relativa alla regolamentazione del traffico e gestione dei cancelli nella fase di emergenza. 1. per l attività relativa agli interventi antinquinamento; 2. per l attività relativa agli interventi veterinari e simili; 3. per l attività relativa agli interventi tecnici di emergenza per quanto di competenza (es. Industrie etc.)
16 16 Piano di Emergenza Comunale 3. Lavori pubblici 4. Servizi Sociali 5. Urbanistica 1. per l attività rivolta agli interventi preventivi tecnici; 2. per l attività rivolta agli interventi tecnici di emergenza; 3. per l attività rivolta all accertamento e stima dei danni; 4. per l attività rivolta alla ripresa della normalità; 5. per l attività rivolta alla ristrutturazione e/o ricostruzione. 1. per l attività relativa ai primi interventi assistenziali; 2. per l attività relativa al coordinamento delle attività socio-assistenziali. 1. per l attività relativa alle informazioni cartografiche; 2. per l attività relativa alla individuazione della situazione reale. 6. Trasporti e viabilità 1. per l attività relativa all attivazione dei mezzi disponibili in collaborazione con le aziende trasporti (es. STAV, GARBARINI ); 2. per l attività relativa al collegamento con le informazioni cartografiche per l individuazione dello stato della viabilità stradale e per gli eventuali percorsi alternativi; 3. per l attività relativa alla segnaletica di emergenza. 7. Anagrafe 1. per l attività relativa al censimento della popolazione; 2. per l attività relativa all individuazione dei soggetti deboli.
17 Reperibilità dei Funzionari del C.O.C./U.C.L. Il Centro Operativo Comunale è composto da quattro funzioni di supporto, che saranno convocate e prenderanno posizione nei locali predisposti in viale Risorgimento 15 Dorno. 1 Centro Operativo Comunale di Dorno a Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : Longitudine: ' N ,50 E b Frequenze radio assegnate dalla Provincia di Pavia al comune di Dorno CB - 40 [ Canale operativo assegnato 15] ad uso personale PMR Banda 466 mhz [CANALE 5] Delimitazione delle aree a rischio. La delimitazione di tali aree avviene tramite l istituzione di posti di blocco denominati cancelli, sulle reti di viabilità, per meglio regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dalla zona a rischio. La predisposizione dei cancelli è in corrispondenza di nodi stradali per meglio favorire manovre e deviazioni. 2 Punto del Cancello 1, ( strada per Garlasco c/o zona di ammassamento) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : Longitudine: N E b. Frequenza radio: (2) [CANALE 5]; 17
18 3 Punto del Cancello 2, (Strada per Gropelo Cairoli) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 4 Punto del Cancello 3, (Strada da Zinasco Nuovo ) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 5 Punto del Cancello 4, (Strada da/per Scaldasole e Pieve Albignola) a. Altitudine s.l.m. : 89 m. UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 6 Punto del Cancello 5, (Strada da/per Alagna) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 7 Campo sportivo e tensostruttura, (Punto di emergenza ricovero popolazione) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. Via A. De Gasperi 31 UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 18
19 8 Palestra Scuola Primaria, (Punto di emergenza ricovero popolazione) a. Altitudine s.l.m. : 90 m. Piazza Curti 1 Viale Papa Giovanni XXIII 1 UTM Latitudine : N Longitudine: E b. Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 9 Palestra Secondaria di Primo Grado, (Punto di emergenza ricovero popolazione) a Altitudine s.l.m. : 90 m. via Strada Nuova 1 UTM Latitudine : N Longitudine: E b Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 10 Campo Motocross, (Punto di emergenza ricovero popolazione) a Altitudine s.l.m. : 90 m. Strada da/per Gropello Cairoli UTM Latitudine : N Longitudine: E b Frequenza radio: (2)[CANALE 5]; 11 Area Ammassamento Soccorritori, con eventuale eliporto annesso e area ricovero popolazione con tendopoli permanente ( Via Conte Cesare Bonacossa vicinanza deposito Stav ) a Altitudine s.l.m. : 90 m. UTM Latitudine : N Longitudine: E b Frequenza radio: (1) CB 40 Ad uso personale Frequenza radio: (2) [CANALE 5]; 19
20 Piani di emergenza: i ruoli istituzionali La Pianificazione attiene all ambito dell emergenza e si riferisce a quel complesso di procedure operative di intervento da realizzarsi nel caso si verifichi l evento atteso previsto in un apposito scenario. E indispensabile che la pianificazione sia collegata alla programmazione di previsione e prevenzione predisposta. Il compito di elaborare i Piani spetta: 0 a livello nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile; Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4 8, Legge 225/92); 0 a livello provinciale, al Prefetto che ne cura l attuazione (art. 14, Legge 225/92); 0 a livello regionale, l art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998 prevede che la Regione predisponga programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali; 0 a livello comunale, il Sindaco, che è autorità comunale di Protezione Civile, durante la fase di emergenza è preposto al coordinamento ed alla direzione delle attività di Protezione Civile. L invio di messaggi o comunicazioni è definito nelle procedure operative previste dalla legge Regionale e riportata nel piano di emergenza comunale di protezione civile. (ve di LR. vigente ) 20
21 Piano di Emergenza Comunale Punto 10 Campo Motocross Strada Provinciale per Gropello Cairoli é individuato nella Tav. 8 pag
22 Cascine Latitudine Longitudine Abitanti Adulti Abitanti Bambini Cascina Nuova ' 14.38" N ' 56.58" E * * Cascina S.nta Giuliana ' 10.68" N ' 7.14" E * * Cascina Chiozzino ' 3.82" N ' 28.31" E * * Cascina Castagnaro ' 28.09" N ' 21.25" E * * Cascina Pavesa ' 39.42" N ' 49.21" E * * Casina Santa Maria ' 28.87" N ' 44.89" E * * Cascina Cascinetta ' 13.23" N ' 42.26" E * * Cascina Rosa ' 9.20" N ' 22.95" E * * Cascina Moglia ' 34.26" N ' 8.68" E * * Cascina Boschetto ' 29.29" N ' 9.23" E * * Cascina Angeli ' 30.43" N ' 59.25" E * * Cascina Grande ' 8.86" N ' 36.84" E * * Cascina Menocca ' 39.49" N ' 18.71" E * * Cascina Tacconetta ' 32.52" N ' 11.63" E * * Cascina Taccona ' 36.66" N ' 13.02" E * * Cascina Lovese ' 2.55" N ' 10.95" E * * Cascina Remondolino ' 58.30" N ' 45.15" E * * Cascina Remondò ' 45.00" N ' 46.69" E * * Cascina Batterra ' 59.50" N ' 16.09" E * * Az. Agr. Agridorno ' 5.06" N ' 25.99" E * * 22
23 2.2 - Allegati cartografici CARTA DI INQUADRAMENTO Tavola 1 Inquadramento Territoriale INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI DORNO Provincia PAVIA CAP Superficie territoriale ETTARI Latitudine 45 9'24"84 N Longitudine 08 57'13"68 E Altitudine min 70 - max 94 m.s.l.m. Il Comune di Dorno è ubicato sulla riva sinistra del torrente Terdoppio e confina a Nord con il Comune di Garlasco e Gropello Cairoli, a Sud con il Comune di Pieve Albignola e Scaldasole, ad Ovest con il Comune di Valeggio ed Alagna ad Est con il Comune di Zinasco Nuovo. 23
24 2.3 Individuazione rischi del territorio comunale Rischio IDROGEOLOGICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: eventi atmosferici avversi, alluvione, frane, dighe ed invasi, valanghe Rischio INCENDIO BOSCHIVO Rischio INDUSTRIALE in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: chimico, nucleare, industriale, ambientale e igienico sanitario Rischio SISMICO Rischio VIABILISTICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: trasporti pericolosi e maxi-emergenze (incidenti, ingorghi, ) sulla rete viaria 24
25 Capitolo 3 Rischio Idrogeologico. 3.1 Descrizione del rischio Tavola 2 - Punti di Rischio esondazione Torrente Terdoppio Il Torrente Terdoppio è il principale corso d acqua perenne che interessa il territorio comunale di Dorno. È disposto con direzione NO-SE e incide il Piano Generale Terrazzato - P.G.T. Tutta la rimanente rete idrografica è costituita da una serie di canali artificiali, con funzione anche di colatori, per lo più sotto il controllo e la gestione del Consorzio Irriguo Est-Sesia, che si diramano da nord verso sud portando acqua per le colture a riso e mais della pianura e che trovano un naturale recapito nei fiumi principali della Pianura Padana. I canali principali sono la Roggia Batterra, la Roggia Crivella, il Cavo Marangone, il Cavone e il Cavo Dassi. Lo scorrimento e le portate di questi canali sono regolate dai rilasci consortili e dai vari moduli di prelievo stagionali che vengono effettuati dalla fitta rete di canalizzazione che si presenta leggermente incassata a partire dal piano campagna attuale. Il torrente Terdoppio è un corso d acqua classificato pubblico, inserito come reticolo idrico minore (D.Lgs. 7/7868 del e DGR 7/13950), riportato nel B.U.R.L. con fasce di rispetto del Suppl. Straordinario n 42 e vincolato ai sensi del D.Lgs n. 490 ex Legge 431/85: rispetto ambientale per una fascia di 150 m dalle sponde, divieto di edificabilità assoluta per una fascia di 10 m dalle sponde (R.D. 523/1904). 25
26 Lungo il corso del torrente Terdoppio sono state individuate fasce potenzialmente inondabili, per cui insistono rischi di fattibilità geologica. Il territorio di Dorno è inoltre interessato, per una minima parte nell area Nord e Sud del Comune Area di inondazione per piena catastrofica, come riportati con Punto 1 e Punto 2 dell elaborato grafico denominato Carta Idrogeologica e del sistema idrografico. Tale fascia è rappresentata dalle aree allagabili per una piena con tempo di ritorno T = 500 anni. PUNTO 1 : CHALET BOSCHETTO Residenti n. (*) UTM Latitudine : ,12 ' N Longitudine: ,99 E PUNTO 2 : CHALET TERDOPPIO Residenti n. (*) n. (*) Attività Commerciale UTM Latitudine : ,49 ' N Longitudine: ,03 E Tavola 3 - Punti di Rischio allagamento Centro Abitato 26
27 Come si evince dalla Tavola n. 3 sono stati individuati i punti in cui si potrebbero verificare allagamenti della rete viabile e delle abitazioni adiacenti solo in caso di eccezionali eventi atmosferici. Punto 1 - Via C.C.Bonacossa incrocio Via Lazzaretto Punto 2 Via V.Veneto incrocio Via dei Dossi Punto 3 Via Mons.Passerini incrocio Via Zinasco e Via C.F.Gabba RISCHIO PER EVENTI METEOROLOGICI E CLIMATICI ECCEZIONALI L Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Lombardia, mediante il Servizio Meteorologico Regionale, svolge la duplice funzione di monitoraggio meteorologico e di previsione meteorologica per la Regione Lombardia. È inoltre parte del Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile. Il Servizio è strutturato in due sedi: quella centrale di Milano (Centro Meteorologico) e quella di Bormio (Centro Nivometeorologico). Il Servizio Meteorologico Regionale svolge quotidianamente attività di previsione meteorologica su breve e medio termine, che viene divulgata al pubblico tramite il bollettino MeteoLombardia (disponibile via web, mail, fax e numero verde, televideo regionale, stampa, radio e TV). Il Servizio Meteorologico fornisce inoltre consulenza e supporto tecnico ai processi decisionali ed alle attività di utenti istituzionali regionali: in particolare, produce e comunica alla Protezione Civile le previsioni di eventi meteorologici di particolare intensità rispetto al rischio idrogeologico, sulla base delle quali viene valutata l opportunità di allertare le province del territorio regionale. La comunicazione sulla probabilità di eventi meteorologici intensi viene diffusa quotidianamente alla Protezione Civile ed alle Prefetture attraverso prodotti di previsione specifici. Il Servizio si occupa anche delle attività inerenti il monitoraggio delle grandezze meteorologiche sul territorio regionale e della loro diffusione all utenza. La graduale messa a punto e l integrazione con altre reti di rilevamento presenti in Lombardia, ha portato alla gestione di un numero complessivo di postazioni automatiche superiore a 250. Le misure sono organizzate in un unico database disponibile attraverso un servizio di accesso diretto ai dati via web. Il Servizio utilizza per le attività di analisi e previsione diversi sistemi di remote sensing: satelliti meteorologici (Meteosat7 e MSG1), radar meteorologico (MeteoSvizzera) e sistema di rilevamento fulmini (SIRF-CESI). Tali strumenti integrano le informazioni puntuali delle stazioni meteorologiche e permettono un efficace attività di sorveglianza e nowcasting in caso di eventi critici. Il rischio eventi meteorologici eccezionali è costituito dalla possibilità che, su un determinato territorio, si verifichino fenomeni naturali (definibili per la loro intensità eventi calamitosi) quali trombe d'aria, grandinate, intense precipitazioni, nevicate particolarmente abbondanti, raffiche di vento eccezionali in grado di provocare danni alle persone, alle cose ed all'ambiente con riguardo a: a) Trombe d'aria o raffiche di vento eccezionali. b) Grandine. c) Nebbia. d) Precipitazioni particolarmente intense e raffiche di venti eccezionali. e) Precipitazioni nevose. Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare danni ingenti ed a volte coprire estensioni notevoli di territorio. Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni temporaleschi molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno arrecato danni ad abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone. In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti, anche se spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare. Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazioni temporalesche, a titolo preventivo, sono 27
28 allertate le squadre preposte al soccorso e i mezzi interessati all'intervento. Piogge Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa possono determinare il seguente scenario: - avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi d acqua, con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto. Nevicate Il rischio neve provocato da precipitazioni nevose (o più difficilmente grandine) abbondanti ed improvvise può determinare l instaurarsi del seguente scenario: problemi di mobilità (veicolare e pedonale) causati dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve; interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve; isolamento temporaneo di località; cedimento delle coperture di edifici e capannoni. La climatologia ci indica che la pianura lombarda riceve in media dai 20 ai 50 cm di neve l anno, raramente nei mesi di ottobre e aprile (a titolo di curiosità si può citare la nevicata del 17 aprile 1991) e molto raramente in maggio. Gelate Gelate precoci o tardive rispetto alla stagione in corso con manifestazioni rilevanti possono provocare: danni alle coltivazioni; problemi alla viabilità (veicolare e pedonale). Ondate di calore Prolungate condizioni di caldo con elevati valori di umidità e assenza di ventilazione possono causare malori e creare un elevato disagio nella popolazione. Temporali Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni, sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, possono determinare il seguente scenario: locali allagamenti ad opera di fossi e sistemi fognari, con coinvolgimento di locali interrati e sottopassi stradali; problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di vento; danni alle coltivazioni causati da grandine; incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini. Venti Venti molto forti possono provocare: danni alle strutture provvisorie; disagi alla circolazione, in particolare degli autocarri; possibili crolli di padiglioni; possibile caduta rami, lampioni e cartellonistica stradale; problemi per la sicurezza dei voli. Nebbie Condizioni di scarsa visibilità per nebbie diffuse e persistenti possono instaurare il seguente scenario: problemi alla viabilità stradale; 28
29 3.2 Schede attività a rischio Scheda di rilevamento elementi vulnerabili Rischio Idrogeologico e Meteoclimatico Identificativo Punto 1 Tav. 3 Denominazione Via C.C.Bonacossa/Via Lazzartetto Residenti nuclei familiari (*) adulti (*) bambini (*) anziani (*) Non Autosufficienti (*) Attività Commerciale (*) Identificativo Punto 2 Tav. 3 Denominazione Via V.Veneto/Via dei Dossi Residenti nuclei familiari (*) adulti (*) bambini (*) anziani (*) Non Autosufficienti (*) Identificativo Punto 3 Tav. 3 Denominazione Via Mons.Passerini/Via Zinasco/Via C.F.Gabba Residenti nuclei familiari (*) adulti (*) bambini (*) anziani (*) Non Autosufficienti (*) Attività Commerciale (*) Dati complessivi attività a rischio Popolazione (*) Nuclei Famigliari (*) Attività Commerciale (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 29
30 3.3 Schema procedure operative Popolazione autosufficiente esposta al rischio Evento A n. (*) Evento B n. (*) Popolazione non autosufficiente esposta al rischio Evento A n. (*) Evento B n. (*) Attività Commerciale Evento A n. (*) Evento B n. (*) FASE Figura operativa Azioni Ricordare ai cittadini di tenersi aggiornati sui bollettini meteo locali Evento A Allagamento strade a seguito di evento atmosferico eccezzionale nelle zone indicate nella Tav. 3 Punti 1, 2 e 3 Evento B Esondazione del torrente Terdoppio nelle zone indicate nella Tav. 2 Punto 1 e Tav. 2 Punto 2 Sindaco: Comandante Polizia Locale: Respons. Ufficio Tecnico C.le: Addetti ai servizi manutentivi C.li: Responsabile Gruppo C.le di P.C.: Evento A: Chiusura al transito delle strade interessate all'evento e attivazione del Gruppo di Protezione Civile Comunale e dei VV.FF. Evento B: Evacuazione delle eventuali persone che risiedono e si trovano all'interno dell'attività commerciale denominata "Hamburgheria Peter's", nelle zone interessate Comando VV.FF. Carabinieri di Garlasco Referente di Area Provinciale P.C. Responsabile Provincile P.C. Prefetto N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 30
31 3.4 - Allegati cartografici Dettaglio TAV. 2 Punto 1 Chalet Boschetto 31
32 Dettaglio TAV. 2 Punto 2 Chalet Terdoppio 32
33 Dettaglio TAV. 3 Punto 1 Via C.C.Bonacossa incrocio Via Lazzaretto 33
34 Dettaglio TAV. 3 Punto 2 Via V.Veneto/Via dei Dossi 34
35 Dettaglio TAV. 3 Punto 3 Via Mons.Passerini/Via Zinasco/Via Gabba 35
36 Capitolo 4. Rischio Incendio Boschivo 4.1 Descrizione del rischio Il fenomeno degli incendi boschivi ha assunto negli ultimi anni la connotazione di un serio problema sociale, che richiede sempre maggiore impegno da parte degli Enti Locali, per assicurare la massima attenzione al problema al fine di avviare tutte le attività e le iniziative necessarie per prevenire e affrontare l emergenza in maniera risolutiva. Il periodo critico, per lo svilupparsi di incendi nelle aree in esame, è durante la stagione estiva, quando si verificano alte temperature e prolungati periodi senza precipitazioni, con conseguente rinsecchimento della vegetazione. Le interviste svolte presso i tecnici comunali intervistati hanno evidenziato la quasi totale assenza del fenomeno su tutto il territorio. Qualche evento, sempre circoscritto, in passato, si e verificato nelle zone coltivate in presenza di sterpaglie di cui si stava procedendo all eliminazione tramite combustione, sfuggita al controllo, ma comunque senza mai costituire un rischio concreto. Vista la scarsa rilevanza del problema a livello locale, si illustreranno linee di prevenzione generiche, applicabili a tutto il territorio nazionale. A livello nazionale, gli incendi boschivi costituiscono un problema di rilevante e periodica ricorrenza. Vaste aree della penisola italiana sono sistematicamente percorse e snaturalizzate dagli incendi boschivi. In questa prospettiva occorre riflettere su un sistema sempre piu integrato e coordinato di controllo degli incendi, al fine di sottrarlo a possibili anomale strategie, i cui effetti negativi ricadono sul patrimonio ambientale in generale ma anche sul dissesto territoriale e sulle calamita idrogeologiche in particolare. Le linee di prevenzione del rischio possono essere cosi sintetizzate: Prevenzione indiretta - Mediante informazione e sensibilizzazione Prevenzione diretta mediante una accurata predisposizione di quanto concerne: - Manutenzione - Avvistamento - Rete di segnalazione - Rifornimento idrico - Viali tagliafuoco Prevenzione organizzativa tramite: - Redazione degli scenari di evento probabili. - Predisposizione degli appositi piani di emergenza. - Diffusione dei criteri di comportamento in caso di emergenza alla popolazione. - Installazione di adeguati dispositivi di allarme sonoro, diffuso sul territorio a rischio. Sotto l'aspetto legislativo la lotta agli incendi boschivi si articola su: misure di prevenzione, lotta attiva, repressione degli illeciti, ricostituzione del manto vegetale. Di particolare importanza e la prescrizione formulata circa l'impossibilita di edificare a qualunque titolo sui terreni boscati percorsi dal fuoco. Tali zone "non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio", e cio al fine di evitare che I'incendio possa essere strumento per speculazioni connesse all'edilizia. Si rammenta che le normative piu recenti, e precisamente il D.Lgs. 220/2000 che ha introdotto il reato specifico di incendio boschivo, hanno aggravato le responsabilità e le pene relative all ipotesi di provocazione di incendi boschivi e che da cio devono derivare adeguate estensioni delle attività di vigilanza. Nelle tabelle che seguono si riportano i dati più significativi relativi ad incendi che si sono verificati nelle province della regione Lombardia nell anno 2010 e nel Triennio Le informazioni contenute nelle tabelle provengono dal Servizio Statistica del Servizio Antincendio del Corpo Forestale dello Stato. 36
37 INCENDI CHE SI SONO VERIFICATI NELLE PROVINCE DELLA REGIONE LOMBARDIA NELL ANNO 2010 (Fonte: Corpo Forestale dello Stato) 37
38 38
39 Fonte- Corpo Forestale dello Stato - Incendi Boschivi
40 Tavola 4 - Punti di Rischio Incendio Boschivo PUNTO 1 : ZONA SAN MATERNO Residenti (*) UTM , Latitudine : '31.1"N Longitudine: '55.9"E N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 40
41 PUNTO 2 : FASCIA TORRENTE TERDOPPIO Residenti n. (*) persone adulte e n. (*) Attività Commerciale Ubicazione del punto sensibile: Tutto il tratto interessato dal Torrente Terdoppio nel Territorio Comunale Punti di Accesso: Ponte Torrente Terdoppio su S.P. 19 Ponte Torrente Terdoppio su S.P. 206 Voghera-Novara PUNTO 3 : ZONA DOSSI Residenti (*) UTM Latitudine : '42.2"N Longitudine: '48.3"E PUNTO 4 : ZONA COLOMBARONE Residenti (*) UTM Latitudine : '05.0"N Longitudine: '32.4"E 41
42 4.2 Schede attività a rischio Scheda di rilevamento elementi vulnerabili Rischio Idrogeologico e Meteoclimatico esempio con indicazione areale Identificativo Punto1 Tav 4 Denominazione ZONA SAN MATERNO Luogo di culto Chiesa S.Materno (*) Identificativo Punto2 Tav 4 Denominazione FASCIA Torrente TERDOPPIO Residenti nuclei famigliari (*) adulti (*) Attività Commerciale (*) Identificativo Punto3 Tav 4 Denominazione ZONA DOSSI Residenti nuclei famigliari (*) Identificativo Punto4 Tav 4 Denominazione ZONA COLOMBARONE Residenti nuclei famigliari (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy Dati complessivi attività a rischio Popolazione (*) Nuclei Famigliari (*) Allevamenti (n. capi/n. allevam) (*) Attività Commerciale (*) Attività ricreative (*) 42
43 4.3 Schema procedure operative Popolazione autosufficiente esposta al rischio N. (*) Popolazione non autosufficiente esposta al rischio N. (*) Attività Agricole N. (*) Attività Commerciale N. (*) fase Figura operativa Azioni Principio di incendio boschivo Sindaco: Comandante Polizia Locale: Chiusura al transito delle strade che consentono l'accesso alla zona interessata dall'incendio e attivazione del Corpo Forestale e/o dei VV.FF. Corpo Forestale Tel Comando VV.FF. Tel. 115 Responsabile Gruppo C.le di P.C.: Carabinieri di Garlasco Referente di Area Provinciale P.C. Responsabile Provincile P.C. Prefetto 43
44 4.4 Allegati cartografici Dettaglio TAV. 4 Punto 1 Zona S.Materno 44
45 Dettaglio TAV. 4 Punto 2 Zona Torrente Terdoppio 45
46 Dettaglio TAV. 4 Punto 3 Zona Dossi 46
47 Dettaglio TAV. 4 Punto 4 Zona Colombarone 47
48 Capitolo 5. Rischio Industriale 5.1 Descrizione del rischio Nel territorio comunale é presente una sola industria a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 334/99 "Ditta OLON S.P.A." con sede legale posta a Rodano (MI) e sede operativa posta a Dorno in Via Scaldasole 33. Tale Industria si trova nella parte posta a sud del territorio C.le e più precisamente nella zona industriale. L'attività svolta nello stabilimento consiste nei processi di lavorazione finalizzati alla produzione, per sintesi chimica, di prodotti intermedi per l'industria farmaceutica. Altre attività complementari prevedono la ricezione di sostanze solide o liquide, imballate a seconda dei casi in sacchi, fusti, fustini, la loro movimentazione e deposito in aree dedicate, l'invio ai reparti di lavorazione ed infine la successiva movimentazione e deposito dei prodotti lavorati. Nello stabilimento sono presenti serbatoi di stoccaggio e magazzini, per il deposito delle materie prime e dei finiti delle produzioni di stabilimento. La descrizione del rischio chimico/industriale si evidenzia nell'allegato 1 Sez. 5 48
49 5.2 Schede attività a rischio Scheda di rilevamento elementi vulnerabili Rischio Industriale Identificativo Punto 1 Tav. 7 Denominazione Az. Agricola Allevamento Suini Allevamento n. capi (*) Residenti (*) Identificativo Punto 2 Tav. 7 Denominazione Ditta SIRIUS S.P.A. Industria n. dipendenti (*) Residenti (*) Identificativo Punto 3 Tav. 7 Denominazione Ditta DISANO S.P.A. Industria n. dipendenti (*) Residenti nuclei familiari (*) Identificativo Punto 4 Tav. 7 Denominazione Ditta KERAPLAN S.R.L. Industria n. dipendenti (*) Residenti nuclei familiari (*) Identificativo Punto 5 Tav. 7 Denominazione Ditta RIPAGRI Attività Artigianale n. dipendenti (*) Residenti nuclei familiari (*) Dati complessivi attività a rischio Popolazione (*) Nuclei Famigliari (*) Allevamenti (n. capi/n. allevam) (*) Attività Industriali 4 Attività ricreative (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 49
50 5.3 Schema procedure operative Incendio localizzato in aria Esplosione non confinata Rilascio di sostanze liquide Figura operativa Vigili del Fuoco. Carabinieri di Garlasco Polizia Locale Soccorso Sanitario 118 Responsabile Gruppo C.le di P.C.: Sindaco Prefettura Azioni Chiusura al traffico della Via Scaldasole in prossimità dello stabilimento ed attenersi alle procedure indicate nell'allegato 1 ditta Olon S.P.A. 50
51 5.4 - Allegati cartografici TAV 5 - Inquadramento Territoriale 51
52 TAV 6 - Ubicazione e Perimetrazione Ditta OLON S.P.A. DITTA OLON S.P.A. Residenti (*) UTM , Latitudine : '25.7"N Longitudine: '86.9"E N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 52
53 TAV 7 - Attività confinanti Ditta OLON S.P.A. 53
54 Capitolo 6 - Rischio sismico 6.1 Descrizione del rischio 54
55 INDICE 1 PREMESSA NORMATIVE DI RIFERIMENTO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEL SUOLO DI RIFERIMENTO DATI DI BASE STRATIGRAFIA DEI TERRENI CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE CARATTERIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA SISMICA CALCOLO DELL AZIONE SISMICA DI PROGETTO CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE CONCLUSIONI
56 ELENCO FIGURE Figura 1 Mappa di pericolosità sismica del territorio italiano (2004) Figura 2 Zonazione sismogenetica del territorio italiano, ZS9 (Gruppo di Lavoro, 2004) Figura 3 Zonazione sismogenetica del territorio italiano, ZS9 (Gruppo di Lavoro, 2004) e sismicità strumentale contenuta nel Bollettino Sismico dell Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (anni ) Figura 4 Curve di attenuazione di Ambrayses et al. (1996) corrette per le distanze: in nero le curve corrette (per 4.0<MS<7.5), in blu a tratteggio le curve non modificate Figura 5 Curve di attenuazione di Ambrayses et al. (1996)(ASB96) in funzione del meccanismo di fagliazione prevalente: a tratteggio la curva di attenuazione media, in rosso la correzione per le faglie inverse (R), in verde per le faglie trascorrenti (SS) (zona ZS908) e in blu per le faglie normali (N) Figura 6 Effetti morfologici scarpata scenario Z3a 57
57 1 PREMESSA Il Comune di Dorno è dotato, dall aprile 2001, di uno studio geologico esteso all intero territorio comunale, allegato al P.R.G. vigente. Nell ambito dell aggiornamento degli studi geologici relativamente alla componente sismica, a seguito dell approvazione del D.M. 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30, ed entrato in vigore il 6 marzo 2008, e della legge 28 febbraio 2008 n. 31 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, è stato eseguito uno studio di caratterizzazione sismica del sottosuolo del Comune di Dorno, con le seguenti finalità: definire la categoria del suolo di fondazione, secondo quanto specificato al punto 3.1 dell allegato Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l adeguamento sismico degli edifici - OPCM n.3274 del 20 marzo 2003 ; si segnala che la più recente zonazione sismica del territorio nazionale inserisce il territorio del Comune di Dorno in Zona 4 ; caratterizzare la pericolosità sismica del sito in oggetto, attraverso l individuazione di un parametro di riferimento (a g = accelerazione orizzontale massima); caratterizzare le aree costituenti il territorio comunale in funzione degli effetti di amplificazione sismica locale, così da redigere una Carta della pericolosità sismica locale, in cui viene riportata la perimetrazione areale e lineare degli scenari di pericolosità sismica locale. Tale studio è stato eseguito secondo il 1 livello di approfondimento, seguendo la procedura descritta nell allegato 5 alla D.G.R.Lombardia n. 8/7374 del 28 maggio 2008 Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell art. 57, primo comma, della legge regionale , n. 12, approvati con D.G.R , n. 8/1566. Qualora si verificasse il caso di previsione di realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n del 21 novembre 2003, tale componente del Piano Regolatore dovrà essere aggiornata con analisi di 2 ed eventualmente 3 livello di approfondimento. 58
58 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO D.M. 14 gennaio 2008 Applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. OPCM n del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. D.G.R.Lombardia n. 8/7374 del 28 maggio 2008 Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell art. 57, primo comma, della legge regionale , n. 12, approvati con D.G.R , n. 8/1566. D.d.u.o. n del 21 novembre 2003 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all art. 2, commi 3 e 4 dell ordinanza p.c.m. n del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n del 7 novembre D.M.5 novembre 2001, n. 6792, Norme funzionali e geometriche per la costruzione del- le strade 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Relazione geologica Comune di Dorno Variante Piano Regolatore Generale ai sensi della delibera della giunta regionale lombarda del 24 novembre 1997 art. 41 Carta della pericolosità sismica locale Comune di Dorno Aggiornamento del Piano Regolatore Generale ai sensi della Deliberazione Giunta Regione Lombardia 28 maggio 2008, n. 8/
59 4 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEL SUOLO DI RIFERIMENTO La categoria del suolo di fondazione è stata definita, secondo quanto specificato al punto 3.1 dell allegato Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l adeguamento sismico degli edifici - OPCM n del 20 marzo 2003, sulla base del valore di V s30 (velocità e- quivalente delle onde di taglio nei primi 30 m del sottosuolo) determinata con prove geofisiche, e dei valori di N SPT ricavati dalle prove eseguite in sondaggi geognostici: tali valori sono ricavati da dati bibliografici e da dati in nostro possesso su altre strutture ricadenti nel territorio comunale. 4.1 DATI DI BASE I dati di base utilizzati riguardano la definizione dell assetto geologico locale e le caratteristiche fisico-meccaniche dei depositi superficiali e del substrato. Tali dati includono: Atti e pubblicazioni reperiti presso la Facoltà di Scienze della Terra - Università di Pavia; Rilievi di superficie, al fine di verificare in dettaglio le caratteristiche litostratigrafiche dei terreni, ricavati da dati bibliografici. 4.2 STRATIGRAFIA DEI TERRENI In termini generali l area del Comune di Dorno è fondata su terreni d origine alluvionale, in particolare sono presenti le seguenti formazioni: Fluviale Wurm, di età pleistocenica, Alluvium Medio e Alluvium Recente, di età Olocenica. Lo schema stratigrafico ricostruito sulla base dei dati reperiti è così sintetizzabile: 1 strato di materiali sabbiosi e ghiaiosi permeabili, con intercalazioni, a profondità di circa m, di livelli argillosi; 2 strato argilloso impermeabile attorno ai m. La soggiacenza media della falda si attesta attorno a 5 7 m da p.c. (1 3 m da p.c. nei terreni di vallata del torrente Terdoppio), con oscillazioni stagionali anche di alcuni metri. 60
60 4.3 CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE Considerando le caratteristiche dei terreni presenti nell area oggetto di studio, si classifica il suolo di fondazione nella categoria B, definita dal Decreto OPCM 3274 come segue: Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V s30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica N SPT >50, o coesione non drenata c u >250 kpa). 61
61 5 CARATTERIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA SISMICA La pericolosità sismica, in senso probabilistico, è la probabilità che un valore prefissato di pericolosità, espresso da un parametro di moto sismico al suolo (ad esempio l accelerazione massima) o da un grado di intensità macrosismica, venga superato in un sito dato (o in un insieme di siti) entro un dato periodo di tempo. Il valore di pericolosità sismica è associato al valore di accelerazione orizzontale massima del terreno a g. Nel 2004 è stata elaborata la nuova mappa di pericolosità sismica del territorio italiano (Figura 1). La mappa definisce localmente i livelli di accelerazione massima su suolo roccioso (suolo di categoria A, V s30 >800 m/s) con una probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 anni, ovvero un periodo di ritorno pari a 475 anni. Questa mappa è stata elaborata basandosi: sulla carta di zonazione sismogenetica del territorio italiano ZS9 (Figura 2); sull uso di relazioni di attenuazione (Ambrayses et al., 1996; Sabetta e Pugliese, 1996) modificate per tenere conto dei meccanismi di fagliazione prevalenti nelle diverse ZS, secondo i fattori correttivi determinati da Bomber et al. (2003); sull approccio probabilistico alla Cornell per ricostruire la storia sismica di un sito; su una struttura ad albero logico che tenga conto delle principali alternative decisionali, quali la relazione di attenuazione adottata, la modalità di valutazione dei periodi di completezza del catalogo, il calcolo dei tassi di sismicità, la magnitudo massima per le diverse ZS. 62
62 Figura 1 Mappa di pericolosità sismica del territorio italiano (2004) Il Comune di Dorno, in questa mappa, è inserito nella zona caratterizzata da un valore di a g compreso tra 0.050g e 0.075g. 63
63 Figura 2 Zonazione sismogenetica del territorio italiano, ZS9 (Gruppo di Lavoro, 2004) Nella Zonazione sismogenetica ZS9 compilata dal Gruppo di Lavoro (2004) il Comune di Dorno non è inserito in alcuna zona. 64
64 Figura 3 Zonazione sismogenetica del territorio italiano, ZS9 (Gruppo di Lavoro, 2004) e sismicità strumentale contenuta nel Bollettino Sismico dell Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (anni ) Dalla consultazione del database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia di danno (DOM4.1; Monashesi e Stucchi, 2000), non risultano registrazioni di alcun evento nella zona di Dorno; le registrazioni nelle località di Pavia, Garlasco, Vigevano, Voghera e Stradella riportano eventi con intensità massima pari a 7.0 (I MCS); sulla base di queste informazioni, considerando l attenuazione del moto sismico con la distanza, la sismicità può quindi essere definita di moderata entità. Una relazione d attenuazione del moto sismico è la relazione di Ambraseys et al. (1996). Tale relazione è stata ottenuta con registrazioni di terremoti di area europea e medioorientale e calcola il massimo valore della PGA (o dell accelerazione spettrale per un periodo T) per le due componenti orizzontali del moto data una distanza ed una magnitudo. A t a- le relazione vengono applicate delle correzioni in funzione del fatto che come distanza viene considerata quella dalla proiezione in superficie della faglia per terremoti con MS 6.0, e la distanza epicentrale per quelli più deboli: la prima è sempre minore o al massimo uguale alla distanza epicentrale, portando quindi ad una sottostima dello scuotimento; viene anche introdotta una correzione dovuta al fatto che, a parità di magnitudo, terremoti generati in ambienti compressivi producono scuotimenti maggiori rispetto a quelli che si osservano in contesti distensivi. 65
65 Figura 4 Curve di attenuazione di Ambrayses et al. (1996) corrette per le distanze: in nero le curve corrette (per 4.0<MS<7.5), in blu a tratteggio le curve non modificate Figura 5 Curve di attenuazione di Ambrayses et al. (1996)(ASB96) in funzione del meccanismo di fagliazione prevalente: a tratteggio la curva di attenuazione media, in rosso la correzione per le faglie inverse (R), in verde per le faglie trascorrenti (SS) e in blu per le faglie normali (N) 66
66 5.1 CALCOLO DELL AZIONE SISMICA DI PROGETTO Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione, definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a g in condizioni di campo libero su sito di riferimento con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente S e (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza P VR nel periodo di riferimento V R. In alternativa è ammesso l uso di accelerogrammi, purchè correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito. Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento P VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: a g accelerazione orizzontale massima al sito; F 0 valore massimo di fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzont ale; T* C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. Per il calcolo dei parametri sopra citati sono stati considerati i seguenti parametri: Classe d uso: classe nella quale sono suddivise le opere, con riferimento alle conseguen- ze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso; Vita nominale dell opera V N : intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata (da questo valore viene calcolato il Periodo di riferimento per l azione sismica V R come: dove C U è il coefficiente d uso); V R =V N *C U Probabilità di superamento nel periodo di riferimento P VR : in funzione dello stato limite di riferimento. Nel caso in oggetto sono considerati i seguenti valori: Classe d uso IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M.5 novembre 2001, n. 6792, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e del tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strada di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 67
67 Vita nominale V N : 100 anni: grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di gran- di dimensioni o di importanza strategica. Coefficiente d uso C U : 2.0, relativo alla classe d uso IV. Periodo di riferimento per l azione sismica: V R =V N *C U = 100*2.0=200 anni. In funzione della probabilità di superamento nel periodo di riferimento P VR vengono calcolati i valori a g, F 0, T* C e del periodo di ritorno T R V R ln 1 P VR Stati limite P VR Periodo di ritorno (anni) a g (g) F 0 T* C (sec) SLE SLO 81% SLD 63% SLU SLV 10% SLC 5% Dove: SLE = stati limite di esercizio SLO = stato limite di operatività: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d uso significativi; SLD = stato limite di danno: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell interruzione d uso di parte delle apparecchiature. SLU = stati limite ultimi SLV = stato limite di salvaguardia della vita: a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte di resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 68
68 SLC = stato limite di prevenzione del collasso: a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli nei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 69
69 6 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Nell ambito dell aggiornamento degli studi geologici relativamente alla componente sismica, è stata realizzata una Carta della pericolosità sismica locale del Comune di Dorno, nella quale sono individuate le aree passibili di amplificazione sismica, sulla base di osservazioni geologiche e di dati esistenti. Gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall insieme delle modifiche di ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. Nella Carta della pericolosità sismica locale, secondo le direttive della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 28 maggio 2008 n. 8/7374, deve essere riportata la perimetrazione areale (e lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree di Pericolosità Sismica Locale - PSL). Nell area Comune di Dorno sono presenti due tipologie di scenari: Z3a: zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.), nell area intorno al torrente Terdoppio, i cui limiti sono posti ad una distanza di 10 m dai terrazzi morfologici; Z4a: zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. La misura dell altezza H è pari alla distanza verticale dal piede al ciglio del fronte principale: per i terrazzi intorno al torrente Terdoppio è stata considerata un altezza H pari a 10 m. 70
70 Figura 6 Effetti morfologici scarpata scenario Z3a Il valore della distanza tra il limite della zona Z3a e il terrazzo morfologico è individuata secondo la metodologia riportata nella seguente tabella: Classe altimetrica Classe di inclinazione Valore di Fa Area di influenza 10 m H 20 m 10 α A i =H 20 m H 40 m 10 α A i =3/4 H 10 α <α H>40 m 40 <α A i =2/3 H 60 <α α >
71 6 CONCLUSIONI I risultati del presente lavoro sono così riassumibili: la categoria di suolo di fondazione da adottare per il calcolo dell azione sismica, in accordo con quanto previsto al punto 3.1 dell OPCM n del 20 marzo 2003, è la categoria B; sono stati determinati i valori di accelerazione orizzontale massima (a g ) attesi per il sito in oggetto, rappresentativi della pericolosità di tale sito; è stato eseguito uno studio di caratterizzazione sismica secondo il 1 livello di approfondimento, in quanto non è prevista la realizzazione di alcuna costruzione nella fascia facente parte dello scenario di pericolosità sismica locale Z3a, ed il resto del territorio comunale è classificato nello scenario Z4a, non suscettibile di amplificazioni topografiche e litologiche. 72
72 6.3 Schema procedure operative fase Figura operativa Azioni Scossa Tellurica di forte entità Sindaco: Comandante Polizia Locale: Respons. Ufficio Tecnico C.le: Addetti ai servizi manutentivi C.li: Responsabile Gruppo C.le di P.C.: Il Sindaco con il Responsabile del Servizio Territorio Comunale ed il Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile compiono una prima valutazione dei danni ed attiva immediatamente i VV.FF. ed il 118. Se l'entità dei danni é tale da non poter essere gestita con i propri mezzi, il Sindaco richiede l'intervento al Prefetto ed al dipartimento di Protezione Civile Comando VV.FF. Carabinieri di Garlasco Referente di Area Provinciale P.C. Responsabile Provincile P.C. Prefetto Dipartimento di Protezione Civile 73
73 Capitolo 7 Rischio viabilistico 7.1 Descrizione del rischio 74
74 Piano di Emergenza Comunale Capitolo 8 - Rischio Generico - EVENTI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE 8.1 Descrizione del Rischio Viene specificato che un Comune interessato da questa tipologia di eventi, potrà attivare il Piano di Protezione Civile, istituire temporaneamente l' U.C.L. e impiegare le Organizzazioni di Volontari per i compiti previsti dal Piano a supporto della gestione dell evento, a condizione che gli eventi stessi rappresentino specifici scenari individuati all interno del P.EC. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre Indirizzi operativi volti ad assicurare l unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all attività di protezione civile ha introdotto, al paragrafo che: La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell ordinaria gestione dell evento, su richiesta dell Amministrazione Comunale. L attivazione del piano comunale di protezione civile e l istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l Amministrazione Comunale può disporre l attivazione delle organizzazioni iscritte nell elenco territoriale ed afferenti al proprio comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l attivazione di altre organizzazioni provenienti dall ambito regionale.. 75
75 Pertanto gli eventi e/o manifestazioni che interessano il territorio Comunale di Dorno e per i quali sarà possibile l'intervento di supporto della Protezione Civile riguardano: Sagre Partronali Fiere Manifestazioni di pubblico spettacolo Eventi di culto Eventi culturali o sociali Eventi Sportivi e comunque tutte le attività che potrebbero attrarre o spostare all'interno del territorio comunale un numero di persone o mezzi tali da non poter essere gestiti con le normali risorse a disposizione del Comune, devono essere considerate come potenziali rischi o emergenze per la popolazione. In questi casi il Sindaco potrà attivare il Gruppo Comunale di Protezione Civile a supporto della Polizia Locale o dei Carabinieri, i quali avranno il compito di gestire i volontari in servizio. 76
76 Capitolo 9 Aree di Emergenza Le Aree di Emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare si suddividono in Aree di Attesa, Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse e Aree di Ricovero della popolazione. 9.1 Classificazione delle Aree di Emergenza Aree di Attesa Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente piazze, slarghi, parcheggi, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull evento e i primi generi di conforto, in attesa dell allestimento delle Aree di Ricovero. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di poche ore. Aree Ricovero Popolazione Le Aree di Ricovero della Popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni adeguate ed essere già dotate di un set minimo di infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, acqua, scarichi fognari, ). Solitamente vengono considerati per queste aree campi sportivi, grandi parcheggi, centri fieristici, palestre, palazzi dello sport, aree demaniali di altro tipo, Le Aree di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda del tipo di emergenza da affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate. Aree Ammassamento Soccorsi Le Aree di Ammassamento Soccorsi garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere le strutture abitative ed i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso. Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente raggiungibili dalla viabilità principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree di ricovero della popolazione. Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni di soccorso. Solitamente le Aree di Ammassamento Soccorsi vengono individuate nella pianificazione di livello provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto all area che andranno a servire. 77
77 9.1 Schede Aree di Emergenza AREA - Punto 11 - Area Ammassamento Soccorritori con eventuale Eliporto annesso e Area Ricovero Popolazione con Tendopoli permanente Ubicazione Coordinate Via C.C.Bonacossa Superficie tot Mq ,00 Superficie Coperta Mq. 0,00 Superficie Scoperta Mq ,00 Destinazione PGT Tipologia Pavimento. Accessi Carrai 1 Vie d'accesso Uso Attuale Delimitazione Area Strutture Accessorie Energia Elettrica Gas Acqua Potabile Fognature Servizi Igienici (n.) Docce Posti letto N E Tessuto Agricolo ZTA Terra da Via C.C.Bonacossa Terreno coltivato a Cereali No N.N. No No No No No No Capacità persone 500 Idoneità Container Illuminazione 300 (ipotizzabili) Si No Nome referenti (*) N. telef. referenti (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 78
78 AREA - Punto 7 - Campo Sportivo e Tensostruttura - Emergenza e ricovero popolazione Ubicazione Via A.De Gasperi n. 31 Coordinate Superficie tot Mq ,00 Superficie Coperta Mq ,00 Superficie Scoperta Mq ,00 Destinazione PGT Tipologia Pavimento. Accessi Carrai Vie d'accesso Uso Attuale Delimitazione Area Strutture Accessorie Energia Elettrica Gas Acqua Potabile Fognature N E Verde Sportivo Esistente Gomma e Prato (Campo Sportivo) 2 da Via A.De Gasperi Via A.De Gasperi Centro Sportivo Comunale Si Spogliatoi Campo Sportivo Si Si Si Si Servizi Igienici (n.) 13 Docce 17 Posti letto Capacità persone 300 Idoneità Container Illuminazione Nome referenti 50 Campo Polivalente Coperto (ipotizzabili) Si Si N. telef. referenti (*) Sindaco del Comune di Dorno N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 79
79 AREA - Punto 8 - Palestra Scuola Primaria - Emergenza e ricovero popolazione Ubicazione Viale Papa Giovanni XXIII n. 1 Coordinate Superficie tot Mq ,00 Superficie Coperta Mq. 480,00 Superficie Scoperta Mq ,00 Destinazione PGT Tipologia Pavimento. Accessi Carrai Vie d'accesso Uso Attuale Delimitazione Area Strutture Accessorie Energia Elettrica Gas Acqua Potabile Fognature Servizi Igienici (n.) 4 Docce 2 Posti letto N E Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo esistenti Gomma 1 (Via R.Cordara) V.le Papa Giovanni XXIII e Via R.Cordara Palestra Si Aule Scolastiche e Locale Mensa Si Si Si Si Capacità persone 30 Idoneità Container Illuminazione Nome referenti 30 (ipotizzabili) No Si N. telef. referenti (*) Sindaco del Comune di Dorno N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 80
80 AREA - Punto 9 - Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado - Emergenza e ricovero popolazione Ubicazione Via Strada Nuova n. 1 Coordinate Superficie tot Mq ,00 Superficie Coperta Mq. 800,00 Superficie Scoperta Mq. 730,00 Destinazione PGT N E Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo esistenti Tipologia Pavimento. Accessi Carrai Vie d'accesso Uso Attuale Delimitazione Area Strutture Accessorie Gomma, Erba Sintetica, Asfalto (cortile) 1 (Via Strada Nuova) Via Strada Nuova Palestra Si Atrio Scuola Media e Campo polivalente esterno Energia Elettrica Si Gas Si Acqua Potabile Si Fognature Si Servizi Igienici (n.) 7 Docce 7 Posti letto 30 in Palestra (Ipotizzabili) Capacità persone 100 Idoneità Container Si Illuminazione Si Nome referenti Sindaco del Comune di Dorno N. telef. referenti (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 81
81 AREA - Punto 10 - Campo Motocross - Emergenza e ricovero popolazione Ubicazione S.P. 19 Km. 3,400 Coordinate Superficie tot Mq ,00 Superficie Coperta Mq. 180,00 Superficie Scoperta Mq , N E Destinazione PGT Zona a Servizi Privati di uso pubblico Tipologia Pavimento. Terra battuta Accessi Carrai 1 (da S.P. 19 Km. 3,400) Vie d'accesso S.P. 19 Km. 3,400 Uso Attuale Delimitazione Area Strutture Accessorie Energia Elettrica Gas Acqua Potabile Fognature Servizi Igienici (n.) 6 Docce 4 Posti letto Zona di stazionamento Camper e mezzi crossisti Si Locale ristoro Crossisti Si No No No Capacità persone 200 Idoneità Container Illuminazione 10 (ipotizzabili) Si Si Nome referenti Sig. (*) N. telef. referenti (*) N.B. (*) Il valore é stato omesso in ottemperanza alla legge sulla privacy 82
82 9.2 - Allegati cartografici TAV. 8 - CARTA DI INQUADRAMENTO AREE DI EMERGENZA 83
83 TAV. 9 - CARTA DETTAGLIO AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI - PUNTO 11 84
84 TAV CARTA DETTAGLIO - EMERGENZA RICOVERO POPOLAZIONE - PUNTO 7 85
85 TAV CARTA DETTAGLIO - EMERGENZA RICOVERO POPOLAZIONE - PUNTO 8 86
86 TAV CARTA DETTAGLIO - EMERGENZA RICOVERO POPOLAZIONE - PUNTO 9 87
87 TAV CARTA DETTAGLIO - EMERGENZA RICOVERO POPOLAZIONE - PUNTO 10 88
SEZIONE 0 INTRODUZIONE
 SEZIONE 0 INTRODUZIONE 0.3 COMPENDIO DI NORME E LEGGI DI PROTEZIONE CIVILE NORMATIVA EUROPEA Risoluzione 2002/C 43/01 Cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile NORMATIVA
SEZIONE 0 INTRODUZIONE 0.3 COMPENDIO DI NORME E LEGGI DI PROTEZIONE CIVILE NORMATIVA EUROPEA Risoluzione 2002/C 43/01 Cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile NORMATIVA
cav. Luigi Fasani 1 La legislazione 1970 Legge 996 Norme sul soccorso e l assistenza alle persone colpite da calamità
 Corso per volontari di protezione civile La legislazione di Protezione Civile Luigi Fasani La legislazione 1970 Legge 996 Norme sul soccorso e l assistenza alle persone colpite da calamità 1992 Legge 225
Corso per volontari di protezione civile La legislazione di Protezione Civile Luigi Fasani La legislazione 1970 Legge 996 Norme sul soccorso e l assistenza alle persone colpite da calamità 1992 Legge 225
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE
 Prop.n. 62002 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province,
Prop.n. 62002 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province,
Piano di Emergenza Comune di Dorno
 INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI DORNO Provincia PAVIA CAP 27020 Superficie territoriale 3.061 ETTARI Latitudine 45 9'24"84 N Longitudine 08 57'13"68 E Altitudine min 70 - max 94 m.s.l.m. Carta di Inquadramento
INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI DORNO Provincia PAVIA CAP 27020 Superficie territoriale 3.061 ETTARI Latitudine 45 9'24"84 N Longitudine 08 57'13"68 E Altitudine min 70 - max 94 m.s.l.m. Carta di Inquadramento
INDICE GENERALE 1 OBIETTIVI DEL PIANO D EMERGENZA COMUNALE COMPOSIZIONE PREMESSA 1-1
 INDICE GENERALE I -TOMO VERDE PIANO DI EMERGENZA 1 OBIETTIVI DEL PIANO D EMERGENZA COMUNALE 1-1 1.1 COMPOSIZIONE 1-1 1.2 PREMESSA 1-1 1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 1-2
INDICE GENERALE I -TOMO VERDE PIANO DI EMERGENZA 1 OBIETTIVI DEL PIANO D EMERGENZA COMUNALE 1-1 1.1 COMPOSIZIONE 1-1 1.2 PREMESSA 1-1 1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 1-2
Il Piano Comunale di Protezione Civile e i rischi sul territorio di Serravalle Scrivia
 Il Piano Comunale di Protezione Civile e i rischi sul territorio di Serravalle Scrivia Organizzazione operativa del sistema di protezione civile LIVELLO NAZIONALE Comitato Operativo Commissione Grandi
Il Piano Comunale di Protezione Civile e i rischi sul territorio di Serravalle Scrivia Organizzazione operativa del sistema di protezione civile LIVELLO NAZIONALE Comitato Operativo Commissione Grandi
il Piano di Emergenza del Comune di OPI Parte 3 - Il Rischio Idrogeologico
 il Piano di Emergenza del Comune di OPI rte 3 - Il Rischio Idrogeologico Opi Marzo 2018 Rischio Idrogeologico e Idraulico Sistema di lertamento Si attiva a seguito di comunicazioni del Centro Funzionale
il Piano di Emergenza del Comune di OPI rte 3 - Il Rischio Idrogeologico Opi Marzo 2018 Rischio Idrogeologico e Idraulico Sistema di lertamento Si attiva a seguito di comunicazioni del Centro Funzionale
PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art.
 PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 (Finalità ed Ambito di applicazione) 1. Il presente
PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 (Finalità ed Ambito di applicazione) 1. Il presente
CORSO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RELATORE STEFANO SIMEONE VICEPREFETTO
 CORSO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RELATORE STEFANO SIMEONE VICEPREFETTO Complessa organizzazione che opera per la prevenzione e previsione di calamità, sulla base di conoscenze e studi di organismi scientifici,
CORSO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RELATORE STEFANO SIMEONE VICEPREFETTO Complessa organizzazione che opera per la prevenzione e previsione di calamità, sulla base di conoscenze e studi di organismi scientifici,
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO - A PRESENTAZIONE PIANO QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONE, OBIETTIVI
 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO - A PRESENTAZIONE PIANO QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONE, OBIETTIVI AGORDO, Lì DICEMBRE 2008 1 INDICE PRESENTAZIONE DEL PIANO, QUADRO NORMATIVO, DEFINIZIONI, OBIETTIVI
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO - A PRESENTAZIONE PIANO QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONE, OBIETTIVI AGORDO, Lì DICEMBRE 2008 1 INDICE PRESENTAZIONE DEL PIANO, QUADRO NORMATIVO, DEFINIZIONI, OBIETTIVI
CORSO FUNZIONI APRILE 2017 USIAMO UN METODO PER ORGANIZZARE LA PROTEZIONE CIVILE
 CORSO FUNZIONI 2017 21 APRILE 2017 USIAMO UN METODO PER ORGANIZZARE LA PROTEZIONE CIVILE L ORGANIZZAZIONE CHI FA E CHE COSA FA Nessuno è escluso dal sistema, tutti siamo attori dell Intervento e della
CORSO FUNZIONI 2017 21 APRILE 2017 USIAMO UN METODO PER ORGANIZZARE LA PROTEZIONE CIVILE L ORGANIZZAZIONE CHI FA E CHE COSA FA Nessuno è escluso dal sistema, tutti siamo attori dell Intervento e della
Stipula convenzioni con imprese locali per il pronto intervento in emergenza
 6.3 Evento incendio boschivo e d interfaccia: procedure operative standard SA0 - PREALLERTA Evento incendio d interfaccia Nel periodo di campagna A.I.B. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi
6.3 Evento incendio boschivo e d interfaccia: procedure operative standard SA0 - PREALLERTA Evento incendio d interfaccia Nel periodo di campagna A.I.B. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi
PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
 Aggiornato al: Glossario pag G.1 ALLEGATO F GLOSSARIO Allerta Aree di emergenza Attivazioni in emergenza Attività addestrativa Calamità Cancello Stato di attività del sistema di protezione civile dovuto
Aggiornato al: Glossario pag G.1 ALLEGATO F GLOSSARIO Allerta Aree di emergenza Attivazioni in emergenza Attività addestrativa Calamità Cancello Stato di attività del sistema di protezione civile dovuto
CROCE ROSSA ITALIANA Attività Emergenza Area 3
 CROCE ROSSA ITALIANA Attività Emergenza Area 3 CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA LEZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Istruttore C.R.I. Attività Emergenza e Protezione Civile
CROCE ROSSA ITALIANA Attività Emergenza Area 3 CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA LEZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Istruttore C.R.I. Attività Emergenza e Protezione Civile
Obiettivi della Lezione: 07/11/ Definire gli attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile e la relativa normativa.
 NORMATIVA e PIANIFICAZIONE in Protezione Civile - Formazione per Operatore di Protezione Civile - PERCORSO UNIFICATO Obiettivi della Lezione: - Definire gli attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile
NORMATIVA e PIANIFICAZIONE in Protezione Civile - Formazione per Operatore di Protezione Civile - PERCORSO UNIFICATO Obiettivi della Lezione: - Definire gli attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile
INDICE INDICE... 2 GENERALITÀ... 5
 INDICE INDICE... 2 GENERALITÀ... 5 LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE E DELLE AZIONI DI PIANO... 5 Indice revisioni... 5 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE... 6 1.1 COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE...
INDICE INDICE... 2 GENERALITÀ... 5 LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE E DELLE AZIONI DI PIANO... 5 Indice revisioni... 5 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE... 6 1.1 COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE...
Il Piano Comunale di Emergenza Comune di Genova
 Il Piano Comunale di Emergenza Comune di Genova Dott.ssa Francesca Bellenzier Dirigente Settore Protezione Civile Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa Compiti
Il Piano Comunale di Emergenza Comune di Genova Dott.ssa Francesca Bellenzier Dirigente Settore Protezione Civile Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa Compiti
LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA
 zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
zona E LIVELLI ALLERTA IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E NIVOLOGICA TEMPORALI VERDE Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. GIALLA Occasionale pericolo: fenomeni puntuali
Il Sistema di Protezione Civile del Comune di Genova. Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa
 Il Sistema di Protezione Civile del Comune di Genova Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa Compiti del Sindaco in materia di Protezione Civile Al verificarsi
Il Sistema di Protezione Civile del Comune di Genova Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa Compiti del Sindaco in materia di Protezione Civile Al verificarsi
Amministrazione Comunale di Catanzaro Settore Protezione Civile
 Il modello di intervento è costituito dall insieme delle procedure che, le Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile devono avviare al verificarsi del singolo evento calamitoso per l attivazione
Il modello di intervento è costituito dall insieme delle procedure che, le Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile devono avviare al verificarsi del singolo evento calamitoso per l attivazione
ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD DATA 04/10/2012
 135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2012-280 DATA 04/10/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D USO IN OCCASIONE
135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2012-280 DATA 04/10/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D USO IN OCCASIONE
CHI E LA PROTEZIONE CIVILE? TUTTI SIAMO LA PROTEZIONE CIVILE!!!
 CHI E LA PROTEZIONE CIVILE? TUTTI SIAMO LA PROTEZIONE CIVILE!!! Gestione di un SISTEMA COMPLESSO Strutture Amministrative Componenti di P.C.: Dipartimento Nazionale P.C. Regioni Province/Città Metropolitana
CHI E LA PROTEZIONE CIVILE? TUTTI SIAMO LA PROTEZIONE CIVILE!!! Gestione di un SISTEMA COMPLESSO Strutture Amministrative Componenti di P.C.: Dipartimento Nazionale P.C. Regioni Province/Città Metropolitana
Piani di Protezione Civile
 UNIVERSITÀ DELL INSUBRIA Anno accademico 2013-2014 Rischio Sismico, Rischio Vulcanico e Piani di Protezione Civile ISLA Piani di Protezione Civile I Piani di Protezione Civile Elementi essenziali Organizzazione
UNIVERSITÀ DELL INSUBRIA Anno accademico 2013-2014 Rischio Sismico, Rischio Vulcanico e Piani di Protezione Civile ISLA Piani di Protezione Civile I Piani di Protezione Civile Elementi essenziali Organizzazione
I Piani di Protezione Civile. Campi scuola
 I Piani di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Organizzazione operativa del sistema di protezione civile LIVELLO NAZIONALE Comitato Operativo Commissione Grandi Rischi Sala
I Piani di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Organizzazione operativa del sistema di protezione civile LIVELLO NAZIONALE Comitato Operativo Commissione Grandi Rischi Sala
La Sala operativa regionale
 La Sala operativa regionale 1 Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Ministero dell Interno Prefetto Sindaco Presidenza del del Consiglio Dipartimento della della Prot. Prot. Civile Civile Vigili Vigili
La Sala operativa regionale 1 Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Ministero dell Interno Prefetto Sindaco Presidenza del del Consiglio Dipartimento della della Prot. Prot. Civile Civile Vigili Vigili
CAPITOLO 14: ELENCO DEI DOCUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
 Piano Generale_CAP.14 RV. 26/7/7 CAPITOLO 14: ELENCO DEI DOCUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE Ing. Stefano Allegri Sindaco N. del Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM Redazione
Piano Generale_CAP.14 RV. 26/7/7 CAPITOLO 14: ELENCO DEI DOCUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE Ing. Stefano Allegri Sindaco N. del Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM Redazione
Corso base per volontari di protezione civile La legislazione A.N.C.
 Corso base per volontari di protezione civile La legislazione A.N.C. Cav. Luigi Fasani Commissione Tecnica Valutazione - Scuola Superiore Protezione Civile E tu cosa ne sai? Sei domande chiave Nel Comune
Corso base per volontari di protezione civile La legislazione A.N.C. Cav. Luigi Fasani Commissione Tecnica Valutazione - Scuola Superiore Protezione Civile E tu cosa ne sai? Sei domande chiave Nel Comune
Il ruolo del comune nell ambito del sistema di Protezione Civile:
 Il ruolo del comune nell ambito del sistema di Protezione Civile: 29 Novembre 2017 Arch. Alessia Giovanelli Comune di Moglia (MN) 1 Fasi principali che coinvolgono il sistema di Protezione Civile 1. previsione
Il ruolo del comune nell ambito del sistema di Protezione Civile: 29 Novembre 2017 Arch. Alessia Giovanelli Comune di Moglia (MN) 1 Fasi principali che coinvolgono il sistema di Protezione Civile 1. previsione
ALLEGATO A QUADRO DELLE FUNZIONI
 ALLEGATO A QUADRO DELLE FUNZIONI (Elaborate secondo il Metodo Augustus del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nel rispetto delle linee guida della L.R. n 7/2003) N. FUNZIONI SUPPORTO FUNZIONI
ALLEGATO A QUADRO DELLE FUNZIONI (Elaborate secondo il Metodo Augustus del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nel rispetto delle linee guida della L.R. n 7/2003) N. FUNZIONI SUPPORTO FUNZIONI
ALLEGATO 3 Procedure Operative per il Rischio Sismico
 ALLEGATO 3 Procedure Operative per il Rischio Sismico Pag. 1 di 5 Gestione evento Fase di Allarme L evento sismico appartiene alla tipologia di eventi non prevedibili ma di rapido impatto, e per i quali
ALLEGATO 3 Procedure Operative per il Rischio Sismico Pag. 1 di 5 Gestione evento Fase di Allarme L evento sismico appartiene alla tipologia di eventi non prevedibili ma di rapido impatto, e per i quali
INDICE AREA ANALITICA AREA OPERATIVA AREA TECNICA PREMESSA A. ANALISI TERRITORIALE B. SCENARI DI RISCHIO C. METODI DI PREANNUNCIO
 INDICE GENERALE INDICE AREA ANALITICA A. ANALISI TERRITORIALE 1. ANALISI DELLE PERICOLOSITA 2. ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO AREA OPERATIVA B. SCENARI DI RISCHIO C. METODI DI PREANNUNCIO D. UNITÀ DI
INDICE GENERALE INDICE AREA ANALITICA A. ANALISI TERRITORIALE 1. ANALISI DELLE PERICOLOSITA 2. ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO AREA OPERATIVA B. SCENARI DI RISCHIO C. METODI DI PREANNUNCIO D. UNITÀ DI
Allegato 7 Raccolta normativa
 CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BASSA VAL DI CECINA Allegato 7 Raccolta normativa Normativa Nazionale Leggi, ordinanze e direttive nazionali in ambito di protezione civile L. D.Lgs. 24/02/1992
CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BASSA VAL DI CECINA Allegato 7 Raccolta normativa Normativa Nazionale Leggi, ordinanze e direttive nazionali in ambito di protezione civile L. D.Lgs. 24/02/1992
Pianificazione di Protezione Civile e Prevenzione del Rischio Sismico
 Pianificazione di Protezione Civile e Prevenzione del Rischio Sismico FARE I CONTI CON L AMBIENTE Workshop W - Ravenna, 27 settembre 2013 Ing. Marco Pasquini Commissione Ambiente dell Ordine degli Ingegneri
Pianificazione di Protezione Civile e Prevenzione del Rischio Sismico FARE I CONTI CON L AMBIENTE Workshop W - Ravenna, 27 settembre 2013 Ing. Marco Pasquini Commissione Ambiente dell Ordine degli Ingegneri
LA PROTEZIONE CIVILE IN APPENNINO. 16 novembre 2018, Silla di Gaggio Montano. Idraulico e idrogeologico. Eventi meteorologici estremi
 LA PROTEZIONE CIVILE IN APPENNINO 16 novembre 2018, Silla di Gaggio Montano Gli scenari di rischio connessi ad eventi calamitosi di scala regionale e locale I rischi Idraulico e idrogeologico Eventi meteorologici
LA PROTEZIONE CIVILE IN APPENNINO 16 novembre 2018, Silla di Gaggio Montano Gli scenari di rischio connessi ad eventi calamitosi di scala regionale e locale I rischi Idraulico e idrogeologico Eventi meteorologici
Allegato 2: Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio
 Allegato 2: Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio PIANO SOCCORSO RISCHIO SISMICO di Regione Lombardia Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico (DPCM 14
Allegato 2: Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio PIANO SOCCORSO RISCHIO SISMICO di Regione Lombardia Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico (DPCM 14
assume il coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza della popolazione in ambito comunale;
 8.5 ATTIVAZIONI Il Sindaco, o suo delegato, in base alla valutazione delle situazioni di rischio direttamente ravvisate o a seguito di specifica richiesta da parte della Prefettura - U.T.G. o dell Agenzia
8.5 ATTIVAZIONI Il Sindaco, o suo delegato, in base alla valutazione delle situazioni di rischio direttamente ravvisate o a seguito di specifica richiesta da parte della Prefettura - U.T.G. o dell Agenzia
LA NATURA DEI RISCHI ED IL CICLO DEL DISASTRO
 LA NATURA DEI RISCHI ED IL CICLO DEL DISASTRO Arch. Simona Caragliano 1 CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Bergamo, 4 dicembre 2012 P.A. Croce Bianca Città di bergamo - ONLUS Protezione civile:
LA NATURA DEI RISCHI ED IL CICLO DEL DISASTRO Arch. Simona Caragliano 1 CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Bergamo, 4 dicembre 2012 P.A. Croce Bianca Città di bergamo - ONLUS Protezione civile:
TAV. 9c MODELLO D INTERVENTO RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO. VISTO IL SINDACO (Ing. Carmine Famiglietti) VISTO IL TECNICO (Geom.
 TAV. 9c MODELLO D INTERVENTO RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO VISTO IL SINDACO (Ing. Carmine Famiglietti) VISTO IL TECNICO (Geom. Nicola Saracino) RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO EVENTO PREVEDIBILE Fase di Attenzione
TAV. 9c MODELLO D INTERVENTO RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO VISTO IL SINDACO (Ing. Carmine Famiglietti) VISTO IL TECNICO (Geom. Nicola Saracino) RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO EVENTO PREVEDIBILE Fase di Attenzione
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 Comune di SASSO MARCONI Provincia di Bologna PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROCEDURA OPERATIVA 2 ALLUVIONE O ESONDAZIONE DI CORSI D ACQUA Procedura operativa 2 Evento: alluvione o esondazione dei
Comune di SASSO MARCONI Provincia di Bologna PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROCEDURA OPERATIVA 2 ALLUVIONE O ESONDAZIONE DI CORSI D ACQUA Procedura operativa 2 Evento: alluvione o esondazione dei
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ROCCA S. FELICE
 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ROCCA S. FELICE ATTIVAZIONI IMMEDIATE DOPO UN EVENTO SALA OPERATIVA Presso la sede municipale Se questi locali risultassero inagibili la sala operativa sarà allestita
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ROCCA S. FELICE ATTIVAZIONI IMMEDIATE DOPO UN EVENTO SALA OPERATIVA Presso la sede municipale Se questi locali risultassero inagibili la sala operativa sarà allestita
Protezione Civile Piano di Emergenza Comunale
 Comune di Rovello Porro Protezione Civile Piano di Emergenza Comunale RELAZIONE C1 Diagrammi di flusso V i g e r s r l Via Madonna del Noce 34 22070 Grandate (CO) Tel. (031) 564 933 Fax (031) 729 311 44
Comune di Rovello Porro Protezione Civile Piano di Emergenza Comunale RELAZIONE C1 Diagrammi di flusso V i g e r s r l Via Madonna del Noce 34 22070 Grandate (CO) Tel. (031) 564 933 Fax (031) 729 311 44
Il Sistema Nazionale di Protezione Civile. Campi scuola Anch io sono la protezione civile
 Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Che cos è la Protezione Civile? Con il termine protezione civile si intendono le attività messe in campo dallo Stato
Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Che cos è la Protezione Civile? Con il termine protezione civile si intendono le attività messe in campo dallo Stato
Il ruolo della Sala Operativa Regionale di protezione civile nella prevenzione e gestione delle emergenze
 Il ruolo della Sala Operativa Regionale di protezione civile nella prevenzione e gestione delle emergenze Milano, convegno Arge-Alp, 28.9.2018 Massimo Ghilardi Dirigente Struttura Gestione delle Emergenze
Il ruolo della Sala Operativa Regionale di protezione civile nella prevenzione e gestione delle emergenze Milano, convegno Arge-Alp, 28.9.2018 Massimo Ghilardi Dirigente Struttura Gestione delle Emergenze
BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
 BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE COS È IL BOLLETTINO VIGILANZA METEOROLOGICA E un bollettino che dà indicazioni sui previsti sul Piemonte (diviso in 11 aree di allerta) fenomeni
BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE COS È IL BOLLETTINO VIGILANZA METEOROLOGICA E un bollettino che dà indicazioni sui previsti sul Piemonte (diviso in 11 aree di allerta) fenomeni
AGGIORNAMENTO. Le normative. dal 2008 al 2015
 AGGIORNAMENTO Le normative dal 2008 al 2015 Coordinamento dei soccorsi L. 26 febbraio 2011 n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
AGGIORNAMENTO Le normative dal 2008 al 2015 Coordinamento dei soccorsi L. 26 febbraio 2011 n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
Il Sistema Nazionale di Protezione Civile. Campi scuola Anch io sono la protezione civile
 Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Che cos è la Protezione Civile? Con il termine protezione civile si intendono le attività messe in campo dal Servizio
Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Campi scuola Anch io sono la protezione civile Che cos è la Protezione Civile? Con il termine protezione civile si intendono le attività messe in campo dal Servizio
Il servizio di protezione civile
 Le strutture e l organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia ARCH. FRANCESCO STUCCHI Monza 4 Dicembre 2014 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
Le strutture e l organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia ARCH. FRANCESCO STUCCHI Monza 4 Dicembre 2014 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI E FUNZIONI DI SUPPORTO
 ALLEGATO 11 CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI E FUNZIONI DI SUPPORTO La Sala Operativa è organizzata in 15 funzioni di supporto, secondo i principi del metodo Augustus, il quale disciplina la gestione delle
ALLEGATO 11 CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI E FUNZIONI DI SUPPORTO La Sala Operativa è organizzata in 15 funzioni di supporto, secondo i principi del metodo Augustus, il quale disciplina la gestione delle
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n 1. recante Codice della Protezione Civile
 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale
RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale
Pianificazione di Protezione Civile
 Comune di Prato Protezione Civile Pianificazione di Protezione Civile Normativa e Direttive nazionali e regionali - - Sindaco : Assessore alla Protezione Civile : Dirigente Servizio Prevenzione e Sicurezza
Comune di Prato Protezione Civile Pianificazione di Protezione Civile Normativa e Direttive nazionali e regionali - - Sindaco : Assessore alla Protezione Civile : Dirigente Servizio Prevenzione e Sicurezza
LA GESTIONE E LA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA
 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile U.O.D. 10 - Protezione Civile, Emergenza e post emergenza SALA OPERATIVA LA
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile U.O.D. 10 - Protezione Civile, Emergenza e post emergenza SALA OPERATIVA LA
ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD DATA 01/10/2012
 135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2012-275 DATA 01/10/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D USO IN OCCASIONE
135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2012-275 DATA 01/10/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D USO IN OCCASIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
 COMUNE DI ROZZANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 1 Finalita Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, l attivazione e l operatività
COMUNE DI ROZZANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 1 Finalita Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, l attivazione e l operatività
Il sistema regionale di protezione civile. Giovanni Caldiroli U.O. Protezione Civile Regione Lombardia Milano, giugno 2011
 Il sistema regionale di protezione civile Giovanni Caldiroli U.O. Protezione Civile Regione Lombardia Milano, giugno 2011 Sommario L evoluzione del sistema di protezione civile La legge 225/92 Il ruolo
Il sistema regionale di protezione civile Giovanni Caldiroli U.O. Protezione Civile Regione Lombardia Milano, giugno 2011 Sommario L evoluzione del sistema di protezione civile La legge 225/92 Il ruolo
Allegato paragrafo Esondazione dei corsi d acqua (25 pagine) - separatore colore giallo
 Indice Cap.1 ANALISI TERRITORIALE (15 pagine) - separatore colore rosso Cap.2 SCENARI di RISCHIO e VULNERABILITA (27 pagine) - separatore colore viola Allegato paragrafo 2.2.1 Esondazione dei corsi d acqua
Indice Cap.1 ANALISI TERRITORIALE (15 pagine) - separatore colore rosso Cap.2 SCENARI di RISCHIO e VULNERABILITA (27 pagine) - separatore colore viola Allegato paragrafo 2.2.1 Esondazione dei corsi d acqua
COMUNE DI COSSATO Piazza Angiono, Cossato (BI)
 Protezione Civile C.O.M. 2 Cossato L.R. 14/04/2003, n. 7 D.P.G.R. 18/10/2004, nn. 7R e 8R REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina, nel
Protezione Civile C.O.M. 2 Cossato L.R. 14/04/2003, n. 7 D.P.G.R. 18/10/2004, nn. 7R e 8R REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina, nel
Quadro della pianificazione d emergenza a scala provinciale, comunale, intercomunale
 DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Quadro della pianificazione d emergenza a scala provinciale, comunale, intercomunale
DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Quadro della pianificazione d emergenza a scala provinciale, comunale, intercomunale
Effetti delle precipitazioni nevose dell inverno in Piemonte
 Effetti delle precipitazioni nevose dell inverno 2008-2009 in Piemonte Marco Cordola Area Previsione e Monitoraggio Ambientale La stagione invernale 2008-2009 I danni da valanghe Le misure di mitigazione
Effetti delle precipitazioni nevose dell inverno 2008-2009 in Piemonte Marco Cordola Area Previsione e Monitoraggio Ambientale La stagione invernale 2008-2009 I danni da valanghe Le misure di mitigazione
Marco Incocciati e Antonio Colombi Agenzia Regionale di Protezione Civile
 Marco Incocciati e Antonio Colombi Agenzia Regionale di Protezione Civile mincocciati@regione.lazio.it acolombi@regione.lazio.it La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 ha istituito l Agenzia Regionale
Marco Incocciati e Antonio Colombi Agenzia Regionale di Protezione Civile mincocciati@regione.lazio.it acolombi@regione.lazio.it La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 ha istituito l Agenzia Regionale
MODELLO DI INTERVENTO PER BLACK OUT
 MODELLO DI INTERVENTO PER BLACK OUT Procedura di emergenza p0301030 Secondo quanto previsto per questo scenario di rischio dall allegato A della DGR n.3315 del 21/12/2010 sono da considerarsi le interruzioni
MODELLO DI INTERVENTO PER BLACK OUT Procedura di emergenza p0301030 Secondo quanto previsto per questo scenario di rischio dall allegato A della DGR n.3315 del 21/12/2010 sono da considerarsi le interruzioni
DATA EMISSIONE INIZIO VALIDITA FINE VALIDITA DATA INVIO 30/01/2019 ORE /01/2019 ORE 17:00 31/01/2019 ORE 09:00 30/01/2019 ORE 12:45
 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI N.012/2019
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI N.012/2019
COMUNE DI BORGIA -PROVINCIA DI CATANZARO- -PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-
 COMUNE DI BORGIA -PROVINCIA DI CATANZARO- -PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- Progettista: Dott. Ing. PROCOPIO Francesco ELABORATI TECNICI Delibera del Consiglio Comunale n. del TAVOLA N. Il Sindaco
COMUNE DI BORGIA -PROVINCIA DI CATANZARO- -PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- Progettista: Dott. Ing. PROCOPIO Francesco ELABORATI TECNICI Delibera del Consiglio Comunale n. del TAVOLA N. Il Sindaco
Disciplinare Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di competenza regionale
 Disciplinare Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di competenza regionale 17/07/2008 TESTO 1 Indice Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Ambito d intervento
Disciplinare Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di competenza regionale 17/07/2008 TESTO 1 Indice Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Ambito d intervento
PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNITA MONTANA DEL PINEROLESE EX VALLI CHISONE E GERMANASCA PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AGGIORNAMENTO 2011 Allegato 7 LIVELLI E SCENARI DI RISCHIO UTILIZZATI
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNITA MONTANA DEL PINEROLESE EX VALLI CHISONE E GERMANASCA PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AGGIORNAMENTO 2011 Allegato 7 LIVELLI E SCENARI DI RISCHIO UTILIZZATI
AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 68/2018
 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI N. 68/2018
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI N. 68/2018
Instabilità di versante nella città di Roma
 Seminario tecnico Instabilità di versante nella città di Roma Il Piano Generale di Emergenza per la città di Roma Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Parlamentino del Consiglio Superiore dei
Seminario tecnico Instabilità di versante nella città di Roma Il Piano Generale di Emergenza per la città di Roma Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Parlamentino del Consiglio Superiore dei
NORMATIVA e PIANIFICAZIONE. Protezione Civile. - Formazione per Operatore di Protezione Civile -
 NORMATIVA e PIANIFICAZIONE in Protezione Civile - Formazione per Operatore di Protezione Civile - Obiettivi della Lezione: - Definire gli attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile e la relativa
NORMATIVA e PIANIFICAZIONE in Protezione Civile - Formazione per Operatore di Protezione Civile - Obiettivi della Lezione: - Definire gli attori del Sistema Nazionale di Protezione Civile e la relativa
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SOMMARIO...3 1.1 PREMESSA... 3 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI... 4 1.3 ELENCO DESTINATARI DEL PIANO... 6 1.4 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO... 7 1.5 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SOMMARIO...3 1.1 PREMESSA... 3 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI... 4 1.3 ELENCO DESTINATARI DEL PIANO... 6 1.4 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO... 7 1.5 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE
COMUNE DI CAMAIORE Provincia di Lucca. IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE In sintesi
 COMUNE DI CAMAIORE Provincia di Lucca IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE In sintesi RIFERIMENTI NORMATIVI Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato redatto nel rispetto dell attuale normativa
COMUNE DI CAMAIORE Provincia di Lucca IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE In sintesi RIFERIMENTI NORMATIVI Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato redatto nel rispetto dell attuale normativa
COMUNE di PAULLO (MI)
 pag. 1 di 17 COMUNE di PAULLO (MI) 1 DATI ANAGRAFICI... 2 1.1 COMUNI CONFINANTI ( A CURA DEL SOLO COMUNE CAPOFILA)... 2 2 GESTIONE DELLE EMERGENZE... 3 2.1 RISORSE OPERATIVE... 3 2.2 REPERIBILITÀ H24...
pag. 1 di 17 COMUNE di PAULLO (MI) 1 DATI ANAGRAFICI... 2 1.1 COMUNI CONFINANTI ( A CURA DEL SOLO COMUNE CAPOFILA)... 2 2 GESTIONE DELLE EMERGENZE... 3 2.1 RISORSE OPERATIVE... 3 2.2 REPERIBILITÀ H24...
Comune di Cormano Piano di emergenza
 C 8.1 Leggi e normative di riferimento Viene qui riproposta una serie di riferimenti normativi ritenuti fondamentali per il sistema di Protezione Civile italiano; tale raccolta non ha la pretesa di essere
C 8.1 Leggi e normative di riferimento Viene qui riproposta una serie di riferimenti normativi ritenuti fondamentali per il sistema di Protezione Civile italiano; tale raccolta non ha la pretesa di essere
ATTIVAZIONE FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE DELLA S.O.R.U. E DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI AREA METEREOLOGICA
 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza ATTIVAZIONE FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza ATTIVAZIONE FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRIONI
 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRIONI ATTIVAZIONI IMMEDIATE DOPO UN EVENTO SALA OPERATIVA Presso la Casa comunale Se questi locali risultassero inagibili la sala operativa sarà allestita nei
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRIONI ATTIVAZIONI IMMEDIATE DOPO UN EVENTO SALA OPERATIVA Presso la Casa comunale Se questi locali risultassero inagibili la sala operativa sarà allestita nei
AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N.015/2019
 Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N.015/2019
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile STAFF 50 09 95 Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N.015/2019
Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona
 Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona INTRODUZIONE L obiettivo di questo Corso è: fornire nozioni ai Volontari PC che operano durante un intervento emergenziale; rappresentare uno
Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona INTRODUZIONE L obiettivo di questo Corso è: fornire nozioni ai Volontari PC che operano durante un intervento emergenziale; rappresentare uno
Modello di intervento
 Agenzia Protezione Civile Centro Operativo Regionale PIANIFICAZIONE EMERGENZA PER BLOCCHI PROLUNGATI DELLA VIABILITA Emergenza autostradale e superstradale per maxi esodi estivi in caso di blocchi prolungati
Agenzia Protezione Civile Centro Operativo Regionale PIANIFICAZIONE EMERGENZA PER BLOCCHI PROLUNGATI DELLA VIABILITA Emergenza autostradale e superstradale per maxi esodi estivi in caso di blocchi prolungati
PIANO EMERGENZA NEVE
 Comunità montana dell aniene UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PIANO EMERGENZA NEVE 2012-13 Indice: 1. PREMESSA 2. SCOPI DEL PIANO 3. FASI DI INTERVENTO MISURE PREVENTIVE 4. LIMITAZIONI DELLA VIABILITA 5. ATTIVAZIONE
Comunità montana dell aniene UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PIANO EMERGENZA NEVE 2012-13 Indice: 1. PREMESSA 2. SCOPI DEL PIANO 3. FASI DI INTERVENTO MISURE PREVENTIVE 4. LIMITAZIONI DELLA VIABILITA 5. ATTIVAZIONE
Il Piano Comunale di Protezione Civile
 Comune di Orciano di Pesaro Area Tecnica Servizio Protezione Civile Il Piano Comunale di Protezione Civile Approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30.05.2003 Aggiornato con D.C.C. n. 49 del 30.09.2008 A
Comune di Orciano di Pesaro Area Tecnica Servizio Protezione Civile Il Piano Comunale di Protezione Civile Approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30.05.2003 Aggiornato con D.C.C. n. 49 del 30.09.2008 A
10.1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico: procedure operative standard
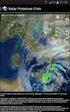 10.1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico: procedure operative standard ATTENZIONE Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali Avviso di criticità idrogeologica e idraulica
10.1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico: procedure operative standard ATTENZIONE Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali Avviso di criticità idrogeologica e idraulica
UNIONE DEI COMUNI DEL VERGANTE. REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (approvato con atto di Consiglio n. 3 del
 DISPOSIZIONI PRELIMINARI UNIONE DEI COMUNI DEL VERGANTE REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (approvato con atto di Consiglio n. 3 del 10.04.2014) Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Belgirate,
DISPOSIZIONI PRELIMINARI UNIONE DEI COMUNI DEL VERGANTE REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (approvato con atto di Consiglio n. 3 del 10.04.2014) Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Belgirate,
Il Servizio Civile Nazionale, che dal 1 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è l opportunità messa a disposizione dei giovani
 Il Servizio Civile Nazionale, che dal 1 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è l opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita
Il Servizio Civile Nazionale, che dal 1 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è l opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita
EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE PER RISCHIO METEO, GEO-IDROLOGICO, IDRAULICO E VALANGHIVO
 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE PER RISCHIO METEO, GEO-IDROLOGICO, IDRAULICO E VALANGHIVO (BUR n. 33 del 16 agosto 2018) Centro Funzionale Piemonte Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi
EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE PER RISCHIO METEO, GEO-IDROLOGICO, IDRAULICO E VALANGHIVO (BUR n. 33 del 16 agosto 2018) Centro Funzionale Piemonte Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi
REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 COMUNE DI TUILI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEG. ALLA DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 22/02/2016) 1 INDICE GENERALE CAPO I: IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE
COMUNE DI TUILI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEG. ALLA DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 22/02/2016) 1 INDICE GENERALE CAPO I: IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE
PROCEDURE OPERATIVE DI FRONTE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO, TEMPORALI FORTI, VENTO FORTE, NEVE
 ALLEGATO 2 PROCEDURE OPERATIVE DI FRONTE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO, TEMPORALI FORTI, VENTO FORTE, NEVE Di seguito si riportano le procedure relative agli Enti interessati dalla gestione dell
ALLEGATO 2 PROCEDURE OPERATIVE DI FRONTE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO, TEMPORALI FORTI, VENTO FORTE, NEVE Di seguito si riportano le procedure relative agli Enti interessati dalla gestione dell
La previsione dei fenomeni e la valutazione delle criticità vengono condotte quotidianamente, di norma per le ore successive, alla scala
 ALLEGATO 2 Documento di regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità tra l Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente
ALLEGATO 2 Documento di regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità tra l Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROCEDURE DI EMERGENZA P0301040_MI_Neve Modello di intervento per rischio neve Il Sindaco On. Dussin Luciano Il tecnico incaricato: dott.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PROCEDURE DI EMERGENZA P0301040_MI_Neve Modello di intervento per rischio neve Il Sindaco On. Dussin Luciano Il tecnico incaricato: dott.
La legislazione in materia di PROTEZIONE CIVILE
 08/11/2018 Corso base volontari di protezione civile BOVISIO MASCIAGO La legislazione in materia di PROTEZIONE CIVILE a cura di Giuditta Galli La PROTEZIONE CIVILE ITALIANA :. una realtà da raccontare.
08/11/2018 Corso base volontari di protezione civile BOVISIO MASCIAGO La legislazione in materia di PROTEZIONE CIVILE a cura di Giuditta Galli La PROTEZIONE CIVILE ITALIANA :. una realtà da raccontare.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Emergenze Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Emergenze Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative Criteri di scelta e simbologia cartografica per l'individuazione
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Emergenze Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative Criteri di scelta e simbologia cartografica per l'individuazione
Ruolo e organizzazione della Protezione Civile Normativa Aspetti organizzativi e operativi
 di ricerca e servizi sui della Protezione Civile Normativa Aspetti organizzativi e operativi Ing. Nicola Salvatore Dirigente responsabile Servizio Protezione Civile Direttore Centro Regionale di Protezione
di ricerca e servizi sui della Protezione Civile Normativa Aspetti organizzativi e operativi Ing. Nicola Salvatore Dirigente responsabile Servizio Protezione Civile Direttore Centro Regionale di Protezione
CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, BORGOMANERO (NO) APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N 67 DEL 28/11/2005.
 CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, 16-28021 BORGOMANERO (NO) REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CORSO CAVOUR, 16-28021 BORGOMANERO (NO) REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Prefettura di Varese Ufficio Territoriale del Governo
 Che cosa è la Protezione Civile La protezione civile è una funzione dai pubblici poteri finalizzata alla salvaguardia tra popolazione e territorio 1 Art. 117 Costituzione La protezione Civile è una materia
Che cosa è la Protezione Civile La protezione civile è una funzione dai pubblici poteri finalizzata alla salvaguardia tra popolazione e territorio 1 Art. 117 Costituzione La protezione Civile è una materia
ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. ORD DATA 12/09/2012
 135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. ORD-2012-258 DATA 12/09/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D
135 4 0 - DIREZIONE CITTA' SICURA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICA INCOLUMITA' E VOLONTARIATO ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. ORD-2012-258 DATA 12/09/2012 OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI D
Tali funzioni sono coordinate dal SINDACO supportato dalla CABINA di REGIA
 C Il Sistema di comando e controllo Centro Operativo Comunale COMUNE di LAVAGNA Per la Comune di Lavagna è stato definito un sistema di comando e controllo considerato più adeguato alle reali disponibilità
C Il Sistema di comando e controllo Centro Operativo Comunale COMUNE di LAVAGNA Per la Comune di Lavagna è stato definito un sistema di comando e controllo considerato più adeguato alle reali disponibilità
SCHEDE DOCUMENTALI NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA STATALE
 SD 0.1 COMPENDIO DI NORME E LEGGI DI PROTEZIONE CIVILE NORMATIVA EUROPEA Risoluzione 2002/C 43/01 Cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile NORMATIVA STATALE Legge 8 dicembre
SD 0.1 COMPENDIO DI NORME E LEGGI DI PROTEZIONE CIVILE NORMATIVA EUROPEA Risoluzione 2002/C 43/01 Cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile NORMATIVA STATALE Legge 8 dicembre
il Piano di Emergenza del Comune di OPI Parte 7 - Il Rischio valanghe
 il Piano di Emergenza del Comune di OPI Parte 7 - Il Rischio valanghe Opi Marzo 2018 Rischio VALANGHE La valanga si verifica quando si ha la rottura della condizione di equilibrio presente nel manto nevoso.
il Piano di Emergenza del Comune di OPI Parte 7 - Il Rischio valanghe Opi Marzo 2018 Rischio VALANGHE La valanga si verifica quando si ha la rottura della condizione di equilibrio presente nel manto nevoso.
COMUNE DI VEROLENGO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 COMUNE DI VEROLENGO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con DCC n. 55 del 28.11.2011 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 OGGETTO DEL
COMUNE DI VEROLENGO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con DCC n. 55 del 28.11.2011 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 OGGETTO DEL
