l carsismo nei ghiacciai
|
|
|
- Erico Maggi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Approfondimenti l carsismo nei ghiacciai Giovanni Badino Contenuto: Descrizione dei fenomeni pseudocarsici da fusione che interessano i ghiacciai e analogie con il carsismo classico. Content: Description of the pseudocarstic phenomena that occur on glacier and analogies with the classical karst. Key-words: ghiacciai, pseudocarsimo, cavita endoglacviali, glaciers, pseudokarst, englacial caves. Year: 2000 Reference: inedito 0
2 IL CARSISMO NEI GHIACCIAI GIOVANNI BADINO Dipartimento di Fisica Generale dell Università di Torino - Associazione Culturale La Venta Riassunto Nel decennio passato le tecniche della speleologia hanno permesso l'esplorazione sistematica delle grotte nei ghiacciai, attraverso le quali avviene il drenaggio dell'acqua endoglaciale. Qui viene fatta una rassegna dei processi fisici che portano alla formazione delle grotte glaciali e una sui ghiacciai visitati. Il carsismo glaciale viene correlato al clima locale sia tramite la valutazione della temperatura media annuale, sia con una tecnica di gradi positivi. Questi studi hanno delineato la forma dei reticoli interni dei ghiacciai e permetteranno la valutazioni di situazioni di rischio connesse con la liberazione improvvisa di depositi d'acqua interni al ghiacciaio. Introduzione Nel decennio passato l'esplorazione speleologica si è avventurata in un campo trascurato, quello dell interno dei ghiacciai. L'evidenza principale, ben nota da secoli, è che sui grandi ghiacciai temperati si formano torrenti, in genere con portate d acqua dell'ordine del metro cubo al secondo che, dopo percorsi di poche centinaia di metri o, raramente, chilometri, si precipitano in rombanti pozzi formatisi nella massa di ghiaccio, i cosiddetti mulini glaciali. I torrenti così spariti riappaiono riuniti in uno solo, alla fronte del ghiacciaio, in genere al contatto fra il letto morenico e il ghiaccio. Sotto i bianchi e regolari pianori c'è evidentemente una struttura interna di drenaggio. Sin dagli inizi della glaciologia ci si interessò dei rumorosi pozzi in cui si precipitavano i torrenti. A quel tempo, siamo alla fine dell'800, non si era ancora formato un distacco fra la speleologia e la glaciologia e dunque quei buchi vennero considerati grotte quanto quelle scavate nel calcare; salvo che le tecniche dell'epoca non ne permettevano l esplorazione e finirono per uscire dall'ambito di interesse degli speleologi. I modellisti glaciali (lo svizzero Röthlisberger e, in modo indipendente, il californiano Shreve) nei primi anni 70 tentarono di modellare quel che poteva accadere all interno. Di massima però le ricerche erano indirizzate alle condizioni di formazione di condotte sul letto roccioso, una situazione di trasporto che è quasi certamente poco interessante se non nelle ultime decine di metri prima di uscire a giorno, là dove il ghiacciaio si fa sottile. In pratica il ghiaccio non era considerato una sostanza carsificabile nel suo insieme, ma solo sull interfaccia rocciosa. Il motivo di questa limitazione è ovvio: all'epoca la verifica sul campo era impossibile e le strutture che si vedevano alla bocca dei ghiacciai erano sempre di interfaccia ghiaccio-roccia. E, d'altra parte le ridotte possibilità di calcolo numerico dell'epoca rendevano difficile l'analisi a calcolatore. Le esplorazioni dirette Alla metà degli anni 80 alcuni gruppi di speleologi, in giro modo indipendente, iniziano ad occuparsi di queste grotte. Quasi subito viene separato il problema tettonico (cavità formate da rotture meccaniche) da quello dissolutivo: i crepacci e le grotte glaciali si escludono a vicenda, perché se un ghiacciaio è intensamente fratturato l'assorbimento d'acqua vi avviene in modo diffuso, senza concentrazioni di energia che consentano all'acqua di scavarvi grotte. I ghiacciai interessati al carsismo sono dunque sub-pianeggianti e temperati. Le esplorazioni dirette, sempre molto complicate, portano a caratterizzare il fenomeno nel suo complesso, almeno nelle parti più epidermiche: le cavità, in genere, si aprono con un pozzo sui metri di profondità, creato dalle acque in caduta in queste parti superficiali del ghiacciaio. Spesso al fondo di esso risulta impossibile avanzare perché il torrente si perde in fessure impraticabili. A volte, invece, il primo salto dà accesso ad una serie di ambienti imponenti, sorta di forre subglaciali lungo le quali il torrente procede a piccoli salti e brevi tratti orizzontali sino a perdersi in una pozza d'acqua da cui viene drenato per vie subacquee. Gli ambienti sono in genere di 1
3 dimensioni decrescenti, le pozze d'acqua conclusive si trovano nella maggior parte dei casi ad un centinaio di metri sotto la superficie, raramente poco oltre. Sono stati così esplorati ghiacciai in tutto il mondo dai vari gruppi: canadesi e polacchi alle Svalbard, svizzeri sulle Alpi, francesi in Groenlandia, spagnoli in Islanda mentre gli italiani hanno realizzato un survey generale con esplorazioni sulle Alpi e poi nel Tien Shan, nel Karakorum, in Islanda, in Antartide e soprattutto in Patagonia, giungendo a caratterizzare la fenomenologia generale del carsismo nei ghiacciai. Caratteristiche del processo di formazione Presso il Dipartimento di Fisica Generale dell'università di Torino è stato sviluppato il modellamento teorico di questi fenomeni, derivandolo dall'approccio analitico della microclimatologia ipogea. Lo studio è stato prima condotto per via analitica e poi, per poter seguire l'evoluzione dei reticoli inserendovi anche le periodicità stagionali, con una serie di modelli numerici sviluppati che ci hanno permesso di chiarire la fenomenologia complessiva del trasporto delle acque interne. Una prima, inusuale, caratteristica importante per la morfologia del reticolo di drenaggio è il comportamento plastico del ghiaccio, che a bassa pressione (<0.1 Mpa) si comporta quasi come una roccia, ad alta pressione (>1 Mpa) quasi come un liquido. Da questo deriva che una cavità (grotta o crepaccio) a pochi metri di profondità ha un durata molto superiore al tempo di evoluzione locale del ghiaccio e dunque nel suo sviluppo la plasticità ha poca importanza: è come se fosse scavata nella roccia, e rimane stabile anche per anni, se il fluire a valle del ghiaccio lo permette. 5 Vita media [Log(giorni)] anni Vita media delle cavità subglaciali vs. profondità 1 anno 1 mese profondità [metri] Una cavità a 50 metri di profondità ha invece una vita media dell ordine di una stagione, e dunque quella è la profondità massima alla quale possono sopravvivere strutture legate a cicli stagionali. A profondità maggiori i tempi di collasso sono più brevi e dunque si tratta di strutture che si formano e durano sinché gli agenti che le scavano sono attivi, per poi collassare e sparire rapidamente all'interno della massa di ghiaccio fluido. Il grafico lo illustra. Le strutture di drenaggio nelle parti più epidermiche, ove la plasticità è trascurabile, sono dunque piuttosto semplici: i ruscelli si formano ed ingrossano nelle zone più depresse del ghiacciaio e poi entrano nel ghiaccio in punti ove il loro flusso concentrato di energia diventa superiore al minimo per perforare la superficie: si forma un punto di assorbimento, un "mulino glaciale". 2
4 Al suo interno l'energia potenziale dell'acqua in caduta viene rilasciata all'aria e nei punti dove essa batte. Trattandosi di un sistema a pressione atmosferica e in condizioni rigorosamente isoterme il sistema si sviluppa in modo proporzionale all'energia rilasciata in caduta dalle cascate. Nelle prime parti, sino ad una cinquantina di metri di profondità, essa non viene contrastata dal collasso plastico e quindi le cavità si ampliano lungo tutta la stagione, in modo proporzionale al flusso d acqua che vi cade. E' solo alla fine della stagione calda che le pareti cominciano a collassare sulla cavità, prevalentemente alle profondità maggiori, dove le sezioni dei pozzi vengono sensibilmente ristrette durante l'inverno. Il grafico illustra l'evoluzione del diametro di un mulino glaciale, alle varie profondità, negli anni, ottenuto tramite calcolo numerico. In questo caso il flusso d'acqua ipotizzato durante la stagione calda è di 50 kg/s anni evoluzione del diametro di un mulino glaciale vs profondità in vari anni successivi raggio [m] anni 1 anno autunno 1 primavera profondità [m] A profondità maggiori la plasticità del ghiaccio prevale ed esso tende a crollare sulla cavità che così viene ad assumere caratteristiche forme sempre più ristrette, a canyon. Questo semplice modello pare giustificare la grande maggioranza delle forme interne dei mulini glaciali. Sin dalle prime esplorazioni, però, ci apparve chiaro che le strutture in cui avanzavamo fra mille difficoltà non potevano essere che un frammento ben piccolo della struttura interna del ghiacciaio. Le grotte avevano sempre un andamento prevalentemente verticale e dunque esse dovevano essere semplici tributarie del sistema di drenaggio principale che doveva essere al di sotto dei piccoli specchi d'acqua in cui si precipitavano i torrenti in fondo alle grotte. In pratica, a differenza di quanto aveva sino ad allora ipotizzato la glaciologia, i torrenti non arrivavano sino al letto roccioso, ma andavano a caricare più falde freatiche poste sul limite del comportamento plastico del ghiaccio. Lo scorrimento principale, cioè, non avveniva sul letto del ghiacciaio ma in prossimità della sommità delle falde interne, a metri sotto la superficie. Il reticolo sommerso Il modellamento numerico è stato sinora l unico strumento per chiarire i processi che avvengono nel reticolo di drenaggio sommerso. In condizioni sommerse i tempi di collasso delle cavità all'interno delle falde acquifere si riducono grazie al contrasto della pressione dell acqua. Come nel caso delle parti epidermiche, lo scavo carsico avviene per rilascio di energia potenziale nella caduta fra i punti a monte e a valle del reticolo di trasporto. Assume dunque un ruolo chiave la perdita di carico lungo le condotte e questo rende il modellamento molto delicato perché si tratta di un parametro che dipende criticamente dalla loro forma, condizioni di trasporto e così via. 3
5 Le condotte a pieno carico sub-glaciali sono strutture di equilibrio fra lo scavo dovuto alla perdita di carico dell'acqua in transito e il riempimento dovuto al ghiaccio che tende ad implodere sulla condotta. Le dimensioni dipendono dunque dalla pressione del ghiaccio sulle pareti e dalla pendenza e forma della galleria. Il calcolo deve essere applicato a casi reali, ma diremo che il diametro al quale diventa stabile una galleria percorsa da 1000 kg/s d'acqua, a cento metri di profondità, è circa 0.9 m, e l acqua vi corre a quasi 1.5 m/s. Se il flusso è di soli 100 kg/s il diametro di equilibrio diviene 35 cm e l'acqua vi corre ad un metro al secondo. Si tratta di dimensioni coerenti coi frammenti di condotte che, in rari casi, abbiamo potuto osservare direttamente. Le gallerie sono di diametro ragionevolmente uniforme: un qualunque restringimento, dovuto ad esempio a crolli, crea un aumento di impedenza e una concentrazione del rilascio locale di energia sino a che la disuniformità viene rimossa. Inoltre il processo è a retroazione negativa, cioè autostabilizzante: quando il flusso d'acqua si ferma, ad esempio durante notti fredde, la galleria si stringe lentamente e aumenta di impedenza. Alla ripresa del flusso il rilascio di energia sarà perciò maggiore e lo scavo avverrà più rapidamente sino a ripristinare le condizioni precedenti. In modo analogo, un temporaneo aumento del flusso dilata la condotta al di sopra della sezione di equilibrio alla quale però ritornerà appena si ridurrà il flusso. La novità principale mostrata dai nostri lavori riguarda però la struttura complessiva della rete di condotte di drenaggio, strettamente legata al fatto che il processo di scavo non è più né isobaro né isotermo, dato che la temperatura di equilibrio fra acqua e ghiaccio dipende dalla pressione. Essa è 0 C ( K) a pressione atmosferica, ma diminui sce di 7.5 mk per ogni incremento di una atmosfera: questo effetto ha un ruolo fondamentale, perché in eventuali tratti ascendenti l'acqua si muove verso pressioni minori, risulta troppo fredda rispetto al ghiaccio circostante e quindi solidifica sulle pareti. Il processo dunque evolve nel senso di allargamento delle parti discendenti e chiusura (e aumento dell'impedenza) delle parti ascendenti delle gallerie. E' dunque fortemente contrastata la formazione di tratti a saliscendi del reticolo e questo, in pratica, vincola l acqua a crearsi un reticolo di drenaggio appiattito sul livello di falda. La dipendenza fra la pressione e la temperatura di equilibrio fra le due fasi ha un effetto rilevante anche sulle singole condotte di drenaggio. L acqua vi scorre in modo turbolento e dunque passa dal pavimento al soffitto: ma in basso la sua pressione è maggiore e perciò non è in equilibrio con il ghiaccio e perciò liquefa ghiaccio per ridepositarlo sul soffitto quando vi arriva: il risultato è che la galleria migra lentamente verso il basso. Questo è l altro motivo che appiattisce il reticolo di drenaggio sul livello dell acquifero: le gallerie infatti non possono migrare troppo in profondità perché sennò i tratti in uscita sarebbero in risalita e dunque le acque tenderebbero a depositare e a chiuderle. Stabilità stagionale Passiamo a discutere la stabilità del reticolo sul lungo periodo. Abbiamo visto come rapide variazioni del flusso comportino piccole fluttuazioni attorno alla struttura di equilibrio, e infatti sia il calcolo che le osservazioni dirette mostrano che i cicli diurni non causano variazioni significative. La situazione cambia invece molto quando la variazione ha durata tipica maggiore di quella del collasso delle gallerie, situazione che si ha all'arrivo della stagione fredda. I flussi profondi si arrestano e le condotte iniziano lentamente a crollare su sé stesse, contrastate solo dalla pressione idrostatica della falda acquifera che viene spinta verso l'alto. In inverno il reticolo glaciale viene riempito d acqua sin nei pressi della superficie. In primavera, perciò, il reticolo c'è ancora anche se più a valle e più in pressione di qualche mese prima. Il flusso d'acqua esterno riprende con modalità analoghe all'anno precedente, e va scavando pozzi praticamente negli stessi punti ove si erano formati l'anno prima, dato che essi sono legati alla struttura tensiva del ghiacciaio che è a sua volta determinata dalle condizioni di vincolo della roccia, che variano di ben poco da una stagione all'altra. Le parti più a valle del reticolo vengono trascinate verso la fronte glaciale e macinate, mentre a monte, nelle profondità 4
6 dei "nuovi" mulini glaciali, se ne riformano di nuove. E curioso notare la glaciologia si accorse di questo processo un ottantina di anni fa, sul ghiacciaio del Lys. Anche il reticolo profondo risulta così essere una struttura che oscilla stagionalmente attorno ad una configurazione di equilibrio, e in pratica migra verso monte alla velocità con la quale il ghiaccio va verso valle. Formazione di tasche d acqua Sin da tempi remoti si sa che i ghiacciai hanno la pericolosa tendenza a liberare improvvise e imponenti masse d acqua che si erano evidentemente formate nelle loro profondità. La nostra attività ne ha permesso l esplorazione diretta subacquea di alcune, soprattutto in Patagonia, ma anche sul Gorner. I processi fisici che permettono la formazione e l ampliamento delle tasche d acqua sono tre. Il primo è un processo già citato: in un serbatoio d acqua le acque in caduta incontrano pressioni via via maggiori e dunque si vengono a trovare troppo calde rispetto al ghiaccio circostante: l entalpia eccedente viene impiegata a liquefare altro ghiaccio. Questo processo, in un sistema termicamente isolato, fa migrare verso il basso la cavità dato che le acque in salita depositano ghiaccio, ma se il sistema, come quasi sempre avviene, non è isolato ma connesso energeticamente all esterno o tramite una grotta o direttamente dall aria aperta, la cavità può allungarsi verso il basso senza staccarsi dalla superficie. Il secondo processo è quello dovuto al fatto che l acqua è più densa del ghiaccio e quindi esercita sul fondo una spinta, tanto maggiore quanto più essa è alta, che tende a far scorrere il ghiaccio verso l alto e ad affondare la cavità. Il terzo processo avviene solo se c è una qualche forma di riscaldamento diretto della superficie dell acqua nella cavità, ed è legato al fatto che la densità massima dell acqua pura si ha a 4.0 C: l acqua scaldata è più densa di quella circostante, circa a 0 C, e dunque affonda andando a portare eccedenze di entalpia nelle parti profonde. Questi processi sono i responsabili delle particolari forme di scavo che abbiamo osservato nelle cavità glaciali piene d acqua. Si tratta di processi che evolvono a velocità proporzionali alle loro dimensioni: tanto maggiore è la cavità, tanto più rapido il suo ampliamento. Viene da chiedersi come mai i ghiacciai non si trasformino in una distesa di grandi cavità piene d acqua, visto che si tratta di processi a retroazione positiva. La risposta è duplice: da una parte, in effetti, certi ghiacciai probabilmente si riempiono proprio di acqua sul letto tanto che ad un certo punto scorrono via quasi d improvviso E il cosiddetto fenomeno dei surge. Dall altra occorre ricordare che il ghiacciaio scorre e dunque bisogna confrontare il tempo tipico di sviluppo della cavità con il suo tempo di permanenza nella zona in cui ci sono le condizioni favorevoli all ampliamento. In pratica, prima che la cavità possa assumere dimensioni davvero grandi essa viene trascinata via e va in frantumi. Grandi tasche d acqua sono dunque possibili o su ghiacciai molto uniformi, dove le condizioni di ampliamento permangono lungo la traiettoria verso valle della cavità, come avviene nei ghiacciai patagonici (Tyndall) o se un ghiacciaio si è quasi fermato, come probabilmente sta avvenendo in diversi ghiacciai alpini, quali il Gorner. Condizioni generali di formazione I quindici anni di attività di ricerca hanno permesso di caratterizzare le condizioni di formazione del carsismo glaciale e, d altra parte, di notare come accanto a forme assiduamente ripetute ce ne siano di inusuali. Vediamo dunque di caratterizzare in modo estremamente sommario quanto abbiamo osservato sul campo per correlarlo poi con le condizioni meteorologiche, rimandando ad altra pubblicazione un analisi più dettagliata delle caratteristiche morfologiche dei singoli carsismi glaciali. I primi ghiacciai che abbiamo indagato con un punto di vista speleologico sono stati quelli europei. Mer de Glace, massiccio del Monte Bianco (Francia). Il fenomeno carsico è limitato al suo celebre inghiottitoio e a bediere di alimentazione. Ghiacciaio del Miage, massiccio del Monte Bianco (Italia). Il fenomeno carsico occupa una regione ristretta al centro della lingua, ma con alcuni mulini di una certa entità. 5
7 Gornergletscher, massiccio del Monte Rosa (Svizzera). Si tratta del ghiacciaio alpino con il fenomeno carsico più sviluppato, quasi certamente a causa della sua pendenza ridotta in modo anomalo. Vi si aprono fra venti e trenta mulini, alcuni di dimensioni veramente notevoli, ed un reticolo epiglaciale molto sviluppato. La zona carsica è concentrata in corrispondenza del lago su cui galleggia la massa glaciale: crediamo sia questo letto fluido che dà al ghiacciaio del Gorner una pendenza ridotta e dunque condizioni di drenaggio che si possono trovare solo su ghiacciai ben più vasti. Hansbreen, zona meridionale dell isola Spitsbergen (Norvegia). Il fenomeno carsico è abbastanza diffuso con anche qualche mulino imponente nella parte terminale ma, in confronto alla vastità del ghiacciaio, abbastanza ridotto. Skeidararjokull e Kviarjokull, lingue di drenaggio del Ghiacciao Vatna (Islanda). Fenomeni carsici diffusi, intensi ma, per quel che abbiamo visto, abbastanza poco imponenti, forse perché le condizioni strutturali non favoriscono la formazione di grossi ruscellamenti di alimentazione. In Asia abbiamo visitato tre ghiacciai. Biafo catena del Karakorum, (Pakistan). E stato il primo esplorato speleologicamente fuori Europa, probabilmente in assoluto. Presenta fenomeno carsico intenso e profondo su tutta la lunghissima parte in ablazione. Le bediere e le grotte si formano, ad intervalli regolari, ai lati delle morene centrali, probabilmente in corrispondenza di avvallamenti dovuti a scorrimenti differenziali delle lingue. Nelle parti inferiore due bediere assumono dimensioni imponenti e si inoltrano in portali sub-orizzontali non esplorati. Si è trattata della prima evidenza di reticoli sub-epidermici di drenaggio. Batura glacier, catena del Karakorum, (Pakistan). Si tratta di una lingua molto più limitata della precedente ma in cui il fenomeno carsico è ben sviluppato ed interessante: ci sono numerosi mulini di piccole dimensioni, qua e là, pochi imponenti in posizioni speciali, grotte di risorgenza, tracce di condotte epidermiche. Enilchek lednik, Tien Shan (Kirgizistan). Si tratta di un ghiacciaio molto lungo ma coperto di detrito, caratterizzato da una piena annuale che si ha quando il lago Metzbaker, 14 km a monte della fronte, si svuota attraverso il ghiacciaio. Abbiamo potuto visitare solo la parte vicina al lago ove ci sono imponenti cavità di distensione e forme carsiche diffuse. Nell America meridionale di siamo concentrati in modo quasi esclusivo su lingue di drenaggio dello Hielo Continental Sur, che con oltre kmq di superficie è la più vasta massa glaciale fuori dei poli. Glaciar Marconi, Patagonia, (Argentina). Si tratta di un piccolo ghiacciaio a nord del Fitz Roy, di avvicinamento molto semplice. Il carsismo è notevole se confrontato con le limitate dimensioni della lingua, concentrato nella sua parte di altopiano, attorno ad un piccolo lago epiglaciale. Glaciar Perito Moreno, Patagonia, (Argentina). Ghiacciaio non imponente ma le cui forme e intensità di carsismo ci hanno mostrato per la prima volta quel che possiamo definire ipercarsismo glaciale. C è un drenaggio principale (Rio Malbec) che genera più volte in una sola stagione una enorme cavità là dove va ad incontrare zone fratturate per l incipiente distensione della fronte. Parallelo ad esso c è un altro prevalentemente in condotte appena sub-glaciale: la grotta Perito Meccanico è stata esplorata in piccola parte ma riesce lo stesso ad essere la più lunga del mondo coi suoi 1150 m di sviluppo. Glaciar Viedma, Patagonia, (Argentina). E probabilmente il più promettente ghiacciaio carsico del mondo, ma la sua esplorazione presenta difficoltà logistiche tremende. Le aree di carsismo sono diffuse ed inframezzate da aree di crepacci in ablazione: i fenomeni carsici sono intensissimi, anche se meno di quanto avviene nel Perito Moreno. Al centro vi è una gigantesca bediere che non è stata esplorata sino al termine. Ventisquero Tyndall, Patagonia, (Cile). Altro ghiacciaio classificabile come ipercarsico, anche se con assorbimenti non diffusi ma concentrati nelle zone laterali e soprattutto nella parte terminale della lingua dove le tre bediere che lo percorrono in parallelo penetrano sotto. Rimandiamo ad articoli specifici l analisi dei particolari comportamenti di questi assorbimenti. 6
8 Tabella 1 Lat. [ ] Caratteristiche di alcune zone carsiche glaciali Long. Dir. Slope Alt. Min. [ ] [ ] [m/km] [m slm] Alt. Max. [m slm] EUROPA mer de glace 45.7 N 5 W gorner 46 N 7.5 W miage 45.8 N 5 W hansbreen 77 N 16 W skeidarar 64 N 18 W kviar 64 N 18 W ASIA biafo 35.7 N 76 W batura 36.3 N 75 W enilchek 42 N 80 W S. AMERICA marinelli 54.5 S 69 E viedma 49.5 S 73 E moreno 50.5 S 73 E tyndall 51.2 S 74 E marconi 49 S 73 E ANTARCTICA collins 62 S 59 E Ventisquero Marinelli, Tierra del Fuego (Chile). E un drenaggio glaciale sulle falde settentrionali della Sierra Darwin che è stato oggetto solo di una ricognizione aerea. Il carsismo vi appare sviluppato nella parte terminale ma la zona di ablazione pare iniziare a quote abbastanza basse. In Antartide abbiamo potuto visitare solo una zona ristrettissima su un solo ghiacciaio: altre cavità che abbiamo trovato altrove nel continente non vengono qui riportate perché hanno genesi totalmente diversa. Collins Glacier, King George (South Shetland). La formazione delle cavità, di dimensioni comunque molto contenute, è limitata alle zone laterali dei drenaggi glaciali che scendono dalla calotta ed entrano in mare. Le zone di ablazione sono piccole e poco potenti (sino a 100 m slm) dato che la massima parte della rimozione del ghiaccio avviene tramite calving in mare. La tabella riassume alcune caratteristiche generali del fenomeno glaciale che abbiamo descritto: posizione geografica, direzione e pendenza, limiti altimetrici (molto approssimativi) delle aree di carsismo profondo. Generazione del carsismo glaciale: la temperatura Passiamo ora a determinare le condizioni meteorologiche che permettono l esistenza del carsismo profondo glaciale. Va da sé che le grotte glaciali per formarsi hanno bisogno di ghiacciai ed essi non possono esistere in zone dove la temperatura media annuale è molto maggiore di 0 C. D altra parte per esistere hanno anche bisogno di ruscellamenti e dunque non possono formarsi in zone dove la temperatura media annuale sia molto inferiore a questo valore: questo nell insieme, ma possiamo quantificare meglio. Grazie alla cortesia della Società Meteorologica Italiana abbiamo potuto utilizzare i dati di alcune stazioni meteorologiche della rete mondiale per dedurre le condizioni medie alle quote limite del carsismo, concentrandoci in particolari sulle tabelle delle temperature medie mensili. Per le interpolazioni dalla posizione della stazione a quella della zona glaciale il gradiente termico con la quota è stato assunto di 6 C/km e quello di latitudine di 0.2 C/ Lat verso l equatore. Solo nel caso dei ghiacciai asiatici quest ultimo termine non è stato utilizzato perché a intorno a quelle zone la variazione della temperatura con la latitudine è trascurabile. Ogni valutazione è stata ripetuta con tutte le stazioni circostanti ed è stata verificata la coerenza del dato. Nel caso di scostamenti sensibili è stata preso il valor medio. 7
9 Tabella 2 Origine dati meteo glaciali Ghiacciaio Stazione Meteorologica Distanza [km] Mer de glace Plateau 2-15 Gorner Miage Zermatt Chamonix Hans Longyearbyn 140 Skeidarar Kirkjubaejar 50 Kviar Viedma Perito Moreno Tyndall Marconi Punta Arenas Lago Argentino Marinelli Ushuaya Punta Arenas Biafo Chitral Batura Srinagar Enilchek Naryn 340 Collins Frey 10 Tabella 3 T medie delle zone carsiche glaciali Alt. Min. [m slm] <T> [ C] Alt. Max. [m slm] <T> [ C] EUROPA mer de glace gorner miage hansbreen skeidarar kviar ASIA biafo batura enilchek S. AMERICA marinelli viedma moreno tyndall marconi ANTARTIDE collins Il risultato è mostrato in tabella 3: le temperature medie annuali sono intorno a 0 C, come ci aspettavamo, ma è pure evidente una grande variabilità. Il grafico seguente lo illustra in dettaglio, mostrando pure i limiti di temperatura media attorno a cui si sviluppa il fenomeno carsico glaciale. Balza all occhio che in Europa il fenomeno è realmente concentrato intorno alla quota corrispondente alla temperatura media di 0 C, ma è pure evidente che sia in Asia che in Sud America il fenomeno si spinge a quote ben più basse. Qui appare evidente che si tratta di processi abbastanza differenti: l alimentazione delle lingue glaciali del Karakorum e soprattutto di quelle patagoniche è tanto più elevata di quella dei ghiacciai europei che le lingue si spingono sino a quote assurdamente basse, naturalmente con ablazioni specifiche enormi. Anche la protezione offerta dalle pareti delle montagne del Karakorum ai ghiacciai può avere un peso importante nel proteggerli dal caldo e introduce quasi certamente un errore nella valutazione della temperatura locale così come l abbiamo fatta 8
10 basandoci su stazioni in zone aperte : quanto più grande è un ghiacciaio tanto più esso è in grado di influenzare il clima locale. 6 4 positive degree index average yearly temperatures of some world glaciers karstic areas -6-8 hansbreen gorner miage m. glace skeidarar kviar enilchek biafo batura marconi viedma tyndall marinelli moreno collins Tre ghiacciai (i due polari e quello dell Asia centrale) si staccano nettamente dall insieme degli altri. D altra parte la lettura delle sequenze temporali della temperatura mostra che il puro dato temperatura media annuale ha poco senso se usato per comparare zone che si estendono da 62 S a 78 N passando per l equatore Generazione del carsismo glaciale: i gradi positivi Per migliorare la stima abbiamo dunque fatto uso di una tecnica diversa: grosso modo al di sotto di 0 C non c è ablazione, al di sopra di 0 C la quant ità di calore che riceve il ghiaccio, e dunque l ablazione, è grosso modo proporzionale alla T, cioè alla temperatura centigrada. Per ogni punto abbiamo quindi stimato la temperatura media mensile basandoci su quella delle stazioni meteorologiche e poi abbiamo fatto la somma dei gradi limitatamente ai mesi in cui essi erano positivi. Chiameremo questo indice GKI, Glacier Karst Index. Il risultato è mostrato in tabella 4. Si vede subito come il quadro si sia differenziato da quello fornito dalle temperature medie annuali. L Hans e soprattutto il Collins sono finiti dove dovevano essere: al limite estremo del carsismo glaciale, l uno a Nord e l altro a Sud. Si noti, infatti che i ghiacciai della parte centrosettentrionale delle Svalbard non mostrano segni di carsismo. L eccezionalità dell Enilchek, che la stima della temperatura media annuale relegava fra i ghiacciai polari, si dimostra apparente: sono le condizioni meteorologiche dell Asia centrale ad essere eccezionali, il ghiacciaio ha un GKI intorno a 30, come quelli alpini, e difatti ha un carsismo di tipo alpino. La salita del GKI corrisponde strettamente a quanto abbiamo visto sul campo: valori intorno a 50 descrivono carsismo molto intenso (Kviar, Marinelli, Marconi), al di sopra il fenomeno diventa di una tale intensità da meritare, probabilmente, il titolo di iper-carsismo glaciale. Il GKI dei ghiacciai pakistani li indica simili al Perito Moreno: pur essendo, in effetti, carsismo intenso la valutazione è eccessiva: probabilmente qui si fanno sentire ancora di più i limiti di affidabilità del metodo di interpolazione da stazioni lontane. Sta di fatto che il GKI pare un indice in grado di far prevedere se e di quale tipo sia il carsismo che incontreremo su un ghiacciaio se le altre condizioni di formazione lo permetteranno. 9
11 Tabella 4 GKI delle zone carsiche glaciali Alt. Min. [m slm] GKI Alt. Max. [m slm] GKI EUROPA mer de glace gorner miage hansbreen skeidarar kviar ASIA biafo batura enilchek S. AMERICA marinelli viedma moreno tyndall marconi ANTARCTICA collins Il grafico lo riassume, zona carsica per zona carsica positive degree index positive degrees yearly sum of each average monthly temperature of some world glaciers karstic areas 0 hansbreen gorner miage m. glace skeidarar kviar enilchek biafo batura marconi viedma tyndall marinelli moreno collins Generazione del carsismo glaciale: la pendenza Uno dei parametri più importanti per permettere la formazione di carsismo glaciale è quello della pendenza della superficie: alte pendenze corrispondono a condizioni di scorrimento troppo distensive e la superficie del ghiacciaio si riempie di crepacci, impedendo la formazione delle grotte e soprattutto delle bediere. Il grafico mostra la distribuzione delle pendenze delle zone carsiche visitate. Si tratta di stime complessive abbastanza rozze (sui ghiacciai la pendenza varia parecchio) che dovranno essere 10
12 perfezionate sul campo, area per area, ma rimane abbastanza chiaro che la pendenza carsica non deve eccedere il 5 %. Si vede pure come la principale qualità del Gorner pare proprio essere quella di una pendenza lieve, comparabile con quella dei grandi ghiacciai sudamericani, grazie al suo letto liquido. Ci sono indizi che suggeriscono che quanto più bassa è la pendenza tanto più è favorita la formazione di sistemi di drenaggio a condotte epidermiche. Il problema è però ancora aperto surface slope estimation of some world glacier karstic areas slope [m/km] ansbreen gorner miage m. glace skeidarar kviar enilchek biafo batura marconi viedma tyndall marinelli moreno collins Conclusioni e future ricerche La speleologia glaciale è nata molto recentemente da una costola della speleologia sportiva, e si è sviluppata nell ambito degli studi di climatologia sotterranea, ma sta riuscendo a chiarire molti processi che avvengono nei ghiacciai e ne sta delineando il mondo che contengono. Il carsismo in rocce calcaree è il risultato dell intera storia del massiccio in cui è scavato perché la roccia conserva memoria di strutture molto antiche. Inoltre una parte sostanziale della loro genesi è legata ad eventi puramente interni, invisibili all esterno. Da una parte questo fa sì che le grotte siano molto complesse dato che sono il risultato della somma di innumerevoli eventi e condizioni climatiche e geografiche, dall altra la previsione della loro esistenza è praticamente impossibile, perché ci sono ignote le situazioni passate e le condizioni profonde. Nel caso del carsismo glaciale questo quadro muta in modo radicale. La plasticità del materiale e il fatto che esso venga incessantemente rinnovato permette il mantenimento delle sole forme in scavo: l essere fossili è permesso solo su una scala temporale molto breve, legata alla profondità sotto ghiaccio. Questo porta con sé che possiamo prevedere l esistenza di carsismo glaciale dal solo analizzare le situazioni in cui lo scavo è possibile. La forte dipendenza del carsismo glaciale dalle condizioni meteorologiche e dalla pendenza della superficie glaciale ci ha permesso di introdurre un indice di carsificazione che, insieme alla misurazione di altri parametri d insieme, sarà in grado di permetterci previsioni sulla morfologia di drenaggio di un ghiacciaio senza fare una ricognizione diretta. In prospettiva immediata tutte queste ricerche miglioreranno l'accuratezza delle valutazioni dei "bilanci di massa" dei ghiacciai che vengono utilizzati per stimare i cambiamenti globali del clima. Ma l aspetto più rilevante per un utilizzo pratico di questi studi è senza dubbio quello della fenomenologia dei depositi d'acqua sub-glaciali; E' infatti ben noto che periodicamente dai ghiacciai fuoriescono improvvisamente enormi quantità d'acqua che si erano venute accumulando negli anni precedenti all'interno della massa glaciale. Questo tipo di fenomeni, di estrema rilevanza per le opere umane costruite a valle dei 11
13 grandi ghiacciai, pare fosse già noto agli ingegneri della Roma antica: è probabile che l'enorme struttura del ponte romano di Pont Saint Martin fosse proprio giustificata dal mettere la strada delle Gallie al riparo da eventi catastrofici di questo tipo, innescati dal ghiacciaio del Lys. La situazioni di rischio va attualmente crescendo proprio perché la generale fase di ritiro delle superfici glaciali sulle Alpi è destinata a liberare le tasche d'acqua esistenti, trattenute dal ghiaccio a valle. Sino ad ora, però, non è stata condotta nessuna analisi sistematica delle dimensioni e delle condizioni di stabilità di questi depositi. Tutto questo va verificato sul campo, sia con ricognizioni dirette che indirette, ed è proprio in questa direzione che stiamo orientando le attuali ricerche. Bibliografia AGASSIZ L., Etudes et Expériences sur les Glaciers actuels, Masson, Paris, AMBACH W., Interpretation of the Positive-Degree-Days Factor by Heat Balance Characteristics, Nordic Hydrology, 19: BRAITHWAITE R., OLESEN O.,1989 Calculation of Glacial Ablation from Air Temperature, in Glacier Fluctuations and Climatic Change, J. Oerlemans, BADINO G., Fisica dei Buchi nell'acqua, Proc. of 1st Int. Symp. of Glacier Caves and Karst in Polar Regions, Madrid, BADINO G., Ice Shaft Genesis: a Simple Numerical Approach, Proc. Of 2nd Int. Symp. of Glacier Caves and Karst in Polar Regions, Miedzygorze, BADINO G., Phenomenology and First Numerical Simulations of the Freatic Drainage Network Inside Glaciers, Proc. of 3rd Int. Symp. of Glacier Caves and Karst in Polar Regions, Chamonix, BADINO G., PICCINI L., 1995 Aspetti Morfologici ed Evolutivi delle Cavità Endoglaciali di Origine Criocarsica, Geogr. Fis. Quat.,18: DÉSOR E., Excursions et Sejour dans les Glaciers, Kissling, Neuchatel. ERASO A., Método de Predicción de las direcciones principales de drenaje en el karst, Kobie, Serie Sc. Nat. XV, , Bilbao. FERUGLIO E., Variaciones del frente del Glaciar Moreno. Gaea, Soc. Arg. Est. Geograficos, 6: FORBES J., Travels through the Alps and Savoy, Edinburgh. FORBES J., Occasional Papers on the Theory of Glaciers, A&C Black, Edinburgh. HOOKE R., On the role of mechanical energy in maintaining subglacial water conduits at atmospheric pressure, Journal of Glaciology, 30, 105, NYE J., Water Flow in Glaciers, J. of Glaciology, 17,76,181, PATERSON W., The Physics of Glaciers, Pergamon Press. ROTHLISBERGER H., Water Pressure in Intra and Subglacial Channels, J. of Glaciology, 11, 62, 177, SHREVE R., Movement of Water in Glacier, J. of Glaciology, 11, 62, BENN D., EVANS D., Glaciers and Glaciation, Arnold Publishers. VALLOT J., Exploration des Moulins de la Mer de Glace, Spelunca, IV,
Grotte e mulini glaciali
 Approfondimenti Grotte e mulini glaciali Giovanni Badino, Leonardo Piccini Contenuto: Morfologia e formazione delle grotte nei ghiacciai. Contents: Morphology and origin of glacier caves. Key-words: ghiacciai,
Approfondimenti Grotte e mulini glaciali Giovanni Badino, Leonardo Piccini Contenuto: Morfologia e formazione delle grotte nei ghiacciai. Contents: Morphology and origin of glacier caves. Key-words: ghiacciai,
LE GROTTE ALL INTERNO DEI GHIACCIAI SI FORMANO QUANDO E PRESENTE ACQUA ALLO STATO LIQUIDO
 LE GROTTE ALL INTERNO DEI GHIACCIAI SI FORMANO QUANDO E PRESENTE ACQUA ALLO STATO LIQUIDO LE CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DI GROTTE SI VERIFICANO IN TUTTI I GHIACCIAI IN ZONE TEMPERATE E SUBPOLARI GHIACCIAIO
LE GROTTE ALL INTERNO DEI GHIACCIAI SI FORMANO QUANDO E PRESENTE ACQUA ALLO STATO LIQUIDO LE CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DI GROTTE SI VERIFICANO IN TUTTI I GHIACCIAI IN ZONE TEMPERATE E SUBPOLARI GHIACCIAIO
Carte meteorologiche, fronti, instabilità
 Carte meteorologiche, fronti, instabilità Le scale meteorologiche Le masse d aria Alte e basse pressioni Le carte meteorologiche I sistemi frontali Plampincieux, 28 maggio 2007 Le scale meteorologiche
Carte meteorologiche, fronti, instabilità Le scale meteorologiche Le masse d aria Alte e basse pressioni Le carte meteorologiche I sistemi frontali Plampincieux, 28 maggio 2007 Le scale meteorologiche
L ACQUA FREDDA NEL NORD ATLANTICO AVRÀ PROBABILMENTE UN IMPATTO SULLA TEMPERATURA DELL ARIA NEVE E GHIACCIO IN GROENLANDIA E NEL RESTO DELLA REGIONE
 L ACQUA FREDDA NEL NORD ATLANTICO AVRÀ PROBABILMENTE UN IMPATTO SULLA TEMPERATURA DELL ARIA NEVE E GHIACCIO IN GROENLANDIA E NEL RESTO DELLA REGIONE ARTICA CONSEGUENZE SULLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE
L ACQUA FREDDA NEL NORD ATLANTICO AVRÀ PROBABILMENTE UN IMPATTO SULLA TEMPERATURA DELL ARIA NEVE E GHIACCIO IN GROENLANDIA E NEL RESTO DELLA REGIONE ARTICA CONSEGUENZE SULLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE
Cosa sono le acque continentali?
 Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
Cosa sono le acque continentali? Le acque sulla terraferma, cioè all'interno dei continenti, nell'insieme prendono il nome di acque continentali e contengono una bassa concentrazione di sostanze disciolte,
I fronti d aria. Sono delle superfici di contatto tra due differenti masse d aria: Fronte caldo. Fronte freddo. Fronte occluso. Fronte stazionario
 I fronti d aria Sono delle superfici di contatto tra due differenti masse d aria: Fronte caldo Fronte freddo Fronte occluso Fronte stazionario Le perturbazioni Si originano dai movimenti delle masse d
I fronti d aria Sono delle superfici di contatto tra due differenti masse d aria: Fronte caldo Fronte freddo Fronte occluso Fronte stazionario Le perturbazioni Si originano dai movimenti delle masse d
Influenza del cambiamento climatico sulla biodiversità e sugli ecosistemi delle aree Protette
 Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
Perché si parla di cambiamenti climatici? Queste sono alcune delle variazioni finora riscontrate (i fatti): Negli ultimi 150 anni la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 0.74
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 1 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-3 Trento
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 1 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-3 Trento
 TICINO: record storico per l'intero mese di maggio... lo comunica meteosvizzera in un articolo appena uscito. MeteoSvizzera - Maggio 2009: caldo? No, caldissimo! Aprile ci ha lasciato abbondanti precipitazioni
TICINO: record storico per l'intero mese di maggio... lo comunica meteosvizzera in un articolo appena uscito. MeteoSvizzera - Maggio 2009: caldo? No, caldissimo! Aprile ci ha lasciato abbondanti precipitazioni
Associazione Il Faggio sul Lago. Anomalie ed eventi climatici particolarmente significativi
 Offriamo in questa sede la traduzione non ufficiale del Global Climate Report redatto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) relativo al mese di novembre 2017. Il documento originale,
Offriamo in questa sede la traduzione non ufficiale del Global Climate Report redatto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) relativo al mese di novembre 2017. Il documento originale,
CICLO IDROLOGICO. Una prima ipotesi: il Sole innalzerebbe l'acqua del mare nell'atmosfera, donde ricadrebbe come pioggia.
 CICLO IDROLOGICO CICLO IDROLOGICO Sin dall antichità e fin verso il 1400 d.c., il concetto di ciclo idrologico è stato argomento di speculazione da parte di molti pensatori. Una prima ipotesi: il Sole
CICLO IDROLOGICO CICLO IDROLOGICO Sin dall antichità e fin verso il 1400 d.c., il concetto di ciclo idrologico è stato argomento di speculazione da parte di molti pensatori. Una prima ipotesi: il Sole
Il vento. Il vento. Il vento 10/02/2019
 è lo spostamento di una massa d aria provocato da una differenza di pressione. L aria infatti si sposta da una zona di alta pressione (area anticiclonica) verso una di bassa pressione (zona ciclonica).
è lo spostamento di una massa d aria provocato da una differenza di pressione. L aria infatti si sposta da una zona di alta pressione (area anticiclonica) verso una di bassa pressione (zona ciclonica).
Elementi di meteorologia. Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado
 Elementi di meteorologia Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado 1 BOLLETTINO METEO Il sole riscalda la terra 2 Come si crea il tempo meteorologico? 3 Il sole riscalda la terra
Elementi di meteorologia Corso per docenti delle scuole primaria, secondaria di I e II grado 1 BOLLETTINO METEO Il sole riscalda la terra 2 Come si crea il tempo meteorologico? 3 Il sole riscalda la terra
Il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico
 Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico
 Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Il cambiamento climatico Resoconto di alcuni dei principali effetti visibili in Europa Ing. Gianluca Bertoni Meteo Varese Responsabile settore previsionale MeteoNetwor Il cambiamento climatico I cambiamenti
Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale
 ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Azoto. La molecola di azoto e formata da due atomi di azoto, legati insieme con un triplo legame:
 Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
Aria ed atmosfera L aria Questo sottile strato, inodore ed incolore è una miscela di gas: 78 % di azoto; 21 % di ossigeno; 0,03 % di anidride carbonica; 0,97 % altri gas. Azoto La molecola di azoto e formata
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 216 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 216 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
QUALCHE NOTIZIA SUI GHIACCIAI
 QUALCHE NOTIZIA SUI GHIACCIAI Nelle zone più fredde della Terra, quindi anche alle quote più elevate delle Alpi, la neve caduta durante la stagione invernale non fonde completamente nel corso della successiva
QUALCHE NOTIZIA SUI GHIACCIAI Nelle zone più fredde della Terra, quindi anche alle quote più elevate delle Alpi, la neve caduta durante la stagione invernale non fonde completamente nel corso della successiva
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2015
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 15 Agosto 15 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 15 Agosto 15 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti,
Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire
 IL SISTEMA TERRA Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire la Terra un sistema, cioè un insieme
IL SISTEMA TERRA Sulla Terra possiamo distinguere quattro parti strettamente connesse tra loro: 1. idrosfera 2. atmosfera 3. litosfera 4. biosfera Possiamo definire la Terra un sistema, cioè un insieme
Bilancio termico. Bilancio termico 16/01/ il 31% circa viene riflesso di nuovo nello spazio; 2. il 20% circa viene assorbito dell atmosfera;
 Bilancio termico La temperatura dell atmosfera è determinata dal riscaldamento solare, ma non direttamente. Il Sole invia sulla Terra un enorme quantità di energia, per lo più sotto forma di radiazioni
Bilancio termico La temperatura dell atmosfera è determinata dal riscaldamento solare, ma non direttamente. Il Sole invia sulla Terra un enorme quantità di energia, per lo più sotto forma di radiazioni
Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo
 Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo Il pianeta Terra il pianeta Terra, il pianeta in cui viviamo e che condividiamo con decine di milioni di specie viventi È un pianeta unico nell ambito del Sistema Solare
Il sistema Terra Acqua, Aria e Suolo Il pianeta Terra il pianeta Terra, il pianeta in cui viviamo e che condividiamo con decine di milioni di specie viventi È un pianeta unico nell ambito del Sistema Solare
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
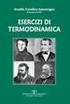 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
Troposfera: strato dell atmosfera in cui la temperatura diminuisce con l altitudine. È dove avvengono quasi tutti i fenomeni metereologici.
 L atmosfera terrestre ionosfera mesosfera Stratosfera Troposfera ( 10-15 km ) Troposfera: strato dell atmosfera in cui la temperatura diminuisce con l altitudine. È dove avvengono quasi tutti i fenomeni
L atmosfera terrestre ionosfera mesosfera Stratosfera Troposfera ( 10-15 km ) Troposfera: strato dell atmosfera in cui la temperatura diminuisce con l altitudine. È dove avvengono quasi tutti i fenomeni
ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO 217-218 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO 217-218 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
CROCE ROSSA ITALIANA. Idrogramma di piena. Pluviometria e valutazione delle piene Valutazione delle piene; Analisi dell idrogrammadi piena.
 CROCE ROSSA ITALIANA Corso di formazione su RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO Pluviometria e valutazione delle piene Valutazione delle piene; Analisi dell idrogrammadi piena. Idrogramma di piena Giuseppe
CROCE ROSSA ITALIANA Corso di formazione su RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROLOGICO Pluviometria e valutazione delle piene Valutazione delle piene; Analisi dell idrogrammadi piena. Idrogramma di piena Giuseppe
Indice di Paterson. Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi. Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
 Indice di Paterson Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Il calcolo dell indice di Paterson o indice C.V.P. (Clima-Vegetazione-Produzione),
Indice di Paterson Luigi Mariani, Simone Gabriele Parisi Università degli Studi di Milano DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Il calcolo dell indice di Paterson o indice C.V.P. (Clima-Vegetazione-Produzione),
LE ACQUE SOTTERANEE. La falda freatica e la falda artesiana Luison Luca, Abbiendi Damiano
 LE ACQUE SOTTERANEE La falda freatica e la falda artesiana Luison Luca, Abbiendi Damiano La falda freatica La falda freatica è una falda idrica delimitata al di sotto da una roccia impermeabile e al di
LE ACQUE SOTTERANEE La falda freatica e la falda artesiana Luison Luca, Abbiendi Damiano La falda freatica La falda freatica è una falda idrica delimitata al di sotto da una roccia impermeabile e al di
Liceo B. Cavalieri Classe II Cs A.S. 2013/2014 di Karolina Chevka
 Liceo B. Cavalieri Classe II Cs A.S. 2013/2014 di Karolina Chevka Indice Acqua ed energia nel VCO La provincia del VCO Le centrali idroelettriche La centrale idroelettrica a salto La diga La diga a gravità
Liceo B. Cavalieri Classe II Cs A.S. 2013/2014 di Karolina Chevka Indice Acqua ed energia nel VCO La provincia del VCO Le centrali idroelettriche La centrale idroelettrica a salto La diga La diga a gravità
1 DATI METEOROLOGICI DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L ANNO 2004
 1 DATI METEOROLOGICI DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L ANNO 2004 Le condizioni meteorologiche condizionano fortemente la qualità dell aria di un territorio: infatti occorre ricordare che la concentrazione
1 DATI METEOROLOGICI DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L ANNO 2004 Le condizioni meteorologiche condizionano fortemente la qualità dell aria di un territorio: infatti occorre ricordare che la concentrazione
Forme carsiche epigee (superficiali)
 Forme carsiche epigee (superficiali) CATEGORIA FORME PICCOLE FORME MEDIO- GRANDI Raccolta Vaschette Ruscellamento Karren Doline Infiltrazione Fori di dissoluzione Pozzi, doline di crollo Emergenza Risorgenze
Forme carsiche epigee (superficiali) CATEGORIA FORME PICCOLE FORME MEDIO- GRANDI Raccolta Vaschette Ruscellamento Karren Doline Infiltrazione Fori di dissoluzione Pozzi, doline di crollo Emergenza Risorgenze
Il sistema Terra. Enrico Degiuli Classe Prima
 Il sistema Terra Enrico Degiuli Classe Prima Le componenti del sistema Terra Idrosfera: la parte liquida della Terra, è formata dall acqua presente sulla Terra allo stato liquido (oceani, mari, laghi,
Il sistema Terra Enrico Degiuli Classe Prima Le componenti del sistema Terra Idrosfera: la parte liquida della Terra, è formata dall acqua presente sulla Terra allo stato liquido (oceani, mari, laghi,
Carso e fenomeni carsici 2 parte
 Carso e fenomeni carsici 2 parte 2017-2018 Carso C - GFGeol - STAN 1 Pradis Caverna nella Forra del T. Cosa ph.ff Forme carsiche ipogee Caverne (ampie) Gallerie (orizz.) Pozzi (vert.) 2017-2018 Carso C
Carso e fenomeni carsici 2 parte 2017-2018 Carso C - GFGeol - STAN 1 Pradis Caverna nella Forra del T. Cosa ph.ff Forme carsiche ipogee Caverne (ampie) Gallerie (orizz.) Pozzi (vert.) 2017-2018 Carso C
Primavera 2010: figlia dell ultimo inverno?
 Primavera 2010: figlia dell ultimo inverno? Prevedere come sarà un intera stagione che inizia è un impresa davvero ardua e spesso si rischia di prendere delle colossali cantonate. Tutto questo è ancora
Primavera 2010: figlia dell ultimo inverno? Prevedere come sarà un intera stagione che inizia è un impresa davvero ardua e spesso si rischia di prendere delle colossali cantonate. Tutto questo è ancora
Sin dall antichità e fin verso il 1400 d.c., il concetto di ciclo idrologico è stato argomento di speculazione da parte di molti pensatori.
 Sin dall antichità e fin verso il 1400 d.c., il concetto di ciclo idrologico è stato argomento di speculazione da parte di molti pensatori. Una prima ipotesi: il Sole innalzerebbe l'acqua del mare nell'atmosfera,
Sin dall antichità e fin verso il 1400 d.c., il concetto di ciclo idrologico è stato argomento di speculazione da parte di molti pensatori. Una prima ipotesi: il Sole innalzerebbe l'acqua del mare nell'atmosfera,
Andamento Meteo 2012 rispetto al clima. Prospettive della coltura della patata in relazione al mutamento climatico. Possibili azioni di adattamento
 Andamento Meteo 2012 rispetto al clima Prospettive della coltura della patata in relazione al mutamento climatico Possibili azioni di adattamento Eventi caratteristici 2011 2012 Siccità autunno inverno
Andamento Meteo 2012 rispetto al clima Prospettive della coltura della patata in relazione al mutamento climatico Possibili azioni di adattamento Eventi caratteristici 2011 2012 Siccità autunno inverno
Dr. Luigi Trovarelli
 Evoluzione stagionale delle masse d acqua lungo la fascia costiera tra Senigallia e Porto Recanati Nella zona tra Senigallia e Porto Recanati l area del largo nel periodo fine inverno primavera, è caratterizzata
Evoluzione stagionale delle masse d acqua lungo la fascia costiera tra Senigallia e Porto Recanati Nella zona tra Senigallia e Porto Recanati l area del largo nel periodo fine inverno primavera, è caratterizzata
MASSE D ARIA E FRONTI. Prof.ssa C. Agizza
 MASSE D ARIA E FRONTI Prof.ssa C. Agizza 1 Porzione limitata di atmosfera. Si può estendere verticalmente fino al limite della troposfera. Massa d aria Caratterizzata da temperatura e umidità. Può coprire
MASSE D ARIA E FRONTI Prof.ssa C. Agizza 1 Porzione limitata di atmosfera. Si può estendere verticalmente fino al limite della troposfera. Massa d aria Caratterizzata da temperatura e umidità. Può coprire
CONTENUTO 4 GLI ELEMENTI METEOROLOGICI 17 LE MASSE D ARIA 37 I FRONTI 46 IL MEDITERRANEO 53 PREVISIONI METEO
 CONTENUTO 4 GLI ELEMENTI METEOROLOGICI 6 La 11 La temperatura 14 Umidità 17 17 I sistemi barici 20 Il vento 25 Circolazione generale dell atmosfera 27 Stabilità e instabilità dell aria 30 Le nubi 34 Classificazione
CONTENUTO 4 GLI ELEMENTI METEOROLOGICI 6 La 11 La temperatura 14 Umidità 17 17 I sistemi barici 20 Il vento 25 Circolazione generale dell atmosfera 27 Stabilità e instabilità dell aria 30 Le nubi 34 Classificazione
Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018
 4/12/2018 Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018 Figura 1. Copertura parzialmente divelta. Pellizzano 24 ottobre 2018. Il 24 ottobre forti venti settentrionali hanno interessato le Alpi.
4/12/2018 Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018 Figura 1. Copertura parzialmente divelta. Pellizzano 24 ottobre 2018. Il 24 ottobre forti venti settentrionali hanno interessato le Alpi.
Le nubi (Fig.3.6) Le nuvole assorbono e riflettono radiazione solare Fig.3.6 L esempio mostra una nuvola che riflette circa il 68% e lascia passare
 Le nubi (Fig.3.6) Le nuvole assorbono e riflettono radiazione solare Fig.3.6 L esempio mostra una nuvola che riflette circa il 68% e lascia passare il 25%, per cui assorbe il 7%, con un assorbimento stimato
Le nubi (Fig.3.6) Le nuvole assorbono e riflettono radiazione solare Fig.3.6 L esempio mostra una nuvola che riflette circa il 68% e lascia passare il 25%, per cui assorbe il 7%, con un assorbimento stimato
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto Roberto Barbiero
 Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Meteo a Bologna - dati aggiornati a Febbraio 2006
 Meteo a Bologna - dati aggiornati a Febbraio 2006 I dati meteo registrati a febbraio nella stazione di Bologna-Borgo Panigale e comunicati dal Servizio IdroMeteorologico dell'arpa della Regione Emilia
Meteo a Bologna - dati aggiornati a Febbraio 2006 I dati meteo registrati a febbraio nella stazione di Bologna-Borgo Panigale e comunicati dal Servizio IdroMeteorologico dell'arpa della Regione Emilia
ATTENZIONE ALTA MONTAGNA QUALI SONO I PERICOLI DELL ALTA MONTAGNA?
 ATTENZIONE ALTA MONTAGNA! QUALI SONO I PERICOLI DELL ALTA MONTAGNA? WWW.ATTENTIONHM.COM CREPACCI PONTI DI NEVE I PRINCIPALI PERICOLI IN ALTA MONTAGNA SCIVOLAMENTO VALANGHE CORNICI CROLLI DI ROCCIA / GHIACCIO
ATTENZIONE ALTA MONTAGNA! QUALI SONO I PERICOLI DELL ALTA MONTAGNA? WWW.ATTENTIONHM.COM CREPACCI PONTI DI NEVE I PRINCIPALI PERICOLI IN ALTA MONTAGNA SCIVOLAMENTO VALANGHE CORNICI CROLLI DI ROCCIA / GHIACCIO
CLUB ALPINO ITALIANO Scuola Intersezionale di Escursionismo VERONESE
 CLUB ALPINO ITALIANO Scuola Intersezionale di Escursionismo VERONESE Introduzione L escursionismo su neve, in tutte le sue forme e modalità, porta il praticante ad accostarsi ad un mondo diverso, fantastico,
CLUB ALPINO ITALIANO Scuola Intersezionale di Escursionismo VERONESE Introduzione L escursionismo su neve, in tutte le sue forme e modalità, porta il praticante ad accostarsi ad un mondo diverso, fantastico,
A cura di Dr. Adriano Barbi
 A cura di Dr. Adriano Barbi A proposito di Cambiamenti climatici 1. Il clima e il sistema climatico 2. Cambiamenti climatici 3. I cambiamenti climatici osservati negli ultimi 150 anni a livello globale
A cura di Dr. Adriano Barbi A proposito di Cambiamenti climatici 1. Il clima e il sistema climatico 2. Cambiamenti climatici 3. I cambiamenti climatici osservati negli ultimi 150 anni a livello globale
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2017
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Maggio Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Maggio 2014 In Piemonte il mese di Maggio 2014 è stato caratterizzato da temperature nella norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000. Nella serie storica
Il Clima in Piemonte Maggio 2014 In Piemonte il mese di Maggio 2014 è stato caratterizzato da temperature nella norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000. Nella serie storica
Variazione delle componenti del bilancio energetico superficiale con la latitudine Tabella 4.5 e figura 4.11.
 Tabella 4.6 Il rapporto SH/LH /rapporto di Bowen) vale circa 0.1 sugli oceani. L australia è il continente più arido (SH/LH=2.18) dopo l'antartide, seguito dall Africa SH/LH=1.61). Sud America ed Europa
Tabella 4.6 Il rapporto SH/LH /rapporto di Bowen) vale circa 0.1 sugli oceani. L australia è il continente più arido (SH/LH=2.18) dopo l'antartide, seguito dall Africa SH/LH=1.61). Sud America ed Europa
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2017
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2017 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2017 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
I CLIMI D'EUROPA. Pearson Italia
 I Che clima c è? Che tempo fa? Il clima è l insieme delle condizioni atmosferiche medie di un luogo, registrate in un lungo periodo (almeno trent anni). Il meteo indica le condizioni atmosferiche di un
I Che clima c è? Che tempo fa? Il clima è l insieme delle condizioni atmosferiche medie di un luogo, registrate in un lungo periodo (almeno trent anni). Il meteo indica le condizioni atmosferiche di un
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA
 I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
I CLIMI IN ITALIA: LE AREE TEMPERATE CALDE MEDITERRANEE A SICCITA ESTIVA Introduzione Continuiamo la trattazione sui climi italiani affrontando l analisi del clima mediterraneo identificato, nella convenzione
Clima. Clima mediterraneo. Clima atlantico. Clima continentale. Europa meridionale. Europa occidentale. Europa centro orientale
 Clima Il clima è l insieme delle condizioni atmosferiche ossia com è il tempo: pioggia, sole, temperatura, pressione di una determinata zona rilevata nell arco di un lungo periodo. A seconda della latitudine
Clima Il clima è l insieme delle condizioni atmosferiche ossia com è il tempo: pioggia, sole, temperatura, pressione di una determinata zona rilevata nell arco di un lungo periodo. A seconda della latitudine
I cambiamenti climatici sulla regione Alpina: Osservazioni e proiezioni future. Filippo Giorgi Abdus Salam ICTP, Trieste
 I cambiamenti climatici sulla regione Alpina: Osservazioni e proiezioni future Filippo Giorgi Abdus Salam ICTP, Trieste Trento, 22 Febbraio 2008 Variazione della concentrazione di gas serra in atmosfera
I cambiamenti climatici sulla regione Alpina: Osservazioni e proiezioni future Filippo Giorgi Abdus Salam ICTP, Trieste Trento, 22 Febbraio 2008 Variazione della concentrazione di gas serra in atmosfera
ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO 216-217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL INVERNO 216-217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
BOLLETTINO STRAORDINARIO RISERVE IDRICHE
 Riserva idrica (Milioni di mc Situazione al 18 marzo 2 Emesso il 22 marzo 2 1 Stato delle riserve idriche 1.1 Quadro generale per l'area alpina e prealpina Totale Lombardia - Situazione al 18 marzo Riserve
Riserva idrica (Milioni di mc Situazione al 18 marzo 2 Emesso il 22 marzo 2 1 Stato delle riserve idriche 1.1 Quadro generale per l'area alpina e prealpina Totale Lombardia - Situazione al 18 marzo Riserve
Ghiacciai e permafrost in Trentino: cambiamenti in atto e scenari futuri
 Ghiacciai e permafrost in Trentino: cambiamenti in atto e scenari futuri Roberto Seppi Dipartimento di Scienze della Terra Università di Pavia Trentino Clima 2008 Ghiacciai alpini e riscaldamento climatico
Ghiacciai e permafrost in Trentino: cambiamenti in atto e scenari futuri Roberto Seppi Dipartimento di Scienze della Terra Università di Pavia Trentino Clima 2008 Ghiacciai alpini e riscaldamento climatico
I cartografi rappresentano l intera superficie del nostro Paese attraverso due strumenti particolari: il globo terrestre e il Planisfero.
 I cartografi rappresentano l intera superficie del nostro Paese attraverso due strumenti particolari: il globo terrestre e il Planisfero. La Terra è una sfera con un raggio di 6378 Km e una circonferenza
I cartografi rappresentano l intera superficie del nostro Paese attraverso due strumenti particolari: il globo terrestre e il Planisfero. La Terra è una sfera con un raggio di 6378 Km e una circonferenza
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2018
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 218 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 218 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA. Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo)
 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo) STAZIONI ARPAV-CMT CON ANEMOMETRO A 10 m Il Centro Meteorologico di Teolo
PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA Analisi campo vento stazioni a 10 m (ARPAV Centro Meteorologico di Teolo) STAZIONI ARPAV-CMT CON ANEMOMETRO A 10 m Il Centro Meteorologico di Teolo
Statica ed equilibrio dei corpi
 Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Statica ed equilibrio dei corpi Avendo stabilito le leggi che regolano il moto dei corpi è possibile dedurre le leggi che regolano il loro equilibrio in condizioni statiche, cioè in assenza di movimento.
Evoluzione del paesaggio
 Evoluzione del paesaggio Maria Chiara Turrini Lettere, arti e archeologia - Università degli Studi di Ferrara A.A. 2017/2018 Carsismo I carbonati sono i litotipi che più comunemente danno luogo alla formazione
Evoluzione del paesaggio Maria Chiara Turrini Lettere, arti e archeologia - Università degli Studi di Ferrara A.A. 2017/2018 Carsismo I carbonati sono i litotipi che più comunemente danno luogo alla formazione
LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE
 LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE LA TEORIA DI WEGENER NON SPIEGAVA PERCHE I CONTINENTI DI MUOVONO. FU UN GEOFISICO INGLESE, HOLMES CHE SUGGERI CHE I CONTINENTI FOSSERO MOSSI DA CORRENTI CONVETTIVE
LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE LA TEORIA DI WEGENER NON SPIEGAVA PERCHE I CONTINENTI DI MUOVONO. FU UN GEOFISICO INGLESE, HOLMES CHE SUGGERI CHE I CONTINENTI FOSSERO MOSSI DA CORRENTI CONVETTIVE
Aprile Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Aprile 2014 In Piemonte il mese di Aprile 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori rispetto alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
Il Clima in Piemonte Aprile 2014 In Piemonte il mese di Aprile 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori rispetto alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
Gli elementi geomorfologici del paesaggio. L'idrografia
 Gli elementi geomorfologici del paesaggio L'idrografia Idrografia: definizione È la scienza che studia le acque marine e terrestri sotto l'aspetto fisico, biologico. Si occupa del rilevamento, della descrizione
Gli elementi geomorfologici del paesaggio L'idrografia Idrografia: definizione È la scienza che studia le acque marine e terrestri sotto l'aspetto fisico, biologico. Si occupa del rilevamento, della descrizione
METEOROLOGIA SINOTTICA CIRCOLAZIONE GENERALE ATMOSFERICA
 Analisi della Circolazione Generale Atmosferica Forza deviante di Coriolis Conseguenze della Circolazione Generale Atmosferica Circolazione termiche Circolazione delle medie latitudini La causa fondamentale
Analisi della Circolazione Generale Atmosferica Forza deviante di Coriolis Conseguenze della Circolazione Generale Atmosferica Circolazione termiche Circolazione delle medie latitudini La causa fondamentale
METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento
 METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento LE PIOGGE DELL INVERNO E PRIMAVERA 28 (a cura di Serenella Saibanti e Roberto Barbiero) La prima parte dell anno è stata caratterizzata dalle abbondanti e frequenti
METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento LE PIOGGE DELL INVERNO E PRIMAVERA 28 (a cura di Serenella Saibanti e Roberto Barbiero) La prima parte dell anno è stata caratterizzata dalle abbondanti e frequenti
Agrometeo Mese N 7 PRIMAVERA 2016
 N 7 PRIMAVERA 216 Andamento Agroclimatico La primavera 216 (periodo marzo-maggio), rispetto ai valori medi stagionali, è stata mediamente un po più piovosa, un po più calda per le temperature minime (+.4
N 7 PRIMAVERA 216 Andamento Agroclimatico La primavera 216 (periodo marzo-maggio), rispetto ai valori medi stagionali, è stata mediamente un po più piovosa, un po più calda per le temperature minime (+.4
Il sistema carsico Stella-Basino (Gessi di Monte Mauro)
 www.venadelgesso.it I sistemi carsici nella Vena del Gesso romagnola Il sistema carsico Stella-Basino (Gessi di Monte Mauro) Torrente Sillaro Gessi di Monte Pènzola Borgo Tossignano Fiume Santerno Fiume
www.venadelgesso.it I sistemi carsici nella Vena del Gesso romagnola Il sistema carsico Stella-Basino (Gessi di Monte Mauro) Torrente Sillaro Gessi di Monte Pènzola Borgo Tossignano Fiume Santerno Fiume
Primavera 2010, misure di accumulo nevoso al ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): una stagione normale
 Primavera 2010, misure di accumulo nevoso al ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): una stagione normale SMI Redazione Nimbus, 4 giugno 2010 Il 1 giugno 2010 sono state effettuate dalla Società Meteorologica
Primavera 2010, misure di accumulo nevoso al ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): una stagione normale SMI Redazione Nimbus, 4 giugno 2010 Il 1 giugno 2010 sono state effettuate dalla Società Meteorologica
Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte 2017 L anno 2017 in Piemonte è stato il 3 più caldo degli ultimi 60 anni, con un anomalia termica di circa +1.5 C rispetto alla climatologia del periodo 1971-2000. Nel 2017 inoltre
Il Clima in Piemonte 2017 L anno 2017 in Piemonte è stato il 3 più caldo degli ultimi 60 anni, con un anomalia termica di circa +1.5 C rispetto alla climatologia del periodo 1971-2000. Nel 2017 inoltre
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2019
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 19 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-31
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 19 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-31
Meteo a Bologna - dati aggiornati ad Agosto 2006
 Meteo a Bologna - dati aggiornati ad Agosto 2006 I dati meteo registrati ad agosto nella stazione di Bologna-Borgo Panigale e comunicati dal Servizio IdroMeteorologico dell'arpa della Regione Emilia Romagna
Meteo a Bologna - dati aggiornati ad Agosto 2006 I dati meteo registrati ad agosto nella stazione di Bologna-Borgo Panigale e comunicati dal Servizio IdroMeteorologico dell'arpa della Regione Emilia Romagna
Periodicità: annuale ANDAMENTO AGROCLIMATICO MESE MAGGIO 2011
 Dipartimento per la Sicurezza del Territorio Servizio Centro Meteorologico di Teolo Copertura: regionale Frequenza: mensile Periodicità: annuale ANDAMENTO AGROCLIMATICO MESE MAGGIO 2011 Il mese di maggio
Dipartimento per la Sicurezza del Territorio Servizio Centro Meteorologico di Teolo Copertura: regionale Frequenza: mensile Periodicità: annuale ANDAMENTO AGROCLIMATICO MESE MAGGIO 2011 Il mese di maggio
Cambiamenti climatici:
 Cambiamenti climatici: Conclusioni principali dell IPCC AR4 Filippo Giorgi Abdus Salam ICTP, Trieste IPCC WGI Bureau Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici,, Roma, 12-13 13 Settembre 2007 L Effetto
Cambiamenti climatici: Conclusioni principali dell IPCC AR4 Filippo Giorgi Abdus Salam ICTP, Trieste IPCC WGI Bureau Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici,, Roma, 12-13 13 Settembre 2007 L Effetto
IL CONTINENTE AMERICANO
 IL CONTINENTE AMERICANO GLI STATI: Stati Uniti Canada Agli Stati Uniti appartiene anche l Alaska, sebbene sia territorialmente confinante con il Canada. La Groenlandia, un enorme isola a Nord Est del
IL CONTINENTE AMERICANO GLI STATI: Stati Uniti Canada Agli Stati Uniti appartiene anche l Alaska, sebbene sia territorialmente confinante con il Canada. La Groenlandia, un enorme isola a Nord Est del
Cambiamenti climatici e strategie di risposta
 IUAV Cambiamenti climatici e strategie di risposta Parte prima: clima e sistema climatico Vincenzo Ferrara - Climatologo ENEA Venezia: 9 giugno 2012 Che cos è il clima? Per i geografi, i naturalisti e
IUAV Cambiamenti climatici e strategie di risposta Parte prima: clima e sistema climatico Vincenzo Ferrara - Climatologo ENEA Venezia: 9 giugno 2012 Che cos è il clima? Per i geografi, i naturalisti e
MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI
 A cura di V. Francani VALLE GLACIALE MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI La foto descrive la morfologia tipica di una valle recentemente abbandonata dal ghiacciaio (Val Viola, Sondrio). Si notano i fianchi
A cura di V. Francani VALLE GLACIALE MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI La foto descrive la morfologia tipica di una valle recentemente abbandonata dal ghiacciaio (Val Viola, Sondrio). Si notano i fianchi
Cenni di Meteorologia
 Cenni di Meteorologia CAI Roma Scuola di Scialpinismo 10 marzo 2005 CAI Roma - Scuola di Scialpinismo 1 La temperatura nell Atmosfera Gradiente termico medio in aria calma: 6.5 C ogni 1000m 10 marzo 2005
Cenni di Meteorologia CAI Roma Scuola di Scialpinismo 10 marzo 2005 CAI Roma - Scuola di Scialpinismo 1 La temperatura nell Atmosfera Gradiente termico medio in aria calma: 6.5 C ogni 1000m 10 marzo 2005
L'IDROSFERA. Per idrosfera si intende l'insieme delle acque presenti sul nostro pianeta, sia in superficie che nel sottosuolo.
 L'IDROSFERA Per idrosfera si intende l'insieme delle acque presenti sul nostro pianeta, sia in superficie che nel sottosuolo. L'acqua è la sostanza più abbondante sulla Terra, la superficie del nostro
L'IDROSFERA Per idrosfera si intende l'insieme delle acque presenti sul nostro pianeta, sia in superficie che nel sottosuolo. L'acqua è la sostanza più abbondante sulla Terra, la superficie del nostro
Reggio Emilia, Parco Nazionale dell Appennino Tosco-Emiliano Via Comunale, Sassalbo di Fivizzano (MS)
 GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo
 Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo SMI Redazione Nimbus, 8 settembre 2009 I forti e prolungati calori dell estate
Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso): un estate caldissima annulla i benefici di un inverno nevoso. Ancora un bilancio negativo SMI Redazione Nimbus, 8 settembre 2009 I forti e prolungati calori dell estate
Febbraio Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Febbraio 2014 In Piemonte il mese di Febbraio 2014 è stato caratterizzato da precipitazioni e temperatura superiori rispetto alla norma. Nella serie storica degli ultimi 57 anni si
Il Clima in Piemonte Febbraio 2014 In Piemonte il mese di Febbraio 2014 è stato caratterizzato da precipitazioni e temperatura superiori rispetto alla norma. Nella serie storica degli ultimi 57 anni si
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2017
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 217 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-381
Profilo verticale della temperatura in atmosfera (Fig.3.16)
 Profilo verticale della temperatura in atmosfera (Fig.3.16) Il profilo verticale della temperatura si può calcolare come soluzione delle equazioni del trasferimento radiativo per la condizione media dell
Profilo verticale della temperatura in atmosfera (Fig.3.16) Il profilo verticale della temperatura si può calcolare come soluzione delle equazioni del trasferimento radiativo per la condizione media dell
POLITECNICO DI TORINO
 POLITECNICO DI TORINO Vittorio Verda Dipartimento Energia POMPE DI CALORE GEOTERMICHE Il calore della terra a casa nostra. La Geotermia: cos è, come funziona, quanto si risparmia Pompe di calore a compressione
POLITECNICO DI TORINO Vittorio Verda Dipartimento Energia POMPE DI CALORE GEOTERMICHE Il calore della terra a casa nostra. La Geotermia: cos è, come funziona, quanto si risparmia Pompe di calore a compressione
Come funziona una pompa di calore geotermica
 Come funziona una pompa di calore geotermica La pompa di calore reversibile abbinata a sonde geotermiche assorbe calore dalla terra e lo trasferisce dell'abitazione o all'acqua da scaldare in inverno;
Come funziona una pompa di calore geotermica La pompa di calore reversibile abbinata a sonde geotermiche assorbe calore dalla terra e lo trasferisce dell'abitazione o all'acqua da scaldare in inverno;
L approvvigionamento idrico nel
 L approvvigionamento idrico nel Il problema dell approvvigionamento idrico sotto i Romani riguardava non solo le esigenze domestiche ma anche quelle derivanti da un intensa vita pubblica, in particolare
L approvvigionamento idrico nel Il problema dell approvvigionamento idrico sotto i Romani riguardava non solo le esigenze domestiche ma anche quelle derivanti da un intensa vita pubblica, in particolare
Cominciamo con il confrontare le zone sismiche e la disposizione dei vulcani subaerei nel mondo
 Cominciamo con il confrontare le zone sismiche e la disposizione dei vulcani subaerei nel mondo Qui sopra è stata riportata la cartina dove sono rappresentate le zone sismiche sulla terra. Esse corrispondono
Cominciamo con il confrontare le zone sismiche e la disposizione dei vulcani subaerei nel mondo Qui sopra è stata riportata la cartina dove sono rappresentate le zone sismiche sulla terra. Esse corrispondono
Settembre Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Settembre 2014 In Piemonte il mese di Settembre 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
Il Clima in Piemonte Settembre 2014 In Piemonte il mese di Settembre 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
Associazione Il Faggio sul Lago
 Offriamo in questa sede la traduzione non ufficiale del Global Climate Report redatto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) relativo al febbraio 2018. Il documento originale, in
Offriamo in questa sede la traduzione non ufficiale del Global Climate Report redatto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) relativo al febbraio 2018. Il documento originale, in
Figura 1: ubicazione del laboratorio mobile all interno dell area di competenza dell istituto; cerchiata l area di posizionamento.
 Andamento della qualità dell aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile presso la Scuola Capasso ubicata in via Alcide De Gasperi, Acerra (NA) Il monitoraggio della qualità dell aria
Andamento della qualità dell aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile presso la Scuola Capasso ubicata in via Alcide De Gasperi, Acerra (NA) Il monitoraggio della qualità dell aria
Tempo e clima. Tempo meteorologico. Clima. condizione momentanea determinata dai vari elementi meteorologici che si verifica in un preciso momento
 Tempo e clima Tempo meteorologico condizione momentanea determinata dai vari elementi meteorologici che si verifica in un preciso momento Clima media delle condizioni meteorologiche verificatesi in un
Tempo e clima Tempo meteorologico condizione momentanea determinata dai vari elementi meteorologici che si verifica in un preciso momento Clima media delle condizioni meteorologiche verificatesi in un
BILANCI DI MASSA. Introduzione
 BILANCI DI MASSA Introduzione L evoluzione di un ghiacciaio dipende principalmente dal bilancio tra gli accumuli di acqua solida (ghiaccio, neve) e le perdite (ablazione). Il bilancio di massa è una metodologia
BILANCI DI MASSA Introduzione L evoluzione di un ghiacciaio dipende principalmente dal bilancio tra gli accumuli di acqua solida (ghiaccio, neve) e le perdite (ablazione). Il bilancio di massa è una metodologia
CAI Milano Scuola di Scialpinismo MARIO RIGHINI
 Fronte caldo L aria calda, scorrendo sulla superficie frontale, si alza, si raffredda, condensa e dà luogo a precipitazioni estese generalmente non molto intense. Queste sono annunciate dalla presenza
Fronte caldo L aria calda, scorrendo sulla superficie frontale, si alza, si raffredda, condensa e dà luogo a precipitazioni estese generalmente non molto intense. Queste sono annunciate dalla presenza
LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE
 LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE LA TEORIA DI WEGENER NON SPIEGAVA PERCHE I CONTINENTI DI MUOVONO. FU UN GEOFISICO INGLESE, HOLMES CHE SUGGERI CHE I CONTINENTI FOSSERO MOSSI DA CORRENTI CONVETTIVE
LE CORRENTI CONVETTIVE DEL MANTELLO TERRESTRE LA TEORIA DI WEGENER NON SPIEGAVA PERCHE I CONTINENTI DI MUOVONO. FU UN GEOFISICO INGLESE, HOLMES CHE SUGGERI CHE I CONTINENTI FOSSERO MOSSI DA CORRENTI CONVETTIVE
