Pulitura di un dipinto (rimozione di sporco o di sostanze indesiderate)
|
|
|
- Tommaso Bertini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SOLUZIONI
2 Le soluzioni sono dei sistemi chimico-fisici omogenei ampiamenti utilizzati sia nell ambito della ricerca che nella vita quotidiana. Per quanto riguarda l ambito del restauro le soluzioni sono utilizzate: Pulitura di un dipinto (rimozione di sporco o di sostanze indesiderate) Applicazione di adesivi, consolidanti e vernici protettive (sotto forma di soluzioni)
3 Una soluzione è un sistema omogeneo costituiti da due o piu componenti. Solvente = il componente presente in quantità maggiore. Soluto = il componente presente in quantità minore. Una soluzione deve essere: - Omogenea (chimicamente, fisicamente ed otticamente) - dispersa a livello MOLECOLARE Omogeneità: le diverse parti della soluzione devono essere indistinguibili e la composizione chimica deve essere identica in ogni punto della soluzione Dispersione molecolare: Le due sostanze miscelate devono interagire intimamente a livello molecolare
4 Vi sono SOLUZIONI LIQUIDE: un soluto,solido o liquido, è solubilizzato in un liquido SOLIDE: le leghe GASSOSE: l aria ( due o più gas mescolati tra loro).
5 Quali sono le caratteristiche che devono avere solvente e soluto perché possa formarsi una soluzione? Non è sufficiente avere una sostanza da sciogliere in un altra perché questo avvenga. Che cosa rende una sostanza solubile in un solvente ed insolubile in un altro? Se una sostanza è solubile, questo vuol dire che possiamo scioglierne quanta ne vogliamo? Se due sostanze, ad esempio cloruro di sodio e zucchero, sono solubili in un solvente, ad esempio acqua, questo vuol dire che entrambe le sostanze possono essere sciolte nella stessa quantità massima in acqua?
6 Molto dipende dalla composizione e struttura chimica sia del soluto che del solvente. Processo di solubilizzazione Una sostanza si scioglie in un liquido per dar luogo ad una soluzione quando si verificano delle forti interazioni tra le molecole del solvente e quelle del soluto.
7 Se le interazioni coinvolgono forze di tipo intermolecolare, il liquido viene definito solvente in senso stretto e per evaporazione del solvente si riottiene il soluto come corpo di fondo. (PROCESSO CHIMICO-FISICO) Se le interazioni coinvolgono forze di tipo intramolecolare, il liquido viene definito solvente reattivo e per evaporazione del solvente non si riottiene la sostanza solida di partenza ma qualche suo derivato. (PROCESSO CHIMICO)
8 L utilizzo dei solventi reattivi deve essere limitato poiché la loro azione è difficilmente controllabile. Quando se ne rende necessario l uso è importante conoscere il meccanismo di reazione, i prodotti che si formano per creare le condizioni che permettano di controllarne l azione. La solubilizzazione di soluti di natura ionica o l utilizzo di solventi ionizzanti che producono la formazione di ioni da molecole che allo stato solido non costituite da ioni non rientra nel caso dei solventi reattivi. Soffermiamo la nostra attenzione solo sui processi chimico-fisici, cioè quelli che coinvolgono i solventi in senso stretto.
9 La solubilizzazione di soluto in un solvente liquido comporta tre fasi: 1) la rottura delle forze intermolecolari soluto/soluto; 2) la rottura delle forze intermolecolari solvente/solvente; 3) la formazione di nuove forze intermolecolari soluto/solvente. Ciascuna di queste tre fasi avviene scambiando energia. Per rompere un legame è necessario fornire energia. Al contrario quando un legame si forma si ottiene energia. La somma dei tre contributi energetici è definito calore di solubilizzazione e potrà essere positivo o negativo. Quando il sistema cede calore all ambiente si parla di processo esotermico, al contrario di processo endotermico.
10 I possibili tipi di forze tra le particelle del solido e tra le particelle del liquido sono: Solido: -forze ioniche; -forze polari; -forze polari tipo legami idrogeno; -forze apolari anche dette di dispersione. Liquido: -forze polari; -forze polari tipo legami idrogeno; -forze apolari ( di dispersione). Da cosa dipendono le forze in gioco?
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 La solubilizzazione di soluto in un solvente liquido comporta tre fasi: 1) la rottura delle forze intermolecolari soluto/soluto; 2) la rottura delle forze intermolecolari solvente/solvente; 3) la formazione di nuove forze intermolecolari soluto/solvente.
23
24
25
26 I solidi cristallini hanno un reticolo tridimensionale regolare occupato da ioni o molecole tenute insieme da forze intermolecolari tutte della stessa entità. Nel processo di solubilizzazione, ciascuono ione passa dal reticolo cristallino alla sluzione venendo circondato da un numero preciso di molecole (sfera di idratazione degli ioni). Questo processo non può continuare all infinito: per i solidi ionici esiste un limite di solubilità oltre il quale il solido non si scioglie più e si deposita come corpo di fondo e precipitato. Valore massimo di solubilità
27
28
29 Osservando i grafici riportati nella slide precedente si osserva che: a) per alcune sostanze, la maggior parte, la solubilità aumenta all aumentare della temperatura; b) per poche sostanze la solubilità aumenta al diminuire della temperatura; c) Per alcune sostanze, non riportate in grafico, la solubilità non dipende dalla temperatura. A COSA E DOVUTA QUESTA DIFFERENZA?
30 Abbiamo già detto che La solubilizzazione di soluto in un solvente liquido comporta tre fasi: 1) la rottura delle forze intermolecolari soluto/soluto; 2) la rottura delle forze intermolecolari solvente/solvente; 3) la formazione di nuove forze intermolecolari soluto/solvente. Ciascuna di queste tre fasi avviene scambiando energia. Per rompere un legame è necessario fornire energia. Al contrario quando un legame si forma si ottiene energia. La somma dei tre contributi energetici è definito calore di solubilizzazione e potrà essere positivo, negativo o nullo.
31 Indicando con A le molecole di soluto e con B le molecole di solvente si ha che: Se la quantità di energia per rompere i legami intermolecolari A/A e B/B è maggiore della quantità di energia che si ottiene dalla formazione dei legami intermolecolari A/B IL PROCESSO DI SOLUBILIZZAZIONE E ENDOTERMICO, il sistema prenderà energia dall ambiente e quindi si raffredderà. Se quindi aumentiamo la temperatura riscaldando favoriamo il processo. A A, B B > A/B
32 Se la quantità di energia per rompere i legami intermolecolari A/A e B/B è minore della quantità di energia che si ottiene dalla formazione dei legami intermolecolari A/B IL PROCESSO DI SOLUBILIZZAZIONE E ESOTERMICO, il sistema cederà energia all ambiente e quindi si riscalderà. Se quindi diminuiamo la temperatura raffreddando, favoriamo il processo. A A, B B < A/B
33 Se la quantità di energia per rompere i legami intermolecolari A/A e B/B è uguale alla quantità di energia che si ottiene dalla formazione dei legami intermolecolari A/B. In questo caso si parla di soluzioni ideali. IL PROCESSO DI SOLUBILIZZAZIONE E ISOTERMICO, il sistema né cede né assorbe energia dall ambiente e quindi non cambia la sua temperatura. Se quindi diminuiamo la temperatura raffreddando o l aumentiamo riscaldando, non produciamo alcun effetto sulla solubilità. A A, B B =A/B
34 Meccanismo di solubilizzazione: il caso dei solidi amorfi La formazione delle soluzione è regolata dagli stessi principi di affinità tra solvente e soluto visti nel caso dei solidi cristallini ma il meccanismo è diverso. Nel caso di polimeri si ha una prima fase di rigonfiamento a cui corrisponde la solubilizzazione delle molecole con peso molecolare piu basso e la solvatazione parziale di quelle piu lunghe. Poi, progressivamente le molecole di solvente penetrano all interno della struttura ed iniziano a rompere i legami intermolecolari interni alla massa che si sta solubilizzando.
35 Il processo si puo fermare alla prima fase; si ha quindi solo un rigonfiamento. Il rigonfiamento puo procedere fino ad una completa modifica della forma originale dando luogo ad una dispersione di gruppi macromolecolari insolubili, i quali rimanendo in soluzione, danno un aspetto nebuloso al sistema. Si puo avere la formazione di un sistema solvente/soluto che per agitazione da luogo ad una soluzione ma che per raffreddamento e riposo si ritrasforma in una massa gelatinosa. Si puo avere la formazione di una soluzione colloidale trasparente i cui aggregato di macromolecole sono dispersi in maniera omogenea nel solvente e non hanno tendenza a formare un gel.
36 I solventi sono quindi delle sostanze in grado di scioglierne un altra. Nel caso specifico di solidi, i solventi hanno le proprietà di portare alcune sostanze solide allo stato di soluzione completa ed altre allo stato di rigonfiamento. Nella pratica si hanno a disposizione numerosi solventi possibili tra i quali bisogna fare una scelta. COME FARE LA SCELTA? Un tempo nei laboratori si faceva una distinzione tra solventi forti e solventi deboli. Alla luce di quanto detto è chiaro che i solventi non si possono distinguere tra forti e deboli ma per la natura delle sostanze che possono sciogliere e per i legami che con esse formano.
37 E inoltre importante tener conto che la maggior parte dei solventi utilizzati nel campo del restauro sono tossici e talvolta cancerogeni per l uomo. Nella scelta e nell utilizzo dei solventi bisogna essere molto cauti perché è molto facile che il solvente produca un danno permanente all opera d arte. BISOGNA QUINDI PRESTARE GRANTE ATTENZIONE ALLA POTENZIALE TOSSICITA PER L OPERATORE E LA PERICOLOSITA PER L OPERA STESSA.
38 Per trovare facilmente i solventi adeguati per ogni tipo di solido, bisogna classificare tutti i solventi e tutti i solidi a seconda delle forze d'attrazione che li caratterizzano per poi aiutarci nella loro scelta mediante l utilizzo di test di solubilità. I parametri principali da considerare nella classificazione dei solventi sono: 1. Il grado di apolarità (A) 2. Il grado di polarità (P) 3. La disponibilità a formare legami idrogeno (H)
39
40
41 Sono stati elaborati anche grafici sui quali sono riportati le solubilità delle sostanze filmogene ( Masschelein-Kleiner)
42 Nel restauro spesso si fa uso di miscele di due o piu solventi. Queste miscele sono dette miste e si assume che abbiano un comportamento che è dato dalla somma delle proprietà dei componenti puri (A,P,H) in base alla loro percentuale. Questo non è del tutto vero nel senso che se A,P ed H possono essere valutati come media pesata dei valori corrispondenti ai singoli solventi mescolati, per quanto riguarda l azione che l utilizzo di miscele produce sulle opere d arte può essere talvolta sinergica.
43 Nella scelta del solvente bisogna anche verificare la capacità di questo nei confronti del materiale da rimuovere di Ammorbidirlo Solubilizzarlo lentamente Trasformarlo in gelò piu facilmente rimovibile e che non spande Bisogna anche tener conto di altre proprietà dei solventi quali: 1. Tensione di vapore, punto di ebollizione, evaporazione, ritenzione. 2. Tensione superficiale e fenomeni correlati (bagnabilità, potere emulsionante). 3. Viscosità
44 L evaporazione L evaporazione è un fenomeno che riguarda solo la superficie del liquido, le particelle sufficientemente veloci possono vincere le forze di attrazione che le legano alle altre particelle e diventare vapore. Forze di coesione Le particelle in superficie devono vincere forze di attrazione di minore entità rispetto a quelle presenti all interno del liquido L evaporazione è favorita dall aumento della superficie del liquido, dalla ventilazione, dall incremento della temperatura. La velocità con cui il liquido evapora è diversa da liquido a liquido. Se il recipiente è aperto il liquido si raffredda e cala di livello.
45
46
47 La tensione di vapore 24 torr 55 torr Situazione iniziale Equilibrio a 25 C Equilibrio a 40 C In un recipiente chiuso, le particelle di vapore si concentrano sempre più nello spazio sovrastante il liquido, opponendosi all evaporazione e favorendo la condensazione: la velocità di evaporazione gradualmente diminuisce, quella di condensazione aumenta, finché diventano uguali; si è raggiunto uno stato di equilibrio dinamico, cioè il numero di particelle che evaporano è uguale al numero di particelle che condensano in un dato intervallo di tempo, e il vapore viene definito saturo Si chiama tensione di vapore la pressione esercitata dal vapore saturo sul proprio liquido.
48 Tensione di vapore (mm Hg) La tensione di vapore indica la tendenza di un liquido a passare allo stato di vapore (volatilità). Essa interessa tutti i liquidi e dipende, oltre che dalla natura delle particelle e dall intensità delle loro reciproche interazioni, anche dalla temperatura e dalla pressione cui si trova il liquido (l evaporazione è favorita da un aumento della temperatura e dalla diminuzione della pressione) alcol etilico benzene acqua Temperatura ( C) variazione della tensione di vapore di alcuni liquidi in funzione della temperatura
49 L ebollizione L acqua bolle a 100 C perché, a tale temperatura, la tensione di vapore dell acqua diventa pari a 1 atmosfera: in questa situazione la pressione esterna non riesce più a schiacciare le bolle di vapore che si originano dentro il liquido, che così comincia a bollire Pressione atmosferica Pressione esercitata dalle molecole di vapore che urtano contro le pareti della bolla Pressione dell atmosfera verso l interno
50 Ebollizione Prende nome di ebollizione la vaporizzazione che avviene in ogni punto del liquido, quando la tensione di vapore eguaglia la pressione esterna. Il punto di ebollizione normale di un liquido è la temperatura alla quale la sua tensione di vapore è pari ad una atmosfera. A una data pressione, l ebollizione di ogni liquido avviene ad una temperatura caratteristica e costante che prende il nome di punto di ebollizione (o temperatura di ebollizione). I liquidi più volatili dell acqua come l alcol etilico e l etere etilico, hanno un punto di ebollizione normale minore di quello dell acqua, perché la loro tensione di vapore raggiunge il valore di un atmosfera a temperature inferiori a 100 C.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75 A bassa concentrazione i Tensioattivi in soluzione abbassano la Tensione Superficiale del liquido, e mostrano solo le proprietà superficiali: maggior potere bagnante, minore diffusione verticale sotto la superficie, o minore risalita capillare. Se si vogliono solo queste proprietà superficiali il Tensioattivo deve essere usato in piccola quantità, al di sotto della sua CMC; perciò non è dunque consigliabile utilizzare Tensioattivi Non Ionici; infatti in questo caso i Tensioattivi Anionici come i Saponi o la Bile sono meglio indicati. Si deve solo tener presente che i Tensioattivi Anionici non sono compatibili con soluzioni a ph acido. A concentrazione maggiore in soluzione si formano aggregati di molecole di Tensioattivo, detti Micelle, che impartiscono alla soluzione proprietà emulsionanti, detergenti e solubilizzanti. La quantità di Tensioattivo necessaria perché si verifichi questa situazione viene detta appunto Concentrazione Micellare Critica, o CMC, ed é caratteristica per ogni Tensioattivo.
76
77
78
79
80
81
82
83
84 EMULSIONI MAGRE EMULSIONI GRASSE OLIO IN ACQUA ACQUA IN OLIO MEZZO O FASE DISPERDENTE- MEZZO O FASE DISPERSA si può variare il volume di fase interna (quella dispersa) a seconda delle proprietà che si vogliono dall'emulsione: a "bassa fase interna", cioè a bassa concentrazione di fase dispersa, l'emulsione sarà fluida, sostanzialmente con le caratteristiche della fase disperdente (un'emulsione di poco "Olio" in acqua avrà sostanzialmente le caratteristiche di una fase acquosa), mentre a maggiore concentrazione si potranno ottenere emulsioni sempre più viscose, fino ad arrivare a paste dense, che non scorrono più. Se nella preparazione si utilizza forte agitazione meccanica é più semplice ottenere particelle di piccole dimensioni, che contribuiscono alla viscosità e alla maggiore stabilità dell'emulsione.
85
86 L efficacia della soluzione è sorprendente; la saliva artificiale, applicata a tampone o a pennello, scioglie in breve lo sporco superficiale rispettando la patina naturale dovuta all invecchiamento. L azione chelante del citrato probabilmente contribuisce a rimuovere le tracce verdastre dei prodotti di corrosione delle leghe di rame impiegate per le corde rivestite. La saliva e lo sporco possono essere rimossi facilmente con un tampone di cotone, e non è necessario alcun risciacquo. La saliva viene passata con un pennello a setole morbide sulla superficie da pulire, e l azione detergente è favorita da un leggero strofinio; non appena lo sporco si smuove, si pulisce e si asciuga con un tamponcino di cotone o di tela. Eventualmente, si riprende la zona appena pulita finché il risultato è soddisfacente
87
88
89
90 Brij 35 Tween 20 idrossipropilcellulosa
91 Emulsioni magre Quelle a "bassa fase interna" possono essere usate nella pulitura. Poco solvente organico (immiscibile con acqua, come ad esempio Esteri o Idrocarburi) emulsionato in acqua fornisce un'emulsione che ha sostanzialmente le proprietà applicative dell'acqua pura (viscosità, ecc.) ma ha potere solvente modificato. In altre parole, aggiungiamo alla soluzione acquosa un po' di potere solvente di tipo lipofilo, che può aiutare nella solubilizzazione di un certo tipo di materiale lipofilo. Quindi senza cambiare sostanzialmente il mezzo, che resta un mezzo acquoso e si comporta a tutti gli effetti principalmente come un mezzo acquoso (e, non trascurabile, con la atossicità di un mezzo acquoso!), lo modifichiamo leggermente dandogli la capacità di agire su materiali altrimenti insolubili in mezzo acquoso. La consistenza cremosa, in particolare, determina caratteristiche applicative completamente diverse da quelle del solo mezzo acquoso. L omogeneità della emulsione influenza i risultati.
92 EMULSIONE CEROSA STEARICA Un'emulsione con importanti scopi applicativi, composta di Cera emulsionata in acqua con un Tensioattivo anionico, lo Stearato d'ammonio (preparato a partire da Acido Stearico e Ammoniaca), è la nota Emulsione Cerosa o Stearica (la "Pappina Fiorentina ). A rigore si tratta di una "Dispersione", in quanto la fase interna, la Cera d'api, non è liquida ma solida. Non è utilizzata coma agente di pulitura essa stessa, ma quale supportante di soluzioni acquose e/o solventi organici per localizzare e circoscrivere l'azione, e per limitare la diffusione sotto superficiale. Se preparata correttamente ha ph neutro. Può essere resa basica per aggiunta di ulteriore Ammonio Idrossido o di altre sostanze alcaline, ma non può essere resa acida (in quanto il Tensioattivo che agisce da emulsionante, lo Ammonio Stearato, è Anionico).
93
94
95
96 RESIN SOAPS
97
98
LE PROPRIETA DELLA MATERIA
 LE PROPRIETA DELLA MATERIA Gli aspetti macroscopico, microscopico e particellare della materia La materia è tutto ciò che possiede una massa e occupa un volume, cioè una porzione di spazio Un campione
LE PROPRIETA DELLA MATERIA Gli aspetti macroscopico, microscopico e particellare della materia La materia è tutto ciò che possiede una massa e occupa un volume, cioè una porzione di spazio Un campione
SOLUZIONI E CONCENTRAZIONE
 SOLUZIONI E CONCENTRAZIONE Miscela omogenea di due o più sostanze: solvente (presente in maggiore quantità) + soluto In genere il solvente è liquido (es.acqua) mentre il soluto può essere solido, liquido,
SOLUZIONI E CONCENTRAZIONE Miscela omogenea di due o più sostanze: solvente (presente in maggiore quantità) + soluto In genere il solvente è liquido (es.acqua) mentre il soluto può essere solido, liquido,
Lo stato liquido. Un liquido non ha una forma propria, ma ha la forma del recipiente che lo contiene; ha però volume proprio e non è comprimibile.
 I liquidi Lo stato liquido Lo stato liquido rappresenta una condizione intermedia tra stato aeriforme e stato solido, tra lo stato di massimo disordine e quello di perfetto ordine Un liquido non ha una
I liquidi Lo stato liquido Lo stato liquido rappresenta una condizione intermedia tra stato aeriforme e stato solido, tra lo stato di massimo disordine e quello di perfetto ordine Un liquido non ha una
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 13 Le proprietà delle soluzioni 1. Perchè le sostanze si sciolgono? 2. La solubilità 3. La concentrazione
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 13 Le proprietà delle soluzioni 1. Perchè le sostanze si sciolgono? 2. La solubilità 3. La concentrazione
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu
 Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 8 La chimica dell acqua 3 Sommario 1. Come si formano i legami chimici 2. I legami covalenti ionici 3. La molecola dell acqua
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 8 La chimica dell acqua 3 Sommario 1. Come si formano i legami chimici 2. I legami covalenti ionici 3. La molecola dell acqua
PASSAGGI DI STATO. sublimazione fusione ebollizione. solidificazione. condensazione. brinamento. Calore processi fisici endotermici ( H>0).
 PASSAGGI DI STATO Calore processi fisici endotermici (H>0). sublimazione fusione ebollizione S solidificazione L condensazione V brinamento Scrittura in formule: - H 2 O (s) H 2 O (l) fusione - H 2 O (l)
PASSAGGI DI STATO Calore processi fisici endotermici (H>0). sublimazione fusione ebollizione S solidificazione L condensazione V brinamento Scrittura in formule: - H 2 O (s) H 2 O (l) fusione - H 2 O (l)
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu
 Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 17 Le proprietà delle soluzioni 3 Sommario (I) 1. Perché le sostanze si sciolgono? 2. Soluzioni acquose ed elettroliti 3. La
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 17 Le proprietà delle soluzioni 3 Sommario (I) 1. Perché le sostanze si sciolgono? 2. Soluzioni acquose ed elettroliti 3. La
1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e apolari 3. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London 4. Il legame a idrogeno 5. Legami a confronto
 Unità n 12 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e apolari 3. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London 4. Il legame a idrogeno
Unità n 12 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e apolari 3. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London 4. Il legame a idrogeno
Capitolo 12 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia
 Capitolo 12 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e apolari 3. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London 4. Il legame a idrogeno
Capitolo 12 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e apolari 3. Le forze dipolo-dipolo e le forze di London 4. Il legame a idrogeno
Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni)
 Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni) Primo principio della termodinamica L energia non si può creare o distruggere, ma solo convertire da una forma all altra. Questo significa
Dinamica delle reazioni chimiche (attenzione: mancano i disegni) Primo principio della termodinamica L energia non si può creare o distruggere, ma solo convertire da una forma all altra. Questo significa
Un elemento è una sostanza pura che non può essere divisa in sostanze più semplici. Le sue molecole sono tutte uguali.
 Elementi, composti, miscugli Un elemento è una sostanza pura che non può essere divisa in sostanze più semplici. Le sue molecole sono tutte uguali. Il composto è formato da sostanze pure scomponibili in
Elementi, composti, miscugli Un elemento è una sostanza pura che non può essere divisa in sostanze più semplici. Le sue molecole sono tutte uguali. Il composto è formato da sostanze pure scomponibili in
Le proprietà colligative delle soluzioni
 1 Approfondimento 1.3 Le proprietà colligative delle soluzioni In un solvente puro, cioè senza soluti disciolti in esso, le molecole sono libere di interagire tra loro, attraendosi. L aggiunta di un soluto
1 Approfondimento 1.3 Le proprietà colligative delle soluzioni In un solvente puro, cioè senza soluti disciolti in esso, le molecole sono libere di interagire tra loro, attraendosi. L aggiunta di un soluto
Distribuzione e Temperatura. Pressione di Vapore. Evaporazione
 Evaporazione Le molecole del Liquido hanno una distribuzione di energia cinetica. Una frazione di molecole della superficie del liquido ha energia cinetica sufficiente per sfuggire all attrazione attrazione
Evaporazione Le molecole del Liquido hanno una distribuzione di energia cinetica. Una frazione di molecole della superficie del liquido ha energia cinetica sufficiente per sfuggire all attrazione attrazione
Tensione di vapore evaporazione
 Transizioni di fase Una sostanza può esistere in tre stati fisici: solido liquido gassoso Il processo in cui una sostanza passa da uno stato fisico ad un altro è noto come transizione di fase o cambiamento
Transizioni di fase Una sostanza può esistere in tre stati fisici: solido liquido gassoso Il processo in cui una sostanza passa da uno stato fisico ad un altro è noto come transizione di fase o cambiamento
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu
 Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 15 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 3 Sommario 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 15 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 3 Sommario 1. Le forze intermolecolari 2. Molecole polari e
Trasformazioni fisiche della materia: i passaggi di stato
 Trasformazioni fisiche della materia: i passaggi di stato Nelle condizioni terrestri la materia può presentarsi in tre differenti stati fisici o stati di aggregazione: solido, liquido e aeriforme. I solidi
Trasformazioni fisiche della materia: i passaggi di stato Nelle condizioni terrestri la materia può presentarsi in tre differenti stati fisici o stati di aggregazione: solido, liquido e aeriforme. I solidi
FORZE INTERMOLECOLARI
 FORZE INTERMOLECOLARI Le forze intermolecolari sono forze di attrazione che si stabiliscono tra le molecole che costituiscono una sostanza Determinano la tendenza delle molecole ad avvicinarsi. Per ogni
FORZE INTERMOLECOLARI Le forze intermolecolari sono forze di attrazione che si stabiliscono tra le molecole che costituiscono una sostanza Determinano la tendenza delle molecole ad avvicinarsi. Per ogni
Le idee della chimica
 G. Valitutti A.Tifi A.Gentile Seconda edizione Copyright 2009 Zanichelli editore Capitolo 2 Le trasformazioni fisiche della materia 1. La materia e le sue caratteristiche 2. I sistemi omogenei e i sistemi
G. Valitutti A.Tifi A.Gentile Seconda edizione Copyright 2009 Zanichelli editore Capitolo 2 Le trasformazioni fisiche della materia 1. La materia e le sue caratteristiche 2. I sistemi omogenei e i sistemi
Esercitazioni di Elementi di Chimica. Modulo 3 Trasformazioni della Materia
 Esercitazioni di Elementi di Chimica Modulo 3 Trasformazioni della Materia Esempi di quiz a risposta multipla e questionari a completamento L esame finale sarà composto da problemi simili Quale/i dei seguenti
Esercitazioni di Elementi di Chimica Modulo 3 Trasformazioni della Materia Esempi di quiz a risposta multipla e questionari a completamento L esame finale sarà composto da problemi simili Quale/i dei seguenti
Termodinamica Chimica
 Universita degli Studi dell Insubria Corsi di Laurea in Scienze Chimiche e Chimica Industriale Termodinamica Chimica Equilibrio Liquido-Vapore dario.bressanini@uninsubria.it http://scienze-como.uninsubria.it/bressanini
Universita degli Studi dell Insubria Corsi di Laurea in Scienze Chimiche e Chimica Industriale Termodinamica Chimica Equilibrio Liquido-Vapore dario.bressanini@uninsubria.it http://scienze-como.uninsubria.it/bressanini
LEZIONE 4. Le soluzioni
 LEZIONE 4 Le soluzioni Le soluzioni sono miscugli omogenei i cui costituenti conservano le loro proprietà. Nelle soluzioni il solvente è il componente in maggiore quantità. Il soluto è il componente delle
LEZIONE 4 Le soluzioni Le soluzioni sono miscugli omogenei i cui costituenti conservano le loro proprietà. Nelle soluzioni il solvente è il componente in maggiore quantità. Il soluto è il componente delle
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA DIAGRAMMI DI STATO DI COMPONENTI PURI
 GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA DIAGRAMMI DI STATO DI COMPONENTI PURI Forti interazioni intermolecolari SOLIDI Assenza di libero movimento delle molecole Volume e forma propria Rigidi e incomprimibili
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA DIAGRAMMI DI STATO DI COMPONENTI PURI Forti interazioni intermolecolari SOLIDI Assenza di libero movimento delle molecole Volume e forma propria Rigidi e incomprimibili
Sostanza pura. Il termine sostanza indica il tipo di materia di cui è fatto un corpo.
 Sostanza pura Il termine sostanza indica il tipo di materia di cui è fatto un corpo. Corpi formati da un unico tipo di materia sono costituiti da sostanze pure. Una sostanza pura ha composizione definita
Sostanza pura Il termine sostanza indica il tipo di materia di cui è fatto un corpo. Corpi formati da un unico tipo di materia sono costituiti da sostanze pure. Una sostanza pura ha composizione definita
L equilibrio dell acqua
 L equilibrio dell acqua Il ph e la reazione di autoprotolisi dell acqua Corpaci Ivana La molecola dell acqua H O H! L acqua è un composto molecolare covalente! La sua molecola è polare per la differenza
L equilibrio dell acqua Il ph e la reazione di autoprotolisi dell acqua Corpaci Ivana La molecola dell acqua H O H! L acqua è un composto molecolare covalente! La sua molecola è polare per la differenza
GAIALAB:INCONTRIAMO L AMBIENTE IN LABORATORIO
 LABORATORIO DI CHIMICA Dal ghiaccio al vapore: scoperta guidata delle proprietà dell acqua Ogni elemento chimico può esistere allo stato gassoso, allo stato liquido e in quello solido. Il passaggio da
LABORATORIO DI CHIMICA Dal ghiaccio al vapore: scoperta guidata delle proprietà dell acqua Ogni elemento chimico può esistere allo stato gassoso, allo stato liquido e in quello solido. Il passaggio da
CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE. Lezione del 5 Maggio 2016
 CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE Lezione del 5 Maggio 2016 Sali Acidi o Basici La neutralità acido-base dell acqua può essere alterata anche dal discioglimento di alcuni sali. Prendiamo ad esempio NH 4
CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE Lezione del 5 Maggio 2016 Sali Acidi o Basici La neutralità acido-base dell acqua può essere alterata anche dal discioglimento di alcuni sali. Prendiamo ad esempio NH 4
CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE. Lezione del 12 Aprile 2016
 CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE Lezione del 12 Aprile 2016 Proprietà dei Metalli Malleabilità: i metalli possono esser facilmente ridotti in lamine sottili per battitura Duttilità: i metalli possono essere
CORSO DI CHIMICA PER L AMBIENTE Lezione del 12 Aprile 2016 Proprietà dei Metalli Malleabilità: i metalli possono esser facilmente ridotti in lamine sottili per battitura Duttilità: i metalli possono essere
La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici
 La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici Materia = tutto ciò che possiede una massa ed occupa uno spazio Energia =
La Termodinamica è la disciplina che si occupa dello studio degli scambi di energia e di materia nei processi fisici e chimici Materia = tutto ciò che possiede una massa ed occupa uno spazio Energia =
LA MATERIA E IL MODELLO PARTICELLARE
 LA MATERIA E IL MODELLO PARTICELLARE - Gli oggetti che ci circondano sono costituiti di materia. - Come possiamo definire la materia? La materia è tutto ciò che possiede una massa e occupa un volume. -
LA MATERIA E IL MODELLO PARTICELLARE - Gli oggetti che ci circondano sono costituiti di materia. - Come possiamo definire la materia? La materia è tutto ciò che possiede una massa e occupa un volume. -
1.La forma delle molecole 2.La teoria VSEPR 3.Molecole polari e apolari 4.Le forze intermolecolari 5.Legami a confronto
 1.La forma delle molecole 2.La teoria VSEPR 3.Molecole polari e apolari 4.Le forze intermolecolari 5.Legami a confronto 1 1. La forma delle molecole Molte proprietà delle sostanze dipendono dalla forma
1.La forma delle molecole 2.La teoria VSEPR 3.Molecole polari e apolari 4.Le forze intermolecolari 5.Legami a confronto 1 1. La forma delle molecole Molte proprietà delle sostanze dipendono dalla forma
 positiva, endotermico (la soluzione si raffredda) negativa, esotermico (la soluzione si scalda). DH sol = E ret + E solv concentrazione Molare Esempio: Preparare mezzo litro (0,5 l) di soluzione acquosa
positiva, endotermico (la soluzione si raffredda) negativa, esotermico (la soluzione si scalda). DH sol = E ret + E solv concentrazione Molare Esempio: Preparare mezzo litro (0,5 l) di soluzione acquosa
Soluzioni unità 3, modulo D del libro
 Soluzioni unità 3, modulo D del libro SOLUZIONE: miscela omogenea di 2 o più sostanze Particelle dei componenti di dimensioni molecolari Componenti distribuiti in maniera caotica Se manca uno di questi
Soluzioni unità 3, modulo D del libro SOLUZIONE: miscela omogenea di 2 o più sostanze Particelle dei componenti di dimensioni molecolari Componenti distribuiti in maniera caotica Se manca uno di questi
Le soluzioni. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti
 Le soluzioni Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti VIDEO Introduzione (I) La materia che ci circonda normalmente non è formata da elementi chimici o da composti, ma da miscugli, cioè insiemi di più sostanze
Le soluzioni Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti VIDEO Introduzione (I) La materia che ci circonda normalmente non è formata da elementi chimici o da composti, ma da miscugli, cioè insiemi di più sostanze
La misura della temperatura
 Calore e temperatura 1. La misura della temperatura 2. La dilatazione termica 3. La legge fondamentale della termologia 4. Il calore latente 5. La propagazione del calore La misura della temperatura La
Calore e temperatura 1. La misura della temperatura 2. La dilatazione termica 3. La legge fondamentale della termologia 4. Il calore latente 5. La propagazione del calore La misura della temperatura La
INDICE PARTE PRIMA LE RISORSE MATERIALI ED ENERGETICHE E L'ANALISI DELLE LORO PROPRIETÀ STRUTTURALI E TERMODINAMICHE
 INDICE Nota dell'autore 9 PARTE PRIMA LE RISORSE MATERIALI ED ENERGETICHE E L'ANALISI DELLE LORO PROPRIETÀ STRUTTURALI E TERMODINAMICHE Capitolo I La formazione dell'universo 11 1.1 La storia dell universo
INDICE Nota dell'autore 9 PARTE PRIMA LE RISORSE MATERIALI ED ENERGETICHE E L'ANALISI DELLE LORO PROPRIETÀ STRUTTURALI E TERMODINAMICHE Capitolo I La formazione dell'universo 11 1.1 La storia dell universo
Elementi sistemati nella TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI in base al numero atomico crescente O, H, N, C (+ del 96% della materia vivente)
 OVERVIEW Atomo: più piccola porzione di un elemento che mantiene le proprietà chimiche dello stesso Teoria atomica e tavola periodica Legami e interazioni degli atomi Acqua e le sue proprietà Acidi e basi
OVERVIEW Atomo: più piccola porzione di un elemento che mantiene le proprietà chimiche dello stesso Teoria atomica e tavola periodica Legami e interazioni degli atomi Acqua e le sue proprietà Acidi e basi
Statistiche domande. di 11. chimica generale Esami Esame 7986 Statistiche. Esame del: elementi chimica generale: Bioinformatica
 chimica generale Esami Esame 7986 Statistiche Esame del: 04-02-2015 elementi chimica generale: Bioinformatica Statistiche domande 1) All'aumentare della pressione cosa succede al punto di fusione del ghiaccio?
chimica generale Esami Esame 7986 Statistiche Esame del: 04-02-2015 elementi chimica generale: Bioinformatica Statistiche domande 1) All'aumentare della pressione cosa succede al punto di fusione del ghiaccio?
9065X Chimica. Modello esame svolto. Esempio di compito scritto di Chimica. Politecnico di Torino CeTeM
 svolto Esempio di compito scritto di Chimica 1 - La configurazione elettronica: [Ar]3d 6 4s 0 rappresenta lo ione: 1) Mn 2+ 2) Ni 2+ 3) Fe 3+ 4) Co 3+ 5) Cu 2+ 2 - Un gas reale mantenuto sempre al di sopra
svolto Esempio di compito scritto di Chimica 1 - La configurazione elettronica: [Ar]3d 6 4s 0 rappresenta lo ione: 1) Mn 2+ 2) Ni 2+ 3) Fe 3+ 4) Co 3+ 5) Cu 2+ 2 - Un gas reale mantenuto sempre al di sopra
I legami fra molecole nei liquidi non sono forti ed esse possono fluire Riducendo l agitazione termica. legami tra molecole più stabili
 I legami fra molecole nei liquidi non sono forti ed esse possono fluire Riducendo l agitazione termica legami tra molecole più stabili formazione una massa rigida Una disposizione ordinata delle molecole
I legami fra molecole nei liquidi non sono forti ed esse possono fluire Riducendo l agitazione termica legami tra molecole più stabili formazione una massa rigida Una disposizione ordinata delle molecole
FORZE INTERMOLECOLARI o LEGAMI DEBOLI
 FRZE INTERMLECLARI o LEGAMI DEBLI 1 Le forze intermolecolari sono forze attrattive tra entità discrete come atomi o molecole, dette anche legami o interazioni deboli (E
FRZE INTERMLECLARI o LEGAMI DEBLI 1 Le forze intermolecolari sono forze attrattive tra entità discrete come atomi o molecole, dette anche legami o interazioni deboli (E
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E PROPRIETÀ DEI FLUIDI
 STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E PROPRIETÀ DEI FLUIDI 14/01/2014 2 Una porzione di materia costituita da una sostanza la cui composizione chimica non varia da un punto all altro si dice costituita
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E PROPRIETÀ DEI FLUIDI 14/01/2014 2 Una porzione di materia costituita da una sostanza la cui composizione chimica non varia da un punto all altro si dice costituita
Stati della materia. Esempio. Fusione e solidificazione. Esempio. Stati di aggregazione della materia
 Stati della materia STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E GAS PERFETTI Cosa sono gli stati della materia? Gli stati della materia sono come si presenta la materia nell universo fisico e dipendono dalla
Stati della materia STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA E GAS PERFETTI Cosa sono gli stati della materia? Gli stati della materia sono come si presenta la materia nell universo fisico e dipendono dalla
Combustione. Energia chimica. Energia termica Calore. Combustibili fossili
 Combustione La combustione è un processo di ossidazione rapido con produzione di luce e calore, con trasformazione di energia chimica in energia termica Energia chimica Combustibili fossili Energia termica
Combustione La combustione è un processo di ossidazione rapido con produzione di luce e calore, con trasformazione di energia chimica in energia termica Energia chimica Combustibili fossili Energia termica
Stati della materia. Stati della materia
 Stati della materia La materia può esistere in 3 diversi STATI DI AGGREGAZIONE: SOLIDO LIQUIDO GASSOSO MACROSCOPICHE MICROSCOPICHE Stati della materia Lo stato di aggregazione di una sostanza dipende dal
Stati della materia La materia può esistere in 3 diversi STATI DI AGGREGAZIONE: SOLIDO LIQUIDO GASSOSO MACROSCOPICHE MICROSCOPICHE Stati della materia Lo stato di aggregazione di una sostanza dipende dal
MOLECOLE. 2 - i legami chimici. Prof. Vittoria Patti
 MOLECOLE 2 - i legami chimici Prof. Vittoria Patti Gli stati di aggregazione della materia STATO SOLIDO molecole ravvicinate, struttura ordinata, volume proprio, forma propria STATO LIQUIDO molecole
MOLECOLE 2 - i legami chimici Prof. Vittoria Patti Gli stati di aggregazione della materia STATO SOLIDO molecole ravvicinate, struttura ordinata, volume proprio, forma propria STATO LIQUIDO molecole
Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A.
 MATERIA CHIMICA CLASSE 2 INDIRIZZO AFM / TUR DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA MATERIA Aver acquisito la capacità di osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni
MATERIA CHIMICA CLASSE 2 INDIRIZZO AFM / TUR DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA MATERIA Aver acquisito la capacità di osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni
Stechiometria delle soluzioni
 www.matematicamente.it stechiometria delle soluzioni (medicina) 1 Stechiometria delle soluzioni Domande tratte dai test di ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria 1. Se si vuole ottenere una soluzione
www.matematicamente.it stechiometria delle soluzioni (medicina) 1 Stechiometria delle soluzioni Domande tratte dai test di ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria 1. Se si vuole ottenere una soluzione
EQUILIBRI DI SOLUBILITA
 EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità In generale solo una quantità finita di un solido si scioglie in un dato volume di solvente dando luogo ad una soluzione satura, cioè una soluzione in equilibrio con
EQUILIBRI DI SOLUBILITA Solubilità In generale solo una quantità finita di un solido si scioglie in un dato volume di solvente dando luogo ad una soluzione satura, cioè una soluzione in equilibrio con
Gli stati di aggregazione della materia
 Gli stati di aggregazione della materia STATO SOLIDO La materia allo stato solido possiede una propria forma e un proprio volume, quindi è rigida (indeformabile) e incomprimibile. Questo perché le particelle
Gli stati di aggregazione della materia STATO SOLIDO La materia allo stato solido possiede una propria forma e un proprio volume, quindi è rigida (indeformabile) e incomprimibile. Questo perché le particelle
LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA
 Capitolo 2 LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA N.B I concetti proposti sulle slide, in linea di massima seguono l ordine e i contenuti del libro, ma!!!! Ci possono essere delle variazioni Prof. Vincenzo
Capitolo 2 LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA N.B I concetti proposti sulle slide, in linea di massima seguono l ordine e i contenuti del libro, ma!!!! Ci possono essere delle variazioni Prof. Vincenzo
Gli stati di aggregazione della materia.
 Gli stati di aggregazione della materia. Stati di aggregazione della materia: Solido, liquido, gassoso Passaggi di stato: Solido Liquido (fusione) e liquido solido (solidificazione); Liquido aeriforme
Gli stati di aggregazione della materia. Stati di aggregazione della materia: Solido, liquido, gassoso Passaggi di stato: Solido Liquido (fusione) e liquido solido (solidificazione); Liquido aeriforme
1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5.
 Unità n 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5. La legge di Gay-Lussac o legge
Unità n 6 Le leggi dei gas 1. Lo studio dei gas nella storia 2. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare 3. La pressione dei gas 4. La legge di Boyle o legge isoterma 5. La legge di Gay-Lussac o legge
Organizzazione della materia
 Organizzazione della materia Elementi: sostanze che non possono essere scisse in altre più semplici mediante reazioni chimiche ordinarie. Atomo: è la porzione più piccola di un elemento, formato da 3 particelle
Organizzazione della materia Elementi: sostanze che non possono essere scisse in altre più semplici mediante reazioni chimiche ordinarie. Atomo: è la porzione più piccola di un elemento, formato da 3 particelle
IL CALORE. Il calore. Esperimento di Joule. Il calore
 l calore l calore Q è energia che sta transitando da un sistema all altro, e compare ogni volta che c è un dislivello di temperatura. L CALORE l corpo più caldo cede parte della sua energia interna al
l calore l calore Q è energia che sta transitando da un sistema all altro, e compare ogni volta che c è un dislivello di temperatura. L CALORE l corpo più caldo cede parte della sua energia interna al
Diagramma di fase f(p,v,t)=0
 Diagramma di fase f(p,v,t)=0 Taglio P(V) (per diversi valori di T) Prospetto P(T) Prospetto P(T): variazione di volume alla fusione Congelando si contrae Es: anidride carbonica Congelando si espande
Diagramma di fase f(p,v,t)=0 Taglio P(V) (per diversi valori di T) Prospetto P(T) Prospetto P(T): variazione di volume alla fusione Congelando si contrae Es: anidride carbonica Congelando si espande
METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI
 METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI I metodi gravimetrici si basano sulla misura della massa e sono sostanzialmente di due tipi: - nei metodi di precipitazione l analita viene trasformato in un precipitato
METODI GRAVIMETRICI DI ANALISI I metodi gravimetrici si basano sulla misura della massa e sono sostanzialmente di due tipi: - nei metodi di precipitazione l analita viene trasformato in un precipitato
Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia. Corso di Analisi Chimico-Tossicologica.
 Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia Corso di Analisi Chimico-Tossicologica Distillazione La distillazione La distillazione consiste nel vaporizzare un liquido
Università Degli Studi di Cagliari Facoltà Farmacia Corso di laurea in Tossicologia Corso di Analisi Chimico-Tossicologica Distillazione La distillazione La distillazione consiste nel vaporizzare un liquido
Lo stato liquido: il modello
 Lo stato liquido: il modello lemolecolesonoin moto perpetuo e casuale(moto Browniano) l'energia del moto: è dello stesso ordine di grandezza dell'energia di interazione tra le molecole dipende dalla temperatura(agitazione
Lo stato liquido: il modello lemolecolesonoin moto perpetuo e casuale(moto Browniano) l'energia del moto: è dello stesso ordine di grandezza dell'energia di interazione tra le molecole dipende dalla temperatura(agitazione
Chimica e laboratorio
 ITIS H.HERTZ Progetto Monoennio Chimica e laboratorio PARTE PRIMA I MODULO: Struttura atomica e molecolare della materia PESO : 70% UNITA ORARIE PREVISTE : 20 h Unità A: ATOMI Descrivere le caratteristiche
ITIS H.HERTZ Progetto Monoennio Chimica e laboratorio PARTE PRIMA I MODULO: Struttura atomica e molecolare della materia PESO : 70% UNITA ORARIE PREVISTE : 20 h Unità A: ATOMI Descrivere le caratteristiche
ACQUA negli ALIMENTI. E il principale costituente di molti alimenti: E il mezzo in cui avvengono moltissime reazioni; Carne 65-75% Latte 87%
 ACQUA negli ALIMENTI E il principale costituente di molti alimenti: E il mezzo in cui avvengono moltissime reazioni; Carne 65-75% Latte 87% La rimozione dell acqua ritarda molte reazioni ed inibisce la
ACQUA negli ALIMENTI E il principale costituente di molti alimenti: E il mezzo in cui avvengono moltissime reazioni; Carne 65-75% Latte 87% La rimozione dell acqua ritarda molte reazioni ed inibisce la
Legame chimico e proprietà delle sostanze
 I solidi hanno volume e forma propria. Stati di aggregazione della materia stato solido stato liquido stato gassoso Il loro volume dipende da temperatura e pressione e in generale aumenta leggermente all
I solidi hanno volume e forma propria. Stati di aggregazione della materia stato solido stato liquido stato gassoso Il loro volume dipende da temperatura e pressione e in generale aumenta leggermente all
CORSO DI CHIMICA. Esercitazione del 7 Giugno 2016
 CORSO DI CHIMICA Esercitazione del 7 Giugno 2016 25 ml di una miscela di CO e CO 2 diffondono attraverso un foro in 38 s. Un volume uguale di O 2 diffonde nelle stesse condizioni in 34,3 s. Quale è la
CORSO DI CHIMICA Esercitazione del 7 Giugno 2016 25 ml di una miscela di CO e CO 2 diffondono attraverso un foro in 38 s. Un volume uguale di O 2 diffonde nelle stesse condizioni in 34,3 s. Quale è la
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI CLASSE A033 TEST FINALE DEL CORSO DI CHIMICA
 PERCORSI ABILITANTI SPECIALI 2014 - CLASSE A033 TEST FINALE DEL CORSO DI CHIMICA Cognome Nome Numero progressivo sul registro 1. Viene disciolto zucchero in un certo volume di acqua pura fino a che si
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI 2014 - CLASSE A033 TEST FINALE DEL CORSO DI CHIMICA Cognome Nome Numero progressivo sul registro 1. Viene disciolto zucchero in un certo volume di acqua pura fino a che si
Principi di Biochimica
 Principi di Biochimica Augusto Innocenti Biologo Nutrizionista Perfezionamento in Biochimica e Biologia Molecolare Phd in Neurobiologia e Neurofisiologia Materia: Atomi e Molecole La materie è costituita
Principi di Biochimica Augusto Innocenti Biologo Nutrizionista Perfezionamento in Biochimica e Biologia Molecolare Phd in Neurobiologia e Neurofisiologia Materia: Atomi e Molecole La materie è costituita
L ACQUA E LE SUE PROPRIETÀ
 L ACQUA E LE SUE PROPRIETÀ L acqua è una sostanza indispensabile per tutte le forme di vita. Ogni molecola di acqua (H2O) è formata da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, uniti tramite due legami
L ACQUA E LE SUE PROPRIETÀ L acqua è una sostanza indispensabile per tutte le forme di vita. Ogni molecola di acqua (H2O) è formata da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, uniti tramite due legami
Termodinamica e termochimica
 Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
Termodinamica e termochimica La termodinamica è una scienza che studia proprietà macroscopiche della materia e prevede quali processi chimici e fisici siano possibili, in quali condizioni e con quali energie
SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI
 SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI UNITÀ FORMATIVA N 1 - CLASSE 2 A Professionale TITOLO: Le formule dei composti e le reazioni chimiche Periodo/Durata: settembre-ottobre/ 12 ore Saper
SCHEDA PROGRAMMAZIONE UNITÀ FORMATIVE DISCIPLINARI UNITÀ FORMATIVA N 1 - CLASSE 2 A Professionale TITOLO: Le formule dei composti e le reazioni chimiche Periodo/Durata: settembre-ottobre/ 12 ore Saper
Introduzione alla Chimica. Paolo Mazza
 Introduzione alla Chimica Paolo Mazza 2 aprile 2013 Indice 1 Introduzione 2 2 Le teorie della materia 4 2.1 Teoria atomica.................................... 4 2.2 Teoria cinetica.....................................
Introduzione alla Chimica Paolo Mazza 2 aprile 2013 Indice 1 Introduzione 2 2 Le teorie della materia 4 2.1 Teoria atomica.................................... 4 2.2 Teoria cinetica.....................................
pressione esercitata dalle molecole di gas in equilibrio con Si consideri una soluzione di B in A. Per una soluzione ideale
 PROPRIETA COLLIGATIVE Proprietà che dipendono solo dal numero di particelle presenti in soluzione 1. TENSIONE DI VAPORE 2. INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO 3. ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO 4. PRESSIONE OSMOTICA
PROPRIETA COLLIGATIVE Proprietà che dipendono solo dal numero di particelle presenti in soluzione 1. TENSIONE DI VAPORE 2. INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO 3. ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO 4. PRESSIONE OSMOTICA
FORZA DI COESIONE mantiene le molecole di un liquidi unite le une e alle altre
 BAGNABILITA FORZA DI COESIONE mantiene le molecole di un liquidi unite le une e alle altre FORZA DI ADESIONE rappresenta la forza con cui le molecole del liquido l aderiscono alla superficie di un materiale
BAGNABILITA FORZA DI COESIONE mantiene le molecole di un liquidi unite le une e alle altre FORZA DI ADESIONE rappresenta la forza con cui le molecole del liquido l aderiscono alla superficie di un materiale
SOLUZIONI. Soluzioni gassose, liquide e solide
 LE SOLUZIONI SOLUZIONI Miscela fisicamente omogenea, cioè un insieme di due o più componenti che costituiscono un unica fase. Componente in eccesso: solvente Componente in minore quantità: soluto Soluzioni
LE SOLUZIONI SOLUZIONI Miscela fisicamente omogenea, cioè un insieme di due o più componenti che costituiscono un unica fase. Componente in eccesso: solvente Componente in minore quantità: soluto Soluzioni
Le proprietà colligative delle soluzioni Sappiamo dall esperienza quotidiana che una soluzione ha caratteristiche diverse dal solvente puro.
 Le proprietà colligative delle soluzioni Sappiamo dall esperienza quotidiana che una soluzione ha caratteristiche diverse dal solvente puro. Molte delle sue proprietà, come il sapore, il colore, l odore,
Le proprietà colligative delle soluzioni Sappiamo dall esperienza quotidiana che una soluzione ha caratteristiche diverse dal solvente puro. Molte delle sue proprietà, come il sapore, il colore, l odore,
Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti
 Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti INTRODUZIONE (I) VIDEO INTRODUZIONE (II) La comprensione delle proprietà delle sostanze e le trasformazioni che
Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti INTRODUZIONE (I) VIDEO INTRODUZIONE (II) La comprensione delle proprietà delle sostanze e le trasformazioni che
SOLUZIONI e DILUIZIONI
 SOLUZIONI e DILUIZIONI Introduzione In chimica viene definita soluzione un sistema in cui due o più sostanze formano un miscuglio omogeneo. Nella maggior parte dei casi una soluzione è costituita da due
SOLUZIONI e DILUIZIONI Introduzione In chimica viene definita soluzione un sistema in cui due o più sostanze formano un miscuglio omogeneo. Nella maggior parte dei casi una soluzione è costituita da due
Prodotto di solubilità (Kps)
 Prodotto di solubilità (Kps) SOLUBILITA Concentrazione massima che si può raggiungere per un soluto in un dato solvente ad una certa temperatura. (Es: g soluto/100g di solvente) Solubiltà di NaCl in acqua
Prodotto di solubilità (Kps) SOLUBILITA Concentrazione massima che si può raggiungere per un soluto in un dato solvente ad una certa temperatura. (Es: g soluto/100g di solvente) Solubiltà di NaCl in acqua
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
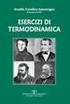 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
Le soluzioni possono esistere in ognuno dei tre stati della materia: gas, liquido o solido.
 SOLUZIONI Una soluzione è una miscela omogenea (=la sua composizione e le sue proprietà sono uniformi in ogni parte del campione) di due o più sostanze formate da ioni o molecole. Differenza con i colloidi
SOLUZIONI Una soluzione è una miscela omogenea (=la sua composizione e le sue proprietà sono uniformi in ogni parte del campione) di due o più sostanze formate da ioni o molecole. Differenza con i colloidi
Passaggi di stato. Prof.ssa Paravizzini Maria Rosa
 Passaggi di stato Prof.ssa Paravizzini Maria Rosa Proprietà e trasformazioni fisiche Le proprietà fisiche di una sostanza possono essere colte attraverso i sensi (colore, odore, consistenza al tatto) o
Passaggi di stato Prof.ssa Paravizzini Maria Rosa Proprietà e trasformazioni fisiche Le proprietà fisiche di una sostanza possono essere colte attraverso i sensi (colore, odore, consistenza al tatto) o
L acqua. Ci devono essere delle forze che tengono saldamente insieme le molecole d acqua
 L acqua Comparata a molecole con caratteristiche atomiche simili e di grandezza comparabile, l acqua presenta alcune caratteristiche peculiari Comparando l idruro dell ossigeno con gli idruri degli elementi
L acqua Comparata a molecole con caratteristiche atomiche simili e di grandezza comparabile, l acqua presenta alcune caratteristiche peculiari Comparando l idruro dell ossigeno con gli idruri degli elementi
INSIEME ALL ACQUA SI MISCHIA O NON SI MISCHIA?
 3 classe Prerequisiti Saper riconoscere le sostanze che costituiscono la materia che ci circonda Conoscere le proprietà fisiche della materia Conoscere la differenza tra sostanza pura, elemento e composto
3 classe Prerequisiti Saper riconoscere le sostanze che costituiscono la materia che ci circonda Conoscere le proprietà fisiche della materia Conoscere la differenza tra sostanza pura, elemento e composto
Classificazione della materia 3 STATI DI AGGREGAZIONE
 Classificazione della materia MATERIA spazio massa Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (Volume e forma propri) LIQUIDO (Volume definito e forma indefinita) GASSOSO
Classificazione della materia MATERIA spazio massa Composizione Struttura Proprietà Trasformazioni 3 STATI DI AGGREGAZIONE SOLIDO (Volume e forma propri) LIQUIDO (Volume definito e forma indefinita) GASSOSO
Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica
 Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica Luigi Cerruti www.minerva.unito.it Lezioni 35-36 2010 Regola delle fasi di Gibbs Lo stato di un sistema fisico è definito quando si conoscono i valori di tutte
Corso di Studi di Fisica Corso di Chimica Luigi Cerruti www.minerva.unito.it Lezioni 35-36 2010 Regola delle fasi di Gibbs Lo stato di un sistema fisico è definito quando si conoscono i valori di tutte
Il legame tra le molecole
 1 Il legame tra le molecole Obiettivo L'obiettivo di questa lezione è piuttosto ambizioso. Partendo dal concetto di dipolo elettrico e passando per la forma delle molecole arriveremo a definire il concetto
1 Il legame tra le molecole Obiettivo L'obiettivo di questa lezione è piuttosto ambizioso. Partendo dal concetto di dipolo elettrico e passando per la forma delle molecole arriveremo a definire il concetto
ESTRAZIONE CON SOLVENTE
 ESTRAZIONE CON SOLVENTE TECNICA DI SEPARAZIONE BASATA SUL TRASFERIMENTO SELETTIVO DI UNO O PIÙ COMPONENTI DI UNA MISCELA SOLIDA, LIQUIDA O GASSOSA DA UN SOLVENTE AD UN ALTRO SOLVENTE IMMISCIBILE CON IL
ESTRAZIONE CON SOLVENTE TECNICA DI SEPARAZIONE BASATA SUL TRASFERIMENTO SELETTIVO DI UNO O PIÙ COMPONENTI DI UNA MISCELA SOLIDA, LIQUIDA O GASSOSA DA UN SOLVENTE AD UN ALTRO SOLVENTE IMMISCIBILE CON IL
IL LEGAME CHIMICO. Per descrivere come gli elettroni si distribuiscono nell atomo attorno al nucleo si può far riferimento al MODELLO A GUSCI
 IL LEGAME CIMICO Come dagli atomi si costruiscono le molecole 02/19/08 0959 PM 1 Per descrivere come gli elettroni si distribuiscono nell atomo attorno al nucleo si può far riferimento al MODELLO A GUSCI
IL LEGAME CIMICO Come dagli atomi si costruiscono le molecole 02/19/08 0959 PM 1 Per descrivere come gli elettroni si distribuiscono nell atomo attorno al nucleo si può far riferimento al MODELLO A GUSCI
Cambiamenti di stato
 Cambiamenti di stato Equilibri tra le fasi: diagrammi di stato per un componente puro diagrammi di stato a due componenti 1 Equilibri tra fasi diverse fase 3 fase 1 fase 2 FASE: porzione di materia chimicamente
Cambiamenti di stato Equilibri tra le fasi: diagrammi di stato per un componente puro diagrammi di stato a due componenti 1 Equilibri tra fasi diverse fase 3 fase 1 fase 2 FASE: porzione di materia chimicamente
Fenomeno fisico. Le trasformazioni che la materia subisce senza modificare la sua composizione e che sono reversibili si chiamano fenomeni fisici
 Atomi e molecole Fenomeno fisico Le trasformazioni che la materia subisce senza modificare la sua composizione e che sono reversibili si chiamano fenomeni fisici Fenomeno chimico Le trasformazioni che
Atomi e molecole Fenomeno fisico Le trasformazioni che la materia subisce senza modificare la sua composizione e che sono reversibili si chiamano fenomeni fisici Fenomeno chimico Le trasformazioni che
Materia. Tutto ciò che occupa spazio e ha massa
 Materia Tutto ciò che occupa spazio e ha massa Gli Stati della Materia Solido Liquido Gas I solidi sono rigidi ed hanno forma e volume definito. I liquidi prendono la forma del contenitore. Hanno un volume
Materia Tutto ciò che occupa spazio e ha massa Gli Stati della Materia Solido Liquido Gas I solidi sono rigidi ed hanno forma e volume definito. I liquidi prendono la forma del contenitore. Hanno un volume
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA. Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta
 INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
INTRODUZIONE ALLA TERMODINAMICA Supponiamo di voler studiare il comportamento di una determinata quantità di gas contenuta in un recipiente, ad esempio 5g di ossigeno. Dato l elevato numero di molecole
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE Scienze Integrate Chimica Classe 2M IPIAS Anno Scolastico Prof. Marcello Riolo Prof. P.
 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE Scienze Integrate Chimica Classe 2M IPIAS Anno Scolastico 2015-2016 Prof. Marcello Riolo Prof. P. Bianchi Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE Scienze Integrate Chimica Classe 2M IPIAS Anno Scolastico 2015-2016 Prof. Marcello Riolo Prof. P. Bianchi Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione
La base di partenza per la maggior parte dei processi produttivi di materiali ceramici sono le sospensioni. Queste si ottengono dalla miscelazione di
 La base di partenza per la maggior parte dei processi produttivi di materiali ceramici sono le sospensioni. Queste si ottengono dalla miscelazione di un solido (polvere) che diverrà il ceramico, con un
La base di partenza per la maggior parte dei processi produttivi di materiali ceramici sono le sospensioni. Queste si ottengono dalla miscelazione di un solido (polvere) che diverrà il ceramico, con un
Estrazione con solventi. Dott.ssa Laura Casu Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche 9 crediti
 Estrazione con solventi Dott.ssa Laura Casu Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche 9 crediti Estrazione in Soxhlet Vantaggi: Estrazione in continuo Refrigerante Svantaggi: richiede molte ore (12/24)
Estrazione con solventi Dott.ssa Laura Casu Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche 9 crediti Estrazione in Soxhlet Vantaggi: Estrazione in continuo Refrigerante Svantaggi: richiede molte ore (12/24)
Un rifornimento dal benzinaio di Maria Altieri
 Un rifornimento dal benzinaio di Maria Altieri Autore Maria Altieri Referente scientifico Michela Mayer Grado scolastico Scuola Secondaria di II grado Percorso collegato La materia si trasforma? È solo
Un rifornimento dal benzinaio di Maria Altieri Autore Maria Altieri Referente scientifico Michela Mayer Grado scolastico Scuola Secondaria di II grado Percorso collegato La materia si trasforma? È solo
1. CARATTERISTICHE E PROPRIETA DELLE EMULSIONI
 1. CARATTERISTICHE E PROPRIETA DELLE EMULSIONI Le emulsioni sono sistemi dispersi, cioè eterogenei, costituiti da due fasi liquide immiscibili tra loro. Possiamo distinguere emulsioni olio in acqua (O/A,
1. CARATTERISTICHE E PROPRIETA DELLE EMULSIONI Le emulsioni sono sistemi dispersi, cioè eterogenei, costituiti da due fasi liquide immiscibili tra loro. Possiamo distinguere emulsioni olio in acqua (O/A,
Il Gas Ideale. Il gas ideale é un'astrazione
 Il Gas Ideale a) le particelle sono animate da moto perenne, ed occupano omogeneamente tutto lo spazio a loro disposizione b) il movimento delle particelle è casuale c) le particelle hanno volume proprio
Il Gas Ideale a) le particelle sono animate da moto perenne, ed occupano omogeneamente tutto lo spazio a loro disposizione b) il movimento delle particelle è casuale c) le particelle hanno volume proprio
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE A.A. 2008-2009 Prova scritta del corso di Chimica A-K Compito prova
 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE A.A. 2008-2009 Prova scritta del corso di Chimica A-K Compito prova Cognome e nome.... n di matricola Nei quesiti a risposta multipla, verranno ANNULLATI i quesiti
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE A.A. 2008-2009 Prova scritta del corso di Chimica A-K Compito prova Cognome e nome.... n di matricola Nei quesiti a risposta multipla, verranno ANNULLATI i quesiti
I LEGAMI CHIMICI. I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune
 I LEGAMI CHIMICI I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune alcuni elettroni con altri atomi, per completare il guscio elettronico più esterno. 1. LEGAME IONICO
I LEGAMI CHIMICI I legami chimici si formano quando gli atomi cedono, acquistano oppure mettono in comune alcuni elettroni con altri atomi, per completare il guscio elettronico più esterno. 1. LEGAME IONICO
Tavola Periodica degli Elementi
 Tavola Periodica degli Elementi È possibile classificare gli elementi? Hp: In base alla massa atomica. Ogni 8 elementi le proprietà si ripetono. Incongruenze A Ar >A K Il Problema Le proprietà Chimiche
Tavola Periodica degli Elementi È possibile classificare gli elementi? Hp: In base alla massa atomica. Ogni 8 elementi le proprietà si ripetono. Incongruenze A Ar >A K Il Problema Le proprietà Chimiche
relazioni tra il calore e le altre forme di energia.
 Termodinamica i Termodinamica: ramo della scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia. Sistema e ambiente sistema: zona dello spazio all interno della quale studiamo i fenomeni
Termodinamica i Termodinamica: ramo della scienza che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia. Sistema e ambiente sistema: zona dello spazio all interno della quale studiamo i fenomeni
