ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
|
|
|
- Isabella Verde
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2006 Stampa: Centro Grafico S.r.l. - Tel
2 ANNA MARIA TUNZI SISTO* MICHELA DANESI** RAMON SIMONETTI** Il grande abitato neolitico di Troia Monte S. Vincenzo * Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ** Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell Antichità, Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il sito Il più antico popolamento umano del Tavoliere è oggetto da svariati decenni di studi e sintesi sufficienti a definire l esatta fisionomia di questo territorio in età neolitica. Tuttavia più labile ed indistinto appariva il quadro delle conoscenze dell areale situato subito ad occidente, caratterizzato dagli ampi altopiani che si affacciano sulla valle del torrente Celone, in posizione altimetrica prossima ai 400 m s.l.m. Su questi primi rilievi, dove il terreno sale senza brusche variazioni dalla grande pianura, era finora mancato l avvio di indagini sistematiche, oggi favorite dai dati emersi dal Progetto Valle del Celone, nato a seguito di specifiche esigenze di tutela alla vigilia di realizzazioni di grandi opere idriche (VOLPE et alii 2002). Questo progetto in seguito divenuto pluriennale, basato sulla ricognizione globale del territorio con taglio diacronico molto ampio, è in grado di fornire alla ricerca un supporto particolarmente idoneo che, oltretutto, si avvale delle tecniche dell aerotopografia e della fotointerpretazione archeologica. Dai primi riscontri noti la valle del Celone emerge come un comparto territoriale capillarmente interessato dalle presenze neolitiche, che nell insieme sembrano coprire gran parte dell intero arco cronologico in cui si sviluppò la civiltà dei primi agricoltori. Ne è un esempio il grande villaggio trincerato di Monte San Vincenzo, situato in
3 40 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti posizione altimetrica più bassa (m 250 circa s.l.m.) sul versante occidentale di un altura aperta verso la grande pianura solcata dal Celone. Dal magnetogramma del sito si evince una straordinaria articolazione di opere trincerate diverse per dimensioni e forma, che in più riprese furono realizzate a partire almeno dalla fase di Masseria la Quercia. Complessivamente, la superficie interessata dalle strutture di abitato è una delle più grandi ad oggi note: l assetto finale dell area include, procedendo dall esterno verso l interno, una prima coppia di fossati concentrici (fossati esterni) che racchiude un area di circa 25 ettari, a cui segue una seconda coppia di fossati concentrici (fossati interni) che racchiude una superficie pari a circa 16 ettari; la presenza di alcune anomalie nel loro tracciato, ben evidenti nel magnetogramma, potrebbe corrispondere ad aperture o passaggi. L articolazione del sito prosegue con svariati fossati minori circolari ed ellittici, racchiusi nel circuito dei due fossati interni e con numerosi piccoli compounds (o fossati a C) dislocati tanto all interno che all esterno di questi. L insieme delle strutture non rientra in un piano progettuale unitario, bensì - come è norma in questi villaggi - costituisce l esito di una progressione di realizzazioni che talora si sovrappongono al tracciato di altre già da tempo in disuso. L apertura di due saggi, distanti tra loro circa 200 m, ha permesso l indagine archeologica approfondita di un area che, complessivamente, copre una superficie di 36 settori di m 4X4 (16 settori nel I saggio e 20 nel II), pari ad un estensione totale di più di 570 mq. Lo scavo ha riguardato, per quanto concerne il saggio I, uno dei fossati minori (fossato B; misura 125 m di perimetro e 40 m di diametro), che racchiude al suo interno un compound (fossato A; misura 50 m di perimetro e 16 m di diametro), con apertura orientata ad ovest. Le due strutture trincerate si diversificano prevedibilmente anche per la larghezza, pari a m 3,5 per il fossato e m 2 per il compound e la profondità (m 2 per il compound; m 2,5 per il fossato circolare). Per quanto riguarda il saggio II lo scavo ha interessato un area in cui, dal magnetogramma e dalle foto aeree, si individuavano tracce relative a più fossati, tra loro intersecanti. In particolare si è indagato parte del tracciato della coppia di fossati perimetrali più interna (fossato D e fossato E) e parte di un fossato circolare più antico (fossato C) che risulta tagliato ed in parte riutilizzato dalla coppia di fossati perimetrali stessa. Per quanto i livelli superiori, in entrambi i settori di scavo, siano apparsi seriamente intaccati dai lavori agricoli, che in alcuni punti sono arrivati a sfiorare la cosiddetta crusta, ossia il banco carbonatico calcareo in cui le strutture furono realizzate, non sono stati arrecati danni ai profili dei fossati, che risultano abbastanza regolari. Non si sono invece conservati gli strati relativi alla vita del sito, nelle fasi in cui i fossati erano verosimilmente attivi.
4 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 41 Lo scavo, in collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e l Università degli Studi di Foggia, è stato condotto sotto la direzione di chi scrive dalla Cooperativa Adrìas nell autunno 2005, con oneri di spesa a carico della Società EOS 1 Troia San Vincenzo s.r.l. Vi hanno preso parte studenti delle Università di Foggia e di Roma La Sapienza. AMTS Saggio I 1 Con il saggio I (16 x 20 m) si è indagata l area interessata da uno dei fossati minori circolari (fossato A) che racchiude al suo interno un fossato a C (fossato B), il quale presenta un apertura orientata ad ovest. Il fossato B si trova, in posizione eccentrica, nell area Nord-est racchiusa dal fossato A. Nell ambito del saggio, indagato in estensione, è stato inoltre effettuato lo scavo in profondità in un settore di di 4x8m che ricade, per quanto riguarda il fossato A, nei settori C3, C4, D3, D4, e, per il fossato B, nei settori E3, E4. L approfondimento è stato effettuato proprio nel punto in cui il fossato B si trovava più vicino al fossato A, per verificare se uno dei due tagliava l altro: il magnetogramma infatti rivelava in quel punto un anomalia, interpretabile come una tangenza tra i due tracciati. Sulla base dell approfondimento, si è accertato che il fossato a C è separato dal fossato A da una porzione di crusta di circa 1,5 m nel punto più stretto (Fig. 1). Le evidenze emerse dai dati di scavo sembrano indicare che i due fossati furono utilizzati in modo simultaneo o che dovevano essere almeno in parte visibili, poiché non si intersecano; se pure sono stati realizzati in due momenti differenti si può pensare dunque che il primo in ordine di tempo doveva ancora essere visibile (Fig. 1). I fossati in questione sono tagliati nella crusta, ma giungono in profondità fino ad un livello concrezionato, vergine, composto, in parte, da pietre di medie e grandi dimensioni, come accade anche in altri villaggi del Tavoliere (TINÈ, 1983, p. 37, Fig. 10). Sopra il piano di crusta sono state evidenziate piccole buche, sul lato meridionale del saggio. Il diametro è abbastanza piccolo e la loro caratteristica è quella di formare un cerchio, ed anche se all interno di queste non sono state trovate zeppe per l alloggio ed il mantenimento di pali lignei, queste ultime potrebbero essere state 1 Desideriamo ringraziare: la Dott.ssa Anna Maria Tunzi per averci affidato lo studio dei materiali provenienti dallo scavo 2005, la Dott.ssa Giulia Recchia per i preziosi suggerimenti, la Dott.ssa Annalisa Di Zanni e il Dott. Angelo Valentino Romano per la disponibilità e per le utili discussioni durante lo scavo, gli studenti, che hanno partecipato allo scavo, del Corso di Laurea in Beni Culturali, sede di Lucera (in particolare Giuseppe Delli Carri per i disegni delle sezioni) e dell Università di Roma La Sapienza, per l aiuto.
5 42 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti scalzate dall aratro che ha danneggiato anche la stessa crusta. I dati a nostra disposizione non permettono di formulare alcuna ipotesi riguardo la funzione o l utilizzo di tali buche, ma solo di precisare che esse si trovano all interno del compound, in posizione piuttosto marginale (Fig. 1). Fossato A Il fossato A ha un andamento circolare ed un diametro di circa 40 m (Tab. 1). Le foto aeree e le prospezioni geo-magnetiche hanno rilevato che il tracciato del fossato si presenta senza interruzioni ed è solo in parte intaccato dall impianto di un uliveto di epoca storica le cui tracce sono ancora visibili nella crusta (Fig. 1). Lo scavo in profondità ha verificato che questo fossato ha una larghezza di 3,5 m nella parte superiore, mentre presso il fondo ha una dimensione minore poiché il taglio si restringe verso il basso, dandogli una forma leggermente imbutiforme. Il fossato raggiunge una profondità di circa 2,5 m (Fig. 2). È comunque possibile che esso potesse avere, in origine, una profondità maggiore, che quindi partisse da una certa altezza al di sopra della crusta, come sembra essere dimostrato in altri siti del Tavoliere, come quello di Passo di Corvo (TINÈ 1983) e dell Ex Ippodromo(TUNZI, MONACO in questo volume), per citarne alcuni, dove si sono conservati anche gli strati al di sopra dello strato calcareo. Lo strato superficiale è risultato abbastanza consistente di circa 0,50 m ed i segni dell aratro erano visibili fino sulla crusta stessa. Per questo, come accennato, gli unici livelli in posto sono riferibili ai riempimenti dei fossati. In particolare il fossato A presenta diversi livelli di riempimento (almeno 7 eventi di colmata) talvolta intervallati da scarichi di pietre; in particolare è stato possibile distinguere, dal basso, le seguenti unità stratigrafiche: US 59 strato di terreno di colore grigio chiaro, di granulometria sottile, con inclusi carboniosi, US 55 strato di terreno di colore grigio, di granulometria sottile, con inclusi carboniosi e pietre di medie dimensioni, US 46 strato di terreno di colore giallo e di consistenza friabile, US 40 strato di terreno di colore grigio con inclusi carboniosi e calcarei centimetrici, US 38 strato di terreno di colore grigio e consistenza compatta, US 37 strato di terreno di colore giallo chiaro con pietre all interno, US 24 strato di terreno di colore bruno con inclusi di crusta, US 16 strato di terreno bruno con molte pietre di piccole dimensioni al suo interno e sulla sua superficie. Fossato B Sulle basi dell approfondimento (4X8 m) effettuato in continuità con quello del fossato A (Fig. 1), si può osservare che il fossato del compound ha una larghezza di 2m, ha una profondità di 2 m, ed ha, anch esso, un profilo imbutiforme verso il basso; esso presenta un andamento a ferro di cavallo leggermente irregolare soprattutto verso gli apici ed al suo interno si sono potuti distinguere tre livelli di riempimento di spessore più consistente rispetto a quelli del fossato A. I livelli di riempimento del fossato B sembrano differenziarsi tra di loro: mentre gli strati inferiori (US 39 e
6 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 43 US 34) sono caratterizzati da un terreno senza pietre, il terzo e superiore strato di riempimento, US 18, ha incluse molte pietre di medie dimensioni: in particolare l US 39, la più bassa, a contatto con il fondo del fossato del compound, si presenta di colore grigio, di consistenza friabile e di granulometria molto sottile e priva di pietre, l US 34, è di colore giallo chiaro e di granulometria sottile, senza inclusi di alcun genere, l US 18 ha colore bruno chiaro, di granulometria medio-fine con inclusi di calcare ed ha incluse molte pietre di medie dimensioni. Il diametro ed il perimetro del fossato del compound (Tab. 1), 15 m di diametro e circa 50 m di perimetro, ben si accordano con le dimensioni di altri fossati dello stesso tipo del Tavoliere: tutti e tre i fossati a C di Passo di Corvo hanno un diametro compreso tra i 15 m ed i 16m (TINÈ 1983, pp ) ed un perimetro compreso tra i 47 m ed i 50 m; il fossato semicircolare di Rendina ha un perimetro di 100 m (CIPOLLONI 1983, pp ) ed un diametro di circa 30 m, dunque più grande rispetto ai fossati dei compound del Tavoliere e se ne distingue anche per la forma poiché presenta un apertura agli apici di 50m, mentre a Monte S. Vincenzo è di circa 7 m (il dato è ricavato sulla base della foto area) e a Passo di Corvo il fossato beta ha un apertura di 13 m. I reperti ceramici, litici e bioarcheologici Benché lo studio dei materiali rinvenuti nel sito sia in fase preliminare è possibile fare osservazioni molto interessanti. Per quanto riguarda i manufatti ceramici, essi mostrano una cronologia che arriva fino alla fase Passo di Corvo, comprendendo anche quest ultima. Si sono rinvenuti frammenti ceramici decorati a rocker, a incisione, a impressione, dipinti nello stile Masseria la Quercia e dipinti nello stile Passo di Corvo, sia Arcaico (pittura bianca) che Tipico (pittura rossa) (TINÈ 1983, pp ). Come è noto, durante il V millennio vengono introdotte innovazioni importanti nella fabbricazione della ceramica che portano all introduzione della ceramica figulina che si distingue da quella d impasto, seppur ben depurato dei periodi precedenti, sia per le tecniche di cottura che per l argilla utilizzata; a questo proposito rimane ancora aperto il problema di quando questa tecnica sia stata adottata e se sia pertinente solo alle fasi Passo di Corvo o anche a quella di Masseria la Quercia. Per quanto riguarda una scansione cronologica tra la fase Masseria la Quercia e quella Passo di Corvo è interessante osservare come questi due stili ceramici si distribuiscano nei riempimenti dei fossati, se ammettiamo la sequenzialità tra queste due facies. Gli strati di riempimento più bassi del fossato A, US 59, 55, 46 hanno restituito ceramica impressa, incisa, rocker e dipinta in stile Masseria la Quercia (Fig. 7:1,2), l US 40 ha restituito, oltre a frammenti decorati con i motivi appena citati, anche un frammento di ceramica figulina decorata in stile Passo di Corvo arcaico (Fig. 7: 4), mentre le US superiori (US 38, 37, 24, 16) presentano diversi frammenti di ceramica riferibili allo stile di Passo di Corvo tipico (Fig. 7: 5).
7 44 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti Situazione analoga è emersa dallo scavo dei riempimenti del fossato B. I livelli più bassi (US 39 e 34) hanno restituito ceramica riferibile all orizzonte Masseria la Quercia (Fig. 7: 3), mentre nel terzo e superiore riempimento (US 18) si trova anche ceramica riferibile a Passo di Corvo, anche se in percentuale piuttosto bassa. Il fatto che, in quest ultimo caso, anche le caratteristiche dello strato si differenziano dagli altri due riempimenti sottostanti fa supporre che le azioni che hanno portato alla definitiva obliterazione dei fossati possano essere riconducibili a due differenti modalità di riempimento e forse a due momenti diversi di frequentazione. Durante lo scavo sono venuti alla luce numerosi strumenti e schegge di selce, materiale, quest ultimo, presente nel Gargano. Accanto alla selce sono stati rinvenuti in percentuale abbastanza consistente anche manufatti in ossidiana, materia prima che come è noto non è disponibile in zona. I materiali in questione sono ancora in fase di studio e di analisi. A Monte San Vincenzo la fauna è scarsa e mal conservata forse a causa dell acidità del terreno. Sono in corso di studio le faune e le analisi sui resti paleobotanici; nel momento in cui queste si renderanno disponibili, si potrà proporre un confronto tra i risultati emersi dal nostro sito e gli esiti degli studi sull economia di sussistenza nel Neolitico già discussi per molti siti del Tavoliere come Monte Aquilone (MANFREDINI 1972), Masseria Candelaro (CASSANO, MANFREDINI 1990) e più a sud, in Basilicata, per il sito di Rendina (CIPOLLONI 1983). Considerazioni Sulla base dell osservazione della ceramica possiamo notare come i riempimenti dei fossati A e B offrano spunti per la comprensione delle fasi di occupazione e le modalità di utilizzo delle strutture qui esaminate. Come visto, la ceramica presente nei livelli di riempimento sembrerebbe riferirsi a due stili: i livelli inferiori presentano ceramica riferibile alla facies di Masseria la Quercia, mentre i superiori sembrano inquadrabili nella fase Passo di Corvo. Le spiegazioni a queste evidenze possono ssere diverse: si può pensare che i fossati siano stati riempiti completamente durante la fase Masseria la Quercia e successivamente riutilizzati, in modo parziale, durante la fase Passo di Corvo oppure si potrebbe pensare che nella fase Masseria la Quercia non fossero stati riempiti totalmente. È interessante notare come i riempimenti di entrambi i fossati che hanno restituito ceramica fino all orizzonte di Masseria la Quercia siano posti alla stessa profondità (Fig. 2): è probabile che durante la fase Passo di Corvo entrambi i fossati siano stati riscavati ad una stessa profondità, comunque ridotta rispetto al fondo originario delle strutture durante la fase Masseria la Quercia, mentre è difficile che in tale fase i fossati si siano riempiti, più o meno casualmente, fino alla stessa altezza. Rimane difficoltoso stabilire se essi siano stati scavati insieme o in due fasi distinte e se subito dopo il loro svuotamento siano stati usati contemporaneamente. A lungo si è discusso (MANFREDINI 1972; TINÈ 1983; CIPOLLONI 1983; TOZZI 1984)
8 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 45 sulla funzione di tali fossati i quali richiedevano una certa forza lavoro per essere realizzati (BROWN 1991, pp ) ed il problema rimane ad oggi aperto. Tinè ha proposto che si trattasse di opere per il drenaggio o per la conservazione dell acqua; altri (GRAVINA 1975; 1980) che si trattasse di opere, oltre che per la conservazione, anche per l approviggionamento dell acqua; altri ancora che si trattasse di opere per racchiudere il bestiame o a fini difensivi, ma queste ultime osservazioni si scontrerebbero con le evidenze di Rendina, dove alcuni fossati semicircolari, con un apertura di 50 m, e sembrano essere poco adatti a tali scopi. Non è da escludere un loro significato simbolico/territoriale, come opere che delimitavano il territorio occupato da una comunità (CASSANO, MANFREDINI 1983; CAZZELLA, MOSCOLONI 1992). I dati che abbiamo a disposizione per Monte San Vincenzo tenderebbero a sminuire una possibile funzione legata alla conservazione dell acqua, almeno nella fase Passo di Corvo, se i fossati vengono utilizzati pieni di terra per almeno 1,5 m. Il villaggio trincerato di Monte San Vincenzo appare avere una continuità nell utilizzazione delle strutture tra le fasi Masseria la Quercia e Passo di Corvo. Sulla base dei dati di scavo e delle ricognizioni di superficie non sembra che il sito sia stato abitato durante le fasi successive a quella Passo di Corvo, infatti non sono stati trovati frammenti di ceramiche tricromiche tipiche della fase Serra d Alto né forme riconducibili all ultima fase neolitica, quella Diana. Non sembra neanche possibile distinguere una fase precedente a quella Masseria la Quercia che sarebbe caratterizzata dall assenza di decorazioni pittoriche, e dalla presenza di ceramiche impresse o incise, le quali persistono anche durante la fase Masseria la Quercia. Riguardo al problema, molto discusso in letteratura, dell articolazione interna dei villaggi trincerati rispetto alla complessità sociale e alla cronologia del sito, è stato proposto da Tinè (TINÈ 1983, pp , Fig. 8), sulla base delle ricognizioni da lui effettuate (le quali avrebbero evidenziato una diminuzione quantitativa dei siti insieme ad un aumento progressivo delle loro dimensioni), che i siti di piccole dimensioni, cioè comprendenti uno o due fossati a C, non siano da considerarsi veri e propri villaggi ma semplici fattorie probabilmente da porsi in una fase antica del Neolitico, mentre i siti più articolati, che presentano un certo numero di fossati perimetrali che cingono un numero consistente di fossati a C devono essere considerati villaggi con una cronologia più bassa, del tipo Passo di Corvo. La Brown (BROWN 1991, pp. 8-10, Fig. 2) propone una classificazione simile a quella suggerita da Tinè, secondo la quale esisterebbe un vero e proprio cambiamento nel tempo che avrebbe portato i villaggi neolitici da quelli costituiti da uno o due fossati a siti sempre più complessi nel corso del Neolitico stesso fino a raggiungere l articolazione di tipo Passo di Corvo. Nonostante il Tavoliere sia una delle zone più densamente indagate per quanto riguarda il periodo in questione, sono ancora assai scarsi gli elementi utilizzabili per una ricostruzione degli aspetti sociali di questi gruppi, ad esempio lo scavo in estensione di più villaggi. Per quanto riguarda Monte San Vincenzo si può osservare come la forma complessiva del villaggio visibile dalle foto aree e dal
9 46 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti magnetogramma sia molto articolata, con un gran numero di fossati minori e compound circoscritti da almeno quattro fossati perimetrali, probabilmente riferibili a diverse fasi di occupazione, attestate anche dalle indagini di scavo. La sua composizione definitiva avviene durante la fase Passo di Corvo, poiché non sono testimoniati livelli di occupazione successivi a questa, ma è difficile concludere che in tale fase fossero in uso, in modo contemporaneo, tutte le strutture evidenziate dalle foto aeree. M. D. Saggio II Il saggio II (a 200 m di distanza dal saggio I in direzione ovest) di 40 x 20 m è stato impostato su un area dove, dal magnetogramma, la coppia dei fossati perimetrali interni (fossati D e E), intercettano un fossato circolare più antico(fossato C) e lo riutilizzano; uno ne sfrutta in parte l andamento(fossato D) ampliandolo in larghezza e profondità mentre l altro lo taglia trasversalmente(fossato E). I dati sin ora raccolti, se pure relativi solo ad una porzione del perimetro di queste strutture, sembrano indicare che la chiusura dei fossati perimetrali sia avvenuta nell ambito della fase Passo di Corvo: in questo periodo infatti sono inquadrabili gran parte dei livelli di colmata che obliterano le strutture stesse, ma è possibile una frequentazione anche precedente di questa area nella fase Masseria la Quercia (VI millennio a.c ). Fossato C Il fossato C ha un andamento circolare e delimita un area di circa 2 ettari. Le prospezioni geo-magnetiche e le foto aeree non rivelano nessuna interruzione nel suo tracciato: alcune anomalie sembrano piuttosto dovute alla leggibilità del sottosuolo. Nella zona interessata dallo scavo ha una larghezza di 1,20 m e una profondità di 0, 40 m anche se dobbiamo considerare che durante il Neolitico l interro poteva essere di maggiore spessore e di conseguenza il fossato avere una profondità diversa da quella attuale. Le pareti sono inclinate verso l interno, il fondo è concavo ed è ricavato interamente nel banco di crusta. Il riempimento(us 42-50), nella porzione indagata, risulta privo di reperti archeologici e di conseguenza non si hanno dati utili per un inquadramento cronologico, anche se la sua realizzazione è verosimilmente anteriore ai due grandi fossati perimetrali che in parte lo riutilizzano (fossato D) e lo tagliano (fossato E). Al momento attuale è difficile stabilire se durante la realizzazione del fossato perimetrale esterno(fossato E) il fossato C fosse completamente obliterato oppure visibile; considerando che questo è tagliato dal fossato E, e che entrambi presentano
10 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 47 riempimenti simili, si può pensare che un tratto del fossato C, una volta caduto in disuso e venuta meno la sua funzione originaria, sia stato riutilizzato per canalizzare l acqua dal fossato esterno(fossato E) a quello interno (fossato D). Un problema diverso è rappresentato invece dalla funzione che esso poteva avere in origine prima che venissero costruiti i fossati perimetrali, anche in considerazione delle sue ridotte dimensioni, soprattutto per la limitata profondità. Appare dunque difficile ipotizzare per il fossato C una funzione difensiva; non si può escludere che possa in origine aver circoscritto un area particolare che sia stata volontariamente rispettata dai costruttori del fossato perimetrale più interno (fossato D) e, in una fase successiva, venuto meno questo uso sia stata tagliata e riutilizzata dai costruttori del fossato E. Fossato D Il fossato D circoscrive un area di circa 16 ettari e mostra, sulla base del magnetogramma, un andamento ellissoidale per quasi tutto il perimetro. Nella zona indagata, come accennato in precedenza, sfrutta per un tratto l andamento del fossato C che viene ampliato in larghezza e profondità, riutilizzandone il margine interno e abbattendone quello esterno. Il perimetro del fossato D è reso irregolare dalla presenza di un appendice con terminazione doppia; la terminazione est è larga 2,5 m, presenta pareti quasi verticali, ed è stata indagata per circa 2,70 metri, profondità alla quale si incontra un terreno sterile, probabilmente il fondo. In questo tratto la struttura sembra ricavata in parte nella crusta fino a raggiungere le sabbie pleistoceniche di base, ma non è detto che anche in altri punti della struttura la situazione sia la stessa, lo spessore del banco di crusta infatti può variare da un punto all altro. Nel resto delle aree indagate del fossato D, terminazione ovest compresa, si è raggiunta con lo scavo una profondità di circa 70 centimetri, sufficiente per mettere in luce i margini della struttura, e sono stati indagati dunque solo i primi strati di riempimento (US 14-US 28), che hanno restituito materiali ceramici attribuibili alla facies di Passo di Corvo. Nel braccio ovest (quadrati M10-M11), dove il fossato D, sulla base del magnetogramma, intercetta il fossato C, si è impostata una trincea di 1 x 4 m per indagare la zona in profondità; sotto i primi livelli di riempimento(us 14-US 56), attribuibili alla facies di Passo di Corvo, è venuta alla luce una sepoltura (ancora in fase di scavo) alla quale si possono porre in relazione due vasi in impasto piuttosto inusuali, di forma aperta con fondo a tacco. L inumato sembra poggiare su una sistemazioni di pietre di medie dimensioni messe in opera sul riempimento del fossato ancora non completamente obliterato. Per il momento non sono stati individuati tagli nel terreno ed è possibile che siano gli stessi margini del fossato, che in questo punto si restringono, a rappresen-
11 48 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti tare i limiti della sepoltura. Un possibile confronto è suggerito dalla sepoltura ad inumazione rinvenuta a Ripa Tetta: questa era priva di fossa sepolcrale e lo scheletro era stato adagiato all interno del fossato e poi ricoperto con terra(tozzi, VEROLA 1991). Le condizioni di rinvenimento del corredo e delle ossa, di cui si intuiscono una tibia e l attacco del bacino mancanti del femore, fanno pensare che la sepoltura sia piuttosto sconnessa. Lo strato che oblitera l inumazione ha restituito sia frammenti di ceramica in impasto non decorata che ceramica figulina a bande rosse inquadrabile nella fase di Passo di Corvo, insieme a una discreta quantità di industria litica; la sepoltura dunque potrebbe essere relativa alla fase Passo di Corvo se non precedente. La presenza di un probabile corredo funebre si discosterebbe con quanto è già noto per le tombe di Passo di Corvo (TINÈ 1983). Ampliato il saggio in direzione sud di 1 x 8 m, lo scavo ha messo in luce, oltre al fossato C e in particolar modo il punto esatto in cui questo veniva tagliato e ne veniva sfruttato il margine interno, anche una canaletta di 70 cm di larghezza e 30 di profondità, impostata sul margine esterno del fossato D e probabilmente connessa al fossato C (fossato F). Per quanto riguarda i riempimenti del Fossato D e in particolar modo quelli della terminazione est, l unica ad essere stata indagata sino al fondo, gli strati sono stati raggruppati in 3 fasi: fase1(us 47), fase 2(US 33-US 28-US14) e fase 3 (US 1). La fase 1 è caratterizzata da pietre e frammenti di crusta disgregata, frammista a resti di fauna e a frammenti di ceramica di grandi dimensioni. Nella fase 2 diminuisce la percentuale di pietre e aumentano i reperti ceramici e la loro frammentazione. La fase 3, pertinente allo strato di campagna che ricopre le strutture, ha restituito frammenti di ceramica neolitica e storica. Ammettendo che la comunità provvedesse a ripulire il fondo del fossato dai detriti che vi si accumulavano, la situazione riscontrata nella fase 1 lascia supporre che a un certo punto la struttura sia caduta in disuso e di conseguenza abbia iniziato a riempirsi con pietre e materiali che si trovavano in prossimità dei margini; anche i resti di fauna ben si accordano con l ipotesi di scarti di pasto gettati intenzionalmente nel fossato o nelle aree limitrofe e poi confluitivi. Ad avvalorare questa ipotesi contribuisce il ritrovamento negli strati della fase 2 di una ventina di frammenti di concotto, alcuni recanti tracce di incannucciato, probabilmente resti di una capanna bruciata da relazionare ad un butto intenzionale all interno del fossato o confluitivi per cause naturali in seguito alla sua distruzione. Tutto ciò lascia supporre che il fossato D, almeno la terminazione est obliterata nella fase Passo di Corvo, abbia pian piano perso la sua funzione originale e si sia riempito per cause naturali. Ulteriori strutture in negativo sono state individuate nei settori Q8 e Q9 dove nello strato di crusta sono state messe in luce buche rotondeggianti.
12 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 49 Abbandonata l idea che potesse trattari di buche di palo, vista l assenza di zeppe e le ridotte dimensioni, si è propensi a credere che si tratti di buche naturali createsi a seguito del disfacimento della crusta. Lungo il perimetro NO e SE del fossato D sono state notate delle canalette che correvano parallele ai margini del fossato; inizialmente si pensava che fossero state realizzate appositamente, vista la regolarità con cui costeggiavano il bordo della struttura, ma dopo averne svuotata completamente una ci si è resi conto che si trattava di un crollo naturale, causato forse dall innesto di buche di palo atte a sorreggere delle strutture ausiliari e lungo il perimetro del fossato, ma tale ipotesi non è stata supportata dai dati archeologici. Nel settore Q8 è stata rinvenuta una vasca con imbocco ovoidale di circa 1,5 m. di diametro che in parte scompare in sezione, intaccata poi in epoca storica dallo scasso di una buca di ulivo. Lo scavo dei riempimenti ha dato scarsi risultati, il terreno si presentava molto concrezionato e ha restituito solo qualche frammento di selce. Tutto ciò lascia pensare che si tratti di una cavità naturale creatasi a seguito dell impianto dell ulivo. Fossato E Il fossato perimetrale E, distanziato di circa 10 m dal fossato D, circoscrive un area di circa16 ettari ed ha un andamento ellissoidale per quasi tutto il perimetro, ad eccezione di quei tratti dove intercetta e in alcuni casi sfrutta fossati circolari più antichi. Dal magnetogramma si notano nella parte NE delle aperture nel tracciato probabilmente riconducibili a ingressi. Nella zona interessata dallo scavo(settori H11-H12) il fossato E taglia il fossato C in modo trasversale. Il margine interno presenta pareti dritte mentre quello esterno non è stato raggiunto dal saggio di scavo; di conseguenza si può stimare che il fossato avesse una larghezza superiore ai 4 m. La profondità raggiunta è quella di 1,50 m dal piano di campagna ma non si è arrivati al fondo della struttura, che sulla base di confronti con altri siti, potrebbe essere superiore ai 3-4 m. I frammenti ceramici rinvenuti sono scarsi e poco diagnostici, infatti non presentano decorazioni e di conseguenza non ci forniscono dati utili per un inquadramento cronologico. Anche se al momento attuale non si dispongono di dati sufficienti per chiarire quale dei due fossati perimetrali sia il più antico, si è orientati a credere che quello più interno sia stato il primo ad essere costruito. I reperti ceramici, litici e bioarcheologici I materiali rinvenuti sono in corso di analisi, si può comunque notare che le ceramiche rinvenute durante lo scavo constano di frammenti prevalentemente in impa-
13 50 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti sto e in ceramica figulina. In tutte le aree scavate è presente ceramica in impasto incisa, impressa e graffita, spesso brunita sia internamente che esternamente a volte anche con tracce di ingubbiatura, associata a ceramica figulina dipinta con pittura rossa tipo Passo di Corvo mentre, a differenza del saggio I, appare assente la ceramica con decorazioni dipinte tipo Masseria la Quercia Tra le ceramica d impasto si possono distinguere ceramica impressa ed incisa e alcuni frammenti di ceramica brunita; la ceramica figulina è presente sia dipinta in stile Passo di Corvo che acroma. Sono attestati anche alcuni elementi litici, in selce e in ossidiana, e pochi resti di fauna. Come accennato sono stati rinvenuti anche diversi frammenti di intonaco di capanna, tra i quali alcuni con impronte di incannucciato, in particolare negli strati della fase 2 della terminazione est. Si presenta di seguito un primo conteggio percentuale delle classi ceramiche principali(impasto e figulina) tenendo conto dell aspetto quantitativo. Come si può notare dalla tabella 3 le percentuali delle ceramiche in impasto e in figulina del Fossato D si mantengono costanti e non sembrano esservi delle variazioni significative tra uno strato e l altro: un fattore di diversificazione è rappresentato dallo stato di frammentazione della ceramica che appare assai più elevato nella fase 2. Nell ambito della ceramica figulina sono presenti frammenti dipinti a fasce rosse inquadrabili nello stile di Passo di Corvo: benché rimanga difficile proporre ipotesi circa la fase cronologica di realizzazione di questo fossato, la sua definitiva obliterazione sembra avvenire nell ambito della facies di Passo di Corvo. Nel Fossato E, invece, le differenze quantitative tra ceramica in impasto e figulina sono meno accentuate anche se la prima appare numericamente minore rispetto al fossato D. Come accennato si tratta principalmente di ceramica in impasto con decorazioni incise e impresse generiche e di ceramica figulina acroma. Dunque in assenza di decorazioni dipinte rimane difficile proporre un inquadramento cronologico di dettaglio, dal momento che la produzione di questa classe ceramica sembra avere inizio già durante la fase Masseria La Quercia. Appare probabile in ogni caso che anche l obliterazione definitiva di questo fossato sia avvenuta, come nel caso del fossato D, nella fase Passo di Corvo e che l assenza di frammenti in ceramica figulina dipinta sia casuale. Le differenze percentuali di ceramica in impasto e figulina tra il Fossato D e il Fossato E suggeriscono l esistenza di una differenza cronologica tra la colmata delle due strutture. Ammettendo che la produzione di ceramica figulina aumenti nel tempo, potremmo ipotizzare che il fossato E sia stato colmato per ultimo, poiché in questa struttura le differenze percentuali tra le due classi ceramiche è meno accentuata rispetto al
14 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 51 fossato D. Elementi litici: La materia prima utilizzata è la selce in misura maggiore, ma l ossidiana è presente in percentuale abbastanza consistente (poco più del 10% sul totale del saggio I e del saggio II): questo dato appare interessante se confrontato con altri siti neolitici, quello della Villa Comunale relativo al IV millennio (CALATTINI, GALIBERTI 1978) dove è presente con il 10% sul totale, Passo di Corvo(TINÈ 1983) 3% sul totale degli strumenti e 7,2% sul totale delle schegge, mentre nei siti più antichi, come Tirlecchia (BERNABÒ BREA 1976) 4 schegge e Ripa Tetta 1 lamella, le percentuali diminuiscono. C è sempre da considerare che si parla di valori percentuali e che in termini assoluti il quadro è ben diverso, per esempio Passo di Corvo ha restituito 196 pezzi tra strumenti e schegge mentre nel nostro caso 8 nel saggio II e 15 nel saggio I: un altro fattore da tenere in considerazione è l ubicazione dei saggi di scavo poiché le aree interne al villaggio (compound) rispetto a quelle esterne(fossati perimetrali) sono, dal punto di vista dei materiali, quantitativamente più ricche; anche l estensione dello scavo nel nostro caso è di gran lunga inferiore a quella di Passo di Corvo. Dal punto di vista tipologico l industria litica è rappresentata da lame e lamelle. Per quanto riguarda la selce sono presenti 13 lame di cui 2 a dorso, 40 schegge e un tranchet, mentre per l ossidiana si segnala la presenza di 7 lame ed 1 scheggia. R. S.
15 52 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti BIBLIOGRAFIA BERNABÒ BREA M. 1976, Nuovi scavi nei villaggi di Serra d Alto e Tirlecchia, in Atti della XX Riun. Scient., I.I.P.P., pp BROWN K. A. 1991, A passion for excavation. Labour requirements and possible functions for the ditches of the villaggi trincerati of the Tavoliere, Apulia, The Accordia, Research Papers, vol. 2, pp CALATTINI M., GALIBERTI A. 1978, Industria litica e ossea del villaggio neolitico della Villa Comunale (FG), Origini, XI, pp CASSANO S. M., MANFREDINI A. 1990, Recenti campagne di scavo a Masseria Candelaro (Manfredonia), in A. Gravina (a cura di), Atti dell 11 Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, pp CAZZELLA A., MOSCOLONI M. 1992, Popoli e civiltà dell Italia antica, Neolitico ed Eneolitico, vol. 11, Bologna. CIPOLLONI SAMPÒ M. 1983, Scavi nel villaggio neolitico di Rendina, Origini, XI, pp GRAVINA A. 1975, Fossati e strutture ipogeiche dei villaggi neolitici in agro di S. Severo, in Attualità Archeologiche, San Severo, pp GRAVINA A. 1980, Annotazioni sui fossati e strutture ipogeiche dei villaggi neolitici della Daunia Settentrionale, in Riv. Sc. Preist., XXXV, 1-2, pp JONES, G. B. D. (a cura di) 1987, Apulia, I. Neolithic settlement in the Tavoliere, London. MANFREDINI A. 1972, Il villaggio trincerato di Monte Aquilone nel quadro del Neolitico dell Italia meridionale, Origini, VI, pp TINÈ, S. 1983, Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, Genova. TOZZI, C. 1984, Il villaggio a ceramica impressa di Ripa Tetta (Lucera). Ricerche preliminari, Taras, IV, 2, pp TOZZI, C., VEROLA M. L. 1991, La campagna di scavo 1990 a Ripa Tetta (Lucera, Foggia), in A. Gravina (a cura di), Atti del 12 Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, pp VOLPE G., ROMANO A. V., GOFFREDO R. 2002, Archeologia dei paesaggi della valle del Celone, in A. Gravina (a cura di), Atti del 23 Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, pp
16 Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo 53 Tab.1 - Monte San Vincenzo - Saggio I, dimensioni dei fossati indagati. Tab. 2 - Monte San Vincenzo - Saggio II, dimensioni dei fossati indagati. Tab. 3 - Monte San Vincenzo - Saggio II, incidenza percentuale della ceramica d impasto e figulina in ciascuna US.
17 54 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti Fig. 1 - Monte San Vincenzo - Saggio I, planimetria generale dell area indagata.
18
19
20
21 58 A. M. Tunzi Sisto, M. Danesi, R. Simonetti Fig. 5 - Monte San Vincenzo - Ceramica: 1-5 Saggio I; 6-9 Saggio II.
22 299 INDICE PAOLO BOSCATO, ANNAMARIA RONCHITELLI La serie esterna di Paglicci. Gli scavi del pag. 3 ANNA MARIA TUNZI SISTO, ANDREA MONACO Il Neolitico a Foggia » 17 COSIMO D ORONZO, GIROLAMO FIORENTINO Analisi preliminare dei resti carpologici rinvenuti nel villaggio neolitico di Foggia (località ex-ippodromo)..» 33 ANNA MARIA TUNZI SISTO, MICHELA DANESI, RAMON SIMONETTI Il grande abitato neolitico di Troia - Monte S. Vincenzo...» 39 ARMANDO GRAVINA Casale De Maria (Carlantino, riva destra del Fortore). Frequentazione preistorica e protostorica » 59 PIERFRANCESCO TALAMO L aspetto campano di Laterza in Irpinia » 83 ARMANDO GRAVINA Santo Venditti (Carlantino, Valle medio-alta del Fortore) fra preistoria e protostoria » 97 ALBERTO CAZZELLA, MAURIZIO MOSCOLONI, GIULIA RECCHIA Gli scavi nell insediamento fortificato dell età del Bronzo di Coppa Nevigata (Manfredonia)...» 113 PIER FRANCESCO FABBRI, ISABELLA LEONE, ANNA MARIA TUNZI SISTO L ipogeo del Gigante a Trinitapoli (Fg): analisi tafonomica e antropologica di una sepoltura dell età del Bronzo....» 125
23 ALBERTO CAZZELLA, VALENTINA COPAT, MICHELA DANESI I livelli subappenninici del sito della Rocca di Oratino (CB): nuovi dati dalla valle del Biferno pag. 137 GIULIA RECCHIA, ALESSANDRO DE DOMINICIS, CRISTIANA RUGGINI Monteroduni - loc. Paradiso (IS): nuovi dati sulle fasi di occupazione del sito » 171 MARCO BETTELLI Un frammento di ceramica micenea da Monteroduni...» 189 ARMANDO GRAVINA L insediamento del Bronzo Medio e Recente di Pianelli (Carlantino - FG). Valle medio-alta del Fortore. Nota preliminare » 195 ANGELO VALENTINO ROMANO, GIULIA RECCHIA L età del Bronzo nel Tavoliere interno: nuovi dati dalle ricognizioni nella valle del Celone » 205 MARIA LUISA NAVA, VINCENZO CRACOLICI, RICHARD FLETCHER Osservazioni sulla topografia di Forentum-Lavello alla luce dei più recenti rinvenimenti » 253 MARISA CORRENTE Alcuni documenti di architettura funeraria da Canosa...» 275 GIANFRANCO DE BENEDITTIS La necropoli di Carlantino - Santo Venditti (FG).....» 307 PATRIZIO PENSABENE, ALESSANDRO D ALESSIO Il tempio di San Leucio a Canosa. Le nuove indagini dell Università degli Studi La Sapienza di Roma....» 317 GIOVANNA PACILIO Civiltà lungo un tracciato nel basso Tavoliere......» 333 GIORGIO POSTRIOTI L occupazione in età romana della collina di San Mercurio a Canne della Battaglia » 345
24 ROBERTO GOFFREDO Archeologia aerea nelle valli dell Ofanto e del Carapelle... pag. 359 ALESSANDRA DE STEFANO Alcune considerazioni sulla circolazione delle merci nella Daunia romana tra importazioni e produzioni locali (III a. C.).» 397 MARIA LUISA MARCHI, VALENTINA DI STEFANO, GIORGIA LEONI Paesaggi rurali della Daunia interna. Nuovi dati dall agro di Spinazzola (Ba), il complesso in località La Santissima » 425 GIOVANNA BALDASARRE Note preliminari sulla produzione laterizia a Canosa di Puglia in età tardoantica » 443 CATERINA ANNESE Ceramiche fini da mensa e circolazione delle merci nell Apulia tardoantica » 469 ANTONIETTA BUGLIONE Ricerche archeozoologiche in Puglia centro-settentrionale: primi dati sullo sfruttamento della risorsa animale fra Tardoantico e Altomedioevo » 495 PASQUALE FAVIA, GIANNI DE VENUTO, ANNALISA DI ZANNI Progetto di ricerca archeologica a San Lorenzo in Carminiano (Foggia). L avvio dell indagine e i primi risultati » 533 ARTURO PALMA DI CESNOLA Ricordo di Gianfranco Cresti ( ) » 569
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 1998 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO SECONDO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO SECONDO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
La frontiera di Lucania
 Comune di Rionero PIT Vulture Alto Bradano - The Vultur Archaeological Project La frontiera di Lucania Un area di interazione culturale nell epocaepoca pre-romana romana e di stabilità nell età romana.
Comune di Rionero PIT Vulture Alto Bradano - The Vultur Archaeological Project La frontiera di Lucania Un area di interazione culturale nell epocaepoca pre-romana romana e di stabilità nell età romana.
Giuseppe Delli Carri Viale Candelaro 28 L/c
 F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Giuseppe Delli Carri Viale Candelaro 28 L/c Telefono 0039 0881744942-00393404059484 Fax E-mail
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo Giuseppe Delli Carri Viale Candelaro 28 L/c Telefono 0039 0881744942-00393404059484 Fax E-mail
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO SECONDO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO SECONDO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
SITI DELL ETÀ MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB)
 SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4
 Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE
 COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE PROGETTO PER L APERTURA DI UNA CAVA DI CONGLOMERATO IN LOCALITÀ LUPAIOLO BASSO, COMUNE DI LUNANO. POLO ESTRATTIVO FCOB014-22B, PEAE PROV. DI
COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGIONE MARCHE PROGETTO PER L APERTURA DI UNA CAVA DI CONGLOMERATO IN LOCALITÀ LUPAIOLO BASSO, COMUNE DI LUNANO. POLO ESTRATTIVO FCOB014-22B, PEAE PROV. DI
RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI
 Povegliano Veronese f. 1 RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI POVEGLIANO VERONESE, EFFETUATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL VENETO IN COLLABORAZIONE
Povegliano Veronese f. 1 RELAZIONE SULL INTERVENTO DI RECUPERO DI ALCUNE SEPOLTURE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI POVEGLIANO VERONESE, EFFETUATO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL VENETO IN COLLABORAZIONE
REGIONE SICILIANA. Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana.
 REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI
 Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI Archeologa, coordinatrice degli scavi effettuati nel territorio di Montegibbio a partire dall estate del 2006. Finalità principale di questa ricerca, oggetto della sua tesi
Dottoressa FRANCESCA GUANDALINI Archeologa, coordinatrice degli scavi effettuati nel territorio di Montegibbio a partire dall estate del 2006. Finalità principale di questa ricerca, oggetto della sua tesi
II.1 I RITROVAMENTI. L incessante opera di erosione ed incisione del fiume Cesano, che
 II.1 I RITROVAMENTI L incessante opera di erosione ed incisione del fiume Cesano, che continua ininterrotta ormai dall epoca dell ultima glacaiazione, quella di Würm, quando era stata abbandonata per depositare
II.1 I RITROVAMENTI L incessante opera di erosione ed incisione del fiume Cesano, che continua ininterrotta ormai dall epoca dell ultima glacaiazione, quella di Würm, quando era stata abbandonata per depositare
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2007 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 28 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 25-26 novembre 2007 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2008 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 28 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 25-26 novembre 2007 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2008 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972)
 Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
Luciano Salzani 111 SABBIONARA DI GARDA. ABITATO DELL ANTICA ETA DEL BRONZO (SCAVI 1972) Luciano Salzani Nell autunno del 1971 i lavori di una cava di sabbia intaccavano l ultimo sperone di una collina
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2011 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ITALO M. MUNTONI* FRANCESCO
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ITALO M. MUNTONI* FRANCESCO
COMUNE DI REGGIO EMILIA RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 1 LETTERA b DELLA L.R. 24/2017 PER L AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE SEDE
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 1 LETTERA b DELLA L.R. 24/2017 PER L AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE SEDE
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA NOVEMBRE Con il patrocinio:
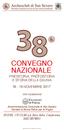 CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
I N D I C E 1 PREMESSA SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICI METODOLOGIA DESCRIZIONE ANALITICA...
 I N D I C E 1 PREMESSA... 2 2 SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO... 7 3 SAGGI ARCHEOLOGICI... 9 3.1 METODOLOGIA... 9 3.2 DESCRIZIONE ANALITICA... 14 4 ESITO ARCHEOLOGICO... 27 1 PREMESSA La presente relazione
I N D I C E 1 PREMESSA... 2 2 SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO... 7 3 SAGGI ARCHEOLOGICI... 9 3.1 METODOLOGIA... 9 3.2 DESCRIZIONE ANALITICA... 14 4 ESITO ARCHEOLOGICO... 27 1 PREMESSA La presente relazione
LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
MASSERIA E CHIESA SS. PIETRO E ANDREA (LOC. MARRESE) INSEDIAMENTI
 UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa Componenti culturali e insediative Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico) MASSERIA E CHIESA SS. PIETRO E ANDREA (LOC. MARRESE)
UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa Componenti culturali e insediative Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico) MASSERIA E CHIESA SS. PIETRO E ANDREA (LOC. MARRESE)
Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1
 ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
ARIMNESTOS Ricerche di Protostoria Mediterranea 1/2018, pp. 147-155 Patrizia von Eles* Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso 1 Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Verucchio
SAN DtrMETRIO NE'VtrSTINI (AQ). FRAZIONE STIFFE CENTRALE IDROELETTRICA
 SAN DtrMETRIO NE'VtrSTINI (AQ). FRAZIONE STIFFE CENTRALE IDROELETTRICA Rapporto sondaggi di scavo archeologico rt s fi e Introduzione La presente relazione è stata redatta in seguito alla nota della Soprintendenza
SAN DtrMETRIO NE'VtrSTINI (AQ). FRAZIONE STIFFE CENTRALE IDROELETTRICA Rapporto sondaggi di scavo archeologico rt s fi e Introduzione La presente relazione è stata redatta in seguito alla nota della Soprintendenza
fusione, di piccole dimensioni, e due monete residuali di epoca romana, tra cui un Giano bifronte con la prora della nave sul retro.
 Il mastio sorge nel punto più alto del vicus, la vista è notevole e apre a 270 su un panorama che spazia dal Massiccio della Maiella e si perde verso sud fino a Foggia. Lo scavo interessa i due ambienti
Il mastio sorge nel punto più alto del vicus, la vista è notevole e apre a 270 su un panorama che spazia dal Massiccio della Maiella e si perde verso sud fino a Foggia. Lo scavo interessa i due ambienti
Archeologia Report n.4
 MONITORAGGIO AMBIENTALE Archeologia Report n.4 Data del rilievo Settimana dal 28/03/2016 al 01/04/2016. Luogo del rilievo Campo base (pile 41-43-44), Cava Berleta (pile 14-15-16), Aeroporto (pile 1-5-6-7-8),
MONITORAGGIO AMBIENTALE Archeologia Report n.4 Data del rilievo Settimana dal 28/03/2016 al 01/04/2016. Luogo del rilievo Campo base (pile 41-43-44), Cava Berleta (pile 14-15-16), Aeroporto (pile 1-5-6-7-8),
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro
 Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
R07 FILE DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO
 Via Pier Carlo Cadoppi, 14-42124 Reggio Emilia Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006 Mail: COMMITTENTE PROGETTISTA AR/S Archeosistemi Soc. Coop. COLLABORATORE FASE DI PROGETTO MONTANARI & GRUZZA via
Via Pier Carlo Cadoppi, 14-42124 Reggio Emilia Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006 Mail: COMMITTENTE PROGETTISTA AR/S Archeosistemi Soc. Coop. COLLABORATORE FASE DI PROGETTO MONTANARI & GRUZZA via
CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO
 1 of 24 CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO 2 of 24 L intervento in oggetto si è svolto in agro di Crispiano (Loc. Cacciagualani) all interno
1 of 24 CRISPIANO (TA) LOC. CACCIAGUALANI PROPRIETA ZACCARIA RELAZIONE SCIENTIFICA DI SCAVO ARCHEOLOGICO 2 of 24 L intervento in oggetto si è svolto in agro di Crispiano (Loc. Cacciagualani) all interno
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
DIGA DI BADANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE BOSIO (AL) PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO. SAGGI
 DIGA DI BADANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE BOSIO (AL) PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO. SAGGI RELAZIONE ARCHEOLOGICA Committente: Mediterranea delle Acque Referente Scientifico:
DIGA DI BADANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE BOSIO (AL) PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO. SAGGI RELAZIONE ARCHEOLOGICA Committente: Mediterranea delle Acque Referente Scientifico:
!!" # $ %$" && "#' & # (" " * # )!" +,-.
 !!"#$%$" &&"#'&#(")" *#)!"+,-. Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
!!"#$%$" &&"#'&#(")" *#)!"+,-. Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
Progetto di Dottorato Curriculum Archeologia Preistorica XXXI ciclo
 Progetto di Dottorato Curriculum Archeologia Preistorica XXXI ciclo GLI IPOGEI DELL ETÀ DEL BRONZO DI TRINITAPOLI E SAN FERDINANDO DI PUGLIA RACHELE MODESTO INTRODUZIONE Il presente progetto di ricerca
Progetto di Dottorato Curriculum Archeologia Preistorica XXXI ciclo GLI IPOGEI DELL ETÀ DEL BRONZO DI TRINITAPOLI E SAN FERDINANDO DI PUGLIA RACHELE MODESTO INTRODUZIONE Il presente progetto di ricerca
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
Acquarossa: tramonto.
 La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
La Città Silente 8 Il Territorio e gli Insediamenti 12 Acquarossa: il Nome e la Storia 14 l importanza degli Scavi di Acquarossa 20 Ferento: il Nome 22 La Storia degli Scavi nel sito di Ferento 26 Gli
1. Introduzione I. M. Muntoni dott. Francesco Genchi dott.ssa Nicoletta Scopece dott.ssa Nunzia Maria Mangialardi dott.
 1. Introduzione Le indagini archeologiche condotte in Via Parini, alla periferia sud di Foggia, nei pressi del Campo degli Ulivi e a poche centinaia di metri della Masseria Pantano, sono state promosse
1. Introduzione Le indagini archeologiche condotte in Via Parini, alla periferia sud di Foggia, nei pressi del Campo degli Ulivi e a poche centinaia di metri della Masseria Pantano, sono state promosse
NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA
 NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA Nel settembre 1977, durante i lavori di scavo per l impianto di un tratto della nuova rete fognante, sono venute in luce, nel centro di Foggia,
NOTA SUL VILLAGGIO NEOLITICO SCOPERTO AL CENTRO DI FOGGIA Nel settembre 1977, durante i lavori di scavo per l impianto di un tratto della nuova rete fognante, sono venute in luce, nel centro di Foggia,
Figura 1 Foto aerea del sito studiato. L area di interesse archeologico è delimitata dal cerchio rosso.
 ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA E DEI SUOI TESORI INVISIBILI: INDAGINI GEOFISICHE E DATABASE ON LINE PER IL SITO DI EGNAZIA ALLEGATO TECNICO Le tecniche geofisiche da oltre 50 anni offrono un importante contributo
ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA E DEI SUOI TESORI INVISIBILI: INDAGINI GEOFISICHE E DATABASE ON LINE PER IL SITO DI EGNAZIA ALLEGATO TECNICO Le tecniche geofisiche da oltre 50 anni offrono un importante contributo
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
Piazza Marconi [1] Per quanto riguarda le buche, chiamate da noi per distinguerle, "rosse", sono state svuotate le U.S.
![Piazza Marconi [1] Per quanto riguarda le buche, chiamate da noi per distinguerle, rosse, sono state svuotate le U.S. Piazza Marconi [1] Per quanto riguarda le buche, chiamate da noi per distinguerle, rosse, sono state svuotate le U.S.](/thumbs/88/115025551.jpg) Piazza Marconi [1] Ad un mese circa dalla ultime notizie fornite sullo scavo di Piazza Marconi, ora si può dire che le indagini stratigrafiche si sono concentrate in due punti: l'edificio sul lato ovest,
Piazza Marconi [1] Ad un mese circa dalla ultime notizie fornite sullo scavo di Piazza Marconi, ora si può dire che le indagini stratigrafiche si sono concentrate in due punti: l'edificio sul lato ovest,
Piazza Marconi, gli scavi continuano [1]
![Piazza Marconi, gli scavi continuano [1] Piazza Marconi, gli scavi continuano [1]](/thumbs/88/115808587.jpg) Piazza Marconi, gli scavi continuano [1] Nonostante il freddo polare, gli scavi in Piazza Marconi continuano con una serie di ritrovamenti di grandissimo interesse. Lo scavo ha raggiunto la profondità
Piazza Marconi, gli scavi continuano [1] Nonostante il freddo polare, gli scavi in Piazza Marconi continuano con una serie di ritrovamenti di grandissimo interesse. Lo scavo ha raggiunto la profondità
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
L ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO SULL ACROPOLI DI BROGLIO DI TREBISACCE
 GRANDI CONTESTI E PROBLEMI DELLA PROTOSTORIA ITALIANA 6/2 Prima di Sibari a cura di R. Peroni e A. Vanzetti Claudio Moffa L ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO SULL ACROPOLI DI BROGLIO DI TREBISACCE Dallo studio
GRANDI CONTESTI E PROBLEMI DELLA PROTOSTORIA ITALIANA 6/2 Prima di Sibari a cura di R. Peroni e A. Vanzetti Claudio Moffa L ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO SULL ACROPOLI DI BROGLIO DI TREBISACCE Dallo studio
$ #% &'( & ) # * ++ ' )# ' ( & -./0
 !" #$#%&'(& )#*++')# ),('(& -./0 Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
!" #$#%&'(& )#*++')# ),('(& -./0 Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
LA NECROPOLI DI FENIL NUOVO
 Luciano Salzani 11 LA NECROPOLI DI FENIL NUOVO La località Fenil Novo è rappresentata da un grande dosso ghiaioso, situato presso la riva destra dell Adige. I rinvenimenti sono avvenuti nel 1980. Nei lavori
Luciano Salzani 11 LA NECROPOLI DI FENIL NUOVO La località Fenil Novo è rappresentata da un grande dosso ghiaioso, situato presso la riva destra dell Adige. I rinvenimenti sono avvenuti nel 1980. Nei lavori
Santuario preistorico di Monte d Accoddi
 Santuario preistorico di Monte d Accoddi Il villaggio-santuario di Monte d Accoddi è composto da un gruppo di abitazioni (solo parzialmente indagate) che si dispongono attorno ad un singolare ed imponente
Santuario preistorico di Monte d Accoddi Il villaggio-santuario di Monte d Accoddi è composto da un gruppo di abitazioni (solo parzialmente indagate) che si dispongono attorno ad un singolare ed imponente
Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica Relazione sulle indagini preliminari Dott.ssa Gabriella
Resti del III-IV secolo a Solaro (MI)
 The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
The Journal of Fasti Online Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica Piazza San Marco, 49 I-00186 Roma Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org
Gravellona Toce Prima campagna di scavo del castrum Gravallone
 Gravellona Toce Prima campagna di scavo del castrum Gravallone Paolo de Vingo Giovanni Battista Parodi Paolo de Vingo Dipartimento di Studi Storici Università degli Studi di Torino Via S. Ottavio 20 (4
Gravellona Toce Prima campagna di scavo del castrum Gravallone Paolo de Vingo Giovanni Battista Parodi Paolo de Vingo Dipartimento di Studi Storici Università degli Studi di Torino Via S. Ottavio 20 (4
REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI INTROD
 REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI INTROD REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA LOC.PLANTEY CENTRALE RU DE PONTON Verifica preventiva di rischio archeologico Dottoressa Cinzia Joris Dottoressa
REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI INTROD REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA LOC.PLANTEY CENTRALE RU DE PONTON Verifica preventiva di rischio archeologico Dottoressa Cinzia Joris Dottoressa
ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018. Allegato 2. Prof. Roberto PERNA
 ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018 Allegato 2 Prof. Roberto PERNA Pollentia-Urbs Salvia : localizzazione topografica Tardoantico 19 siti Medioevo 81 siti Paleolitico - mesolitico 25 siti Non id. 106 siti
ARCHEOLOGIA CLASSICA AA 2017/2018 Allegato 2 Prof. Roberto PERNA Pollentia-Urbs Salvia : localizzazione topografica Tardoantico 19 siti Medioevo 81 siti Paleolitico - mesolitico 25 siti Non id. 106 siti
Necropoli di Pantalica, un luogo speciale che racconta il passato
 Necropoli di Pantalica, un luogo speciale che racconta il passato - Siciliafan Page 1 of 7 Necropoli di Pantalica, un luogo speciale che racconta il passato La Necropoli di Pantalica è un importante area
Necropoli di Pantalica, un luogo speciale che racconta il passato - Siciliafan Page 1 of 7 Necropoli di Pantalica, un luogo speciale che racconta il passato La Necropoli di Pantalica è un importante area
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
 COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Marta BOTTOS. Materiali di età medievale e moderna
 Marta BOTTOS Materiali di età medievale e moderna Non sono molte le attestazioni di ceramiche postclassiche provenienti dall area in oggetto di studio. L analisi dei pochi reperti recuperati nell area
Marta BOTTOS Materiali di età medievale e moderna Non sono molte le attestazioni di ceramiche postclassiche provenienti dall area in oggetto di studio. L analisi dei pochi reperti recuperati nell area
OGGETTO : RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO - 5/8 LOTTO DI LAVORI
 MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
1970 Santa Maria Capua Vetere (antica Capua). Necropoli delle Fornaci. Soprintendenza archeologica delle Province di Napoli e Caserta.
 1968 Alba - La Romaine (Francia). Università Claude Bernard (Lyon).. 1969 Ampurias (Spagna). Istituto di Studi Liguri. Albintimillium Ventimiglia. Istituto di Studi Liguri. Albenga. Relitto repubblicano.
1968 Alba - La Romaine (Francia). Università Claude Bernard (Lyon).. 1969 Ampurias (Spagna). Istituto di Studi Liguri. Albintimillium Ventimiglia. Istituto di Studi Liguri. Albenga. Relitto repubblicano.
Nota per la stampa ARCHEOLOGIA E ALTA VELOCITÀ IN ITALIA
 Nota per la stampa ARCHEOLOGIA E ALTA VELOCITÀ IN ITALIA Bologna, 16 dicembre 2007 UN OCCASIONE DI CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ANTICO In Italia la realizzazione dell alta velocità ferroviaria rappresenta
Nota per la stampa ARCHEOLOGIA E ALTA VELOCITÀ IN ITALIA Bologna, 16 dicembre 2007 UN OCCASIONE DI CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ANTICO In Italia la realizzazione dell alta velocità ferroviaria rappresenta
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Documento di Valutazione Archeologica Preventiva. Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC
 AR.PA. Ricerche Committente EUSIDER Immobiliare Documento di Valutazione Archeologica Preventiva Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC 2013 AR.PA. Ricerche - Via Strada della Piazza, 13-23821 Abbadia Lariana
AR.PA. Ricerche Committente EUSIDER Immobiliare Documento di Valutazione Archeologica Preventiva Cascina Cadrega Costa Masnaga -LC 2013 AR.PA. Ricerche - Via Strada della Piazza, 13-23821 Abbadia Lariana
Stefan Planker / Herwig Prinoth RELAZIONE SULLA SCOPERTA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO STETTENECK IN VAL GARDENA
 Stefan Planker / Herwig Prinoth RELAZIONE SULLA SCOPERTA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO STETTENECK IN VAL GARDENA Sigillo degli Stetteneck 1. Individuazione del sito. Secondo la tradizione popolare il castello
Stefan Planker / Herwig Prinoth RELAZIONE SULLA SCOPERTA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO STETTENECK IN VAL GARDENA Sigillo degli Stetteneck 1. Individuazione del sito. Secondo la tradizione popolare il castello
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO CONVEGNO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2017 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109\2005 artt.2ter
CONVEGNO NAZIONALE. Archeoclub di San Severo PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011
 Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2011 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ALBERTO CAZZELLA* MAURIZIO
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 32 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 12-13 novembre 2011 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2012 ALBERTO CAZZELLA* MAURIZIO
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI. (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE
 LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE Dr. Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street Sheffield,
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO (VICUS) A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO 2012 RAPPORTO PRELIMINARE Dr. Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street Sheffield,
Storia di un reperto archeologico. Dott.ssa Martellucci Sabrina 1
 Storia di un reperto archeologico Dott.ssa Martellucci Sabrina 1 Come si sceglie un sito? Le Fonti : storiche; geografiche; cartografiche; fotografiche; Iconografiche. Studio Approfondimento Probabile
Storia di un reperto archeologico Dott.ssa Martellucci Sabrina 1 Come si sceglie un sito? Le Fonti : storiche; geografiche; cartografiche; fotografiche; Iconografiche. Studio Approfondimento Probabile
ELENCO DELLE UNITÀ STRATIGRAFICHE
 8. 191 Strato Pulizia della metà orientale della carreggiata. 192 Strato Pulizia del settore nord-occidentale dell area di scavo. 193 Strato Pulizia del settore sud-occidentale dell area di scavo. 194
8. 191 Strato Pulizia della metà orientale della carreggiata. 192 Strato Pulizia del settore nord-occidentale dell area di scavo. 193 Strato Pulizia del settore sud-occidentale dell area di scavo. 194
Relatore: Fabio Mantovani Correlatore: Riccardo Salvini. Tesista : Nadia Bianconi
 Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO CONVEGNO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2017 A T T I
 ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO 38 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18-19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38 Convegno Nazionale
Capitolato d Oneri Prescrizioni per la redazione elaborati
 Affidamento dei servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS per le attività di studio e di indagini archeologiche nell ambito del Progetto Definitivo di Adeguamento e messa in sicurezza della SS
Affidamento dei servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS per le attività di studio e di indagini archeologiche nell ambito del Progetto Definitivo di Adeguamento e messa in sicurezza della SS
(I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
 SCAVO DI DUE TOMBE ALLA CAPPUCCINA (I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio CINETO ROMANO (Roma) Loc. Torrente Ferrata 27-29 aprile
SCAVO DI DUE TOMBE ALLA CAPPUCCINA (I II sec d. C.) Prof. Zaccaria MARI Funzionario archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio CINETO ROMANO (Roma) Loc. Torrente Ferrata 27-29 aprile
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO Metroferrovia di Palermo Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama Relazione sulla prevenzione archeologica. Relazione sul rischio archeologico Lavori eseguiti dalla
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI. (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE
 LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE Prof.ssa Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street
LO SCAVO NELL INSEDIAMENTO A VAGNARI (Gravina in Puglia, BA) LUGLIO-AGOSTO 2015 RAPPORTO PRELIMINARE Prof.ssa Maureen Carroll Department of Archaeology University of Sheffield Northgate House West Street
PREMESSA LO SCAVO. Fratta Nord
 1 PREMESSA L intervento oggetto di questa relazione si è svolto nelle giornate dal 23 al 25 novembre 2010, nel comune di Fossalta di Portogruaro (VE), presso le stazioni di servizio Fratta Nord e Fratta
1 PREMESSA L intervento oggetto di questa relazione si è svolto nelle giornate dal 23 al 25 novembre 2010, nel comune di Fossalta di Portogruaro (VE), presso le stazioni di servizio Fratta Nord e Fratta
Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia)
 Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia) Università degli Studi di Siena Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento LAP&T Data dei rilievi: 19-20/08/2006 Area del rilievo: Città antica
Prospezioni magnetometriche Burnum (Croazia) Università degli Studi di Siena Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento LAP&T Data dei rilievi: 19-20/08/2006 Area del rilievo: Città antica
Committente: COMUNE di TRANI (BT) RAPPORTO TECNICO INTEGRATIVO. Relativa a:
 Committente: COMUNE di TRANI (BT) RAPPORTO TECNICO INTEGRATIVO Relativa a: - Esecuzione di trincee esplorative presso la ex Cava Cortellino, cava dismessa posta in Contrada Monachelle in agro di Trani
Committente: COMUNE di TRANI (BT) RAPPORTO TECNICO INTEGRATIVO Relativa a: - Esecuzione di trincee esplorative presso la ex Cava Cortellino, cava dismessa posta in Contrada Monachelle in agro di Trani
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC)
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) PIANA DI SAN MARTINO SITO TARDO ANTICO ALTOMEDIEVALE INDAGINI ARCHEOLOGICHE L'area di scavo della Piana di San Martino,
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO --- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) PIANA DI SAN MARTINO SITO TARDO ANTICO ALTOMEDIEVALE INDAGINI ARCHEOLOGICHE L'area di scavo della Piana di San Martino,
5 ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO - ARCHEOLOGICO
 PROVINCIA DI FORLI -CESENA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PSC 2004 ADOTTATO 26.04.2004 APPROVATO PIANO STRUTTURALE LR 24 marzo 2000 n. 20 art. 28 e attuazione dell art. 8 del PTPR 5 ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE
PROVINCIA DI FORLI -CESENA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PSC 2004 ADOTTATO 26.04.2004 APPROVATO PIANO STRUTTURALE LR 24 marzo 2000 n. 20 art. 28 e attuazione dell art. 8 del PTPR 5 ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE
n 24 GROTTE GROTTE TROIANO
 n 24 GROTTE GROTTE TROIANO GROTTE TROIANO (Descrizione : Giuseppe Sorino Presidente Archeoclub) Ubicate nel foglio di mappa, N. 21, particella N. 434, alla profondità di circa 5,00 mt., si snodano da sud
n 24 GROTTE GROTTE TROIANO GROTTE TROIANO (Descrizione : Giuseppe Sorino Presidente Archeoclub) Ubicate nel foglio di mappa, N. 21, particella N. 434, alla profondità di circa 5,00 mt., si snodano da sud
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia
 Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
Amiternum ricerche archeologiche dell Istitutio Archeologico dell Università di Colonia Rapporto sulla campagna 2010 (Michael Heinzelmann Manuel Buess) Dal 26/7 al 31/8/2010 l Istituto Archeologico dell
Sandrino Luigi MARRA. Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce)
 Sandrino Luigi MARRA Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce) Le ceramiche del castello di Gioia Sannitica sono il frutto di un salvataggio effettuato tra il 2004 ed il 2005 durante i lavori di
Sandrino Luigi MARRA Le ceramiche del Castello di Gioia Sannitica (Ce) Le ceramiche del castello di Gioia Sannitica sono il frutto di un salvataggio effettuato tra il 2004 ed il 2005 durante i lavori di
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CLAUDIO NEGRELLI. Castelli tardoantichi 2
 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 2014-2015 CLAUDIO NEGRELLI Castelli tardoantichi 2 I castelli bizantini della Liguria Il problema dei castelli altomedievali in Liguria viene trattato per la prima volta da D. Bullough,
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 2014-2015 CLAUDIO NEGRELLI Castelli tardoantichi 2 I castelli bizantini della Liguria Il problema dei castelli altomedievali in Liguria viene trattato per la prima volta da D. Bullough,
