1 Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale
|
|
|
- Norberto Mariani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento, 2-3 Novembre 2002 TECNICA RADIOASTRONOMICA DILETTANTISTICA E possibile la radioastronomia amatoriale? Flavio Falcinelli
2 Cos è la Radioastronomia? La radioastronomia studia i corpi celesti analizzando la radiazione elettromagnetica da questi emessa nell'intervallo spettrale delle radioonde grazie ai radiotelescopi. Un radiotelescopio è un complesso strumento di misura che comprende un sistema di antenna collegato ad apparati elettronici riceventi e di registrazione dei dati. CNR-IRA Medicina Stazione VLBI Mappa radio del cielo a 408 MHz
3 L'analisi dei segnali ricevuti consiste nel determinare l'intensità delle radiazioni cosmiche captate dalle diverse direzioni dello spazio e per differenti lunghezze d'onda, oltre al loro grado di polarizzazione. Ulteriore campo d indagine consiste nell analizzare le caratteristiche spettrali dei segnali ricevuti per ottenere importanti informazioni sugli oggetti radioemittenti. Radiomappa del quasar 3C179
4 Radioastronomia = tecniche radioelettriche applicate allo studio del cielo Il radiotelescopio più grande del mondo: VLA
5 RADIOASTRONOMIA AMATORIALE Ha senso parlare di radioastronomia amatoriale? Sono ipotizzabili esperienze interessanti anche per il dilettante in un settore complesso come questo??
6 Radioastronomia amatoriale Presenta qualche ostacolo e difficoltà di natura tecnica. Non sono disponibili commercialmente gli strumenti, quindi occorre costruirsi tutto (o quasi) in proprio. E una disciplina che richiede un minimo di conoscenze in settori paralleli quali: - fisica ed astrofisica (conoscenze teoriche di base) - astronomia (conoscenze teoriche di base) - elettronica (costruzione degli strumenti) - meccanica (costruzione degli strumenti) - informatica (acquisizione ed elaborazione dati). Per ottenere qualche risultato interessante è auspicabile impostare l attività nello stile del lavoro di gruppo.
7 Ricerca radioastronomica ufficiale Radioastronomia dilettantistica Visitando le imponenti e complesse strutture della ricerca radioastronomica ufficiale appare evidente l elevato livello di competenza e di specializzazione dei ricercatori, insieme ai costi astronomici delle strutture indispensabili per gareggiare con successo nella competizione scientifica. Ciò può facilmente scoraggiare i modesti progetti a carattere amatoriale se non sono ben chiari i limiti raggiungibili e gli obiettivi del lavoro.
8 Come ci si accosta alla radioastronomia: Conoscenza teorica dei principi di base Approccio corretto all attività dilettantistica Conoscere bene gli strumenti e gli impianti Individuare le possibilità concrete di ricerca Lavoro di gruppo per ottenere i migliori risultati
9 Un po di storia La radioastronomia studia la radiazione elettromagnetica naturale proveniente dagli oggetti celesti nell intervallo spettrale delle radioonde (tipicamente 20 MHz GHz). E nata casualmente circa 60 anni fa per opera di K. Jansky, un radioingegnere (Bell & Teleph.) impegnato nello studio dei disturbi elettromagnetici artificiali e naturali. La prima antenna radioastronomica della storia (1931): si tratta della famosa giostra di Jansky funzionante alla frequenza di 20.5 MHz. La struttura, in grado di ruotare di 360, era organizzata come un array di loop quadrate collegato ad un ricevitore appositamente costruito.
10 Primo segnale extraterrestre rivelato a 20.5 MHz: radioemissioni provenienti dal centro della Galassia. Primo impianto radioastronomico costruito ad hoc : paraboloide orientabile (9 metri di diametro) e ricevitore di G. Reber funzionanti a 160 MHz con il quale è stato possibile compilare la prima radiomappa della Galassia (1944). Radiomappa di Reber a 160 MHz G. Reber
11 Inizio ufficiale della ricerca radioastronomica: subito dopo la 2 guerra mondiale, stimolata dagli sviluppi tecnologici delle radiocomunicazioni e delle tecniche radar. Costruzione dei primi grandi impianti radioastronomici. Compilazione dei primi cataloghi di radiosorgenti, scoperta delle PULSAR, delle QUASAR, della radiazione fossile del fondo a microonde a 3 K, delle righe di emissione di molecole complesse (molte delle quali organiche). Sviluppo della radiointerferometria, delle tecniche di ricezione a sintesi d apertura, delle tecniche interferometriche a base continentale (VLBI) e della radioastronomia spaziale.
12 IL FUTURO DELLA RADIOASTRONOMIA: perfezionamento delle tecniche radiointerferometriche ad elevatissima risoluzione; radiointerferometria VLBI fra strumenti a terra e strumenti a bordo di satelliti artificiali; installazione di radiotelescopi sulla faccia nascosta della Luna. sistemi SKA (Square Kilometer Array)
13 I NEMICI DELLA RICERCA RADIOASTRONOMICA Sono l inquinamento elettromagnetico artificiale, sempre più diffuso, e l appropriazione indebita delle radiofrequenze riservate alla ricerca radioastronomica. I disturbi atmosferici ed artificiali sono molto importanti alle basse frequenze, mentre diventano trascurabili nella banda delle microonde. E per questi motivi che un radiometro SHF può anche essere installato sotto casa [db] 10log 10 (T a /T o ), con T o =290 K disturbo atmosferico notte disturbo artificiale giorno max rumore cosmico min Frequenza f [MHz]
14 Discipline parallele che utilizzano strumenti analoghi a quelli della radioastronomia RADARASTRONOMIA: utilizza le tecniche radar per analizzare i radioechi provenienti dai corpi celesti più vicini (pianeti, asteroidi, etc.) bombardati da impulsi radioelettrici molto potenti. Ricerche SETI (Searc for Extraterrestrial Intelligence): si occupano di esplorare il cielo nel tentativo di scoprire possibili segnali radio provenienti da civiltà extraterrestri progredite. In questo caso la ricerca è mirata verso segnali radio artificiali con caratteristiche peculiari. Guida e Controllo di sonde spaziali.
15 SPETTRO ELETTROMAGNETICO L estensione della finestra radio all interno dello spettro elettromagnetico è di notevole ampiezza (superiore a 10 ottave nello spettro) rispetto al quella ottica (di ampiezza pari a circa 1 ottava).
16 FINESTRA RADIO e TRASPARENZA ATMOSFERICA La finestra operativa è quella delle radioonde, limitata inferiormente dai noti effetti schermanti della ionosfera terrestre, superiormente dai fenomeni di assorbimento molecolare delle onde radio dovuti principalmente al vapore acqueo (con picchi di assorbimento alle frequenze di circa 22 GHz e 184 GHz) e all ossigeno (con picchi di assorbimento a circa 60 GHz e 118 GHz). Radioastronomia
17 Radiosorgenti termine generico che indica tutti gli oggetti celesti responsabili delle radioemissioni cosmiche. Tali corpi, in funzione del loro meccanismo di emissione specifico e prevalente, possono esibire caratteristiche fisiche e radiative molto diverse uno dall altro. Radiotelescopio è lo strumento che consente di osservare, misurare e registrare il flusso di onde radio naturali emesse dalle radiosorgenti. E composto da un sistema di antenna, da linee di trasmissione che convogliano il segnale ricevuto ad un ricevitore, da dispositivi per l elaborazione e la registrazione dei dati acquisiti. La struttura comprende anche gli organi di controllo e di puntamento.
18 Concettualmente un RADIOTELESCOPIO non è troppo differente da un normale apparato ricevente per radiocomunicazioni, anche se alcune caratteristiche peculiari sono specializzate per garantire il corretto trattamento dei segnali ricevuti (sostanzialmente rappresentati da RUMORI). Schema a blocchi che illustra la struttura di un semplice RADIOMETRO
19 Segnali elaborati da un ricevitore radioastronomico Equazione del radiometro: T= T S K BNτ o B=banda passante RX; N= numero registrazioni; T s =temperatura di rumore del sistema ricevente; τ o =cost. di tempo integratore; T = segnale min. rivelabile
20 L intensità minima di radiazione che può essere raccolta dall antenna di un radiotelescopio dipende dalla rumorosità complessiva del sistema ricevente. Il segnale utile cosmico è di tipo aleatorio, costituito da rumore a distribuzione gaussiana dei livelli e spettro di potenza uniforme, simile al rumore termico degli apparati, quindi indistinguibile da questo. T= T S K BNτ o Schematizzazione dell andamento della temperatura d antenna di un sistema ricevente quando l antenna è puntata verso il cielo. Si noti l incremento rispetto al rumore di fondo dovuto al passaggio di una radiosorgente attraverso il fascio d antenna.
21 Le frequenze inferiori a 1 MHz sono assorbite dalle particelle cariche della ionosfera terrestre che funge da schermo per tutte le onde radio di frequenza inferiore a MHz. D'altra parte, la stessa atmosfera limita superiormente le frequenze utilizzabili (intorno ai 20 GHz) a causa dei fenomeni di assorbimento molecolare. Quali frequenze utilizzare per le osservazioni? I grafici evidenziano l intervallo delle frequenze utili per le osservazioni radioastronomiche da terra. Si vede come la finestra spettrale aperta dall atmosfera terrestre sia quella compresa fra MHz e GHz.
22 La scelta della frequenza operativa è legata anche alle caratteristiche emissive delle radiosorgenti: radiazione termica i segnali ricevuti sono più intensi alle frequenze elevate; radiazione non termica i segnali ricevuti sono più intensi alle basse frequenze. Variazione spettrale relativa delle radioemissioni termiche e non termiche. Le sorgenti termiche emettono come corpi neri a temperatura costante ed uniforme e sono caratterizzate da un andamento del flusso crescente con la frequenza. Le sorgenti non termiche (molto più numerose) sono caratterizzate da un flusso decrescente con la frequenza ed irradiano generalmente per emissione di sincrotrone.
23 Legge della radiazione di corpo nero di Planck spiega le radioemissioni di natura termica Questo è l andamento dell emissione nella finestra radio Tipica curva di emissione (per una specifica temperatura) di un oggetto cosmico che irradia secondo meccanismi termici (es. il Sole quieto)
24 Principali radiosorgenti accessibili agli strumenti amatoriali
25 Densità di flusso [f.u.] per CASSIOPEIA A Frequenza [MHz] Tipici spettri di radiosorgenti non termiche: sono decrescenti con la frequenza Qui si riceve meglio che qui Temperatura di brillanza dell'equatore galattico [ K] Sono particolarmente adatte per i primi esperimenti radioastronomici Frequenza [MHz]
26 10000 Radioemissione del sole quieto S(f) [10-22 W m -2 Hz -1 ] max. min. Spettro della radiosorgente termica più intensa: il Sole Frequenza [MHz] Densità di flusso [f.u.] Le più importanti radiosorgenti non termiche Cyg A Tau A Cass A Sag A 100 Vir A Frequenza [MHz] 10000
27 Unità di misura per la densità di flusso delle radiosorgenti: 1 f.u. = 1 Jy = W/(Hz.m 2 ) chiamata unità di flusso (f.u.) o Jansky (Jy)
28 Classificazione delle bande di frequenza radio Lunghezza d onda Frequenza Denominazione Km KHz ELF: Extremely Low Frequency Km 3-30 KHz VLF: Very Low Frequency 10-1 Km KHz LF: Low Frequency m MHz MF: Medium Frequency m 3-30 MHz HF: High Frequency 10-1 m MHz VHF: Very High Frequency mm GHz UHF: Ultra High Frequency mm 3-30 GHz SHF: Super High Frequency 10-1 mm GHz EHF: Extremely High Frequency
29 Frequenze riservate alla radioastronomia Osservazione nel continuo: Osservazione nel continuo e del deuterio: Osservazione del continuo: Osservazione dell idrogeno: Osservazione dell ossidrile: Osservazione nel continuo: Osservazione di CH: Osservazione nel continuo e di H 2 CO: Osservazione nel continuo: Osservazione di H 2 CO: Osservazione nel continuo: Osservazione di H 2 CO: Osservazione di NH 3 : Osservazione nel continuo e del radicale ammonio: Osservazione nel continuo: MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz In grassetto sono indicate le bande ad uso esclusivo, all interno delle quali é vietato produrre qualsiasi tipo di emissione: queste bande sono di particolare interesse astrofisico e spesso coincidono con le righe d emissione di molecole importanti.
30 Antenne per radioastronomia Un antenna ricevente è un sistema che ha lo scopo di convertire l energia elettromagnetica captata dallo spazio in segnali elettrici misurabili. Un antenna radioastronomica deve essere molto direttiva (per stabilire la direzione di provenienza della radiazione) ed essere caratterizzata da elevato potere risolutivo (capacità di distinguere due radiosorgenti molto vicine nello spazio).
31 Caratteristiche delle antenne Un antenna é utile in radioastronomia se possiede: 1. Elevata direttività e ridotto livello dei lobi laterali 2. Elevato potere risolutivo 3. Grande area efficace 4. Struttura orientabile. Notevoli problemi strutturali e di costo Tipico diagramma di ricezione di un sistema d antenna utilizzato in radioastronomia
32 SISTEMI DI ANTENNA RADIOASTRONOMICI: esempi di realizzazioni dilettantistiche A B D C A. Array di yagi B. Array di eliche C. Riflettore parabolico D. Tromba piramidale
33 Array di 4 antenne ad elica (tipica realizzazione amatoriale)
34 Analisi dei segnali ricevuti Analisi radiometrica (ricevitore total power): si valuta la potenza associata alla radiazione elettromagnetica incidente. Lo strumento utilizzato è il radiometro. Analisi spettrale: si valutano l ampiezza e la fase delle varie componenti del segnale entro una specificata banda di frequenze. Lo strumento utilizzato è il radiospettrografo. Analisi interferometrica: si valutano l ampiezza e la fase della cosiddetta funzione visibilità delle frange di interferenza (prodotte da un sistema di due o più antenne) per stimare la distribuzione di brillanza della radiosorgente osservata. Lo strumento utilizzato è il radiointerferometro.
35 Possibili aree di interesse per la ricerca radioastronomica amatoriale: banda ELF-VLF: non sono ricevibili le radiazioni esterne in quanto schermate dalla ionosfera, ma si possono programmare studi molto interessanti per rivelare l attività meteorica (fenomeni di ionizzazione dell atmosfera terrestre indotta da eventi astronomici). Interessanti correlazioni con le ricerche su Radio Natura. Strumenti molto economici, semplici da costruire e da installare. banda HF: si effettuano ricezioni non troppo lontane dal limite inferiore dello spettro radio. Studio delle tempeste radio solari e gioviane, studio della radiazione galattica. In questa banda di frequenze sono particolarmente intense le radiosorgenti non termiche. Ricevitori non troppo complicati da costruire, sistemi d antenna molto ingombranti e caratterizzati da modesta direttività.
36 banda VHF: a tali frequenze sarà relativamente semplice la ricezione del centro galattico, di Cassiopeia A e di Cygnus A. Installando un buon sistema d'antenna accoppiato con un ricevitore abbastanza sensibile si potranno rivelare le pulsar più potenti che, a causa del loro meccanismo di emissione, presentano un massimo di emissione proprio in banda VHF. Questa è una ricerca difficile. Ricevitori relativamente complessi e sistemi d antenna accessibili. Possibilità di interessanti interventi di modifica su apparati provenienti da mercato radioamatoriale e/o surpuls, su kit di ricevitori Proposti da riviste di elettronica hobbistica e da case produttrici di kit Elettronici. Possibilità di utilizzo di tuner TV commerciali. banda UHF: in tale banda, molto utilizzata dalla ricerca ufficiale (soprattutto negli anni 60 e 70) le radiosorgenti accessibili ai dilettanti non sono particolarmente intense. Ricevitori relativamente complessi e sistemi d antenna accessibili. E possibile utilizzare materiale TV (tuner ed antenne a basso costo).
37 banda SHF: in questa banda di frequenze è molto importante la componente termica della radiazione cosmica e, utilizzando strumenti non troppo complicati, è relativamente semplice la ricezione del Sole, della Luna e di altre radiosorgenti. La diffusione di mercato della ricezione SAT-TV, GPS e della telefonia cellulare ha reso disponibili, a prezzi molto vantaggiosi, componenti elettronici e moduli adatti alla costruzione di efficienti radiometri a microonde. Una grande varietà di antenne SHF è reperibile sul mercato. Si possono sviluppare interessanti attività dilettantistiche di esplorazione radioastronomica spettrale del cielo, comprese ricerche SETI amatoriali. Radiometro SHF sperimentale funzionante nella banda di frequenze GHz costruito utilizzando moduli provenienti dal mercato TV-SAT.
38 Proposte per la ricerca amatoriale Studio dei fenomeni elettromagnetici naturali nella parte inferiore dello spettro radio (banda ELF-VLF): - Rivelazione dei fenomeni meteoritici - Attività di monitoraggio Radio Natura (prog. Ispire NASA) - Correlazione con i fenomeni sismici (precursori) - Disturbi ionosferici indotti dall attività solare. Studio delle tempeste radio del Sole e di Giove in banda HF (collegamenti con il progetto RadioJove della NASA). Collegamento con le scuole. Interessanti correlazioni con le fluttuazioni del campo magnetico terrestre. Programma SIDs dell AAVSO (monitoraggio dei brillamenti solari osservando stazioni VLF nella banda KHz). Collegamento con le scuole. Attività di METEOR SCATTER. Attività di ricerca SETI amatoriale (ad es. progetto BAMBI - USA) in banda SHF (rete di osservatori ciascuno dotato di piccoli strumenti).
39 TIPO di PROGETTO ATTREZZATURE LIVELLO DI CULTURA e NECESSARIE PRATICA in ELETTRONICA Monitoraggio dei brillamenti Ricevitore VLF ed modesto (ricevitore ed antenna Solari in VLF antenna loop magnetica semplici ed economici) Studi sulle meteore Ricevitore VLF ed antenna modesto (come sopra) FACILE Tempeste radio di Giove Ricevitore e Dipolo HF buono (ricevitore non troppo complesso, antenna semplice) Ricezione total-power di radiosorgenti in banda Ricevitore HF-VHF ed buono (ricevitore relativamente HF-VHF antenna complesso ed antenna complessa) Radiometri in banda Preampli-RF a basso rumore buono-avanzato (ricevitore UHF-SHF Ricevitori ed antenne SHF relativamente complesso ed antenna ottimizzate complessa) Rivelazione di Pulsar Preampli-RF a basso rumore avanzato (ricevitore complesso ed Ricevitori VHF-UHF ed antenna molto complessa) antenne ottimizzate DIFFICILE Radiointerferometria e Ricevitori multipli, array molto avanzato (notevole Mappatura di radiosorgenti di antenne e tecniche FFT complessità del sistema e degli algoritmi di elaborazione) Ricerche SETI Ricevitore SHF ed antenna avanzato (complessità del ricevitore, ottimizzati, algoritmi FFT dell antenna e degli algoritmi di elaborazione)
40 Parametri importanti di uno strumento radioastronomico Sensibilità (minima rumorosità del ricevitore) Guadagno del sistema (tipico db, regolabile) Stabilità del sistema (non esiste AGC) Banda passante del ricevitore Costante di tempo dell integratore Direttività del sistema d antenna Calibrazione dello strumento Possibilità di orientare il fascio di ricezione Possibilità di inseguire le radiosorgenti. Occorre controllare in particolare: - la stabilità delle tensioni di alimentazione - la stabilità della temperatura ambiente
41 Osservazioni in banda ELF-VLF
42 Sistemi riceventi ULF-ELF-VLF: semplici da costruire economici software disponibile in rete molti sperimentatori con cui confrontarsi Ricevitore ELF-VLF sperimentale Tipico spettrogramma
43 Interventi chiave: 1. Disattivare il circuito AGC 2. Rifare l alimentazione stabilizzata generale 3. Perfezionare lo stadio rivelatore 4. Stabilizzare termicamente il sistema. Osservazioni in banda VHF-UHF modifiche su un televisore
44 Registrazione di prova effettuata per verificare la stabilità del sistema rispetto alle variazioni della temperatura ambiente. Al posto dell'antenna è stato applicato un carico fittizio con il ricevitore sistemato all'interno di un'abitazione. La misura è stata avviata un'ora dopo l'accensione dell'apparecchio registrando automaticamente i dati nel corso delle successive 25 ore. La variazione del segnale registrato rappresenta la risposta del sistema alle variazioni di temperatura del carico fittizio e dei circuiti interni. Esaminando il grafico si vede come il minimo della risposta del sistema si verifichi effettivamente durante le ore notturne, quando si registrano i minimi valori della temperatura ambiente.
45 Monitoraggio della radiazione decametrica di Giove e delle radiotempeste solari Schema di principio della più semplice stazione ricevente amatoriale utilizzabile per la registrazione dei radio burst di Giove alle frequenze intorno a 20 MHz. HF_RadioAstroLab Esempio di ricevitore amatoriale adatto per la registrazione dei radioburst solari e di Giove
46 Radiazione galattica alle lunghezze d onda decametriche Prototipo di un ricevitore ad amplificazione diretta funzionante alla frequenza di 20.4 MHz (banda passante pari a circa 830 KHz) con il quale è stato possibile replicare le esperienze di Jansky. Registrazione di prova effettuata con il ricevitore collegato ad un semplice dipolo filare a mezz onda disposto orizzontalmente rispetto al terreno ed orientato con i massimi di radiazione in direzione NE-SO. A parte i disturbi locali a carattere impulsivo, si distinguono i larghi massimi periodici dovuti alla radiazione complessiva proveniente da centro galattico. Si noti la stabilità del sistema tipica dei ricevitori ad amplificazione diretta.
47 Radiotelescopio a MHz con antenna ad array di dipoli e riflettore piano Antenna formata da 4 file parallele con 16 dipoli ciascuna (64 dipoli in totale), caratterizzata da un guadagno superiore a 23 db (corrispondente ad un area efficace di circa 65 m 2 ). La forma del lobo di ricezione è a ventaglio con un ampiezza del fascio dell ordine di 20 nella direzione N-S, 8 nella direzione E-W.
48 Stazione ricevente 134, 327, 408 MHz Il ricevitore é fisicamente organizzato in 3 scatole metalliche schermate principali, oltre ad un gruppo di contenitori esterni che comprendono gli stadi RF commutabili e le relative alimentazioni. Ogni scatola comprende i circuiti di alimentazione stabilizzati con il relativo trasformatore di rete mentre i comandi, le visualizzazioni e le connessioni sono disposti in modo da poter "comporre" l'impianto sovrapponendo semplicemente i vari moduli. Nella foto a destra si vedono (partendo dall alto) il modulo degli oscillatori locali, il modulo dell amplificatore principale (comprendente i convertitori di frequenza, gli amplificatori IF e l attenuatore discreto di precisione, il rivelatore di ampiezza che utilizza un moltiplicatore analogico a quattro quadranti). Il modulo che si vede in basso è quello relativo all amplificatore di post-rivelazione e all integratore.
49 Osservazione delle radiosorgenti termiche in banda SHF
50 Sole
51 Galassia Scansione del cielo alla frequenza di 12 GHz (06 Gennaio 2002). La parte destra della registrazione mostra il massimo corrispondente al passaggio della Via Lattea per la declinazione di +22. Il ricevitore SHF, equipaggiato con un antenna ad array di fessure, è stato predisposto per un amplificazione DC pari a 100 con una costante di tempo dell ordine di 2 secondi.
52 Registrazione della radiosorgente TAURUS A (Crab Nebula: residuo compatto di supernova) effettuata con il radiometro SHF alla frequenza di 10 GHz al limite della sensibilità e della risoluzione strumentale. Il grafico mostra uno zoom relativo al transito della radiosorgente dove appaiono evidenti i limiti della risoluzione (errore di quantizzazione) del convertitore analogico-digitale ad 8 bit utilizzato nella scheda di acquisizione automatica del segnale rivelato. Tale limitazione è evidenziata dall ampiezza molto ridotta del picco di segnale (dell ordine di 80 mv) rispetto alla dinamica totale consentita per l ingresso dell ADC (0-5 V). Si sarebbe ottenuta una rappresentazione molto più accurata utilizzando un ADC con risoluzione pari a 12 o 16 bit.
53 Radiometro e Radiospettrografo funzionante nella finestra water-hole ( MHz) Il sistema può operare come radiometro (segnale d uscita proporzionale alla potenza associata al segnale captato dall antenna) e come radiospettrografo per analisi e studi nel dominio della frequenza (utilizzabile per ricavare il profilo delle righe spettrali di interesse astrofisico e per ricerche SETI amatoriali). In modalità spettrale occorre elaborare il segnale in banda base (0-8 MHz) con un ADC veloce in grado di campionare in tempo reale segnali fino ad 8 MHz.
54 Copyright 1999 by H. Paul Shuch, Ph.D. Executive Director, The SETI League, Inc. PO Box 555, Little Ferry NJ Ricerca SETI amatoriale Analisi spettrale a scansione di frequenza
55 Ricerche SETI amatoriali metodi spettrali a confronto: - analisi spettrale a scansione di frequenza (es. progetto BAMBI) semplice ma poco efficiente in quanto si analizza una fettina di frequenza alla volta entro una specificata banda. Tipico sistema amatoriale è quello mostrato nella precedente diapositiva. - analisi spettrale in tempo reale con FFT più complessa e costosa della precedente in quanto richiede un ricevitore con uscita in banda-base (qualche MHz) che sarà analizzata da un sistema di acquisizione veloce che calcola la FFT dei dati. Grazie alla disponibilità di PC veloci, è oggi possibile effettuare il calcolo della FFT via software anziché utilizzando DSP dedicati. Esempio di radiospettrometro é SHF_RadioAstroLab.
56 Sistemi di acquisizione e registrazione automatica dei dati Indispensabili per registrare automaticamente i campioni del segnale rivelato, sono generalmente costituiti da una scheda elettronica che realizza l interfaccia fra il ricevitore ed il PC. Il cuore del circuito è un convertitore analogico-digitale (ADC) che trasforma il segnale rivelato all uscita del ricevitore in un dato numerico (binario) inviato al PC in forma seriale (RS232C) o in forma parallela (porta parallela o slot interno). Il programma di gestione del PC consentirà la visualizzazione e la registrazione dei dati acquisiti in maniera automatica, realizzando una stazione non presidiata da operatore.
57 La scelta dell ADC dipende dalla dinamica del segnale analogico da convertire. Ogni volta che si effettua una conversione AD si introduce un rumore, detto rumore di quantizzazione, che è tanto maggiore quanto minore è il numero di bit in cui è convertito ogni singolo campione (risoluzione dell ADC). Una conversione AD caratterizzata da una risoluzione troppo bassa produce una cattiva rappresentazione delle variazioni in ampiezza del segnale originale, quindi introduce un rumore aggiuntivo di cui occorre tener conto. La velocità di conversione dipende dalla rapidità di variazione del segnale (Teorema del Campionamento).
58 Radiometri (ricevitori total power) di solito si utilizza una elevata costante di tempo per l integratore (ridottissima banda passante dello stadio di uscita del ricevitore) in modo da ottimizzare il rapporto segnale/rumore del sistema. Non servono ADC veloci e la trasmissione dei dati al PC può essere di tipo seriale (RS232C) a tutto vantaggio della semplicità e della praticità della connessione. Radiospettrografi in questo caso occorre campionare ed acquisire tutti i segnali che cadono all interno di una banda di qualche MHz (segnali in bandabase). Serve un ADC veloce che trasmetta altrettanto velocemente i dati al PC: non è più utilizzabile il canale seriale ma è indispensabile accedere al bus interno del computer (schede connesse direttamente allo slot interno).
59 Prototipo di amplificatore DCintegratore con interfaccia di acquisizione dati seriale per PC. L apparecchio è stato costruito recuperando il contenitore (completo di strumento a bobina mobile ad ampio quadrante) di un voltmetro elettronico da laboratorio fuori uso. Si nota il pannello frontale con i comandi di regolazione discreta del guadagno DC, dell offset del segnale d uscita (livello dello zero di riferimeto) realizzata con potenziometro di precisione multigiri e della costante di tempo dell integratore. Sono anche visibili i connettori BNC per il segnale d ingresso e d uscita, oltre al cavetto per la connessione seriale con il PC.
60 Radiointerferometria Ultima generazione di radiotelescopi é quella dei radiointerferometri, complessi strumenti che sfruttano i principi già noti dell'interferometria ottica per migliorare notevolmente il potere risolutivo. Antenne del VLA
61 Per rivelare il flusso di radiosorgenti deboli é indispensabile utilizzare un sistema di antenna caratterizzato da grande area efficace, per distinguere maggiori dettagli strutturali é necessario un elevato potere risolutivo raggiungibile utilizzando strumenti dotati di un fascio di ricezione sufficientemente stretto. Questa caratteristica é direttamente collegata alle dimensioni fisiche del sistema di antenna, con limiti notevoli circa la risoluzione ottenibile in pratica: il problema si risolve utilizzando i sistemi interferometrici che derivano, in linea di principio, dallo strumento ottico di Michelson.
62 Sintesi d apertura E una tecnica di ricezione (Ryle ed Hewish, 1960) che si contrappone alla ricezione ad apertura piena tipica delle grandi antenne singole: nello studio delle sorgenti celesti con radiazione che non varia nel tempo non é necessario che sia immediatamente disponibile l'intera apertura dell'antenna ricevente. Utilizzando un numero ridotto di aree riceventi elementari (al limite due) e muovendole sequenzialmente in maniera opportuna é possibile sintetizzare l'informazione che sarebbe ottenibile istantaneamente dall'intera superficie. La velocità di ricostruzione dell'informazione dipende dal numero, dalla disposizione e dalla mobilità dei singoli elementi.
63 Per spingere il potere risolutivo oltre i limiti raggiungibili da una singola antenna si ricorre alla composizione dei segnali provenienti da due o più antenne (ciascuna avente dimensioni relativamente modeste) poste a una distanza grande rispetto alle loro dimensioni e alla lunghezza d'onda operativa. Veduta aerea del radiotelescopio Croce del Nord a Medicina (BO). Sulla destra è visibile anche l antenna VLBI da 32 m a riflettore parabolico. E evidente la caratteristica struttura a T basata sul principio della croce di Mills.
64 I radiointerferometri e gli array di antenne a sintesi d'apertura sono stati sviluppati per misurare fini dettagli angolari della radiazione cosmica, superando agevolmente i limiti di risoluzione imposti dai radiotelescopi ad antenna singola. La principale informazione astronomica che si ottiene dalle osservazioni interferometriche é contenuta nelle ampiezze e nelle fasi delle frange di interferenza. Struttura del radiointerferometro di Westerbork (Olanda)
65 Le moderne tecniche radiointerferometriche utilizzano gruppi di radiotelescopi distribuiti su dimensioni molto grandi (sull'intera superficie della Terra - VLBI, oppure sulla Terra e lo spazio a bordo di satelliti artificiali) che operano come le fenditure di un reticolo di diffrazione: il potere risolutivo dipende dalle dimensioni totali dello strumento e può essere reso molto grande. Oggi si raggiungono poteri risolutivi inferiori al millesimo di secondo d'arco che consentono di studiare oggetti celesti con notevole dettaglio (parti centrali di galassie e quasar lontane).
66 Strutture dei radiointerferometri semplici Andamento delle risposte (frange di interferenza) relative alle due configurazioni basilari di radiointerferometri.
67 1 Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento, 2-3 Novembre 2002 TECNICA RADIOASTRONOMICA DILETTANTISTICA E possibile la radioastronomia amatoriale? Flavio Falcinelli
Radioastronomia. Il radioastrofilo. dott. Mario Sandri
 Radioastronomia Il radioastrofilo dott. Mario Sandri mario@grrat.cjb.net La radioastronomia amatoriale è Sono possibili esperimenti per un semplice appassionato del settore oppure tale ambito di ricerca
Radioastronomia Il radioastrofilo dott. Mario Sandri mario@grrat.cjb.net La radioastronomia amatoriale è Sono possibili esperimenti per un semplice appassionato del settore oppure tale ambito di ricerca
Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Flavio Falcinelli
 Radioastronomia amatoriale Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Parleremo di Gli strumenti della radioastronomia: il radiotelescopio. Possibilità operative della radioastronomia
Radioastronomia amatoriale Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Parleremo di Gli strumenti della radioastronomia: il radiotelescopio. Possibilità operative della radioastronomia
Radioastronomia: qualche cosa per iniziare.
 Radioastronomia: qualche cosa per iniziare. Semplice radiometro a microonde Marco Bagaglia Laboratorio di Astrofisica Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Perugia Osservatorio Astronomico e
Radioastronomia: qualche cosa per iniziare. Semplice radiometro a microonde Marco Bagaglia Laboratorio di Astrofisica Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Perugia Osservatorio Astronomico e
Radioastronomia Amatoriale
 Radioastronomia Amatoriale Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it www.radioastrolab.it Dopo
Radioastronomia Amatoriale Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it www.radioastrolab.it Dopo
Ricevitore SID: schema a blocchi
 Ricevitore SID: schema a blocchi Pre-Amp All frequencies Coax Band-pass Filter Band-pass Filter (10-50kHz) (Amplitude Modulation) Signal Strength 12 bit, Analog to Digital Conversion DATAQ RS-232 = Computer
Ricevitore SID: schema a blocchi Pre-Amp All frequencies Coax Band-pass Filter Band-pass Filter (10-50kHz) (Amplitude Modulation) Signal Strength 12 bit, Analog to Digital Conversion DATAQ RS-232 = Computer
Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11
 Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11 La radioastronomia Giorgio G.C. Palumbo Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Astronomia Lo spettro elettromagnetico Osservare il cielo solo nella
Introduzione alla Cosmologia Fisica Lezione 11 La radioastronomia Giorgio G.C. Palumbo Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Astronomia Lo spettro elettromagnetico Osservare il cielo solo nella
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico. Laura Vallone
 Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
Strumentazione per la misura a banda stretta del campo elettromagnetico Laura Vallone Strumentazione a banda stretta Un misuratore di campo EM a banda stretta si compone di varie parti: o Sistema di ricezione
Associazione Astrofili Urania Le possibilità di ricerca per gli astrofili nello spettro radio.
 Associazione Astrofili Urania Le possibilità di ricerca per gli astrofili nello spettro radio. Stefano Bologna, IZ1BPN Le osservazioni astronomiche si basano sull analisi della radiazione elettromagnetica
Associazione Astrofili Urania Le possibilità di ricerca per gli astrofili nello spettro radio. Stefano Bologna, IZ1BPN Le osservazioni astronomiche si basano sull analisi della radiazione elettromagnetica
Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito
 Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito Andrea Trucco, Ph.D. Dipartimento Ingegneria Biofisica ed Elettronica DIBE - Università di Genova trucco@ieee.org 1 Segnale audio Variazione della pressione
Calcolo numerico per utilizzare i residui di udito Andrea Trucco, Ph.D. Dipartimento Ingegneria Biofisica ed Elettronica DIBE - Università di Genova trucco@ieee.org 1 Segnale audio Variazione della pressione
Unione Astrofili Napoletani. I Mercoledì del Cielo. Introduzione alla radioastronomia. Gino Di Ruberto
 Unione Astrofili Napoletani I Mercoledì del Cielo Introduzione alla radioastronomia Gino Di Ruberto 1 Onde elettromagnetiche Sono oscillazioni del campo elettrico e del campo magnetico. Come la luce, anche
Unione Astrofili Napoletani I Mercoledì del Cielo Introduzione alla radioastronomia Gino Di Ruberto 1 Onde elettromagnetiche Sono oscillazioni del campo elettrico e del campo magnetico. Come la luce, anche
Amplificatore DC con integratore e ADC
 Amplificatore DC con integratore e ADC Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it www.radioastrolab.it
Amplificatore DC con integratore e ADC Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it www.radioastrolab.it
Grandezze radiometriche
 Grandezze radiometriche La Radiometria ha per oggetto la misurazione dell energia irradiata da una o più sorgenti in una qualunque regione dello spettro elettromagnetico. Si consideri una sorgente di radiazione
Grandezze radiometriche La Radiometria ha per oggetto la misurazione dell energia irradiata da una o più sorgenti in una qualunque regione dello spettro elettromagnetico. Si consideri una sorgente di radiazione
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Osservare la radiazione a microonde della Luna con RAL10
 Osservare la radiazione a microonde della Luna con RAL10 Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it
Osservare la radiazione a microonde della Luna con RAL10 Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39 071 6608166 - Fax: +39 071 6612768 info@radioastrolab.it
DEFINIZIONE DI RADIANZA La radiazione è caratterizzata tramite la Radianza Spettrale, I (λ, θ, φ, T), definita come la densità di potenza per unità di
 SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
Struttura Analizzatore di Reti
 ANALIZZATORE DI RETI Struttura Analizzatore di Reti test generazione DUT incidente riflesso trasmesso rivelazione visualizzazione e controllo 1 Sezione di Generazione Oscillatori spazzolati Oscillatori
ANALIZZATORE DI RETI Struttura Analizzatore di Reti test generazione DUT incidente riflesso trasmesso rivelazione visualizzazione e controllo 1 Sezione di Generazione Oscillatori spazzolati Oscillatori
MATERIALI PER LA DISCUSSIONE
 SETTORE TECNOLOGICO MATERIALI PER LA DISCUSSIONE ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ESITI DI APPRENDIMENTO Regolamento, Art. 5 comma 1 Nota: Le Competenze,
SETTORE TECNOLOGICO MATERIALI PER LA DISCUSSIONE ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ESITI DI APPRENDIMENTO Regolamento, Art. 5 comma 1 Nota: Le Competenze,
Misure e requisiti sperimentali di misure di spettro e anisotropia del fondo cosmico
 Misure e requisiti sperimentali di misure di spettro e anisotropia del fondo cosmico Aniello Mennella Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Cosa trattiamo oggi Richiamiamo la temperatura
Misure e requisiti sperimentali di misure di spettro e anisotropia del fondo cosmico Aniello Mennella Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Cosa trattiamo oggi Richiamiamo la temperatura
Banco Educazionale Arra MT 1
 Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università
Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università
Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13
 Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13 Via ai Ronchi 21049 Tradate (VA) Cod. Fisc./P.I. 02880420126 Tel/fax: 0331 841900 Cell: 333-4585998 Email: foam13@foam13.it Internet: www.foam13.it
Fondazione onlus sservatorio stronomico di Tradate essier 13 Via ai Ronchi 21049 Tradate (VA) Cod. Fisc./P.I. 02880420126 Tel/fax: 0331 841900 Cell: 333-4585998 Email: foam13@foam13.it Internet: www.foam13.it
Il segnale radio in arrivo dallo spazio Lo studio del cosmo con gli strumenti radioelettrici
 Il segnale radio in arrivo dallo spazio Lo studio del cosmo con gli strumenti radioelettrici Le possibilità della radioastronomia amatoriale La radioastronomia studia i corpi celesti analizzando la loro
Il segnale radio in arrivo dallo spazio Lo studio del cosmo con gli strumenti radioelettrici Le possibilità della radioastronomia amatoriale La radioastronomia studia i corpi celesti analizzando la loro
Rappresentazione digitale del suono
 Rappresentazione digitale del suono Perché rappresentazione del suono Trasmettere a distanza nel tempo e nello spazio un suono Registrazione e riproduzione per tutti Elaborazione del segnale audio per
Rappresentazione digitale del suono Perché rappresentazione del suono Trasmettere a distanza nel tempo e nello spazio un suono Registrazione e riproduzione per tutti Elaborazione del segnale audio per
UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 1 AstroUAN MEETING OAC, 5 NOVEMBRE 2011 Socio: Filippo Bove TANTO PER COMINCIARE
 UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 1 AstroUAN MEETING OAC, 5 NOVEMBRE 2011 Socio: Filippo Bove TANTO PER COMINCIARE La Radioastronomia La radioastronomia studia i corpi celesti analizzando la radiazione elettromagnetica
UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 1 AstroUAN MEETING OAC, 5 NOVEMBRE 2011 Socio: Filippo Bove TANTO PER COMINCIARE La Radioastronomia La radioastronomia studia i corpi celesti analizzando la radiazione elettromagnetica
Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Flavio Falcinelli
 Radioastronomia amatoriale Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Parleremo di Gli strumenti della radioastronomia: il radiotelescopio. Possibilità operative della radioastronomia
Radioastronomia amatoriale Uno sguardo sulle possibilità di ricerca per i radioastronomi dilettanti Parleremo di Gli strumenti della radioastronomia: il radiotelescopio. Possibilità operative della radioastronomia
DA RADIO FREQUENZA A CORRENTE CONTINUA
 GIUSEPPE ZELLA DA RADIO FREQUENZA A CORRENTE CONTINUA Sistemi di Conversione di Energia Prefazione L'energia dei segnali RF generati e presenti nell'ambiente RF offre una potenziale sorgente di energia
GIUSEPPE ZELLA DA RADIO FREQUENZA A CORRENTE CONTINUA Sistemi di Conversione di Energia Prefazione L'energia dei segnali RF generati e presenti nell'ambiente RF offre una potenziale sorgente di energia
Capitolo IX. Convertitori di dati
 Capitolo IX Convertitori di dati 9.1 Introduzione I convertitori di dati sono circuiti analogici integrati di grande importanza. L elaborazione digitale dei segnali è alternativa a quella analogica e presenta
Capitolo IX Convertitori di dati 9.1 Introduzione I convertitori di dati sono circuiti analogici integrati di grande importanza. L elaborazione digitale dei segnali è alternativa a quella analogica e presenta
Strumentazione di misura dei livelli di esposizione
 Modulo A.1: Organizzazione sanitaria (Formazione di base) Strumentazione di misura dei livelli di esposizione Ente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma E-mail: settimio.pavoncello@pec.ording.roma.it
Modulo A.1: Organizzazione sanitaria (Formazione di base) Strumentazione di misura dei livelli di esposizione Ente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma E-mail: settimio.pavoncello@pec.ording.roma.it
2. Analisi in frequenza di segnali
 2.1 Serie di Fourier 2. Analisi in frequenza di segnali Secondo il teorema di Fourier, una funzione periodica y(t) è sviluppabile in una serie costituita da un termine costante A 0 e da una somma di infinite
2.1 Serie di Fourier 2. Analisi in frequenza di segnali Secondo il teorema di Fourier, una funzione periodica y(t) è sviluppabile in una serie costituita da un termine costante A 0 e da una somma di infinite
DEIS ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
 ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Campi a basse e alte frequenze per la valutazione dei livelli di esposizione Vengono considerati in modo del tutto distinto i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
La strumentazione NMR. ed alcuni dettagli sul metodo a Trasformata di Fourier
 La strumentazione NMR ed alcuni dettagli sul metodo a Trasformata di Fourier 1 Lo Spettrometro NMR 2 Il magnete: genera il campo B 0, intenso, stabile ed omogeneo 600MHz 15 T 900 MHz 22 T 60MHz 1.5 T 3
La strumentazione NMR ed alcuni dettagli sul metodo a Trasformata di Fourier 1 Lo Spettrometro NMR 2 Il magnete: genera il campo B 0, intenso, stabile ed omogeneo 600MHz 15 T 900 MHz 22 T 60MHz 1.5 T 3
Acquisizione Dati. Introduzione
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali Corso di Sperimentazione sulle Macchine Acquisizione Dati Introduzione Introduzione In campo scientifico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali Corso di Sperimentazione sulle Macchine Acquisizione Dati Introduzione Introduzione In campo scientifico
BOCCHIGLIERO Sistema di comunicazione ---- Materia: Telecomunicazioni. Serafini Rossella. prof. Ing. Zumpano Luigi
 I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO a.s. 2010/2011 -classe III- Materia: Telecomunicazioni ---- Sistema di comunicazione ---- alunna Serafini Rossella prof. Ing. Zumpano Luigi Sistema di comunicazione Messaggi
I.P.S.I.A. Di BOCCHIGLIERO a.s. 2010/2011 -classe III- Materia: Telecomunicazioni ---- Sistema di comunicazione ---- alunna Serafini Rossella prof. Ing. Zumpano Luigi Sistema di comunicazione Messaggi
L Universo Invisibile. Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico
 L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
Antenna Da Interno Amplificata DVB-T SRT ANT 12
 Antenna Da Interno Amplificata DVB-T SRT ANT 12 Istruzioni d uso 1.0 Introduzione Gentile Cliente La ringraziamo per aver acquistato l antenna DVB-T STRONG SRT ANT 12. L antenna è stata sviluppata per
Antenna Da Interno Amplificata DVB-T SRT ANT 12 Istruzioni d uso 1.0 Introduzione Gentile Cliente La ringraziamo per aver acquistato l antenna DVB-T STRONG SRT ANT 12. L antenna è stata sviluppata per
SENSORE DI TENSIONE SP
 SENSORE DI TENSIONE SP3000-01 2 Sensore di tensione per la cattura di segnali elettrici senza contatto metallico sul conduttore L ingegneria elettronica è spesso chiamata a misurare impulsi di breve durata
SENSORE DI TENSIONE SP3000-01 2 Sensore di tensione per la cattura di segnali elettrici senza contatto metallico sul conduttore L ingegneria elettronica è spesso chiamata a misurare impulsi di breve durata
Esperimenti a 11.2 GHz con SPIDER230: Il transito di Cassiopea A
 Esperimenti a 11.2 GHz con SPIDER230: Il transito di Cassiopea A Flavio Falcinelli Doc. Vers. 1.0 del 27.03.2014 @ 2014 RadioAstroLab RadioAstroLab s.r.l., Via Corvi, 96 60019 Senigallia (AN) Tel. +39
Esperimenti a 11.2 GHz con SPIDER230: Il transito di Cassiopea A Flavio Falcinelli Doc. Vers. 1.0 del 27.03.2014 @ 2014 RadioAstroLab RadioAstroLab s.r.l., Via Corvi, 96 60019 Senigallia (AN) Tel. +39
LSS ADC DAC. Piero Vicini A.A
 LSS 2016-17 ADC DAC Piero Vicini A.A. 2016-2017 Conversione Digitale-Analogica La conversione digitale-analogica (DAC, Digital to Analog Conversion) permette di costruire una tensione V (o una corrente
LSS 2016-17 ADC DAC Piero Vicini A.A. 2016-2017 Conversione Digitale-Analogica La conversione digitale-analogica (DAC, Digital to Analog Conversion) permette di costruire una tensione V (o una corrente
Antenne per i telefoni cellulari
 Antenne per i telefoni cellulari annamaria.cucinotta@unipr.it http://www.tlc.unipr.it/cucinotta 1 Requisiti terminali mobili I principali vincoli da tenere in conto nella progettazione di un antenna per
Antenne per i telefoni cellulari annamaria.cucinotta@unipr.it http://www.tlc.unipr.it/cucinotta 1 Requisiti terminali mobili I principali vincoli da tenere in conto nella progettazione di un antenna per
Sorgenti per telecomunicazioni e modalità di esposizione
 Salute e campi elettromagnetici Ministero della Salute CCM Centro di Controllo delle Malattie Torino, 26 maggio 2009 Sorgenti per telecomunicazioni e modalità di esposizione Giovanni d Amore ARPA Piemonte
Salute e campi elettromagnetici Ministero della Salute CCM Centro di Controllo delle Malattie Torino, 26 maggio 2009 Sorgenti per telecomunicazioni e modalità di esposizione Giovanni d Amore ARPA Piemonte
L' Elettronica s.a.s. Via S. G. Bosco n. 22 Asti
 L' Elettronica s.a.s. Via S. G. Bosco n. 22 Asti L' Elettronica s.a.s. Sede legale e punto vendita diretto: via S. G. Bosco n. 22-14100 ASTI sede ufficio e magazzino spedizioni: via Valle n. 24 14033 Castell'
L' Elettronica s.a.s. Via S. G. Bosco n. 22 Asti L' Elettronica s.a.s. Sede legale e punto vendita diretto: via S. G. Bosco n. 22-14100 ASTI sede ufficio e magazzino spedizioni: via Valle n. 24 14033 Castell'
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Controllo dell irrigazione senza fili
 Introduzione Oggi è possibile sostituire il comando delle valvole di irrigazione effettuato via cavo con un comando via radio ottenendo una serie indiscutibile di vantaggi: È molto improbabile il verificarsi
Introduzione Oggi è possibile sostituire il comando delle valvole di irrigazione effettuato via cavo con un comando via radio ottenendo una serie indiscutibile di vantaggi: È molto improbabile il verificarsi
DIGITALE TERRESTRE. Non Solo Televisione. Parte.2 Ricezione del segnale DTT Problematiche di convivenza con i segnali AM-TV
 DIGITALE TERRESTRE Non Solo Televisione Parte.2 Ricezione del segnale DTT Problematiche di convivenza con i segnali AM-TV a cura di: Vincenzo Servodidio Ricezione dei segnali DTT Nella ricezione dei segnali
DIGITALE TERRESTRE Non Solo Televisione Parte.2 Ricezione del segnale DTT Problematiche di convivenza con i segnali AM-TV a cura di: Vincenzo Servodidio Ricezione dei segnali DTT Nella ricezione dei segnali
N. 5 Misuratori in Banda Larga per il rilevamento del campo elettrico e magnetico
 La strumentazione del Servizio Agenti Fisici utilizzata per le attività di misurazione dei campi elettromagnetici o per le attività di studio e di ricerca è composta dai seguenti strumenti: N. 1 Misuratore
La strumentazione del Servizio Agenti Fisici utilizzata per le attività di misurazione dei campi elettromagnetici o per le attività di studio e di ricerca è composta dai seguenti strumenti: N. 1 Misuratore
Unione Astrofili Napoletani Corso base di radioastronomia Lezione 3
 Unione Astrofili Napoletani Corso base di radioastronomia Lezione 3 Indice: Ricordiamo cosa sono le onde elettromangetiche p. 2 Ricordiamo lo spettro elettromagnetico p. 2 Ricordiamo lo spettro radio p.
Unione Astrofili Napoletani Corso base di radioastronomia Lezione 3 Indice: Ricordiamo cosa sono le onde elettromangetiche p. 2 Ricordiamo lo spettro elettromagnetico p. 2 Ricordiamo lo spettro radio p.
convertitore D/A convertitore A/D
 n bit linee digitali N =2 n livelli range o dinamica tensione analogica d'ingresso IN IN convertitore D/A convertitore A/D OUT 1 filo linea analogica la tensione v out è quantizzata OUT n bit o N livelli
n bit linee digitali N =2 n livelli range o dinamica tensione analogica d'ingresso IN IN convertitore D/A convertitore A/D OUT 1 filo linea analogica la tensione v out è quantizzata OUT n bit o N livelli
Apparati per uso industriale e ricerca Dott.ssa Alessandra Bernardini
 Apparati per uso industriale e ricerca Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Apparecchiature radiologiche per analisi industriali e ricerca Le apparecchiature a raggi X utilizzate nell industria utilizzano
Apparati per uso industriale e ricerca Dott.ssa Alessandra Bernardini 1 Apparecchiature radiologiche per analisi industriali e ricerca Le apparecchiature a raggi X utilizzate nell industria utilizzano
Il tema proposto può essere risolto seguendo due ipotesi:
 Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
Per la trattazione delle tecniche TDM, PM e Trasmissione dati si rimanda alle schede 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del libro Le Telecomunicazioni del Prof. F. Dell Aquila. Il tema proposto può essere
Codice Descrizione u.m. Prezzo %m.d'o.
 L.08 IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI L.08.10 CAVI L.08.10.10 Cavo per impianti TV L.08.10.10.a Coassiale 75 Ohm, bassa perdita m 0,99 47,29 L.08.10.10.b Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm² m 1,25 37,46 0,01 L.08.20
L.08 IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI L.08.10 CAVI L.08.10.10 Cavo per impianti TV L.08.10.10.a Coassiale 75 Ohm, bassa perdita m 0,99 47,29 L.08.10.10.b Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm² m 1,25 37,46 0,01 L.08.20
Manuale per la progettazione dei circuiti elettronici analogici di bassa frequenza
 Manuale per la progettazione dei circuiti elettronici analogici di bassa frequenza C. Del Turco 2007 Indice : Cap. 1 I componenti di base (12) 1.1 Quali sono i componenti di base (12) 1.2 I resistori (12)
Manuale per la progettazione dei circuiti elettronici analogici di bassa frequenza C. Del Turco 2007 Indice : Cap. 1 I componenti di base (12) 1.1 Quali sono i componenti di base (12) 1.2 I resistori (12)
S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it
 Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento 30-31 31 Ottobre 2004 S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it La radioastronomia
Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale Trento 30-31 31 Ottobre 2004 S. Montebugnoli Istituto di Radioastronomia (Bologna) Istituto Nazionale di Astrofisica http://www.ira.cnr.it La radioastronomia
Laboratorio di Fisica Moderna Cosmologia
 Laboratorio di Fisica Moderna Cosmologia Programma di oggi Da dove vengono le mappe di CMB Le mappe di CMB del satellite Planck Estrazione dello spettro di potenza Localizzazione del primo picco Misura
Laboratorio di Fisica Moderna Cosmologia Programma di oggi Da dove vengono le mappe di CMB Le mappe di CMB del satellite Planck Estrazione dello spettro di potenza Localizzazione del primo picco Misura
Corso di Strumentazione e Misure Elettroniche 18/07/03 Prova Scritta
 Corso di Strumentazione e Misure Elettroniche 18/07/03 Per una corretta elaborazione di un segnale, è necessario conoscerne lo spettro di frequenza, cioè almeno il modulo delle componenti sinusoidali in
Corso di Strumentazione e Misure Elettroniche 18/07/03 Per una corretta elaborazione di un segnale, è necessario conoscerne lo spettro di frequenza, cioè almeno il modulo delle componenti sinusoidali in
Comune di Costa Masnaga Provincia di Lecco
 RELAZIONE MISURAZIONI CAMPI PER IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE 2011 Comune di Costa Masnaga Provincia di Lecco Dicembre 2011 INDICE PREMESSA... 2 LE SORGENTI... 3 GLI OBIETTIVI... 4 QUADRO NORMATIVO...
RELAZIONE MISURAZIONI CAMPI PER IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE 2011 Comune di Costa Masnaga Provincia di Lecco Dicembre 2011 INDICE PREMESSA... 2 LE SORGENTI... 3 GLI OBIETTIVI... 4 QUADRO NORMATIVO...
 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 IT Manuale utente Sommario 1 Importante 4 Sicurezza 4 Riciclaggio 4 2 SDV6120 5 Panoramica 5 3 Guida introduttiva 6 Installazione
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 IT Manuale utente Sommario 1 Importante 4 Sicurezza 4 Riciclaggio 4 2 SDV6120 5 Panoramica 5 3 Guida introduttiva 6 Installazione
Antenna digitale HD da interno MODELLO: FMAHD1500
 1 Antenna digitale HD da interno MODELLO: FMAHD1500 Progettata per migliorare la ricezione dei segnali digitali HD Vi ringraziamo per aver acquistato questo modello di antenna da interno. Prima dell installazione
1 Antenna digitale HD da interno MODELLO: FMAHD1500 Progettata per migliorare la ricezione dei segnali digitali HD Vi ringraziamo per aver acquistato questo modello di antenna da interno. Prima dell installazione
I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di. elaborazione e gestione, hanno un profondo impatto su prodotti di larga
 CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
CAPITOLO 1 INTRODUZIONE AI SENSORI IN FIBRA OTTICA 1.1 La sensoristica 1.1.1. Generalità I sensori, in quanto interfaccia tra l ambiente esterno e i sistemi di elaborazione e gestione, hanno un profondo
D SISTEMI DI ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI
 Ingegneria dell Informazione Modulo SISTEMI ELETTRONICI D SISTEMI DI ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI 10-Jan-02-1 1 Obiettivi del gruppo di lezioni D Analisi Sistemistica di soluzioni analogiche/digitali»
Ingegneria dell Informazione Modulo SISTEMI ELETTRONICI D SISTEMI DI ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI 10-Jan-02-1 1 Obiettivi del gruppo di lezioni D Analisi Sistemistica di soluzioni analogiche/digitali»
LA NASCITA DELLA RADIOASTRONOMIA Una visione alternativa dell universo
 FRANCESCO TOFFOLI INDICE La nascita della radioastronomia... pag.3 Struttura di un radiotelescopio.. pag.5 Analisi schematica dei componenti di un radiotelescopio pag.5 Cosa si vede tramite un radiometro...
FRANCESCO TOFFOLI INDICE La nascita della radioastronomia... pag.3 Struttura di un radiotelescopio.. pag.5 Analisi schematica dei componenti di un radiotelescopio pag.5 Cosa si vede tramite un radiometro...
NHT-3D ANALIZZATORE PER SEGNALI COMPLESSI
 ANALIZZATORE PER SEGNALI COMPLESSI CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Misure selettive di induzione magnetica e di campo elettrico con qualsiasi fattore di forma. Banda passante o 0Hz - 400 KHz in modalità selettiva
ANALIZZATORE PER SEGNALI COMPLESSI CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Misure selettive di induzione magnetica e di campo elettrico con qualsiasi fattore di forma. Banda passante o 0Hz - 400 KHz in modalità selettiva
Digitale Terrestre non solo televisione parte 5
 Digitale Terrestre non solo televisione parte 5 Verifiche, Collaudo e Certificazione - Verifica strumentale dei parametri di qualità dei segnali distribuiti nell impianto tv, normative da rispettare e
Digitale Terrestre non solo televisione parte 5 Verifiche, Collaudo e Certificazione - Verifica strumentale dei parametri di qualità dei segnali distribuiti nell impianto tv, normative da rispettare e
Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. I suoni Rappresentazione digitale
 Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. Anno Accademico 2008/2009 Docente: ing. Salvatore
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Elaborazione di Immagini e Suoni / Riconoscimento e Visioni Artificiali 12 c.f.u. Anno Accademico 2008/2009 Docente: ing. Salvatore
Tutor: Stefania Canella Stagisti: Luca Scomparin, Elia Guerra, Marco Ferla, Elena Zanella
 Tutor: Stefania Canella Stagisti: Luca Scomparin, Elia Guerra, Marco Ferla, Elena Zanella Introduzione ai Sistemi Operativi Open Source Il codice sorgente è pubblico Permette a programmatori indipendenti
Tutor: Stefania Canella Stagisti: Luca Scomparin, Elia Guerra, Marco Ferla, Elena Zanella Introduzione ai Sistemi Operativi Open Source Il codice sorgente è pubblico Permette a programmatori indipendenti
Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore
 Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore Cos'è la propagazione Nell'accezione classica radioamatoriale per "propagazione" si intende ogni fenomeno che estende la comunicazione
Propagazione nelle bande radio adibite al servizio di satellite d'amatore Cos'è la propagazione Nell'accezione classica radioamatoriale per "propagazione" si intende ogni fenomeno che estende la comunicazione
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
elettromagnetiche: il contributo delle analisi scientifiche Alessandro Vaccari Ricercatore REET FBK Center for Materials and Microsystems
 Corpo umano ed emissioni elettromagnetiche: il contributo delle analisi scientifiche Alessandro Vaccari Ricercatore REET FBK Center for Materials and Microsystems Basse frequenze pochi Hz 100 khz Alte
Corpo umano ed emissioni elettromagnetiche: il contributo delle analisi scientifiche Alessandro Vaccari Ricercatore REET FBK Center for Materials and Microsystems Basse frequenze pochi Hz 100 khz Alte
MEZZI DI RTASMISSIONE 1 DOPPINO TELEFONICO 2 CAVO COASSIALE 1 MULTI 2 MONO 1 ONDE RADIO 2 MICROONDE 3 INFRAROSSI 4 LASER
 1 ELETTRICI 2 OTTICI 3 WIRELESS MEZZI DI RTASMISSIONE 1 DOPPINO TELEFONICO 2 CAVO COASSIALE 1 MULTI 2 MONO 1 ONDE RADIO 2 MICROONDE 3 INFRAROSSI 4 LASER MODALI ELETTRICI PARAMETRI 1 IMPEDENZA 2 VELOCITA'
1 ELETTRICI 2 OTTICI 3 WIRELESS MEZZI DI RTASMISSIONE 1 DOPPINO TELEFONICO 2 CAVO COASSIALE 1 MULTI 2 MONO 1 ONDE RADIO 2 MICROONDE 3 INFRAROSSI 4 LASER MODALI ELETTRICI PARAMETRI 1 IMPEDENZA 2 VELOCITA'
Acquisizione e rappresentazione di immagini
 Acquisizione e rappresentazione di immagini Stefano Ferrari Università degli Studi di Milano stefano.ferrari@unimi.it Elaborazione delle immagini anno accademico 2009 2010 Radiazione elettromagnetica λ
Acquisizione e rappresentazione di immagini Stefano Ferrari Università degli Studi di Milano stefano.ferrari@unimi.it Elaborazione delle immagini anno accademico 2009 2010 Radiazione elettromagnetica λ
Capitolo 1. Sistemi a microonde
 Capitolo 1 Sistemi a microonde 1.1 Introduzione Il termine microonde è comunemente utilizzato per indicare il campo di frequenze compreso tra 1 e 300 GHz. Come mostrato nella Tab. 1.1, introdotta dall'istituto
Capitolo 1 Sistemi a microonde 1.1 Introduzione Il termine microonde è comunemente utilizzato per indicare il campo di frequenze compreso tra 1 e 300 GHz. Come mostrato nella Tab. 1.1, introdotta dall'istituto
Il punto di partenza della radioastronomia amatoriale: un radiotelescopio a potenza totale nella banda GHz.
 Il punto di partenza della radioastronomia amatoriale: un radiotelescopio a potenza totale nella banda 10-12 GHz. Esperienze di radioastronomia amatoriale per tutti utilizzando moduli e componenti commerciali
Il punto di partenza della radioastronomia amatoriale: un radiotelescopio a potenza totale nella banda 10-12 GHz. Esperienze di radioastronomia amatoriale per tutti utilizzando moduli e componenti commerciali
Esempio di antenna a telaio, con spire rettangolari e circolari.
 ANTENNE A TELAIO LA QUAD di Giovanni G. Turco, ik0ziz Questo tipo di antenna fu realizzata da Clarence J. Moore, ingegnere, ed adottata per la prima volta a Quito, in Equator, oltre sessant anni fa, quando
ANTENNE A TELAIO LA QUAD di Giovanni G. Turco, ik0ziz Questo tipo di antenna fu realizzata da Clarence J. Moore, ingegnere, ed adottata per la prima volta a Quito, in Equator, oltre sessant anni fa, quando
Acquisizione ed elaborazione di segnali
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea in Scienze Motorie Tecnologie e strumentazione biomedica Elaborazione di segnali Alberto Macerata Dipartimento di Ingegneria dell Informazione Acquisizione ed elaborazione
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea in Scienze Motorie Tecnologie e strumentazione biomedica Elaborazione di segnali Alberto Macerata Dipartimento di Ingegneria dell Informazione Acquisizione ed elaborazione
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2. Laboratorio per l Osservazione e l Analisi della Terra e del Clima, ENEA 4
 H 2 O e processi radiative nell Artico: presentazione dei risultati preliminari dello spettrometro VESPA-22 ottenuti durante la campagna di misura SVAAP a Thule, Groenlandia G. Mevi 1,2, G. Muscari 1,
H 2 O e processi radiative nell Artico: presentazione dei risultati preliminari dello spettrometro VESPA-22 ottenuti durante la campagna di misura SVAAP a Thule, Groenlandia G. Mevi 1,2, G. Muscari 1,
QUANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA. 1 Fondamenti Segnali e Trasmissione
 UANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA Fondamenti Segnali e Trasmissione Campionamento e quantizzazione di un segnale analogico Si consideri il segnale x(t) campionato con passo T c. Campioni del
UANTIZZAZIONE E CONVERSIONE IN FORMA NUMERICA Fondamenti Segnali e Trasmissione Campionamento e quantizzazione di un segnale analogico Si consideri il segnale x(t) campionato con passo T c. Campioni del
DWT-B01. Trasmettitore da cintura per microfono wireless digitale. Presentazione
 DWT-B01 Trasmettitore da cintura per microfono wireless digitale Presentazione Sony presenta il nuovo sistema radiomicrofonico completamente digitale per prestazioni audio avanzate: la combinazione perfetta
DWT-B01 Trasmettitore da cintura per microfono wireless digitale Presentazione Sony presenta il nuovo sistema radiomicrofonico completamente digitale per prestazioni audio avanzate: la combinazione perfetta
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
La soluzione innovativa CONSUMI IN TEMPO REALE SU CLOUD SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE PER TUTTI I TIPI DI CONTATORE BASSO COSTO
 NEW Gestione illuminazione pubblica da remoto e La soluzione innovativa CONSUMI IN TEMPO REALE SU CLOUD SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE PER TUTTI I TIPI DI CONTATORE BASSO COSTO per controllare i consumi
NEW Gestione illuminazione pubblica da remoto e La soluzione innovativa CONSUMI IN TEMPO REALE SU CLOUD SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE PER TUTTI I TIPI DI CONTATORE BASSO COSTO per controllare i consumi
La modulazione numerica
 La modulazione numerica Mauro Giaconi 26/05/2009 trasmissione numerica 1 Principi di modulazione numerica 26/05/2009 trasmissione numerica 2 Modulazione numerica La modulazione trasla l informazione di
La modulazione numerica Mauro Giaconi 26/05/2009 trasmissione numerica 1 Principi di modulazione numerica 26/05/2009 trasmissione numerica 2 Modulazione numerica La modulazione trasla l informazione di
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
Sezione A - Ramo "Elettronica" Prova del 23 Novembre 2004
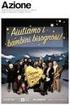 Politecnico di Torino Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere Sezione A - Ramo "Elettronica" Prova del 23 Novembre 2004 Si consideri un sistema di tramissione da
Politecnico di Torino Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere Sezione A - Ramo "Elettronica" Prova del 23 Novembre 2004 Si consideri un sistema di tramissione da
Andrea Dell Immagine IW5BHY - XXV convegno ARI EME Marina di Pietrasanta- 22/23 Aprile 2017
 Caratteristiche principali delle Pulsar Una stella Pulsar è caratterizzata da una emissione direzionale a larga banda In rapida rotazione, produce impulsi regolari con un meccanismo simile ad un «faro»
Caratteristiche principali delle Pulsar Una stella Pulsar è caratterizzata da una emissione direzionale a larga banda In rapida rotazione, produce impulsi regolari con un meccanismo simile ad un «faro»
Utilizziamo RAL10KIT e RAL10AP per costruire un radiotelescopio a microonde
 STRUMENTI PER RADIOASTRONOMIA AMATORIALE Utilizziamo RAL10KIT e RAL10AP per costruire un radiotelescopio a microonde FLAVIO FALCINELLI Vers. 1.0 del 7 ottobre 2016 RadioAstroLab s.r.l. Strada della Marina,
STRUMENTI PER RADIOASTRONOMIA AMATORIALE Utilizziamo RAL10KIT e RAL10AP per costruire un radiotelescopio a microonde FLAVIO FALCINELLI Vers. 1.0 del 7 ottobre 2016 RadioAstroLab s.r.l. Strada della Marina,
Correzione radiometrica
 Correzione radiometrica Correzione delle immagini I dati raccolti dai sensori per telerilevamento necessitano, prima dell utilizzo nelle applicazioni, di una serie di correzioni per eliminare o limitare
Correzione radiometrica Correzione delle immagini I dati raccolti dai sensori per telerilevamento necessitano, prima dell utilizzo nelle applicazioni, di una serie di correzioni per eliminare o limitare
Ricevitore AC-RX2/CS. AC-RX2/CS Manuale d istruzioni. Pin-out. Connessioni. Caratteristiche tecniche. Component Side
 Ricevitore AC-RX2/CS AC-RX2/CS Ricevitore RF dati superreattivo in ASK, economico a basso assorbimento ed elevata sensibilità. Caratteristiche generali ottimizzate per l uso con i decoder/encoder della
Ricevitore AC-RX2/CS AC-RX2/CS Ricevitore RF dati superreattivo in ASK, economico a basso assorbimento ed elevata sensibilità. Caratteristiche generali ottimizzate per l uso con i decoder/encoder della
Processi radiativi. Assorbimento Emissione spontanea Emissione stimolata. Gli stati eccitati sono instabili (il sistema non è in equilibrio)
 Processi radiativi conservazion e dell energia transizioni I I Assorbimento Emissione spontanea Emissione stimolata Lo stato ad energia più bassa è detto fondamentale, gli altri sono detti stati eccitati
Processi radiativi conservazion e dell energia transizioni I I Assorbimento Emissione spontanea Emissione stimolata Lo stato ad energia più bassa è detto fondamentale, gli altri sono detti stati eccitati
MISURATORE DI CAMPO PER TV ANALOGICO E DIGITALE MC-577
 MISURATORE DI CAMPO PER TV ANALOGICO E DIGITALE MC-577 1. GENERALE 1.1 Descrizione L'MC-577 è uno strumento di misura estremamente compatto e leggero, che offre agli installatori tutte le funzioni base
MISURATORE DI CAMPO PER TV ANALOGICO E DIGITALE MC-577 1. GENERALE 1.1 Descrizione L'MC-577 è uno strumento di misura estremamente compatto e leggero, che offre agli installatori tutte le funzioni base
Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino
 Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino Andrea Canesi (1), Daniele Grosso (2) 1. Ministero della Pubblica Istruzione Liceo Classico e Linguistico C. Colombo, Genova 2. Università di
Esperienze di spettrofotometria per la scuola, con arduino Andrea Canesi (1), Daniele Grosso (2) 1. Ministero della Pubblica Istruzione Liceo Classico e Linguistico C. Colombo, Genova 2. Università di
NVIS. By Norm Fusaro, W3IZ Traduzione e adattamento: Fabio Bonucci, IK0IXI KF1B 11/25/2010 1
 NVIS NearVerticalIncidentSkywave By Norm Fusaro, W3IZ Traduzione e adattamento: Fabio Bonucci, IK0IXI KF1B 11/25/2010 1 Introduzione Cos è l NVIS? Quali sono i vantaggi della NVIS? 11/25/2010 2 Cos è la
NVIS NearVerticalIncidentSkywave By Norm Fusaro, W3IZ Traduzione e adattamento: Fabio Bonucci, IK0IXI KF1B 11/25/2010 1 Introduzione Cos è l NVIS? Quali sono i vantaggi della NVIS? 11/25/2010 2 Cos è la
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote
 Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
La candela. La storia della realizzazione della candela
 La candela La storia della realizzazione della candela 1860 La prima realizzazione di riferimento per la misura delle luce utilizza delle candele ricavate dal grasso di balena (spermaceti). 1898 Il passo
La candela La storia della realizzazione della candela 1860 La prima realizzazione di riferimento per la misura delle luce utilizza delle candele ricavate dal grasso di balena (spermaceti). 1898 Il passo
Total-Power Microwave Radiometer RAL10 Ricevitore radiometrico 11.2 GHz per osservazioni radioastronomiche didattiche.
 Total-Power Microwave Radiometer RAL10 Ricevitore radiometrico 11.2 GHz per osservazioni radioastronomiche didattiche. MANUALE OPERATIVO Doc. Vers. 1.0 del 15.03.2013 @ 2013 RadioAstroLab RadioAstroLab
Total-Power Microwave Radiometer RAL10 Ricevitore radiometrico 11.2 GHz per osservazioni radioastronomiche didattiche. MANUALE OPERATIVO Doc. Vers. 1.0 del 15.03.2013 @ 2013 RadioAstroLab RadioAstroLab
Teoria dei Segnali Un esempio di processo stocastico: il rumore termico
 Teoria dei Segnali Un esempio di processo stocastico: il rumore termico Valentino Liberali Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano valentino.liberali@unimi.it Teoria dei Segnali Il rumore
Teoria dei Segnali Un esempio di processo stocastico: il rumore termico Valentino Liberali Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano valentino.liberali@unimi.it Teoria dei Segnali Il rumore
Ultrasonic Level Meter USM-02. (Estratto dal manuale operatore)
 Ultrasonic Level Meter USM-02 (Estratto dal manuale operatore) Ultrasonic Level Meter USM-02 Estratto dal manuale operatore Pag. 2 Introduzione La misura del livello gioca un ruolo fondamentale in molte
Ultrasonic Level Meter USM-02 (Estratto dal manuale operatore) Ultrasonic Level Meter USM-02 Estratto dal manuale operatore Pag. 2 Introduzione La misura del livello gioca un ruolo fondamentale in molte
26/08/2010. Segnale analogico. Convertitore AD. Segnale digitale. Sensore. Computer
 CAP 6: ACQUISIZIONE ED ANALISI DIGITALE DEI SEGNALI Che tutte le operazioni di analisi del segnale descritte nei precedenti capitoli si effettuano, quasi sempre, impiegando sistemi digitali di elaborazione
CAP 6: ACQUISIZIONE ED ANALISI DIGITALE DEI SEGNALI Che tutte le operazioni di analisi del segnale descritte nei precedenti capitoli si effettuano, quasi sempre, impiegando sistemi digitali di elaborazione
Radioastronomia Amatoriale: utilizziamo il kit microral10+ral126 per costruire un radiotelescopio a 11.2 GHz
 Radioastronomia Amatoriale: utilizziamo il kit microral10+ral126 per costruire un radiotelescopio a 11.2 GHz Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39
Radioastronomia Amatoriale: utilizziamo il kit microral10+ral126 per costruire un radiotelescopio a 11.2 GHz Flavio Falcinelli RadioAstroLab s.r.l. 60019 Senigallia (AN) - Italy - Via Corvi, 96 Tel: +39
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto Roberto Barbiero
 Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI
 Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI Attività 1 Sistemi portatili per misure rapide e non distruttive di parametri ottici di mirtillo, uva e mela
Valorizzazione delle produzioni vitifrutticole valtellinesi mediante metodi innovativi INNOVI Attività 1 Sistemi portatili per misure rapide e non distruttive di parametri ottici di mirtillo, uva e mela
Che cosa è la luce? 1
 Che cosa è la luce? 1 CAMPO ELETTROMAGNETICO 2 Onde Che cosa è un onda? Un onda è una perturbazione di un mezzo, dove il mezzo può essere un campo (es: il campo gravitazionale) o di una sostanza materiale
Che cosa è la luce? 1 CAMPO ELETTROMAGNETICO 2 Onde Che cosa è un onda? Un onda è una perturbazione di un mezzo, dove il mezzo può essere un campo (es: il campo gravitazionale) o di una sostanza materiale
UDA Competenze Abilità Conoscenze (Contenuti) UDA Competenze Abilità Conoscenze (Contenuti)
 UDA 1 VISUALIZZAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI RILEVATI DA MISURAZIONI Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l ausilio di rappresentazioni grafiche,
UDA 1 VISUALIZZAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI RILEVATI DA MISURAZIONI Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l ausilio di rappresentazioni grafiche,
Power meter Misure di potenza assoluta Misure di potenza relativa. Misure di potenza. F. Poli. 10 aprile F. Poli Misure di potenza
 Misure di potenza F. Poli 10 aprile 2008 Outline Power meter 1 Power meter 2 3 Misure di potenza Misure di potenza = base della metrologia in fibra ottica. Misure di potenza 1 assoluta: necessarie in relazione
Misure di potenza F. Poli 10 aprile 2008 Outline Power meter 1 Power meter 2 3 Misure di potenza Misure di potenza = base della metrologia in fibra ottica. Misure di potenza 1 assoluta: necessarie in relazione
