ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2004 A T T I
|
|
|
- Gianpaolo Parodi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 25 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo dicembre 2004 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2005 Stampa: Centro Grafi co S.r.l. - Tel cofoggia.it
2 PAOLO BOSCATO * ARTURO PALMA DI CESNOLA * L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) * Università di Siena, Dipartimento di Scienze Ambientali G. Sarfatti, Sezione di Ecologia Preistorica Come già è stato detto in un precedente convegno di San Severo (PALMA DI CESNOLA 2001 b), nel corso delle campagne del Settembre-Ottobre 1999 e dell Aprile-Maggio 2000 l Università di Siena concentrò le sue ricerche nell area esterna di Paglicci. Ciò fu possibile grazie ad un cospicuo contributo ministeriale, che permise l ausilio - imprescindibile, data la natura del deposito (strato 1 della sequenza stratigrafica stabilita negli anni 70) cementato e ricco di massi di dimensioni talvolta assai grandi- di una ditta specializzata, con operai e mezzi meccanici idonei. Già in precedenza, P. BOSCATO (2001) ed io (2001 b) abbiamo parlato, sebbene in forma preliminare, delle industrie e della faune contenute nei livelli 1B-1E. Al di sopra di questo grosso complesso stratigrafico (dello spessore di alcuni metri), attribuibile, come abbiamo visto, ad epoca pre-würmiana, era presente, nell area meridionale, una breccia non osservata prima, in quanto coperta da detriti a pietrisco di media grandezza, a spigoli vivi, ed a matrice sabbio-limosa color giallastro chiaro, quasi biancastro, discretamente cementata. Essa fu da noi denominata 1A. Il suo spessore risultava assai variabile, da poche decine di centimetri fino ad un massimo di alcuni metri. Tale breccia, che si addossava verso Nord ad un enorme masso di crollo, doveva originariamente terminare contro la parete rocciosa immediatamente adiacente all ingresso della grotta, costituendo la base di un cumulo di deposito, che oggi è sormontato da un olivo. Purtroppo, sistematici lavori di sbancamento
3 4 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola condotti in passato lungo la suddetta parete rocciosa (e dovuti senza dubbio al cercatore di tesori Leonardo Esposito) ne hanno asportato la massima parte. Ne rimangono ancora piccoli lembi, fortemente concrezionati, rimasti aderenti alla parete rocciosa o penetranti in talune sue irregolarità e fessure. In essi sono presenti alcune (poche) selci, accompagnate da resti faunistici (specialmente denti di Equidi). Lo scavo della breccia 1 A, operato nel 1999 e nel 2000, fruttò, oltre ad alcuni nuclei ed a schegge di lavorazione, relativamente poco abbondanti, un buon numero di strumenti litici. Malgrado la quadrettatura dell area esterna, realizzata all inizio della campagna del 1999, per motivi tecnici facilmente intuibili (e comunque in mia forzata assenza dal cantiere) i reperti risultarono distribuiti spazialmente in maniera alquanto disorganica. Per alcuni sono indicati i Quadrati 2 e 12, per altri la prossimità ad un grosso masso (recante in planimetria il numero 114), per altri ancora, senza ulteriore precisazione, i Quadrati 11,12, 20, 21 e 22 nel loro insieme. Vi sono poi materiali del tutto privi d indicazione di quadrato, ed inoltre un piccolo lotto proveniente dallo scavo effettuato per aprire un nuovo passaggio verso l imboccatura delle grotta. Un paio di strumenti furono cavati dal deposito placcato contro la parete rocciosa, cui sopra si è accennato. Per quanto riguarda la posizione stratigrafica dei reperti all interno della breccia, possediamo pochi ragguagli: 1 A base (relativamente al Quadrato 12), 1 A base (senza indicazione di quadrato), 1 A complessivo (del Quadrato 2), 1 A superiore (relativamente ai Quadrati 11,12, 20, 21 e 22), a terreno più bruno. A parte queste insufficienti indicazioni stratigrafiche, il numero dei manufatti raccolti nei singoli livelli è troppo scarso per poter documentare una eventuale evoluzione tipologica e tipometrica dell industria attraverso la spessore della breccia 1 A. Per cui ci è parso opportuno considerare l industria di 1 A nel suo insieme. Del resto, il deposito costituente la breccia 1 A non mostrava una regolare stratificazione, ma risultava piuttosto caotico. Il suo aspetto sembrava piuttosto quello di un conoide, cioè di una sorta di ammasso di terreno e di pietrami, che dalla parete rocciosa di Sud-Est scendeva verso Nord fino a coprire i blocchi della parte meridionale dell area. La correlazione tra detta breccia esterna e la stratigrafia dell interno della grotta resta alquanto problematica. La breccia 1 A, presso l attuale ingresso della grotta, appare comunque tagliata ab antiquo dall erosione: i livelli dell Epigravettiano più avanzato si appoggiano chiaramente sui testimoni concrezionati di essa, aderenti alla parete di destra.. Lo strumentario litico, frutto delle campagne di scavo , assomma a circa 140 pezzi. Esso comprende (secondo il sistema Laplace del 1964): Bulini, Grattatoi, Troncature, Becchi, Punte a dorso, Lame a dorso, frammenti indistinti di dorsi, Dorsi troncati, Punte, Raschiatoi lunghi, Raschiatoi corti, frammenti indistinti di Raschiatoi lunghi e corti, Denticolati, Pezzi scagliati. Vi si aggiungono una ventina di elementi a ritocco inframarginale, 8 nuclei, 90 tra schegge, lame semplici e frammenti, residuo di lavorazione.
4 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) 5 Non pochi pezzi presentano una leggera patina biancastra, diffusa o a chiazze, che documenta una, non prolungata, esposizione al sole. Privi di patina i pezzi provenienti dal passaggio nuovo verso l imboccatura della grotta 1. Frequenti le incrostazioni. I Bulini ammonterebbero a 18 Tipi primari (3 tuttavia sono assai dubbi ed uno è un frammento non assegnabile ad un preciso tipo primario). Si hanno 7 bulini semplici (2B1, 2B2, 2B3 ed 1 B4); 10 su ritocco (4 B6, 5 B7 ed 1 B8). Stando a questi dati, si avrebbe una leggera prevalenza di bulini su ritocco rispetto ai semplici (Br/Bs: 1,40). Risulterebbero assenti i bulini su frattura. Esistono le seguenti associazioni fra bulini: 1B3.B8, 1B6.B7-B1. Il bulino fratturato è opposto a B7. Le dimensioni dei pezzi singoli interi e dei multipli vanno da un minimo di 28,5 ad un massimo di 67,5. Sono ricavati ora da schegge larghe, ora da schegge o schegge laminari, ora da lame. La qualità è in genere buona. I Grattatoi, in numero di 16 Tipi primari, sono in prevalenza frontali piatti (e in particolare frontali lunghi): 4 G1, 3 G2, 1 G4, 1 frammento di G1-3, 2 frammenti di G2-4: contro 5 grattatoi a muso e carenati (2 G6, 1 G7, 1 G8 ed 1 G9). Si ha una sola associazione fra grattatoi (1 G2.G2). È poi presente un G1.T3. Le dimensioni dei grattatoi interi, singoli e multipli, vanno da 31,0 a 56,5 mm di lunghezza; i frammenti da >18,5 a >70,5. I supporti sono in forma di schegge, lame (prevalentemente) e lame strette. La Famiglia dei RAD è quantitativamente poco rappresentata. Essa accoglie: 6 Troncature; (3 T2 e 3 T3); 3 Becchi, del tipo BC1; 5 Punte a dorso, del tipo PD4; 3 Lame a dorso (1LD1 e 2 LD2); 2 Dorsi troncati, del tipo DT1; 10 frammenti indistinti di dorsi. Delle 2 Troncature intere (singole) una è su lama di 52 mm ed una su grande lama di 118 mm. Gli elemento frammentari misurano fra >36,5 e >33 mm. I 2 Becchi integri hanno come supporti lame, rispettivamente, di 46 e di 60,5 mm. Un elemento frammentario è di >23,5 mm. Le dimensioni dei pochi pezzi a dorso interi vanno da 19,5 a 51 mm di lunghezza; i frammenti sono compresi fra un minimo di >10 ed un massimo di >53 mm. Il maggior formato si osserva tra le PD4. I dorsi hanno profilo rettilineo. Presente spesso il ritocco complementare. Fra gli elementi non integri, si ha un pezzo a cran prossimale sinistro, con ritocco erto marginale discontinuo sullo steso lato: si tratta evidentemente di una PD5 o di una LD3. Il Substrato, per contro assai ricco (73 elementi), comprende: 3 Punte (1 P1 e 2 P2, uno dei G6 è poi al limite con P2); 12 Raschiatoi lunghi (8 L1 e 4 L2), 15 Raschiatoi corti (4 R1, 8 R2, 2 R3 ed 1 R4); 16 elementi frammentari indistinti fra L ed R; 27 Denticolati (8 D1, 17 D2, 1 D3 ed 1 D5). Alcuni elementi del Substrato (Punte, Raschiatoi lunghi, Denticolati), come abbiamo già visto riguardo a qualche grattatolo e a qualche troncatura, hanno dimensioni ragguardevoli, fino ad un massimo di 117 mm, nei pezzi interi, e di >120 mm, nei pezzi frammentari. Bisogna poi tener 1 Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che questo settore dell area esterna è aderente alla parete rocciosa, che anticamente doveva costituire un riparo.
5 6 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola conto di alcuni altri elementi frammentari aventi misure di poco inferiori a quelle delle grandi lame. Rari i Pezzi scagliati (9), dei quali 6, integri, misurano tra 30,5 e 49 mm di lunghezza Gli Inframarginali comprendono 1 To, 9 Lo, 1 Ro e 9 Do. Nei pezzi integri, i supporti vanno da 27,5 a 95,5 mm di lunghezza. Tra i residui di lavorazione si hanno: 10 lame e lamelle, 18 schegge, 4 tra lame a cresta e recoupes di bulino, 58 frammenti. Le dimensioni sono per lo più modeste, da meno di 10 ad un massimo di 57mm. I nuclei, quasi tutti da lame e lamelle, hanno dimensioni variabili da 42,5 a 73,5 mm. Hanno forma subpiramidale o subprismatica. Gli stacchi appaiono sia unipolari, sia (più frequentemente) bipolari. Da notare un esemplare usato, successivamente, come percussore. Avangrotta Str. 18A B G T BC PD LD DT D fr F P L R L-R n.c A D E n.c Infram. n.c B G RAD F SUB E n.c B/G Tab. 1 Struttura tipologica dell industria litica Cunicolo Str. 1 Esterno liv. 1A
6 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) 7 Per la sua struttura tipologica ed il suo grande formato, l industria del livello 1 A dell area esterna ci riporta agli insiemi dell avangrotta strato 18 A (18 della sequenza dello Zorzi) (MEZZENA, PALMA DI CESNOLA 1967), del cunicolo di accesso alla saletta delle pitture strato 1 e del fondo della sala 1 strato B, già attribuiti all Epigravettiano antico iniziale (PALMA DI CESNOLA 1979, 1982; BOSCATO, PALMA DI CESNOLA 2000). Ricordiamo che nell avangrotta lo strato 18 A si trovava fra il Gravettiano finale del sottostante strato 18B, datato al tetto a ca. da oggi ed il soprastante Epigravettiano antico a Foliati dello strato17, datato alla base a ca. da oggi. Esso dunque dovrebbe risalire al ca. da oggi. Caratteri generali di questo orizzonte iniziale dell Epigravettiano antico sono: il tenore piuttosto elevato dei Bulini e dei Grattaoi, quantitativamente in equilibrio tra loro, lo scarso sviluppo della Famiglia dei RAD e l invadenza del Substrato. Riferendoci alla Tabella qui sopra riportata, notiamo la presenza nell avangrotta di Foliati, i quali invece risulterebbero assenti negli altri due contesti (a parte in entrambi alcuni pezzi tendenti a foliato). In secondo luogo vediamo che da sinistra a destra (nell ordine che abbiamo dato ai tre insiemi) si avrebbe un certo aumento dei RAD (in particolare degli elementi a dorso). Va tenuto tuttavia conto del fatto che il valore dei RAD nel 18 A (particolarmente basso) è da considerare certamente in difetto, data la sommaria tecnica di setacciatura e di scelta adottata negli anni Di conseguenza le percentuali degli altri gruppi tipologici ne vengono un po esaltati. A ciò si aggiunga che i Pezzi Scagliati non figurano nel suddetto strrato 18 A, in quanto non considerati a quell epoca come strumenti. Nell ambito del Substrato, che tocca il suo massimo nell 1 A dell area esterna, osserviamo un aumento, da sinistra a destra, dei Denticolati.. In quanto poi al valore elevato, nell avangrotta, dei Raschiatoi lunghi, va detto che essi comprendono anche i frammenti (negli anni 60 non veniva infatti contemplato a parte, come attualmente, il gruppo dei frammenti indistinti di L-R). Se sommiamo L+R del 18 A e ne confrontiamo il totale con quello degli L+R+L-R dell 1 A, i valori risultano pressoché eguali. Meno concordanti quelli del cunicolo-sala 1, che però si basano su un numero più esiguo di pezzi. L aumento dei RAD potrebbe ben raccordarsi con l Epigravettiano antico del soprastante strato 17, che ne è assai più ricco. L incremento dei Denticolati potrebbe poi documentare un processo che si verifica spesso verso la fine di un ciclo o di una fase culturale. Non concorda invece con la direzione evolutiva ora supposta l assenza (se non è casuale), nel cunicolo e all esterno, dei Foliati, che costituiscono nel 17 2 In questo caso non si tratta di una ipotesi. La perdita di non pochi elementi di piccole dimensioni (e in particolare di frammenti di dorsi) negli scavi degli anni 60 è stata regolarmente provata dal confronto con i risultati degli scavi più recenti negli stessi strati attraversati dai vecchi scavi.
7 8 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola l aspetto più caratteristico. D altra parte, capovolgendo la direzione evolutiva prima suggerita, i dati non appaiono meno improbabili. Non è dunque accertabile, nei tre contesti, una sequenza di momenti cronologicamente distinti. Dobbiamo accontentarci di esserci per così dire imbattuti a Paglicci in un terzo insieme di questo Epigravettiano iniziale. I tre punti nei quali sono stati rinvenuti gli insiemi qui messi a confronto sono assai distanti fra loro: il primo è all esterno, il secondo nell avangrotta, il terzo al fondo della cavità. Non è da escludere quindi che le differenze (per altro non troppo rilevanti) ora osservate nei tre insiemi stessi possano derivare da attività umane un po diverse. In numerose altre occasioni (BARTOLOMEI, BROGLIO, PALMA DI CESNOLA 1979, BOSCATO, PALMA DI CESNOLA 2000; GALIBERTI, PALMA DI CESNOLA 1980; PALMA DI CESNOLA 1982, 2001a) abbiamo sottolineato l importanza dell Epigravettiano antico iniziale di Paglicci per cui non ci dilungheremo qui su questo argomento. Ci basti ricordare che esso costituisce una vera e propria frattura tipologica, strutturale e tipometrica (e quindi culturale) rispetto al Gravettiano finale locale, ed è dunque da considerarsi come un evento trasgressivo, che si contrappone nettamente alla tradizione gravettiana ed è alla base di un filone (l Epigravettiano), che a Paglicci presenta una stupefacente continuità con una durata di quasi anni. L origine di questo primo Epigravettiano - secondo una ipotesi da tempo da me avanzata, e che forse potrà a qualcuno apparire come un po azzardata, va ricercata nell area alto e medio-tirrenica, dalla quale si sarebbe poi diffusa nel tempo in tutta la Penisola. A. P. di C. I resti ossei Il campione di resti ossei animali esaminato, proveniente dallo strato 1a della serie esterna ha restituito 144 reperti determinati a livello specifico. L insieme è costituito essenzialmente da resti di ungulati accompagnati da due soli reperti di volpe: un metacarpo e un metatarso. Questa associazione faunistica si discosta nettamente da quella rinvenuta negli orizzonti inferiori 1b, 1c, 1d, 1e della stessa serie esterna, attribuiti all ultimo interglaciale o ad una fase interstadiale del penultimo glaciale (BOSCATO 2001). In questi orizzonti più antichi sono molto numerosi i resti di lagomorfi e di carnivori e l associazione ad ungulati è caratterizzata dalla presenza di Rinoceronte e dall abbondanza di Daino, specie dominante in 1c, 1d e 1e. L insieme faunistico dello strato 1a contiene i caratteri tipici delle associazioni legate a fasi aride interstadiali a freddo moderato rinvenute nella serie interna della grotta. L ungulato più abbondante risulta essere il Cavallo, con 63 reperti (44.4%), seguito dallo Stambecco (26.8%), dall Uro (18.3%) e, con frequenze molto inferiori, da Camoscio, Cervo, Cinghiale e Idruntino (tab. 2).
8 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) 9 Tab. 2 Numero dei reperti determinati dello strato 1 a (Paglicci esterno). Le tre specie più numerose sono legate ad ambienti aperti di prateria, nel caso del Cavallo, di aree rilevate prive di forestazione (Stambecco), e di praterie arborate (Uro) (HEPTNER et alii 1989). Nell insieme, queste tre specie raggiungono quasi il 90% degli ungulati rinvenuti. La pianura, che si estendeva ai piedi della grotta, ed i primi rilievi del Gargano, territori frequentati dai cacciatori paleolitici durante il periodo di formazione dello strato 1a, dovevano quindi essere quasi totalmente privi di forestazione. Aree marginali di bosco, in grado di ospitare il Cervo e il Cinghiale, erano probabilmente situate all interno delle vicine incisioni vallive. Nell articolata sequenza stratigrafica dell interno grotta, l insieme di strati 20b _. 18 dell Epigravettiano antico, attribuiti all interstadio di Laugerie (SALA 1983), contiene associazioni faunistiche con valori di frequenza parzialmente confrontabili con lo strato in oggetto. La stessa successione delle tre specie più abbondanti (Cavallo, Stambecco e Uro), pur con valori percentuali diversi, è infatti riscontrata in 20a, 19b, 18b2 e 18a. Tale successione non è invece rilevabile nell interstadio più recente (Lascaux) (strati 14 _. 12/13) (SALA 1983) in cui queste tre specie, sempre dominanti, vedono una prevalenza dello Stambecco nello strato 14 e dell Uro sullo Stambecco negli strati 12 e 12/13. Recenti ritrovamenti di Epigravettiano antico nel cunicolo di accesso alla sala delle pitture di grotta Paglicci (BOSCATO, PALMA DI CESNOLA 2000) hanno fornito un associazione faunistica sempre caratterizzata dall alta frequenza delle tre specie sopra citate, con Cavallo dominante (33.1%), seguito da Uro (24.7%) e da Stambecco (18.3%). Anche in questa associazione le rimanenti specie di ungulati sono state rinvenute con valori percentuali nettamente inferiori. Fa eccezione l Idruntino con un 9.8%. Questi tre ritrovamenti di Epigravettiano antico a Grotta Paglicci dunque, sono accompagnati da associazioni faunistiche non identiche ma caratterizzate dalla netta dominanza di specie di ambienti aperti. Cavallo, Stambecco e Uro sono prevalenti in modo costante, con lo Stambecco sempre subordinato al Cavallo. La diversa dislocazione di questi rinvenimenti può essere una delle ragioni delle differenze
9 10 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola riscontrate nelle presenze dei vari taxa. Le tre aree corrispondono ad altrettanti ambienti del tutto diversi della grotta: l area esterna, oggetto di questa nota, l area interna, fortemente antropizzata, e il cunicolo di accesso alla sala pitture con resti di caccia dell uomo e tracce di frequentazione di carnivori. Un diverso utilizzo di questi ambienti può avere determinato varie modalità di abbandono del materiale osseo con ripercussioni sulla composizione dei campioni. Nel caso del cunicolo, è probabile che la frequentazione, in periodi di abbandono antropico, di carnivori come la iena macchiata, nella cui dieta le ossa hanno un ruolo non marginale, abbia modificato l insieme osseo derivato dalla caccia dell uomo, sia attraverso l apporto di nuovi elementi, sia con la distruzione di parte del materiale. Un altra ragione delle differenze faunistiche riscontrate nelle tre aree può essere legata alla non contemporaneità dei tre depositi, collocabili all interno dell interstadio di Laugerie ma relativi, forse, a fasi ravvicinate diverse. Il materiale osseo rinvenuto è composto per più del 60% da resti di ungulati di grande taglia (Uro e Cavallo). Per queste specie, ma molto probabilmente anche per altre di minori dimensioni, l abbattimento era seguito dallo smembramento delle carcasse e dal trasporto nella grotta quasi esclusivamente dei crani e degli arti: i primi probabilmente per lo sfruttamento del cervello, i secondi per l utilizzo dei tendini, del midollo osseo e delle masse muscolari. A dimostrazione di questa selezione di parti, tra i resti determinati a livello specifico i denti isolati, probabile residuo della distruzione dei crani, raggiungono complessivamente il 31%. Il materiale rimanente, se si escludono tre elementi del cinto scapolare e pelvico, è totalmente riferibile agli arti anteriori e posteriori con una prevalenza di elementi di piccole dimensioni come falangi, carpali e tarsali (31.2% sul totale degli elementi determinati) (tab. 3). Nell esame degli elementi non determinati si contano alcuni frammenti, quantitativamente trascurabili, attribuibili a vertebre e molti frammenti legati a diafisi di ossa lunghe. Da questo campione osseo non emergono particolari informazioni su strategie di caccia o frequenza stagionale del sito. Gli elementi attribuibili ad animali abbattuti in giovane età sono in totale sei: due denti decidui e due emergenti di Cavallo, un radio con epifisi distale non saldata di Stambecco, ed una prima falange di Cinghiale. Sono, questi, dati frammentari ma che contribuiscono ad ampliare le informazioni custodite nell importante deposito di grotta Paglicci. P. B.
10 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) 11 Tab. 3 Elementi anatomici suddivisi per specie dello strato 1a.
11 12 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola BIBLIOGRAFIA BARTOLOMEI G., BROGLIO A., PALMA DI CESNOLA A.,1979, Chronostratgraphie et écologie de l Epigravettien en Italie, in: Sonneville, Bordes D. de (ed.) La fin des temps glaciers en Europe, CNRS, Paris, pp BOSCATO P. 2001, Le faune dello strato 1 dell area esterna di Paglicci (Rignano Garganico), Atti 21 Convegno sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 2000, a cura di A. Gravina, pp BOSCATO P., PALMA DI CESNOLA A.,2000, Nuovi ritrovamenti di Epigravettiano antico iniziale a Grotta Paglicci (Rignano Garganico, Foggia), Società Preistoria Protostoria Friuli-Venezia Giulia, Trieste Quaderno 8, pp GALIBERTI A;, PALMA DI CESNOLA A.,1980, La Grotta Paglicci e il Paleolitico del Gargano Meridionale, Atti Conv. Archeologico Civiltà e Culture antiche tra Gargano e Tavoliere, Quaderni del Sud, 1, Lacaita, Mandria, pp HEPTNER V.G., NASIMOVICH A.A., BANNIKOV A. G. 1989, Mammals of the Soviet Union, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi, pp LAPLACE G:, 1964, Essai de typologie systématique, Annali Univ. di Ferrara, n.s., Sez.XV, suppl.ii, Vol.I, Ferrara, pp MEZZENA F., PALMA DI CESNOLA A., 1967, L Epigravettiano della Grotta Paglicci nel Gargano (scavi F. Zorzi ), Rivista di Scienze Preistoriche, XXII, pp PALMA DI CESNOLA A., 1975, Il Gravettiano della Grotta Paglicci nel Gargano, I: L industria litica e la cronologia assoluta, Riv. di Scienze Preist., XXX, 1-2, Firenze, pp PALMA DI CESNOLA A., 1982, Sulla periodizzazione dell Epigravettiano italico, in: AA VV, Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, I, Como, pp PALMA DI CESNOLA A.,2001 a, Le Paléolithique supérieur en Italie, Collection L Homme des origines, Série Préhistoire d Europe, n.9, Ed.J.Million, Grenoble. PALMA DI CESNOLA A., 2001 b, Notizie preliminari sugli scavi condotti dall Università di Siena durante gli anni 1999 e 2000 nell area esterna di Paglicci, Atti 21 Conv. sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, San Severo 2000, a cura di A. Gravina. SALA B. 1985, Variations climatiques et séquences chronologiques sur la base des variations des associations fauniques à grands mammifères, Actes du Colloque International: La position taxonomique et chronologique des industries à pointes à dos autour de la Méditerranée européenne, Siena, nov. 1983, Rivista di Scienze Preistoriche (1983), Firenze, XXXVIII:
12 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) cm Fig. 1. Paglicci Industria litica dell area esterna, liv. 1A (dis. Paolo Giunti).
13 14 Paolo Boscato, Arturo Palma di Cesnola 0 2 cm Fig. 2. Paglicci Industria litica dell area esterna, liv. 1A (dis Paolo Giunti).
14 L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) cm Fig. 3. Paglicci Industria litica dell area esterna, liv. 1A (dis. Paolo Giunti).
15 INDICE PAOLO BOSCATO, ARTURO PALMA DI CESNOLA L industria e la fauna del livello 1 A dell area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano) pag. 3 SONIA LAMI Gli strumenti a cran dell Epigravettiano antico di Grotta Paglicci » 17 ATTILIO GALIBERTI Gli utensili litici per l attività estrattiva della miniera della Defensola » 31 MASSIMO TARANTINI Archeologia mineraria della selce nel Gargano. Nuove ricerche » 43 MASSIMO CALDARA, ILENA CAROLI, ARMANDO GRAVINA, ORONZO SIMONE Ricostruzione dell ambiente fisico nei pressi della Defensola (Vieste) » 57 ARMANDO GRAVINA Monte San Giovanni. Gli insediamenti preistorici (Carlantino - Foggia) » 81
16 MASSIMO CALDARA, ILENA CAROLI, RAFFAELE LOPEZ, ITALO M. MUNTONI, FRANCESCA RADINA, MICHELE SICOLO, ORONZO SIMONE I primi risultati sulle ricerche nel sito di Belvedere - Ariscianne (Barletta) pag. 99 ALBERTO CAZZELLA, GIULIA RECCHIA Coppa Nevigata e la Puglia settentrionale nel contesto dei rapporti transadriatici e con le altre regioni dell Italia orientale durante l età del Bronzo......» 139 ARMANDO GRAVINA, GIUSEPPE MASTRONUZZI PAOLO SANSÒ Evoluzione olocenica e dinamica insediativa antropica della piana costiera del Fiume Fortore (Italia Merdionale) » 151 PIEFRANCESCO TALAMO, CRISTINA RUGGINI Il territorio campano al confine con la Puglia nell età del Bronzo » 171 ANNA MARIA TUNZI SISTO L ipogeismo minore di Trinitapoli » 189 GIOVANNA PACILIO Lesina: Scavi nella laguna: Note preliminari......» 199 MARIA LUISA NAVA, VINCENZO CRACOLICI, RICHARD FLETCHER La romanizzazione della Basilicata nord-orientale tra Repubblica e Impero » 209 VITO SIBILIO Il papato, la Capitanata e la battaglia di Canne del » 233
17 AUSTACIO BUSTO Il casale-castrum di Corneto. Primi risultati di un indagine archeologica estensiva pag. 241 GIULIANA MASSIMO I fonti battesimali di San Severo: osservazioni sulla scultura medievale in Capitanata....» 255 NICOLA LORENZO BARILE Corrado IV di Svevia e la crisi del Regno: le leggi pubblicate a Foggia nel febbraio » 287 ANNA MARIA CALDAROLA I Benedettini nella Diocesi di Salpi: il monastero di San Matteo, prime indagini......» 305 LUISA LOFOCO Aspides isti Sarraceni in Lucheria : la crociata contro i Saraceni di Lucera » 309 FEDERICA MONTELEONE La voce dei santi: san Michele e la vergine guerriera » 323 PASQUALE CORSI Protocolli notarili di San Severo in età moderna » 353
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2004 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 25 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 3-4 - 5 dicembre 2004 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2005 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 25 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 3-4 - 5 dicembre 2004 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2005 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 3-4 - 5 dicembre 2004 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 25 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 3-4 - 5 dicembre 2004 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2005 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 25 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 3-4 - 5 dicembre 2004 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2005 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
FORMIA LOCALITÀ TALIENTO F. 13 p. 1459 PROPRIETÀ CENTOLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA L appezzamento di terreno, circa 5.000 mq., di proprietà Centola (F. 13, p. 1459) è situato in località Taliento e rimane
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
Accumuli di ossa animali Cause della formazione
 Accumuli di ossa animali Cause della formazione Trappole naturali pozzi carsici sabbie mobili... Eventi catastrofici siccità alluvioni Tane abitazione, ibernazione Predatori carnivori uomo (iena, leone,
Accumuli di ossa animali Cause della formazione Trappole naturali pozzi carsici sabbie mobili... Eventi catastrofici siccità alluvioni Tane abitazione, ibernazione Predatori carnivori uomo (iena, leone,
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4
 Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
Accordo di verifica preliminare di interesse archeologico attività di sorveglianza archeologica VP1 4 VP1 4 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA Via della Pergola, 65 50121 Firenze SAGGI
NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I
 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.I Italia settentrionale e peninsulare 2015-2.I- www.iipp.it - ISSN 2384-8758 ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
ACQUAVIVA DELLE FONTI. GSV-Gruppo Speleologico Vespertilio CENTRO ALTAMURANO RICERCHE SPELEOLOGICHE
 Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998
 ESPLORAZIONI 223 Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998 Rilievo 1998: U. Del Vecchio, A. Lala, M. E. Smaldone 234 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DI POLLA (CP 4) La Grotta di Polla si trova nel settore
ESPLORAZIONI 223 Grotta di Polla (Cp 4) - esplorazioni del 1998 Rilievo 1998: U. Del Vecchio, A. Lala, M. E. Smaldone 234 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DI POLLA (CP 4) La Grotta di Polla si trova nel settore
Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche
 Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
Roma 28.07.2011 Romanina Centralità Metropolitana Municipio X Indagini archeologiche Nel corso degli anni 2004 e 2006, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, è stata effettuata
I SITI MESOLITICI DI CASCINA NA VICF,:LLA E MONTE GABBIONE
 «NATURA BRESCIANA» Ann. Mus. Civ. Se. Nat., Brescia, 26 (1989) 1991: 289-298 SILVIO COLOMBO* I SITI MESOLITICI DI CASCINA NA VICF,:LLA E MONTE GABBIONE (Lonato~ Brescia)** RIASSUNTO - L'Autore descrive
«NATURA BRESCIANA» Ann. Mus. Civ. Se. Nat., Brescia, 26 (1989) 1991: 289-298 SILVIO COLOMBO* I SITI MESOLITICI DI CASCINA NA VICF,:LLA E MONTE GABBIONE (Lonato~ Brescia)** RIASSUNTO - L'Autore descrive
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano
 Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
Condizioni e tendenze del sistema produttivo siciliano 1. Le imprese attive Alla fine del 2011, in Sicilia erano attive poco meno di 381.000 imprese (le registrate erano oltre 463.000), in contrazione
La Preistoria nel Salento
 La Preistoria nel Salento 26/10/2014 500.000 aa.fa Primi ominidi in Puglia In Puglia, la presenza dell uomo risale al Paleolitico inferiore (500.000 anni fa) come testimoniano numerosi siti archeologici
La Preistoria nel Salento 26/10/2014 500.000 aa.fa Primi ominidi in Puglia In Puglia, la presenza dell uomo risale al Paleolitico inferiore (500.000 anni fa) come testimoniano numerosi siti archeologici
OGGETTO PROGETTAZIONE. U.T. Consorzio A.S.I. Arch. Alberto CANNAVALE ELABORATO PD_RS.01. Relazione indagine archeologica R.U.P. Geom.
 OGGETTO Riproduzione del modello "Rustici industriali" nell'agglomerato industriale di San Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio PROGETTO DEFINITIVO PROGETTAZIONE U.T. Consorzio A.S.I. Ing. Luigi TRAVAGLIONE
OGGETTO Riproduzione del modello "Rustici industriali" nell'agglomerato industriale di San Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio PROGETTO DEFINITIVO PROGETTAZIONE U.T. Consorzio A.S.I. Ing. Luigi TRAVAGLIONE
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012
 Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
Valutazione del rischio archeologico Località Stocchetta, Brescia 2012 Committenza: Ricerca storico-archeologica: CAL Srl Brescia CAL srl Archeologia e Conservazione Contrada delle Bassiche 54, 25122 Brescia
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA NOVEMBRE Con il patrocinio:
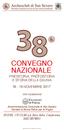 CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
La stratigrafia archeologica
 La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
La stratigrafia archeologica Storia e concetti di base 01 Individuazione della vera natura dei fossili e dei manufatti Geologia: Steno (1660-70) Archeologia: Frere (1790-800) John Frere (1740-1807) La
INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015
 INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015 a cura dell Osservatorio sul sistema formativo piemontese ARTICOLO 3/2015 Chi ha partecipato ai test Invalsi? SOMMARIO
INVALSI 2015: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2015 a cura dell Osservatorio sul sistema formativo piemontese ARTICOLO 3/2015 Chi ha partecipato ai test Invalsi? SOMMARIO
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
DAUNI LE STELE A COLORI ANCIENTCONTEMPORARYART ASSESSORATO ALLA CULTURA TÀ D
 DUNI 200 LE STELE COLORI NCIENTCONTEMPORRYRT.4 by SN MRCO IN L I SSESSORTO LL CULTUR PRESENTZIONE Soltanto da meno di mezzo secolo il Gargano e la Daunia hanno rivelato al mondo il loro incredibile Patrimonio
DUNI 200 LE STELE COLORI NCIENTCONTEMPORRYRT.4 by SN MRCO IN L I SSESSORTO LL CULTUR PRESENTZIONE Soltanto da meno di mezzo secolo il Gargano e la Daunia hanno rivelato al mondo il loro incredibile Patrimonio
Relatore: Fabio Mantovani Correlatore: Riccardo Salvini. Tesista : Nadia Bianconi
 Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
Ricostruzione del percorso dell acquedotto romano di Firenze rinvenuto presso il torrente Zambra (Comune di Sesto Fiorentino - FI) attraverso misure di resistività elettrica Relatore: Fabio Mantovani Correlatore:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE
 INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2016 a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO
INVALSI 2016: I RISULTATI DEL PIEMONTE Sintesi estratta dal rapporto INVALSI 2016 a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO
Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici
 Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici MUSEO DELLE SCIENZE A CURA DI : GIAMPAOLO DALMERI e STEFANO NERI Sezione di Preistoria Dott. G. Dalmeri Dott. S. Neri, Dott.ssa R. Duches, Dott.ssa
Sulle tracce dei cacciatori paleolitici e mesolitici MUSEO DELLE SCIENZE A CURA DI : GIAMPAOLO DALMERI e STEFANO NERI Sezione di Preistoria Dott. G. Dalmeri Dott. S. Neri, Dott.ssa R. Duches, Dott.ssa
Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
 Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
Note di Ricerca - Rivanazzano - pag. di 5 25-26 (2006-2007), pp. 47-51 Note di Ricerca Rivista scientifica del volontariato archeologico www.aut-online.it Manufatti in pietra verde da Rivanazzano (Pavia)
STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA
 STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA Dott.ssa Anna Maria MECCHI Dott.ssa Susanna BRACCI Dott. Fabio
STUDIO DEI MATERIALI DI INCOLLAGGIO E STUCCATURA DELLA STATUA DI EROE APPARTENENTE ALLA COLLEZIONE DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI, ROMA Dott.ssa Anna Maria MECCHI Dott.ssa Susanna BRACCI Dott. Fabio
Kangourou della Matematica 2016 Coppa a squadre Kangourou Ecolier Cervia, 6 maggio 2016
 Kangourou della Matematica 2016 Coppa a squadre Kangourou Ecolier Cervia, 6 maggio 2016 Quesiti 1. Chi sono? Sono uguale al triplo del mio doppio. Che numero sono? 2. La numerazione Al numero 7 sommiamo
Kangourou della Matematica 2016 Coppa a squadre Kangourou Ecolier Cervia, 6 maggio 2016 Quesiti 1. Chi sono? Sono uguale al triplo del mio doppio. Che numero sono? 2. La numerazione Al numero 7 sommiamo
ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 1 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-3 Trento
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELLA PRIMAVERA 1 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 1-3 Trento
III. I VETRI. BAUMGARTNER, KRUEGER 1988, p
 III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
III. I VETRI Nelle stratigrafie di metà VII-XV secolo del castello di Montarrenti sono stati rinvenuti 74 frammenti vitrei *. Tra le forme riconsciute compaiono tre bicchieri con parete liscia, uno con
La Grotta di Roccia San Sebastiano (Mondragone, Caserta)
 GIORGIO BELLUOMINI (1) - GILBERTO CALDERONI (2) - CARMINE COLLINA (3) MAURIZIO FEDI (4) - IVANA FIORE (5) - ROSALIA GALLOTTI (6) BARTOLOMEO GAROFALO (7) - MASSIMO PENNACCHIONI (8) MARCELLO PIPERNO (9)
GIORGIO BELLUOMINI (1) - GILBERTO CALDERONI (2) - CARMINE COLLINA (3) MAURIZIO FEDI (4) - IVANA FIORE (5) - ROSALIA GALLOTTI (6) BARTOLOMEO GAROFALO (7) - MASSIMO PENNACCHIONI (8) MARCELLO PIPERNO (9)
ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL ESTATE 2016 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
PRIMO RAPPORTO SULLA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI a cura di Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci Ricercatori FNC
 PRIMO RAPPORTO SULLA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI 2015 a cura di Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci Ricercatori FNC Roma 5 maggio 2015 Presentazione Il Rapporto presenta per la prima volta un
PRIMO RAPPORTO SULLA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI 2015 a cura di Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci Ricercatori FNC Roma 5 maggio 2015 Presentazione Il Rapporto presenta per la prima volta un
Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava
 Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava Volate tipo per l abbattimento di materiali lapidei in cave di porfido Volate tipo per la realizzazione di nuove viabilità all interno delle
Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava Volate tipo per l abbattimento di materiali lapidei in cave di porfido Volate tipo per la realizzazione di nuove viabilità all interno delle
Rivivere la Preistoria: che emozione!
 venerdì 11 febbraio ore 16.30-18.30 Rivivere la Preistoria: che emozione! Proposta per l aggiornamento docenti della Scuola dell Infanzia e Primaria a cura di ROSSELLA DUCHES UNIVERSITA DI FERRARA Dip.
venerdì 11 febbraio ore 16.30-18.30 Rivivere la Preistoria: che emozione! Proposta per l aggiornamento docenti della Scuola dell Infanzia e Primaria a cura di ROSSELLA DUCHES UNIVERSITA DI FERRARA Dip.
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI
 DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
10. Lo studio palinostratigrafico e archeobotanico dei depositi archeologici e delle attività dell uomo
 Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Scienze Naturali Corso di Palinologia AA 2014 / 2015 Roberta Pini Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia, C.N.R. IDPA 10. Lo studio palinostratigrafico
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
SITI DELL ETÀ MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB)
 SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
SITI DELL ETÀ del BRONZO NEL MOLISE INTERNO Località Paradiso a Monteroduni (IS) e Rocca di Oratino (CB) L e ricerche archeologiche in due siti interni del Molise riferibili all età del Bronzo, condotte
Regione PUGLIA - Note storiche
 Regione PUGLIA - Note storiche Terremoto del 1627. Mappa con la descrizione dei danni secondo una scala macrosismica a quattro gradi riportata in legenda. [in ENEA (1992), Terremoti in Italia dal 62 a.d.
Regione PUGLIA - Note storiche Terremoto del 1627. Mappa con la descrizione dei danni secondo una scala macrosismica a quattro gradi riportata in legenda. [in ENEA (1992), Terremoti in Italia dal 62 a.d.
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia
 Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
Il complesso archeologico termale e il mosaico del drago di Kaulonia L antica Kaulonia, agli inizi del Novecento è stata identificata dall archeologo Paolo Orsi nella moderna cittadina di Monasterace Marina
C8. LE ASSUNZIONI PREVISTE DELL OCCUPAZIONE DIPENDENTE SECONDO LA RILEVAZIONE EXCELSIOR
 C8. LE ASSUNZIONI PREVISTE DELL OCCUPAZIONE DIPENDENTE SECONDO LA RILEVAZIONE EXCELSIOR Il Progetto Excelsior ha rilievo con riferimento alla previsione delle variazioni occupazionali a breve termine presso
C8. LE ASSUNZIONI PREVISTE DELL OCCUPAZIONE DIPENDENTE SECONDO LA RILEVAZIONE EXCELSIOR Il Progetto Excelsior ha rilievo con riferimento alla previsione delle variazioni occupazionali a breve termine presso
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
 COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale
 ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA
 DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento
 METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento LE PIOGGE DELL INVERNO E PRIMAVERA 28 (a cura di Serenella Saibanti e Roberto Barbiero) La prima parte dell anno è stata caratterizzata dalle abbondanti e frequenti
METEO REPORT Provincia Autonoma di Trento LE PIOGGE DELL INVERNO E PRIMAVERA 28 (a cura di Serenella Saibanti e Roberto Barbiero) La prima parte dell anno è stata caratterizzata dalle abbondanti e frequenti
La soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico in Italia e in Emilia-Romagna
 Direzione generale Europa, Risorse, Innovazione e Istituzioni Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e Partecipazione La soddisfazione degli utenti
Direzione generale Europa, Risorse, Innovazione e Istituzioni Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e Partecipazione La soddisfazione degli utenti
Analisi dei prodotti della scheggiatura del sito dell Epigravettiano finale di La Greppia II US 1 (Parco Naturale dell Orecchiella Lucca)
 Preistoria Alpina, 41 (2005): 5-21 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2006 ISSN 0393-0157 Analisi dei prodotti della scheggiatura del sito dell Epigravettiano finale di La Greppia II US 1 (Parco
Preistoria Alpina, 41 (2005): 5-21 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2006 ISSN 0393-0157 Analisi dei prodotti della scheggiatura del sito dell Epigravettiano finale di La Greppia II US 1 (Parco
Mousterian industry, Middle Paleolithic, Tuscany.
 Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 1 11, figg. 4 A. DANI (*), P. GIUNTI (**), F. MENICUCCI (***) L'INDUSTRIA MUSTERIANA DI QUERCE (FIRENZE) Riassunto - Gli autori descrivono un'industria
Alli Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 100 (1993) pagg. 1 11, figg. 4 A. DANI (*), P. GIUNTI (**), F. MENICUCCI (***) L'INDUSTRIA MUSTERIANA DI QUERCE (FIRENZE) Riassunto - Gli autori descrivono un'industria
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI. Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze. Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella
 SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
COMUNE DI MATELICA. Provincia di Macerata
 DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
DOTT. GEOL. PAOLO BOLDRINI COMUNE DI MATELICA Provincia di Macerata DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA Realizzazione Scuola Federale Off Road Città di Matelica (gestione di rifiuti risultanti dall estrazione e
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive
 Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
CEIPA Centro Studi Psicologia Applicata Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica
 Estatto da: Atti del Convegno di Psicologia Giuridica "La criminalità femminile fra stereotipi culturali e malintese realtà" a cura di L. de Cataldo Neuburger, Noto 21-24 sett. 1995. CEIPA Centro Studi
Estatto da: Atti del Convegno di Psicologia Giuridica "La criminalità femminile fra stereotipi culturali e malintese realtà" a cura di L. de Cataldo Neuburger, Noto 21-24 sett. 1995. CEIPA Centro Studi
Una regione bagnata da due mari
 Una regione bagnata da due mari La Basilicata o anche comunemente Lucania Confina a nord e ad est con la Puglia, ad ovest con la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest è bagnata dal mar Tirreno e
Una regione bagnata da due mari La Basilicata o anche comunemente Lucania Confina a nord e ad est con la Puglia, ad ovest con la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest è bagnata dal mar Tirreno e
LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI
 LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI MA SI DEVE CONSIDERARE IL FOSSILE, O MEGLIO, L ASSOCIAZIONE DEI FOSSILI (TANATOCENOSI), ANCHE IN RELAZIONE ALLA
LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI MA SI DEVE CONSIDERARE IL FOSSILE, O MEGLIO, L ASSOCIAZIONE DEI FOSSILI (TANATOCENOSI), ANCHE IN RELAZIONE ALLA
Tre finestre rettangolari, decorate con vetri multicolore raffiguranti S. Pietro, S. Paolo e Gesù Cristo, illuminano la cantoria e la navata centrale
 Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
Descrizione Oggetto Esterno La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo presenta una tipica facciata a capanna (fotografia 1). Il portale principale (fotografia 2), recante il simbolo del Giubileo del 2000 (fotografia
L economia del Lazio nel 2009
 L economia del Lazio nel 2009 Evidenza dai conti regionali Istat pubblicati il 28 settembre 2010 Servizio Analisi e Finanza Sviluppo Lazio L economia del Lazio nel 2009 1. Premessa Il 28 settembre, l Istat
L economia del Lazio nel 2009 Evidenza dai conti regionali Istat pubblicati il 28 settembre 2010 Servizio Analisi e Finanza Sviluppo Lazio L economia del Lazio nel 2009 1. Premessa Il 28 settembre, l Istat
INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE
 INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO 2/2017 di Luisa Donato Chi ha partecipato
INVALSI 2017: I RISULTATI DEL PIEMONTE a cura dell Osservatorio sul Sistema formativo piemontese SISFORM realizzato da IRES Piemonte e Regione Piemonte ARTICOLO 2/2017 di Luisa Donato Chi ha partecipato
Appunti preliminari sulle relazioni fra materie prime esequenze operative nell industria litica del Lavagnone settore A
 INDICE Marco Minoja 5 MA_net: due anni di esperienza in rete Loretta Bettari 9 La rete dei musei archeologici delle province di Brescia, Cremona e Mantova: costituzione e finalità Marco Baioni - Raffaella
INDICE Marco Minoja 5 MA_net: due anni di esperienza in rete Loretta Bettari 9 La rete dei musei archeologici delle province di Brescia, Cremona e Mantova: costituzione e finalità Marco Baioni - Raffaella
Il flauto dolce. Unità didattica di Educazione Musicale. Classe prima. Corpo
 Il flauto dolce Unità didattica di Educazione Musicale Classe prima Gli obiettivi del nostro lavoro Conoscere il flauto dolce. Capire come funziona e come si utilizza. Imparare le posizioni delle note
Il flauto dolce Unità didattica di Educazione Musicale Classe prima Gli obiettivi del nostro lavoro Conoscere il flauto dolce. Capire come funziona e come si utilizza. Imparare le posizioni delle note
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale. Variazioni relative del livello marino
 Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di Scienze della terra e dell ambiente Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura Uso delle aree aperte da parte di medio mammiferi nel
Fondazione Nord Est Marzo 2012
 C10. LE ASSUNZIONI PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE Il Progetto Excelsior ha rilievo con riferimento alla previsione delle variazioni occupazionali a breve termine presso le imprese. Sono esclusi dal
C10. LE ASSUNZIONI PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE Il Progetto Excelsior ha rilievo con riferimento alla previsione delle variazioni occupazionali a breve termine presso le imprese. Sono esclusi dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche. RAPPORTO DI EVENTO Fenomeni franosi avvenuti in Val Germanasca (TO) il 16 marzo 2011
 Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT ANALISI CLIMATICA DELL AUTUNNO 2014 Dipartimento Protezione Civile Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Previsioni e Pianificazione Via Vannetti, 41-38100
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO Centro Studi di Preistoria e Archeologia
 PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA NOTIZIARIO 2015 Centro Studi di Preistoria e Archeologia Direttore Scientifico Nuccia Negroni Catacchio: Università degli studi di Milano e Centro studi di Preistoria
Monitoraggio. La chiusura degli istituti per minori in Italia
 Monitoraggio La chiusura degli istituti per minori in Italia Aggiornamento sullo stato di attuazione al 31 marzo 2009 Nell ambito della riforma dell adozione e dell affidamento, la legge 149 del 2001 rappresenta
Monitoraggio La chiusura degli istituti per minori in Italia Aggiornamento sullo stato di attuazione al 31 marzo 2009 Nell ambito della riforma dell adozione e dell affidamento, la legge 149 del 2001 rappresenta
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
CORSO DI. Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
 CORSO DI ZOOLOGIA AMBIENTALE Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA RICERCA ZOOLOGICA DI CAMPO: IL METODO NATURALISTICO RELATORE: Dott.ssa
CORSO DI ZOOLOGIA AMBIENTALE Prof. Bernardino Ragni Dipartimento di Chimica, Biologia, Biotecnologie UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA RICERCA ZOOLOGICA DI CAMPO: IL METODO NATURALISTICO RELATORE: Dott.ssa
CONVEGNO NAZIONALE. Archeoclub di San Severo PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011
 Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
Archeoclub di San Severo Movimento di opinione al servizio dei beni culturali ed ambientali CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 12-13 NOVEMBRE 2011 Col patrocinio dell Amministrazione
CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna)
 www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna) CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (SPAGNA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS PROGETTO: realizzazione di uno
www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna) CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (SPAGNA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS PROGETTO: realizzazione di uno
Sulla bilancia: il peso corporeo dei trentini 58,6. Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso
 Famiglia e società Aprile 2002 Sulla bilancia: il peso corporeo dei trentini I dati presentati in questa pubblicazione sono stati raccolti, durante il periodo luglio 1999-giugno 2000, attraverso l indagine
Famiglia e società Aprile 2002 Sulla bilancia: il peso corporeo dei trentini I dati presentati in questa pubblicazione sono stati raccolti, durante il periodo luglio 1999-giugno 2000, attraverso l indagine
Laura FALCERI * SUPERVISOR: Federica Fontana
 Annali dell Università di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica ISSN 1824-2707 Volume 6 (2010) Studio tecnologico dell industria litica dell US 301 di Riparo Tagliente (Stallavena di Grezzana,
Annali dell Università di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica ISSN 1824-2707 Volume 6 (2010) Studio tecnologico dell industria litica dell US 301 di Riparo Tagliente (Stallavena di Grezzana,
1. CONTENUTI DEL PROGETTO
 Volume I - RELAZIONE GENERALE 1.1 Ambito territoriale Il progetto, nella sua formulazione iniziale, riguardava 5 regioni del Sud dell Italia: Molise, Campania,, e la orientale comprendente 67 della provincia
Volume I - RELAZIONE GENERALE 1.1 Ambito territoriale Il progetto, nella sua formulazione iniziale, riguardava 5 regioni del Sud dell Italia: Molise, Campania,, e la orientale comprendente 67 della provincia
I discorsi dei Presidenti
 Ricerca I discorsi dei Presidenti Michele Cortelazzo, Arjuna Tuzzi (Università di Padova) Il discorso del 2 giugno di Giorgio Napolitano comparato con quelli dei predecessori 1. Il corpus Abbiamo analizzato
Ricerca I discorsi dei Presidenti Michele Cortelazzo, Arjuna Tuzzi (Università di Padova) Il discorso del 2 giugno di Giorgio Napolitano comparato con quelli dei predecessori 1. Il corpus Abbiamo analizzato
LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI
 LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI MA SI DEVE CONSIDERARE IL FOSSILE, O MEGLIO, L ASSOCIAZIONE DEI FOSSILI (TANATOCENOSI), ANCHE IN RELAZIONE ALLA
LO SCAVO PALEONTOLOGICO PER OTTENERE TUTTI I DATI POSSIBILI DAI FOSSILI OCCORRE RACCOGLIERLI MA SI DEVE CONSIDERARE IL FOSSILE, O MEGLIO, L ASSOCIAZIONE DEI FOSSILI (TANATOCENOSI), ANCHE IN RELAZIONE ALLA
Su incarico del dott. Francesco Cuozzo ho preso visione di cinque fotografie attribuite al bandito Giuliano.
 Dott. Alberto Bellocco medico chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università Cattolica del Sacro Cuore 00168 L.go F. Vito 1 Roma
Dott. Alberto Bellocco medico chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università Cattolica del Sacro Cuore 00168 L.go F. Vito 1 Roma
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
 18 febbraio #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 16feb2016 Messaggero Veneto 17feb2016 Il Piccolo 17feb2016 Il Gazzettino 17feb2016 I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
18 febbraio #lavoro Rassegna stampa TG3 RAI FVG 16feb2016 Messaggero Veneto 17feb2016 Il Piccolo 17feb2016 Il Gazzettino 17feb2016 I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE IN FVG NEL 2015 (gennaiodicembre)
INDICE 1. PREMESSA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE DELL ECOSISTEMA LOCALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE...
 INDICE 1. PREMESSA... 2 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO... 2 3. DESCRIZIONE DELL ECOSISTEMA LOCALE... 2 4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE... 4 Pagina 1 di 8 1. PREMESSA Le aree a margine della S.P.130 sono
INDICE 1. PREMESSA... 2 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO... 2 3. DESCRIZIONE DELL ECOSISTEMA LOCALE... 2 4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE... 4 Pagina 1 di 8 1. PREMESSA Le aree a margine della S.P.130 sono
OGGETTO : RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO - 5/8 LOTTO DI LAVORI
 MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.a.s. Restauro opere d arte Restauro dipinti su tela e opere lignee Restauro affreschi, stucchi e monumenti Cocconato, 13 gennaio 2012 Alla cortese attenzione della Gent.ma
Relazione di fisica ESPERIMENTO N 1
 ISTITUTO SUPERIORE "B. RUSSELL" DI ROMA Relazione di fisica ESPERIMENTO N 1 1.TITOLO Misurazione indiretta della massa di un cilindretto metallico mediante i metodi della tara di J.C. Borda e della doppia
ISTITUTO SUPERIORE "B. RUSSELL" DI ROMA Relazione di fisica ESPERIMENTO N 1 1.TITOLO Misurazione indiretta della massa di un cilindretto metallico mediante i metodi della tara di J.C. Borda e della doppia
Cana. Sito Complesso Architettonico 1. Corpo di Fabbrica 1. Riccardo Bargiacchi
 Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
Cana Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; Repetti
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI
 UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI a cura di Nicola Ungaro, Annamaria Pastorelli, Enrico Barbone Unità Operativa Semplice Biologia Mare e Coste I rifiuti spiaggiati e
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RIFIUTI SPIAGGIATI LUNGO LE COSTE PUGLIESI a cura di Nicola Ungaro, Annamaria Pastorelli, Enrico Barbone Unità Operativa Semplice Biologia Mare e Coste I rifiuti spiaggiati e
COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA
 Partita I.V.A. e C.F. 07457550635 Capitale sociale uro 100.000 i.v COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA COMMITTENTE: GORI S.p.a. OGGETTO: Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
Partita I.V.A. e C.F. 07457550635 Capitale sociale uro 100.000 i.v COMUNI DI TORRE DEL GRECO-TORRE ANNUNZIATA COMMITTENTE: GORI S.p.a. OGGETTO: Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
 Civico Museo Su Mulinu di Villanovafranca. Dal sito archeologico alla vetrina attraverso la natura, lo scavo e la promozione turistica, Intervento realizzato con finanziamento regionale a valere sul Programma
Civico Museo Su Mulinu di Villanovafranca. Dal sito archeologico alla vetrina attraverso la natura, lo scavo e la promozione turistica, Intervento realizzato con finanziamento regionale a valere sul Programma
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda.
 La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
La carta dei paesaggi italiani Colora la cartina dei grandi paesaggi italiani, seguendo le indicazioni della legenda. paesaggio alpino = verde paesaggio appenninico = rosso paesaggio padano = giallo paesaggio
I numeri della pratica sportiva in Italia Giovedì 23 Febbraio 2017 Salone d Onore del CONI - Foro Italico - Roma
 I numeri della pratica sportiva in Italia Giovedì 23 Febbraio 2017 Salone d Onore del CONI - Foro Italico - Roma I numeri della pratica sportiva I dati dell'istat descrivono come, dal 2013 ad oggi, la
I numeri della pratica sportiva in Italia Giovedì 23 Febbraio 2017 Salone d Onore del CONI - Foro Italico - Roma I numeri della pratica sportiva I dati dell'istat descrivono come, dal 2013 ad oggi, la
Sistemi Informativi Territoriali. Paolo Mogorovich
 Sistemi Informativi Territoriali Paolo Mogorovich www.di.unipi.it/~mogorov Nozioni di Cartografia Esempi di lettura di carte Tratto da La lettura delle carte geografiche di Aldo Sestini Firenze, 1967 Lettura
Sistemi Informativi Territoriali Paolo Mogorovich www.di.unipi.it/~mogorov Nozioni di Cartografia Esempi di lettura di carte Tratto da La lettura delle carte geografiche di Aldo Sestini Firenze, 1967 Lettura
FOCUS settembre Attività culturali nelle regioni italiane e nelle province pugliesi. INGRESSI PER TIPO DI EVENTO PREMESSA
 INGRESSI PER TIPO DI EVENTO FOCUS settembre 2016 Attività culturali nelle regioni italiane e nelle province pugliesi. PREMESSA L Osservatorio dello Spettacolo della Società Italiana degli Autori ed Editori
INGRESSI PER TIPO DI EVENTO FOCUS settembre 2016 Attività culturali nelle regioni italiane e nelle province pugliesi. PREMESSA L Osservatorio dello Spettacolo della Società Italiana degli Autori ed Editori
