Patogenicità e virulenza. Patogenicità e virulenza. Argomenti trattati PATOGENESI DELLE INFEZIONI
|
|
|
- Italo Carnevale
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Argomenti trattati Introduzione - Batteriologia generale Virologia generale e replicazione. Micologia generale; alcuni patogeni d interesse clinico Rapporto ospite-parassita, antibiotici, antivirali, meccanismi di resistenza La flora normale e infezioni nosocomiali Gram positivi: Stafilococchi, Streptococchi, Enterococchi, Bacilli, Clostridi. Gram negativi: Enterobatteri Pseudomonas Neisserie Spirochete Virus respiratori. Virus esantematici e Virus erpetici Virus delle epatiti virali e Virus dell immunodeficienza umana PATOGENESI DELLE INFEZIONI Il processo attraverso il quale un microbo può causare una malattia 1 Il risultato dell interazione tra elementi caratteristici del microbo e fattori tipici dell ospite che rendono possibile l infezione 2 Patogenicità e virulenza Patogenicità e virulenza Requisiti di patogenicità Un batterio è PATOGENO quando causa malattia nell ospite Un batterio è VIRULENTO quando cresce a spese dell ospite Esistono batteri OPPORTUNISTI che non sono particolamente virulenti ma possono trarre vantaggio da alcune condizioni: accedere ed aderire ai tessuti dell ospite, penetrare in cellule permissive distruggere o evadere le difese dell ospite e quindi, danneggiare i tessuti dell ospite Immunosoppressione dell ospite Alterazione delle barriere chimico-fisiche Alterazione della flora residente Presenza in un sito diverso da quello solito Fattori di virulenza 1. Fattori che promuovono la colonizzazione/infezione 3 2. Fattori che danneggiano l ospite 4 1
2 Patogenesi batterica ESPOSIZIONE E DOSE INFETTANTE Ad agenti patogeni esogeni Patogenesi virale Patogenicità e virulenza ovvero come i batteri causano malattia INGRESSO Acquisizione dell infezione REPLICAZIONE sito primario VIREMIA E DISSEMINAZIONE REPLICAZIONE organo target DIFFUSIONE 5 6 Fattori di virulenza 1. Fattori che promuovono la colonizzazione a. Accesso a cellule e tessuti dell ospite b. Adesione a cellule e resistenza a rimozione fisica c. Invasione di cellule d. Resistenza a difese immunitarie innate e. Evasione difese immunitarie acquisite f. Competizione per ferro ed altri nutrienti 2. Fattori che danneggiano l ospite a. b. Endotossina 7 Fattori di virulenza 1a. accesso a cellule e tessuti dell ospite Flagelli es. Helycobacter pylori 8 2
3 Fattori di virulenza 1b. Adesione cellulare e resistenza a rimozione fisica es. Shigella Fattori di virulenza 1c. Invasione di cellule: invasine es. Salmonella es. adesione di Neisseria gonorrhoeae ad epitelio urinario Type III secretion system 9 10 Risposta immunitaria innata: fagocitosi Le molecole complessivamente denominate PAMP -Pathogen-Associated Molecular Patterns- (peptidoglicano, acidi lipoteicoici, LPS) non sono presenti nelle cellule eucariotiche Sono riconosciute e si legano ai recettori noti sotto il nome di Endocytic Pattern- Recognition Receptors sui fagociti che innescano il processo di fagocitosi e distruzione del microrganismo 11 Fattori di virulenza 1d. Resistenza a risposta immunitaria innata (1) Resistenza alla ingestione: capsula Type III secretion system Type III secretion system 12 3
4 Fattori di virulenza 1d. Resistenza a risposta immunitaria innata (2) Risposta immunitaria acquisita: produzione anticorpi - opsonofagocitosi Resistenza alla distruzione Fuga dal fagosoma Listeria monocytogenes, Shigella, Rickettsia Inibizione fusione fagosoma-lisosoma Salmonella, Mycobacterium, Legionella, Chlamydia Resistenza all interno del fagosoma Salmonella Inibizione acidificazione fagosoma Mycobacterium tubercolosis, Legionella Uccisione del fagocita Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, Streptococcus pyogenes Fuga dal fagosoma Inibizione fusione 13 IgG IgG aumentano contatto con fagociti Opsonizzazione e fagocitosi 14 Fattori di virulenza 1e. Evasione della risposta immunitaria acquisita (Ab) - Modificazione antigene - Mascheramento antigene Fattori di virulenza 1f. Competizione per ferro ed altri nutrienti Denota la capacità di competere con successo rispetto alle cellule dell organismo e alla flora residente per l utilizzo di nutrienti presenti in quantità limitata come ad es. il Fe 3+ Secrezione di siderofori che competono per il Fe con i composti chelanti prodotti dal nostro organismo (transferrina, lactoferrina, ferritina, emina) o presenza di recettori per i siderofori di altri batteri es. N. gonorrhoeae es. S. aureus - Distruzione immunoglobuline: IgA proteasi H. influenzae, S. pneumoniae, H. pilori, S. flexneri, N. meningitidis
5 Fattori di virulenza 2. Fattori che danneggiano l ospite Le tossine batteriche = tossine proteiche secrete nel mezzo Endotossina = lipopolisaccaride (Gram negativi) ü proteine tossiche (in genere enzimi), secrete o rilasciate per lisi della cellula, con struttura e meccanismo di azione differenti ü solubili nei liquidi corporei, trasportati attraverso sangue e linfa ü spesso rappresentano il principale fattore di patogenicità di un patogeno ü i geni sono generalmente su plasmidi o fagi ü molte proteggono i batteri dal sistema immune ü in genere sono labili al calore 17 ü >200 tossine batteriche note 18 A. che agiscono a livello della superficie cellulare 1.Tossine che agiscono a livello extracellulare 2.Tossine ciliostatiche 3.Tossine che danneggiano membrane cellulari B. che penetrano nelle cellule bersaglio 1.Tossine che agiscono alterando il contenuto intracellulare di AMPc 2.Tossine che inibiscono la sintesi proteica 3.Tossine citotossiche per azione sul citoscheletro 4.Tossine che inibiscono la liberazione di neurotrasmettitori (metallo proteasi) 19 A. che agiscono a livello della superficie cellulare 20 5
6 1. Tossine che agiscono a livello extracellulare tossina esfoliativa o epidermolitica di Staphylococcus aureus 2. Tossine ciliostatiche Provocano asincronia o paralisi completa del movimento ciliare con perdita di efficienza da parte dei tessuti interessati nel ripulire le mucose (Bordetella pertussis, Pseudomonas aeruginosa) Aree di scollamento epidermico superficiale Sindrome della cute ustionata Interferisce con le proteine della matrice presenti tra le cellule compromettendo la stabilità dello stato granulomatoso per cui la pelle si danneggia al minimo insulto 21 Lecitinasi: tossina α di Clostridium perfringens 3. Tossine che danneggiano membrane cellulari (emolisine e citolisine) attraverso la formazione di pori o canali transmembrana per azione enzimatica sui lipidi e proteine di membrana Staphilococcus aureus H2O 22 aumento permeabilità di capillari e cellule muscolari (edema ) Tossina α Fosfolipasi C gangrena gassosa Proteasi: esotossina B di Streptococcus pyogenes bassa osmolarità Idrolizza la fosforilcolina delle membrane cellulari alta osmolarità MEMBRANA DESTABILZZATA Le cellule dell ospite si gonfiano, lisano e muoiono 23 distruzione delle membrane delle cellule del derma fascite necrotizzante 24 6
7 1) Tossine che alterano il contenuto intracellulare di camp o bloccano EF2 a) attività enzimatica ADP-ribosilante: tossina colerica, tossina difterica B. che penetrano nella cellula bersaglio 25 il gruppo ADP-ribosio è rimosso dal co-enzima NAD ed è legato ad una proteina bersaglio (Gprotein, EF-2)è é camp, blocco sintesi proteica 26 4) Tossine che inibiscono la liberazione di neurotrasmettitori 4) Tossine che inibiscono la liberazione di neurotrasmattitori Neurotossina di Clostridium tetani blocca gli impulsi inibitori spinali inibisce la liberazione dei neurotrasmettitori dai neuroni inibitori del sistema nervoso centrale Neurotossina di Clostridium botulinum: blocca il del rilascio di acetilcolina dalle vescicole presinaptiche delle giunzioni neuromuscolari con conseguente INIBIZIONE DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE PARALISI FLACCIDA PARALISI SPASTICA
8 Endotossina Rilascio di LPS (Lipide A, endotossina) dalla parete dei Gram - Rilascio di molecole infiammatorie Effetto pirogeno Shock settico Ø Stabile al calore: non viene distrutta da bollitura o autoclave Ø Continuamente rilasciata dai Gram-, non è immunogenica: no vaccini Ø Si lega ai macrofagi e causa rilascio di molecole infiammatorie - Effetto pirogeno, Shock settico Ø Limulus test: test per scoprire la presenza di endotossina in - sangue, liquor, soluzioni sterili (plasma, solventi di farmaci) Il concetto iceberg dell infezione Patogenesi delle infezioni virali 31 Nel soggetto sano adulto (eccezioni, Morbillo, Vaiolo, Rabbia, Influenza,) la produzione di malattia, punto focale della patogenesi, è un evento relativamente inusuale dell infezione virale 32 8
9 L esito finale dipende dal bilanciamento di due processi Ceppo virale (patogenicità e virulenza) Dose infettiva Via d ingresso Infezione acuta Persistenza Latenza Regolazione del potenziale litico Possibilità di evasione dal sistema immune Malattia Clearence Background genetico Età Sesso Stato immune Condizioni generali di salute Recettori per l ingresso Fattori di crescita per la replicazione Possibilità di trasmissione ad altre cellule 33 Tipi d infezioni 1. Infezioni Acute - Localizzate (Hit & run) (RhinoV, FluA) - Sistemiche - diffusione del virus attraverso il sangue come virus libero o associato a cellule (morbillo, parotite, rosolia, HAV) IL VIRUS ALLA FINE E ELIMINATO DALL OSPITE 2. Infezioni Persistenti - Nessuna malattia (BKV, JCV) - Malattia Periodica (HSV) - Malattia progressiva con danno del tessuto target (HIV, HCV, HBV) - Tumore (HPV, HBV) IL VIRUS PERSISTE DOPO L INFEZIONE PER IL RESTO DELLA VITA DELL OSPITE 34 Infezioni virali localizzate Infezioni virali localizzate ü REPLICAZIONE LOCALE ü BREVE INCUBAZIONE ü IMMUNITA PROTETTIVA IgA-MEDIATA ü VACCINI EFFICACI SE CAPACI DI SUSCITARE Virus respiratori, gastroenterici (es. rotavirus), virus delle verruche (i papilloma virus) producono infezione alla sede d ingresso (mucose o cute) con una fugace viremia ma senza disseminazione sistemica 35 UNA RISPOSTA IgA 36 9
10 Infezioni virali sistemiche Infezioni virali sistemiche Rosolia ü PERIODO DI INCUBAZIONE ü TRASMISSIONE PRIMA DELLA MALATTIA viremia ü IMMUNITA PERMANENTE Si sviluppano lontano dalla porta d ingresso, i virus raggiungono l organo target in seguito alla viremia primaria o secondaria 37 ü RISPOSTA IgM DIAGNOSTICA ü RISPOSTA IgG PROTETTIVA ü VACCINI EFFICACI Drenaggio per via linfatica dei virus che si trovano nei liquidi extracellulari e immissione in circolo (VIREMIA). 38 Infezioni virali persistenti ü IL SISTEMA IMMUNE NON RIESCE AD ERADICARE L INFEZIONE ü TRASMISSIONE DURANTE LA PERSISTENZA ü IMMUNITA NON PROTETTIVA ü VACCINI INEFFICACI (ECCETTO HBV) 39 Infezioni ESOGENE ed ENDOGENE INFEZIONI ESOGENE: ü i microrganismi patogeni provengono da una sorgente esterna ü uomo antroponosi ü animale zoonosi ü ambiente INFEZIONI ENDOGENE: ü i microrganismi della flora normale ü localizzazione in sede diversa da quella abituale (es.: batteri intestinali infezioni vie urinarie) ü aumento numerico di una o più specie nella sede normale a causa di condizioni favorenti la moltiplicazione (es.: terapia antibiotica) ü riattivazione di infezioni latenti in relazione a eventi chimici, fisici o infettivi/terapeutici immunosopprimenti (es.: virus erpetici, JCV, BKV etc: Mycobacterium tubercolosis, Treponema pallidum, alcuni miceti opportunisti) 40 10
11 Vie d entrata Vie d uscita 1. Tratto respiratorio: rhinovirus, morbillo, parotite, VZ, CMV, EBV, virus respiratori, Mycobatterium tubercolosis, Streptococcus pneumoniae, agenti di micosi sistemiche 2. Tratto gastroenterico: poliovirus, epatite A, epatite E, rotavirus, Salmonella typhi, Vibrio cholerae 3. Tratto genitale: (trasmissione sessuale) HIV, HSV, HBV, papillomavirus Treponema pallidum, Gonococco, Chamydia tracomatis 4. Cute e mucose: papillomavirus, HSV, Clostridium tetani, agenti di micosi cutanee 5. Sangue: virus a trasmissione parenterale, virus, batteri e protozoi trasmessi da insetti Via d ingresso e modalità di trasmissione condizionano fortemente le caratteristiche epidemiologiche dell infezione 41 esempio: Streptococcus pneumoniae agente eziologico di polmonite q se inalato può causare polmonite q se ingerito non provoca malattia 42 Le vie di trasmissione ü Aerea: inalazione di goccioline es. virus respiratori, morbillo, parotite, rosolia, virus erpetici, Mycobacterium tubercolosis, agenti di micosi sistemiche ü Fecale-orale: i microbi si trovano nelle feci e contaminano alimenti e bevande: es. tra i virus Rotav. Adenovirus, Norovirus, HAV, HEV Poliov, Enterov; tra i batteri Salmonella typhi, Vibrio cholerae ü Stretto contatto personale con scambio di fluidi biologici ü contatto diretto con oggetti contaminati (fomiti) es. virus respiratori, v. enterici, agenti di micosi cutanee ü sessuale, es. HSV, CMV, papilloma, HCV, HBV, HIV, gonococco, Treponema pallidum; ü parenterale, trapianti, oggetti taglienti contaminati, es. HSV, CMV, HCV, HBV, HIV, Clostridium tetani ü Placentare: es Rosolia CMV Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes ü Vettori animali: zoonosi a trasmissione diretta dall animale reservoir es. rabbia; a trasmissione indiretta attraverso insetti ematofagi (infezioni da arbovirus es. virus della febbre gialla; da batteri es. Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, Yersinia pestis; da protozoi, Plasmodium, Trypanosoma) Modelli di trasmissione
12 Infezione del feto Potenzialmente tutti i virus che diffondono per via ematica alcuni batteri e/o protozoi possono essere trasmessi al feto In realtà in molti casi la placenta rappresenta una barriera efficiente Virus viremici Virus della rosolia, Citomegalovirus, Parvovirus B19 danno viremia e si replicano abbondantemente nella placenta si trasmettono nel periodo prenatale per via transplacentare INFEZIONI PRENATALI HIV, HCV, HBV danno viremia, ma non si replicano molto bene nella placenta si trasmettono preferenzialmente al momento del parto INFEZIONI CONNATALI o PERINATALI attraverso il contatto del neonato con il sangue materno Anche virus che non danno viremia possono causare infezioni materno-fetali? Ingresso nell ospite Adesione ai tessuti Stadi dell infezione Igiene Causano principalmente INFEZIONI PERINATALI venendo trasmessi durante il parto per contatto con le secrezioni infette: Es: Virus dell Herpes Simplex e Papillomavirus Moltiplicazione Rilascio di tossine locale o sistemico (batteri) Vaccini Antibiotici Antivirali 47 Malattia e diffusione 48 12
13 Terapia antimicrobica La scoperta degli antibiotici DISINFETTANTI Azione aspecifica, poca o nulla tossicità selettiva Sir Alexander Fleming (premio Nobel 1945) scoprì la penicillina prodotta dal fungo Penicillium notatum ANTIBIOTICI Azione specifica, tossicità selettiva più o meno ampia Caratteristiche degli antibiotici Terapia antibiotica Ø Sostanze organiche a basso peso molecolare Ø Struttura chimica anche molto complessa Ø Composizione elementare varia (C, H, O, N, S, F, ecc ) Ø Non riconducibili ad una singola classe chimica Ø Metaboliti secondari ü Sintetizzati da alcune specie microbiche (Streptomiceti, funghi) ü Non hanno una precisa funzione nel processo di crescita di questi microrganismi ü I ceppi produttori di antibiotici possono perdere per mutazione la capacità di produrli senza apparente svantaggio ü Spesso sintetizzati in fase stazionaria Caratteristiche desiderabili per uso clinico Ampio spettro Non tossico, non allergenico, senza effetti collaterali Capace di raggiungere il sito d infezione Facile ed economico da produrre Chimicamente stabile Assenza di resistenze
14 Criteri di classificazione degli antibiotici 1. Classificazione in FAMIGLIE Molecole che presentano caratteristiche simili (es. penicilline, cefalosporine, etc.) 2. Classificazione secondo lo SPETTRO D AZIONE (ampio, medio, stretto) 3. Classificazione secondo il TIPO D AZIONE (azione batteriostatica o battericida) 4. Classificazione secondo l ORIGINE Estrattiva, naturale (antibiotici); semisintetica, di sintesi (chemioterapici) 5. Classificazione in base al MECCANISMO D AZIONE 53 Classificazione degli antibiotici: meccanismo d azione a Inibizione della sintesi del A peptidoglicano ß-lattamici: Penicilline Cefalosporine Carbapenemici Monobattamici v Inibitori ß-lattamasi Acido clavulanico Glicopeptidi: Vancomicina Teicoplanina a A Azione sugli acidi nucleici Chinoloni Rifamicine Nitroimidazoli A Inibizione della sintesi proteica Aminoglicosidi Tetracicline Cloramfenicolo Macrolidi A Lincosamidi New class! Oxazolidinoni Danno alla membrana A Polimixine New class! Lipopeptidi ciclici Inibizione dei processi metabolici (acido folico) Sulfamidici 54 Diaminopirimidine (Trimetoprim) Valutazione dell attività antibatterica: antibiogramma Breakpoint valori soglia di riferimento Lo sviluppo di batteri resistenti Resistenza naturale (o intrinseca) insensibilità costituzionale nei confronti di un dato antibiotico - presente in tutti i ceppi (es: Pseudomonas; Enterococchi) Resistenza acquisita Ø ENDOGENA Mutazioni, selezione clonale Ø ESOGENA Geni eterologhi, trasferimento genetico orizzontale
15 Antibiotici, fitness, resistenza batterica Considerazioni sulla resistenza batterica The survival of the fittest... GLI ANTIBIOTICI SONO PRODOTTI IN NATURA DA ALCUNI MICROORGANISMI PER COMPETERE NELL ECOSISTEMA I BATTERI presenti anche in ecosistemi lontani dalla civiltà FRONTEGGIANO QUOTIDIANAMENTE ANTIBIOTICI ED EVOLVONO RESISTENZE L AMBIENTE URBANO COMPRENDE ECOSISTEMI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ANTIBIOTICI In tali ambienti, I MECCANISMI DI RESISTENZA POSSONO SELEZIONARSI AUTONOMAMENTE O GIUNGERE DA AMBIENTI DIVERSI E QUI EVOLVERE A LIVELLO DI EFFICIENZA E REGOLAZIONE CHEMIOTERAPIA ANTIBATTERICA CHEMIOTERAPIA ANTIVIRALE I batteri sono organismi indipendenti e molto diversi dalle cellule eucariotiche E relativamente facile trovare veleni selettivi I virus usano per lo più le vie metaboliche della cellula ospite E difficile trovare farmaci selettivi E inoltre molto difficile sperimentarne in vitro l efficacia
16 CHEMIOTERAPIA ANTIVIRALE La chiave del successo è la selettività Un farmaco ideale deve essere solubile in acqua stabile chimicamente e metabolicamente facilmente adsorbito (e quindi sufficientemente lipofilo, apolare) Non deve essere cancerogeno allergenico mutagenico teratogenico tossico 61 Requisiti di un chemioterapico antivirale Interferire con un enzima virale non presente nella cellula ospite Interferire con una funzione cellulare indispensabile al virus per la sua replicazione cruciale per il virus e non per la cellula solo le cellule infettate vengono colpite (es. attivazione del farmaco solo nella cellula infettata) 62 Strategie per lo sviluppo di un farmaco Problemi comunque aperti Conoscere al meglio i meccanismi di replicazione del nostro nemico mediante le tecniche di biologia molecolare Trovare il tallone di Achille, il bersaglio da inibire Utilizzare il computer per disegnare la molecola attiva su cui lavorare Utilizzare la chimica combinatoriale per ottenere un gran numero di molecole da saggiare Identificare il composto attivo che sarà il prototipo da cui partire 63 Tossicità cellulare Sviluppo di farmaco resistenza 64 16
17 HIV Ogni stadio della replicazione virale può essere il bersaglio della terapia anti-influenzali ERPETICI, HIV, HCV Inibitori di DNA polimerasi virali, Trascrittasi Inversa, RNApol-RNAdip HIV, HCV anti-influenzali
Nota dell editore. Prefazione
 Autori Nota dell editore Prefazione XI XIII XV 1 Importanza dello studio della microbiologia 1 Cenni di epidemiologia 1 Le infezioni nosocomiali 5 I microrganismi e la microbiologia 7 Microrganismi endogeni
Autori Nota dell editore Prefazione XI XIII XV 1 Importanza dello studio della microbiologia 1 Cenni di epidemiologia 1 Le infezioni nosocomiali 5 I microrganismi e la microbiologia 7 Microrganismi endogeni
La presenza di microrganismi negli alimenti
 La presenza di microrganismi negli alimenti Contaminazione primaria: dovuta a microrganismi naturalmente presenti nell alimento Contaminazione secondaria: proviene dal contatto con Aria acqua suolo Piante
La presenza di microrganismi negli alimenti Contaminazione primaria: dovuta a microrganismi naturalmente presenti nell alimento Contaminazione secondaria: proviene dal contatto con Aria acqua suolo Piante
EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL ASSISTENZA
 EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL ASSISTENZA 1 INTRODUZIONE 2 Le infezioni correlate all assistenza (ICA) rappresentano una complicanza frequente. In media il 5-10% dei pazienti ricoverati in
EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL ASSISTENZA 1 INTRODUZIONE 2 Le infezioni correlate all assistenza (ICA) rappresentano una complicanza frequente. In media il 5-10% dei pazienti ricoverati in
La catena Epidemiologica
 La catena Epidemiologica STORIA NATURALE DELLE MALATTIE esposizione al/ai fattori di rischio insorgenza della malattia esito guarigione cronicizzazione decesso Principali differenze tra malattie infettive
La catena Epidemiologica STORIA NATURALE DELLE MALATTIE esposizione al/ai fattori di rischio insorgenza della malattia esito guarigione cronicizzazione decesso Principali differenze tra malattie infettive
PRINCIPI DI LINEE GUIDA NEL TRATTAMENTO ANTIBIOTICO DELLE INFEZIONI NECROSANTI ACUTE DEI TESSUTI MOLLI
 PRINCIPI DI LINEE GUIDA NEL TRATTAMENTO ANTIBIOTICO DELLE INFEZIONI NECROSANTI ACUTE DEI TESSUTI MOLLI Vezzani G., Caberti L., Cantadori L., Mordacci M., Nicolopoulou A., Pizzola A. U.O. di Anestesia Rianimazione
PRINCIPI DI LINEE GUIDA NEL TRATTAMENTO ANTIBIOTICO DELLE INFEZIONI NECROSANTI ACUTE DEI TESSUTI MOLLI Vezzani G., Caberti L., Cantadori L., Mordacci M., Nicolopoulou A., Pizzola A. U.O. di Anestesia Rianimazione
Malattie infettive microrganismi patogeni trasmissibilità orizzontale o contagiosità
 Le malattie infettive - definizione - rapporto tra microrganismi e uomo - modalità di trasmissione delle infezioni - le basi della prevenzione - il ruolo dell ambiente domestico Malattie infettive: forme
Le malattie infettive - definizione - rapporto tra microrganismi e uomo - modalità di trasmissione delle infezioni - le basi della prevenzione - il ruolo dell ambiente domestico Malattie infettive: forme
INFEZIONI VIRALI A TRASMISSIONE MATERNO-FETALI
 INFEZIONI VIRALI A TRASMISSIONE MATERNO-FETALI Alcune malattie infettive ad eziologia virale e andamento benigno nei soggetti immunocompetenti, se sono contratte durante la gravidanza, possono rappresentare
INFEZIONI VIRALI A TRASMISSIONE MATERNO-FETALI Alcune malattie infettive ad eziologia virale e andamento benigno nei soggetti immunocompetenti, se sono contratte durante la gravidanza, possono rappresentare
Sanità Pubblica. origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione»:
 Sanità Pubblica Definizione: Dal punto di vista etimologico, Epidemiologia è una parola composita (epi-demio-logia) di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione»: Lo
Sanità Pubblica Definizione: Dal punto di vista etimologico, Epidemiologia è una parola composita (epi-demio-logia) di origine greca, che letteralmente significa «discorso riguardo alla popolazione»: Lo
Le esperienze dei CCIO locali: ESPERIENZA DELL AZIENDA 18
 Convegno La prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie della Regione Veneto: i progetti regionali e le esperienze locali Castelfranco Veneto, 18 novembre 2005 Le esperienze dei CCIO locali:
Convegno La prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie della Regione Veneto: i progetti regionali e le esperienze locali Castelfranco Veneto, 18 novembre 2005 Le esperienze dei CCIO locali:
Si distinguono tre diversi livelli di prevenzione. PRIMARIA Obiettivo: impedire l insorgenza della malattia DIMINUISCE l INCIDENZA
 Determinanti di malattia PROFILASSI GENERALE Soggetto sano Soggetto in fase preclinica di malattia Soggetto in fase clinica di malattia Prevenzione primaria Prevenzione secondaria Prevenzione terziaria
Determinanti di malattia PROFILASSI GENERALE Soggetto sano Soggetto in fase preclinica di malattia Soggetto in fase clinica di malattia Prevenzione primaria Prevenzione secondaria Prevenzione terziaria
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute
 ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Del Monte 05 febbraio 2014 sala Piccolotto ANTIBIOTICI: servono sempre? Dott.ssa Daniela Signori Dott. Vincenzo Catena
ULSS 2 INCONTRA I mercoledì della Salute Antibiotici: servono sempre? Relatore: Dr. Del Monte 05 febbraio 2014 sala Piccolotto ANTIBIOTICI: servono sempre? Dott.ssa Daniela Signori Dott. Vincenzo Catena
Insieme di tutti i microrganismi che abitano il corpo umano in modo inoffensivo in un individuo sano: MICROBIOTA. commensali = organismi che si
 Insieme di tutti i microrganismi che abitano il corpo umano in modo inoffensivo in un individuo sano: MICROBIOTA. commensali = organismi che si alimentano insieme Come ci vedono i microrganismi Gli organi
Insieme di tutti i microrganismi che abitano il corpo umano in modo inoffensivo in un individuo sano: MICROBIOTA. commensali = organismi che si alimentano insieme Come ci vedono i microrganismi Gli organi
1 - Cellula batterica 2 - Risposta immunitaria agli agenti patogeni 3 - Crescita batterica e metabolismo 4 - Genetica batterica
 INDICE BATTERIOLOGIA 1 - Cellula batterica...3 Morfologia e disposizione delle cellule batteriche...3 Composizione...3 Struttura della parete cellulare dei micobatteri...10 Domande di Autovalutazione...11
INDICE BATTERIOLOGIA 1 - Cellula batterica...3 Morfologia e disposizione delle cellule batteriche...3 Composizione...3 Struttura della parete cellulare dei micobatteri...10 Domande di Autovalutazione...11
Valori di Riferimento degli esami eseguiti nell'u.o. Microbiologia
 Pagina 1 di 5 Ab anti Adenovirus IgG Anticorpi anti Adenovirus IgG Ab anti Adenovirus IgG : < 8.5 Ab anti Adenovirus IgM Anticorpi anti Adenovirus IgM Ab anti Adenovirus IgM : < 8.5 Ab anti Bartonella
Pagina 1 di 5 Ab anti Adenovirus IgG Anticorpi anti Adenovirus IgG Ab anti Adenovirus IgG : < 8.5 Ab anti Adenovirus IgM Anticorpi anti Adenovirus IgM Ab anti Adenovirus IgM : < 8.5 Ab anti Bartonella
CHE COSA E UNA MALATTIA INFETTIVA?
 MALATTIE INFETTIVE CHE COSA E UNA MALATTIA INFETTIVA? E IL RISULTATO DEL CONTATTO TRA UN SOGGETTO SANO E UN MICRORGANISMO I MICRORGANISMI POSSONO ESSERE DI DIVERSI TIPI: BATTERI VIRUS FUNGHI BATTERI Posseggono
MALATTIE INFETTIVE CHE COSA E UNA MALATTIA INFETTIVA? E IL RISULTATO DEL CONTATTO TRA UN SOGGETTO SANO E UN MICRORGANISMO I MICRORGANISMI POSSONO ESSERE DI DIVERSI TIPI: BATTERI VIRUS FUNGHI BATTERI Posseggono
Rapporti microrganismo-ospite
 Rapporti microrganismo-ospite La maggior parte dei microrganismi sono utili nell'ambiente sono coinvolti in importanti cicli della materia, trasformazioni geochimiche e processi biologici produttori di
Rapporti microrganismo-ospite La maggior parte dei microrganismi sono utili nell'ambiente sono coinvolti in importanti cicli della materia, trasformazioni geochimiche e processi biologici produttori di
Antivirale, antibatterico, antifungo nanotecnologico
 descrizione X-Viral è una soluzione nanotecnologica pronta all uso. Viene usata per disinfettare le superfici. X-Viral si basa sulla tecnologia Bacoban, di cui ne rispetta le percentuali di principio attivo
descrizione X-Viral è una soluzione nanotecnologica pronta all uso. Viene usata per disinfettare le superfici. X-Viral si basa sulla tecnologia Bacoban, di cui ne rispetta le percentuali di principio attivo
Ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori
 Ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori Modifica del 15 dicembre 2003 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del 13 gennaio 1999 1 concernente le dichiarazioni
Ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori Modifica del 15 dicembre 2003 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del 13 gennaio 1999 1 concernente le dichiarazioni
IL RISCHIO BIOLOGICO
 LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA IL RISCHIO BIOLOGICO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Ufficio Scolastico
LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA IL RISCHIO BIOLOGICO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Ufficio Scolastico
Il sistema immunitario utilizza strategie diverse di difesa che operano in tempi e con meccanismi diversi. Ci sono numerosi e complessi meccanismi
 Il sistema immunitario utilizza strategie diverse di difesa che operano in tempi e con meccanismi diversi. Ci sono numerosi e complessi meccanismi che impediscono agli invasori di entrare dentro all organismo
Il sistema immunitario utilizza strategie diverse di difesa che operano in tempi e con meccanismi diversi. Ci sono numerosi e complessi meccanismi che impediscono agli invasori di entrare dentro all organismo
INFEZIONI DA MENINGOCOCCO: INFORMAZIONI PER I CITTADINI
 INFEZIONI DA MENINGOCOCCO: INFORMAZIONI PER I CITTADINI S.I.S.P. - U.O.S. Epidemiologia e Profilassi Malattie Infettive Dr.ssa Andreina Ercole La meningite batterica Evento raro, nei paesi industrializzati,
INFEZIONI DA MENINGOCOCCO: INFORMAZIONI PER I CITTADINI S.I.S.P. - U.O.S. Epidemiologia e Profilassi Malattie Infettive Dr.ssa Andreina Ercole La meningite batterica Evento raro, nei paesi industrializzati,
RISCHI BIOLOGICI NEGLI AMBIENTI INDOOR
 RISCHI BIOLOGICI NEGLI AMBIENTI INDOOR Modalità di trasmissione delle malattie infettive in ambito sportivo Via aerea Contatto diretto Tramite veicoli Tipologie di agenti eziologici Virus Batteri Funghi
RISCHI BIOLOGICI NEGLI AMBIENTI INDOOR Modalità di trasmissione delle malattie infettive in ambito sportivo Via aerea Contatto diretto Tramite veicoli Tipologie di agenti eziologici Virus Batteri Funghi
Abitudini di vita. Tumori delle vie respiratorie (fumo) Cancro della cervice uterina (età del primo rapporto, numero di partners/ Papillomavirus-HPV-)
 Abitudini di vita Tumori delle vie respiratorie (fumo) Cancro della cervice uterina (età del primo rapporto, numero di partners/ Papillomavirus-HPV-) Alterazioni preneoplasiche acquisite Iperplasia
Abitudini di vita Tumori delle vie respiratorie (fumo) Cancro della cervice uterina (età del primo rapporto, numero di partners/ Papillomavirus-HPV-) Alterazioni preneoplasiche acquisite Iperplasia
aggregati di macromolecole dato virus contiene un solo tipo di acido nucleico (DNA o RNA)
 Virus Virus Non sono classificati fra gli organismi viventi in quanto non sono cellule, bensì aggregati di macromolecole (acidi nucleici, proteine, talvolta rivestite da membrana fosfolipidica) Non possono
Virus Virus Non sono classificati fra gli organismi viventi in quanto non sono cellule, bensì aggregati di macromolecole (acidi nucleici, proteine, talvolta rivestite da membrana fosfolipidica) Non possono
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Campo di applicazione Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Definizioni Agente Biologico (a.b.) Qualsiasi microorganismo
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Campo di applicazione Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Definizioni Agente Biologico (a.b.) Qualsiasi microorganismo
www.bayes.it - Le analisi tradizionali - statistiche area microbiologia per gruppo - ver 1.0 Pagina 1 di 6
 sierologia virus VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 3 5,66372 sierologia virus VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 4 5,61642 sierologia virus VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 5 4,10649 sierologia
sierologia virus VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 3 5,66372 sierologia virus VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 4 5,61642 sierologia virus VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 5 4,10649 sierologia
Igiene ed autoprotezione
 Igiene ed autoprotezione Alessio Riitano Istruttore PSTI Croce Rossa Italiana Recapiti: E-mail: alessio.riitano@gmail.com Web: http://www.aleritty.net Creative Commons BY-NC-SA Obiettivi: Conoscere le
Igiene ed autoprotezione Alessio Riitano Istruttore PSTI Croce Rossa Italiana Recapiti: E-mail: alessio.riitano@gmail.com Web: http://www.aleritty.net Creative Commons BY-NC-SA Obiettivi: Conoscere le
La regolazione genica nei virus
 La regolazione genica nei virus Lic. Scientifico A. Meucci Aprilia Prof. Rolando Neri I VIRUS INDICE Caratteristiche dei virus: il capside e il genoma virale Classificazione virale Fasi del ciclo riproduttivo
La regolazione genica nei virus Lic. Scientifico A. Meucci Aprilia Prof. Rolando Neri I VIRUS INDICE Caratteristiche dei virus: il capside e il genoma virale Classificazione virale Fasi del ciclo riproduttivo
La conferma di laboratorio della rosolia
 La conferma di laboratorio della rosolia La risposta anticorpale all infezione post-natale da rosolia IgG Rash IgM Prodromi INCUBAZIONE 0 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 35 42 VIREMIA ESCREZIONE
La conferma di laboratorio della rosolia La risposta anticorpale all infezione post-natale da rosolia IgG Rash IgM Prodromi INCUBAZIONE 0 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 35 42 VIREMIA ESCREZIONE
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA Programma del Corso di Microbiologia Agroalimentare AA 2014-2015
 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA Programma del Corso di Microbiologia Agroalimentare AA 2014-2015 (Prof. Paola Sinibaldi Vallebona, Dott.ssa Roberta Gaziano, Dott.ssa Elisabetta
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA Programma del Corso di Microbiologia Agroalimentare AA 2014-2015 (Prof. Paola Sinibaldi Vallebona, Dott.ssa Roberta Gaziano, Dott.ssa Elisabetta
Clostridium perfrigens
 Clostridi Bacilli G+, mobili, raramente capsulati. producono spore con diametro maggiore di quello batterico Anaerobi obbligati, non hanno citocromi e catalasi, producono ATP fermentando zuccheri o aminoacidi.
Clostridi Bacilli G+, mobili, raramente capsulati. producono spore con diametro maggiore di quello batterico Anaerobi obbligati, non hanno citocromi e catalasi, producono ATP fermentando zuccheri o aminoacidi.
I Microrganismi. Associazione di Promozione Sociale Cucinaverarte No profit Organization Area Educational. Relatore: Nicola Bruno prof.
 Associazione di Promozione Sociale Cucinaverarte No profit Organization Area Educational I Microrganismi Relatore: Nicola Bruno prof. Casadei mail: nicola.casadei@cucinaverarte.eu Per uso personale e di
Associazione di Promozione Sociale Cucinaverarte No profit Organization Area Educational I Microrganismi Relatore: Nicola Bruno prof. Casadei mail: nicola.casadei@cucinaverarte.eu Per uso personale e di
- Polimeri biodegradabili
 POSSIBILI PRODOTTI - Anticorpi - Proteine di interesse farmaceutico - Vaccini edibili - Metaboliti secondari - Polimeri biodegradabili Produzione di Anticorpi SISTEMI DI ESPRESSIONE - Cellule di mammifero
POSSIBILI PRODOTTI - Anticorpi - Proteine di interesse farmaceutico - Vaccini edibili - Metaboliti secondari - Polimeri biodegradabili Produzione di Anticorpi SISTEMI DI ESPRESSIONE - Cellule di mammifero
PATOLOGIA POLMONARE Le infezioni polmonari. www.fisiokinesiterapia.biz
 PATOLOGIA POLMONARE Le infezioni polmonari www.fisiokinesiterapia.biz Infezioni polmonari Vie di ingresso dei microorganismi: Inalazione (attraverso le alte vie respiratorie): batteri e virus Aspirazione
PATOLOGIA POLMONARE Le infezioni polmonari www.fisiokinesiterapia.biz Infezioni polmonari Vie di ingresso dei microorganismi: Inalazione (attraverso le alte vie respiratorie): batteri e virus Aspirazione
Mediatore chimico. Recettore. Trasduzione del segnale. Risposta della cellula
 Mediatore chimico Recettore Trasduzione del segnale Risposta della cellula I mediatori chimici sono prodotti da cellule specializzate e sono diffusi nell organismo da apparati di distribuzione Sistemi
Mediatore chimico Recettore Trasduzione del segnale Risposta della cellula I mediatori chimici sono prodotti da cellule specializzate e sono diffusi nell organismo da apparati di distribuzione Sistemi
ITIS ENRICO MEDI. Individuare l organizzazione strutturale, le funzioni e classificare i virus
 UDA UDA N. 1 I Virus UDA 2 Attività patogena dei microrganismi ITIS ENRICO MEDI PIANO DELLA DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo Ambientale Classe 4Ab PIANO DELLE UDA ANNO 2013-2014
UDA UDA N. 1 I Virus UDA 2 Attività patogena dei microrganismi ITIS ENRICO MEDI PIANO DELLA DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo Ambientale Classe 4Ab PIANO DELLE UDA ANNO 2013-2014
COS E UN AGENTE BIOLOGICO?
 RICHIO BIOLOGICO Rischio connesso con l esposizione a organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani presenti nell ambiente di lavoro a seguito di emissione e/o trattamento
RICHIO BIOLOGICO Rischio connesso con l esposizione a organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani presenti nell ambiente di lavoro a seguito di emissione e/o trattamento
CONTENUTI DELLA ISTRUZIONE OPERATIVA
 Pagina 1 di 6 CONTENUTI DELLA ISTRUZIONE OPERATIVA 1 TITOLO...2 2 AMBITO DI APPLICAZIONE...2 3 DECRIZIONE DELLE ATTIVITA'...2 3.1 Introduzione...2 3.2 Criteri generali di individuazione dei microrganismi
Pagina 1 di 6 CONTENUTI DELLA ISTRUZIONE OPERATIVA 1 TITOLO...2 2 AMBITO DI APPLICAZIONE...2 3 DECRIZIONE DELLE ATTIVITA'...2 3.1 Introduzione...2 3.2 Criteri generali di individuazione dei microrganismi
Domande per il ripasso e l'autovalutazione Moduli di Batteriologia Speciale e Virologia Speciale Prof. D. Di Luca
 Domande per il ripasso e l'autovalutazione Moduli di Batteriologia Speciale e Virologia Speciale Prof. D. Di Luca Gli studenti che desiderano verificare la propria preparazione prima di sostenere l'esame
Domande per il ripasso e l'autovalutazione Moduli di Batteriologia Speciale e Virologia Speciale Prof. D. Di Luca Gli studenti che desiderano verificare la propria preparazione prima di sostenere l'esame
β-lattamine Penicillina G Penicillina V Oxacillina Cloxacillina Dicloxacillina Cocchi Gram +: stafilococchi
 Nome Penicillina G Penicillina V Oxacillina Cloxacillina Dicloxacillina Ampicillina Amoxicillina Ticarcillina Piperacillina Cefazolina Cefalexina Cefaclor Cefuroxime β-lattamine Spettro Penicilline naturali,
Nome Penicillina G Penicillina V Oxacillina Cloxacillina Dicloxacillina Ampicillina Amoxicillina Ticarcillina Piperacillina Cefazolina Cefalexina Cefaclor Cefuroxime β-lattamine Spettro Penicilline naturali,
Il rischio cancerogeno e mutageno
 Il rischio cancerogeno e mutageno Le sostanze cancerogene Un cancerogeno è un agente capace di provocare l insorgenza del cancro o di aumentarne la frequenza in una popolazione esposta. Il cancro è caratterizzato
Il rischio cancerogeno e mutageno Le sostanze cancerogene Un cancerogeno è un agente capace di provocare l insorgenza del cancro o di aumentarne la frequenza in una popolazione esposta. Il cancro è caratterizzato
Raffaella Michieli Venezia
 Le malattie infettive in gravidanza: quando è indicato il Taglio Cesareo? Raffaella Michieli Venezia Trasmissione verticale delle infezioni in gravidanza Contagio intrauterino ( infezioni congenite) Contagio
Le malattie infettive in gravidanza: quando è indicato il Taglio Cesareo? Raffaella Michieli Venezia Trasmissione verticale delle infezioni in gravidanza Contagio intrauterino ( infezioni congenite) Contagio
I Papillomavirus sono tutti uguali?
 Cos è il Papillomavirus? Il Papillomavirus è un microscopico nemico della tua salute. Attento, però, a non sottovalutare la pericolosità di questo microrganismo lungo solo 55 milionesimi di millimetro.
Cos è il Papillomavirus? Il Papillomavirus è un microscopico nemico della tua salute. Attento, però, a non sottovalutare la pericolosità di questo microrganismo lungo solo 55 milionesimi di millimetro.
Il sistema immunitario: LE MALATTIE CHIARA SARACENI 3B A.S.2011-2012
 Il sistema immunitario: LE MALATTIE CHIARA SARACENI 3B A.S.2011-2012 DIFESA DELL ORGANISMO IMMUNITA INNATA IMMUNITA ACQUISITA Immunità innata IMMUNITA ACQUISITA IMMUNITA CELLULO-MEDIATA IMMUNITA UMORALE
Il sistema immunitario: LE MALATTIE CHIARA SARACENI 3B A.S.2011-2012 DIFESA DELL ORGANISMO IMMUNITA INNATA IMMUNITA ACQUISITA Immunità innata IMMUNITA ACQUISITA IMMUNITA CELLULO-MEDIATA IMMUNITA UMORALE
(Auto)analisi microbiologiche in farmacia?
 (Auto)analisi microbiologiche in farmacia? Prof. Giovanni Antonini Dipartimento di Biologia, Università Roma Tre PERCHE OCCORRE FARE ANALISI MICROBIOLOGICHE? Sta assumendo sempre maggiore importanza l
(Auto)analisi microbiologiche in farmacia? Prof. Giovanni Antonini Dipartimento di Biologia, Università Roma Tre PERCHE OCCORRE FARE ANALISI MICROBIOLOGICHE? Sta assumendo sempre maggiore importanza l
Le PROTEINE sono i biopolimeri maggiormente presenti all interno delle cellule, dal momento che costituiscono dal 40 al 70% del peso a secco.
 Le PROTEINE sono i biopolimeri maggiormente presenti all interno delle cellule, dal momento che costituiscono dal 40 al 70% del peso a secco. Svolgono funzioni biologiche di fondamentale importanza e possono
Le PROTEINE sono i biopolimeri maggiormente presenti all interno delle cellule, dal momento che costituiscono dal 40 al 70% del peso a secco. Svolgono funzioni biologiche di fondamentale importanza e possono
ACIDO FUSIDICO. Isolato da colture di Fusidium coccineum. MECCANISMO DI AZIONE: inibizione del fattore di elongazione G
 ACID FUSIDIC Isolato da colture di Fusidium coccineum MECCAISM DI AZIE: inibizione del fattore di elongazione G MECCAISM DI AZIE DELL ACID FUSIDIC Linezolid Fattori di iniziazione 30S & mra fmet-tra 30S
ACID FUSIDIC Isolato da colture di Fusidium coccineum MECCAISM DI AZIE: inibizione del fattore di elongazione G MECCAISM DI AZIE DELL ACID FUSIDIC Linezolid Fattori di iniziazione 30S & mra fmet-tra 30S
metodo Denominazione del test regionale
 Denominazione del test Indagini microbiologiche Anaerobi ricerca 90.84.3 Materiale biologico 7 Colturale Anaerobi identificazione biochimica 90.84.2 Da coltura 3 Biochimico Antibiogramma anerobi 90.84.1
Denominazione del test Indagini microbiologiche Anaerobi ricerca 90.84.3 Materiale biologico 7 Colturale Anaerobi identificazione biochimica 90.84.2 Da coltura 3 Biochimico Antibiogramma anerobi 90.84.1
Biomarkers per la diagnosi precoce di tumori
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Biomarkers per la diagnosi precoce di tumori Dott.ssa Maria Luana Poeta Cos è un Tumore Omeostasi Tissutale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Biomarkers per la diagnosi precoce di tumori Dott.ssa Maria Luana Poeta Cos è un Tumore Omeostasi Tissutale
Che cosa è la infezione da HIV?
 Che cosa è l HIV? L HIV - human immunodeficiency virus è un virus che progressivamente distrugge le difese del nostro corpo contro le infezioni e alcuni tumori Che cosa è la infezione da HIV? L infezione
Che cosa è l HIV? L HIV - human immunodeficiency virus è un virus che progressivamente distrugge le difese del nostro corpo contro le infezioni e alcuni tumori Che cosa è la infezione da HIV? L infezione
Reovirus. Stabili in svariate condizioni di ph, T e negli aerosol.
 Orthoreovirus, Rotavirus, Orbivirus, Coltivirus Caratteri generali: Privi di mantello. Due involucri capsidici. 10-12 segmenti di RNA genomico a doppio filamento. Reovirus Stabili in svariate condizioni
Orthoreovirus, Rotavirus, Orbivirus, Coltivirus Caratteri generali: Privi di mantello. Due involucri capsidici. 10-12 segmenti di RNA genomico a doppio filamento. Reovirus Stabili in svariate condizioni
Farmacocinetica dell escrezione dei farmaci nel latte. I neurotrasmettitori nella moderna diagnostica. Piperazina e suoi derivati
 Farmacocinetica dell escrezione dei farmaci nel latte I neurotrasmettitori nella moderna diagnostica Piperazina e suoi derivati dr. Angelo Marzìa FARMACOCINETICA DELL ESCREZIONE DEI FARMACI NEL LATTE
Farmacocinetica dell escrezione dei farmaci nel latte I neurotrasmettitori nella moderna diagnostica Piperazina e suoi derivati dr. Angelo Marzìa FARMACOCINETICA DELL ESCREZIONE DEI FARMACI NEL LATTE
LE PIANTE COME BIOREATTORI
 LE PIANTE COME BIOREATTORI POSSIBILI PRODOTTI - Anticorpi - Proteine di interesse farmaceutico - Vaccini edibili - Metaboliti secondari - Polimeri biodegradabili Produzione di Anticorpi SISTEMI DI ESPRESSIONE
LE PIANTE COME BIOREATTORI POSSIBILI PRODOTTI - Anticorpi - Proteine di interesse farmaceutico - Vaccini edibili - Metaboliti secondari - Polimeri biodegradabili Produzione di Anticorpi SISTEMI DI ESPRESSIONE
Cod. tariffario. Costo ad analisi C1 INIBITORE 90.60.1 6,2 ALLERGOLOGIA DAY-HOSPITAL 2 12,4
 Prestazioni Cod. tariffario Costo ad analisi Reparto Tot. Analisi Costo totale C1 INIBITORE 90.60.1 6,2 ALLERGOLOGIA DAY-HOSPITAL 2 12,4 C1 INIBITORE 90.60.1 6,2 ALLERGOLOGIA DAY-HOSPITAL 2 12,4 IMMUNOGLOBULINE
Prestazioni Cod. tariffario Costo ad analisi Reparto Tot. Analisi Costo totale C1 INIBITORE 90.60.1 6,2 ALLERGOLOGIA DAY-HOSPITAL 2 12,4 C1 INIBITORE 90.60.1 6,2 ALLERGOLOGIA DAY-HOSPITAL 2 12,4 IMMUNOGLOBULINE
MALATTIE A VEICOLO IDRICO: EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE
 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO:RISCHI MICROBIOLOGICI E MALATTIE A VEICOLO IDRICO: EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE PROF. G. Sansebastiano Dr.ssa R. Zoni Dr.ssa L. Bigliardi UNIVERSITA DI PARMA microrganismi
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO:RISCHI MICROBIOLOGICI E MALATTIE A VEICOLO IDRICO: EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE PROF. G. Sansebastiano Dr.ssa R. Zoni Dr.ssa L. Bigliardi UNIVERSITA DI PARMA microrganismi
Patogeno Ospite MA LATTIA Ambiente
 C1 Patogeno Ospite MALATTIA Ambiente pucciniquartaci.blogspot.com/.../i-batteri.html http://www.omero.it/media/76/20080630-image001.jpg Germi c2 commensali Dlso DLso Infezione patogenicità Virulenza, patogeni
C1 Patogeno Ospite MALATTIA Ambiente pucciniquartaci.blogspot.com/.../i-batteri.html http://www.omero.it/media/76/20080630-image001.jpg Germi c2 commensali Dlso DLso Infezione patogenicità Virulenza, patogeni
RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI
 RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI definizione Rischio da agenti biologici Si sviluppa in seguito all esposizione a microorganismi: BATTERI VIRUS PARASSITI .Le malattie infettive Il rapporto che l agente infettivo
RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI definizione Rischio da agenti biologici Si sviluppa in seguito all esposizione a microorganismi: BATTERI VIRUS PARASSITI .Le malattie infettive Il rapporto che l agente infettivo
CHEMIOTERAPICI ANTIVIRALI
 CHEMIOTERAPICI ANTIVIRALI Farmaci contro i virus erpetici (analoghi nucleosidici = ANTIMETABOLITI) ACICLOVIR (herpes simplex e herpes zoster) VALACICLOVIR (profarmaco dell aciclovir) PENCICLOVIR (herpes
CHEMIOTERAPICI ANTIVIRALI Farmaci contro i virus erpetici (analoghi nucleosidici = ANTIMETABOLITI) ACICLOVIR (herpes simplex e herpes zoster) VALACICLOVIR (profarmaco dell aciclovir) PENCICLOVIR (herpes
HPV. proteggiti davvero. Campagna di informazione sulle patologie da Papillomavirus umano (hpv)
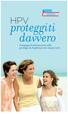 HPV proteggiti davvero Campagna di informazione sulle patologie da Papillomavirus umano (hpv) Che cos è il Papillomavirus (hpv)? L hpv è un virus molto diffuso, che si trasmette in particolare attraverso
HPV proteggiti davvero Campagna di informazione sulle patologie da Papillomavirus umano (hpv) Che cos è il Papillomavirus (hpv)? L hpv è un virus molto diffuso, che si trasmette in particolare attraverso
11 settembre 2001. Niente sarà più come prima
 11 settembre 2001 Niente sarà più come prima Alle 8,45 un Boeing 767 dell American Airlines si schianta contro la torre Nord del World Trade Center, nel cuore del quartiere finanziario di New York. Alle
11 settembre 2001 Niente sarà più come prima Alle 8,45 un Boeing 767 dell American Airlines si schianta contro la torre Nord del World Trade Center, nel cuore del quartiere finanziario di New York. Alle
 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Campo di applicazione Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Definizioni Agente Biologico (a.b.) Qualsiasi microorganismo
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Campo di applicazione Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Definizioni Agente Biologico (a.b.) Qualsiasi microorganismo
KIR EVOLUZIONE RAPIDA E DIVERSIFICATA DEI RECETTORI DELL IMMUNITA INNATA E ADATTATIVA
 KIR EVOLUZIONE RAPIDA E DIVERSIFICATA DEI RECETTORI DELL IMMUNITA INNATA E ADATTATIVA C.Vilches, P. Parham Natural Killer Cellule di origine linfoide la cui funzione è lisare le cellule infettate da virus
KIR EVOLUZIONE RAPIDA E DIVERSIFICATA DEI RECETTORI DELL IMMUNITA INNATA E ADATTATIVA C.Vilches, P. Parham Natural Killer Cellule di origine linfoide la cui funzione è lisare le cellule infettate da virus
La rosolia nella donna in gravidanza
 La rosolia nella donna in gravidanza ROSOLIA Trasmissione materno-fetale Trasmissione transplacentare Nel corso della fase viremica con o senza manifestazioni cliniche L infezione fetale dopo reinfezione
La rosolia nella donna in gravidanza ROSOLIA Trasmissione materno-fetale Trasmissione transplacentare Nel corso della fase viremica con o senza manifestazioni cliniche L infezione fetale dopo reinfezione
sanità Avvertenze Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) interruzioni volontarie di gravidanza malattie infettive
 capitolo 3 sanità Avvertenze Le informazioni statistiche contenute nel presente capitolo provengono dall Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e riguardano dati rilevati presso le strutture sanitarie
capitolo 3 sanità Avvertenze Le informazioni statistiche contenute nel presente capitolo provengono dall Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e riguardano dati rilevati presso le strutture sanitarie
www.zampadicane.it Guida alle Vaccinazioni
 VACCINAZIONI Le vaccinazioni da fare al proprio cane sono parecchie, alcune sono obbligatorie ed alcune facoltative e possono essere consigliate dal veterinario in casi specifici. Vediamo nel dettaglio
VACCINAZIONI Le vaccinazioni da fare al proprio cane sono parecchie, alcune sono obbligatorie ed alcune facoltative e possono essere consigliate dal veterinario in casi specifici. Vediamo nel dettaglio
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A. 2013-2014. 2 anno / II semestre (marzo-giugno 2014) Sedi delle Attività Didattiche
 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A. 2013-2014 2 anno / II semestre (marzo-giugno 2014) Versione 05.03.2014 Sedi delle Attività Didattiche Aula Sede Attività Didattica A1 Aula Anatomia DIMES, Anatomia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A. 2013-2014 2 anno / II semestre (marzo-giugno 2014) Versione 05.03.2014 Sedi delle Attività Didattiche Aula Sede Attività Didattica A1 Aula Anatomia DIMES, Anatomia
Metodi in vivo e in vitro per : il riconoscimento dei farmaci lo studio delle loro proprietà farmacologiche lo studio del loro meccanismo d azione
 Metodi in vivo e in vitro per : il riconoscimento dei farmaci lo studio delle loro proprietà farmacologiche lo studio del loro meccanismo d azione Metodi generali Metodi mirati Scoperta e sviluppo di nuovi
Metodi in vivo e in vitro per : il riconoscimento dei farmaci lo studio delle loro proprietà farmacologiche lo studio del loro meccanismo d azione Metodi generali Metodi mirati Scoperta e sviluppo di nuovi
Le Malattie alimentari
 Le Malattie alimentari Valerio Giaccone Dipartimento di Sanità pubblica, Patologia Comparata e Igiene veterinaria - Padova Sono quelle forme morbose che l uomo può contrarre per ingestione o manipolazione
Le Malattie alimentari Valerio Giaccone Dipartimento di Sanità pubblica, Patologia Comparata e Igiene veterinaria - Padova Sono quelle forme morbose che l uomo può contrarre per ingestione o manipolazione
Funzione della struttura di riferimento regionale per la gestione delle infezioni in gravidanza
 CORSO REGIONALE SULLA ROSOLIA CONGENITA E NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE Funzione della struttura di riferimento regionale per la gestione delle infezioni in gravidanza Dott.ssa Nadia Gussetti U.O. Malattie
CORSO REGIONALE SULLA ROSOLIA CONGENITA E NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE Funzione della struttura di riferimento regionale per la gestione delle infezioni in gravidanza Dott.ssa Nadia Gussetti U.O. Malattie
INFIAMMAZIONE. L infiammazione è strettamente connessa con i processi riparativi! l agente di malattia e pone le basi per la
 INFIAMMAZIONE Risposta protettiva che ha lo scopo di eliminare sia la causa iniziale del danno cellulare (es. microbi, tossine etc), sia i detriti cellulari e le cellule necrotiche che compaiono a seguito
INFIAMMAZIONE Risposta protettiva che ha lo scopo di eliminare sia la causa iniziale del danno cellulare (es. microbi, tossine etc), sia i detriti cellulari e le cellule necrotiche che compaiono a seguito
Vedi note. 10 Acanthamoeba, coltura. Tempi di
 Tempi di N.B. i tempi di risposta riportati si riferiscono ai tempi tecnici per l'esecuzione dell'indagine. In caso di richieste contenenti più esami, il tempo risultante è dato dall'esame più lungo 10
Tempi di N.B. i tempi di risposta riportati si riferiscono ai tempi tecnici per l'esecuzione dell'indagine. In caso di richieste contenenti più esami, il tempo risultante è dato dall'esame più lungo 10
Igiene ed autoprotezione
 Igiene ed autoprotezione Alessio Riitano Istruttore PSTI Croce Rossa Italiana Recapiti: E-mail: alessio.riitano@gmail.com Web: http://www.aleritty.net Creative Commons BY-NC-SA Riepilogo Il nostro organismo
Igiene ed autoprotezione Alessio Riitano Istruttore PSTI Croce Rossa Italiana Recapiti: E-mail: alessio.riitano@gmail.com Web: http://www.aleritty.net Creative Commons BY-NC-SA Riepilogo Il nostro organismo
EPATITI ACUTE E CRONICHE IL CONCETTO DI EPATITE
 EPATITI ACUTE E CRONICHE IL CONCETTO DI EPATITE Epatite = epatocitonecrosi + flogosi in tutto il fegato EPATITE ACUTA CRONICA da varie cause EPATITI ACUTE: EZIOLOGIA NON INFETTIVA ALCOOL TOSSICI - funghi
EPATITI ACUTE E CRONICHE IL CONCETTO DI EPATITE Epatite = epatocitonecrosi + flogosi in tutto il fegato EPATITE ACUTA CRONICA da varie cause EPATITI ACUTE: EZIOLOGIA NON INFETTIVA ALCOOL TOSSICI - funghi
Aspetti microbiologici della sorveglianza nazionale della malattia invasiva da H. Influenzae
 Roma, 26-27 Novembre 2014 Roma, 28-29 Febbraio 2012 Aspetti microbiologici della sorveglianza nazionale della malattia invasiva da H. Influenzae MARINA CERQUETTI Marina Cerquetti Dipartimento di Malattie
Roma, 26-27 Novembre 2014 Roma, 28-29 Febbraio 2012 Aspetti microbiologici della sorveglianza nazionale della malattia invasiva da H. Influenzae MARINA CERQUETTI Marina Cerquetti Dipartimento di Malattie
818.141.11 Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1
 Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 3 capoverso 3 dell ordinanza del
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 3 capoverso 3 dell ordinanza del
APPLICABILE DAL 1 GIUGNO 2015
 CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2015 Guida alla classificazione dei rifiuti Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2015 Guida alla classificazione dei rifiuti Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza
Farmacodinamica II. Mariapia Vairetti. Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Sezione di Farmacologia e Tossicologia Cellulare e Molecolare
 Farmacodinamica II Mariapia Vairetti Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Sezione di Farmacologia e Tossicologia Cellulare e Molecolare Processo di riconoscimento fra farmaco e recettore TIPI DI
Farmacodinamica II Mariapia Vairetti Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Sezione di Farmacologia e Tossicologia Cellulare e Molecolare Processo di riconoscimento fra farmaco e recettore TIPI DI
Leggere attentamente l etichetta e la Scheda di 2Sicurezza (SDS)
 Leggere attentamente l etichetta e la Scheda di 2Sicurezza (SDS) Come si legge un etichetta L etichetta di un agrofarmaco deriva dalla valutazione di numerosi studi effettuati sul prodotto inerenti aspetti
Leggere attentamente l etichetta e la Scheda di 2Sicurezza (SDS) Come si legge un etichetta L etichetta di un agrofarmaco deriva dalla valutazione di numerosi studi effettuati sul prodotto inerenti aspetti
CORSO REGIONALE SULLA ROSOLIA CONGENITA E NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE
 CORSO REGIONALE SULLA ROSOLIA CONGENITA E NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE Padova 11 giugno 2007 Conferma di Laboratorio della Rosolia e Significato del Dosaggio degli Anticorpi Anna Piazza Giorgio Palù
CORSO REGIONALE SULLA ROSOLIA CONGENITA E NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE Padova 11 giugno 2007 Conferma di Laboratorio della Rosolia e Significato del Dosaggio degli Anticorpi Anna Piazza Giorgio Palù
Modalità di trasmissione delle malattie infettive
 Università degli Studi di Perugia FACOLTÀ DI FARMACIA - CORSO DI IGIENE E SANITA PUBBLICA- Modalità di trasmissione delle malattie infettive Prof. Silvano Monarca Vie di trasmissione delle infezioni Catena
Università degli Studi di Perugia FACOLTÀ DI FARMACIA - CORSO DI IGIENE E SANITA PUBBLICA- Modalità di trasmissione delle malattie infettive Prof. Silvano Monarca Vie di trasmissione delle infezioni Catena
Allegato 04 Guida alla corretta effettuazione del prelievo e raccolta materiale biologico
 egato 04 Pag. 1 di 8 del 20/09/2012 La finalità delle indagini microbiologiche è quella di diagnosticare le infezioni ed accertare i patogeni in causa, attraverso indagini dirette e /o colturali ( identificazione
egato 04 Pag. 1 di 8 del 20/09/2012 La finalità delle indagini microbiologiche è quella di diagnosticare le infezioni ed accertare i patogeni in causa, attraverso indagini dirette e /o colturali ( identificazione
Malattie sessualmente trasmesse
 Malattie sessualmente trasmesse Che cosa sono le malattie sessualmente trasmesse? Le malattie sessualmente trasmesse (MST) sono infezioni che si possono contrarre attraverso i rapporti sessuali. Sono causate
Malattie sessualmente trasmesse Che cosa sono le malattie sessualmente trasmesse? Le malattie sessualmente trasmesse (MST) sono infezioni che si possono contrarre attraverso i rapporti sessuali. Sono causate
UNIVERSITA DI PISA. Corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Modulo 2 - Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e biologici
 UNIVERSITA DI PISA Corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro Modulo 2 - Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e biologici Rischi biologici Prof. Daniela Reali Gennaio 2009 Titolo
UNIVERSITA DI PISA Corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro Modulo 2 - Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e biologici Rischi biologici Prof. Daniela Reali Gennaio 2009 Titolo
Infezioni da HCV nella donna in gravidanza e nel bambino
 Infezioni da HCV nella donna in gravidanza e nel bambino Le infezioni da virus dell'epatite C, Trento 14 ottobre 2011 U.O. di Pediatria ospedale Valli del Noce EPATITE C HCV: GENOTIPI CLASSIFICAZIONE Simmonds
Infezioni da HCV nella donna in gravidanza e nel bambino Le infezioni da virus dell'epatite C, Trento 14 ottobre 2011 U.O. di Pediatria ospedale Valli del Noce EPATITE C HCV: GENOTIPI CLASSIFICAZIONE Simmonds
LE MALATTIE INFETTIVE
 LE MALATTIE In base alla loro eziologia (cioè alle loro cause) le malattie possono essere distinte in e NON. Le malattie infettive sono causate da microrganismi, specialmente batteri e virus. Le malattie
LE MALATTIE In base alla loro eziologia (cioè alle loro cause) le malattie possono essere distinte in e NON. Le malattie infettive sono causate da microrganismi, specialmente batteri e virus. Le malattie
Indice. PARTE I Igiene generale. Autore. Prefazione
 Indice I Autore Prefazione XI XIII PARTE I Igiene generale CAPITOLO 1 Medicina clinica, preventiva e predittiva 1 1.1 Concetto di salute 1 1.2 Determinanti della salute 3 1.2.1 Modelli concettuali 3 1.3
Indice I Autore Prefazione XI XIII PARTE I Igiene generale CAPITOLO 1 Medicina clinica, preventiva e predittiva 1 1.1 Concetto di salute 1 1.2 Determinanti della salute 3 1.2.1 Modelli concettuali 3 1.3
sintomi,decorso coinfezioni
 2007 L epatite è un infiammazione del fegato; se è causata da un virus l epatite può essere trasmessa da una persona all altra.invece l epatite non è contagiosa se ha origine da abuso di alcool o medicamenti,
2007 L epatite è un infiammazione del fegato; se è causata da un virus l epatite può essere trasmessa da una persona all altra.invece l epatite non è contagiosa se ha origine da abuso di alcool o medicamenti,
Proliferazione e morte cellulare sono eventi fisiologici
 MORTE CELLULARE Proliferazione e morte cellulare sono eventi fisiologici Omeostasi tissutale (di tessuti dinamici) Sviluppo embrionale Eliminazione di strutture corporee inutili - Fasi di scultura/rimodellamento
MORTE CELLULARE Proliferazione e morte cellulare sono eventi fisiologici Omeostasi tissutale (di tessuti dinamici) Sviluppo embrionale Eliminazione di strutture corporee inutili - Fasi di scultura/rimodellamento
Indice. Capitolo 1 Introduzione alla terapia genica... 1. Capitolo 2 Acidi nucleici con funzione terapeutica... 11
 Romane Giacca 4b 17-02-2011 11:14 Pagina XI Capitolo 1 Introduzione alla terapia genica........................... 1 Geni come farmaci...................................... 1 Terapia genica: una visione
Romane Giacca 4b 17-02-2011 11:14 Pagina XI Capitolo 1 Introduzione alla terapia genica........................... 1 Geni come farmaci...................................... 1 Terapia genica: una visione
ENERGIA: FORME UTILIZZATE DALLE CELLULE
 ENERGIA: FORME UTILIZZATE DALLE CELLULE NEI PROCESSI ANABOLICI - CHIMICA (ENERGIA METABOLICA): ATP ATP ADP + Pi + Energia che viene utilizzata per "far andare avanti" reazioni chimiche che "vorrebbero
ENERGIA: FORME UTILIZZATE DALLE CELLULE NEI PROCESSI ANABOLICI - CHIMICA (ENERGIA METABOLICA): ATP ATP ADP + Pi + Energia che viene utilizzata per "far andare avanti" reazioni chimiche che "vorrebbero
Che cos è l AIDS. Il virus H.I.V. è la causa dell immunodeficienza acquisita
 HIV e AIDS Che cos è l AIDS L A.I.D.S. o S.I.D.A. è una sindrome da immunodeficienza acquisita. E una malattia del sistema immunitario che ne limita e riduce le funzioni. Le persone colpite sono più suscettibili
HIV e AIDS Che cos è l AIDS L A.I.D.S. o S.I.D.A. è una sindrome da immunodeficienza acquisita. E una malattia del sistema immunitario che ne limita e riduce le funzioni. Le persone colpite sono più suscettibili
Infezione da HIV e AIDS in Piemonte
 Infezione da HIV e AIDS in Piemonte anno 212 a cura di Chiara Pasqualini, Vittorio Demicheli si ringraziano i medici referenti del Sistema di Sorveglianza HIV/AIDS del Piemonte: O. Bargiacchi, S. Bonora,
Infezione da HIV e AIDS in Piemonte anno 212 a cura di Chiara Pasqualini, Vittorio Demicheli si ringraziano i medici referenti del Sistema di Sorveglianza HIV/AIDS del Piemonte: O. Bargiacchi, S. Bonora,
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori
 Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori Modifica del 18 giugno 2009 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I Gli allegati 1 4 dell ordinanza del DFI del 13 gennaio
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori Modifica del 18 giugno 2009 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I Gli allegati 1 4 dell ordinanza del DFI del 13 gennaio
CELLULE EUCARIOTICHE
 CELLULE EUCARIOTICHE Le cellule eucariotiche sono di maggiori dimensioni, rispetto a quelle procariotiche (almeno 10 volte più grandi) Oltre a: membrana plasmatica, citoplasma, DNA e ribosomi (comuni a
CELLULE EUCARIOTICHE Le cellule eucariotiche sono di maggiori dimensioni, rispetto a quelle procariotiche (almeno 10 volte più grandi) Oltre a: membrana plasmatica, citoplasma, DNA e ribosomi (comuni a
Organismi Geneticamente. Vademecum sugli OGM Cosa sono e quali sono le loro caratteristiche ed effetti
 Organismi Geneticamente Modificati Estratto da FederBio 2014 Vademecum sugli OGM Cosa sono e quali sono le loro caratteristiche ed effetti In Italia è vietata la coltivazione di OGM, anche se non ne è
Organismi Geneticamente Modificati Estratto da FederBio 2014 Vademecum sugli OGM Cosa sono e quali sono le loro caratteristiche ed effetti In Italia è vietata la coltivazione di OGM, anche se non ne è
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1
 Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 818.141.11 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 3 capoverso 3
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 818.141.11 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 3 capoverso 3
In entrambe le sezioni vi sono domande a scelta multipla e domande aperte.
 Facoltà di Agraria UNIPD Precorso Biologia 2011 Verifica le tue competenze Leggi attentamente il testo e rispondi alle domande che seguono. Le domande sono divise in due sezioni: le domande di competenza
Facoltà di Agraria UNIPD Precorso Biologia 2011 Verifica le tue competenze Leggi attentamente il testo e rispondi alle domande che seguono. Le domande sono divise in due sezioni: le domande di competenza
RISCHIO BIOLOGICO. Titolo X D. Lgs. 81/08 D.M. 28/9/90. Tecnico della prevenzione dr Claudio MARESCA
 Titolo X D. Lgs. 81/08 D.M. 28/9/90. Tecnico della prevenzione dr Claudio MARESCA Definizione Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha l agente biologico di penetrare nell organismo e di provocare
Titolo X D. Lgs. 81/08 D.M. 28/9/90. Tecnico della prevenzione dr Claudio MARESCA Definizione Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha l agente biologico di penetrare nell organismo e di provocare
+'-' - :,.+.%' '2E 2. E -- 2.?? 2 ++ : 2.+.3' 0.+,.- 2 J K 2E 2+. < ' WWW.SUNHOPE.IT
 La via di penetrazione più comune per il M.T. è quella aerogena Goccioline di Pflügge Sospensione nell aria Evaporazione e riduzione a dimensioni di 1-5 μ con bacilli vivi e vitali.possibilità di essere
La via di penetrazione più comune per il M.T. è quella aerogena Goccioline di Pflügge Sospensione nell aria Evaporazione e riduzione a dimensioni di 1-5 μ con bacilli vivi e vitali.possibilità di essere
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1
 Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 del 13 gennaio 1999 (Stato 30 dicembre 2003) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 3 capoverso 3 dell ordinanza
Ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori 1 del 13 gennaio 1999 (Stato 30 dicembre 2003) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 3 capoverso 3 dell ordinanza
