Conoscere i nostri fiumi. Qualità delle acque superficiali lagarine
|
|
|
- Rossana Cenci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente Settore informazione e monitoraggi Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile Comunità della Vallagarina Conoscere i nostri fiumi Qualità delle acque superficiali lagarine Quaderno di approfondimento del percorso triennale di educazione ambientale L Adige e le acque lagarine ambiente, ecologia e fauna acquatica
2 Conoscere i nostri fiumi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E TRASPORTI Vice Presidente della Giunta e Assessore, Dott. Alberto Pacher Via Vannetti, Trento tel fax ass.lavoripubblici@provincia.tn.it AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Dirigente generale, dott. ssa Laura Boschini Piazza Vittoria, Trento tel fax appa@provincia.tn.it Settore informazione e monitoraggi Dirigente, dott.ssa Chiara Defrancesco Piazza Vittoria, Trento tel fax sim@provincia.tn.it sito: RETE TRENTINA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Coordinatore, dott.ssa Monica Tamanini Piazza Vittoria, Trento tel / fax educazioneambientale@provincia.tn.it sito: Iscrizione newsletter: Laboratorio territoriale di educazione ambientale della Vallagarina dott.ssa Monica Santini ( ), dott.ssa Michela Luise ( ), sig.ra Federica Aste LT.EdAmb.vallagarina@provincia.tn.it Coordinamento quaderno: Chiara Defrancesco Testi: Silvia Costaraoss, Valentina Dallafior, Paolo Negri Elaborazione mappe: Mario Mazzurana Disegni: Maurizio Siligardi Revisione testi: Nicola Curzel, Monica Tamanini Grafica e impaginazione: Isabella Barozzi Anno di pubblicazione: 2012 Si autorizza la riproduzione delle informazioni e dei dati pubblicati purchè sia indicata la fonte
3 1 Conoscere i nostri fiumi INDICE Presentazione La classificazione della qualità delle acque superficiali Come sta il fiume: monitoraggio chimico e biologico La nuova rete di monitoraggio dei corsi d acqua della provincia di Trento Frequenza del monitoraggio Scelta dei corpi idrici da monitorare Metodi di monitoraggio dei corsi d acqua Gli elementi di qualità biologica Macrobenthos, cos è? Diatomee, cosa sono? I pesci, cosa sono? La valutazione ecologica fai da te La qualità delle acque superficiali della Vallagarina Fiume Adige - Sacco Rovereto Fiume Adige - ex Montecatini Mori Fiume Adige - Ponte di Borghetto Torrente Arione - Cimone Torrente Arione - Aldeno Fossa Maestra Nomi Rio Cavallo Rio Molini - Villa Lagarina Torrente Leno di Terragnolo - Loc. Geroli Torrente Leno di Vallarsa (Loc.Spino) Torrente Leno - ponte delle Zigherane Torrente Cameras Torrente Ala - loc. Acque Nere Torrente Ala - foce Canale Medio Adige o Biffis Avio Glossario... 38
4 Conoscere i nostri fiumi 2
5 3 Conoscere i nostri fiumi PRESENTAZIONE Il Trentino, grazie alla sua conformazione geografica, è una regione con una certa abbondanza d acqua. Per poterne accertare la qualità è necessario effettuare delle analisi specifiche su corsi d acqua, laghi e acque sotterranee. Questo tipo di esame viene realizzato periodicamente a cura dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (APPA) e i dati raccolti vengono utilizzati per attuare azioni di tutela e risanamento delle acque e di informazione, formazione ed educazione ambientale. Tra i settori dell Agenzia protezione dell ambiente spetta soprattutto al Settore informazione e monitoraggi accertare la qualità dell ambiente mediante il controllo di una complessa rete di punti dislocati su tutto il territorio trentino e diffondere il dato ambientale attraverso puntuali interventi di informazione, formazione ed educazione ambientale. Il quaderno Conoscere i nostri fiumi rivolto alle scuole secondarie di primo grado della Vallagarina nasce a supporto del progetto triennale di educazione ambientale L Adige e le acque lagarine ambiente, ecologia e fauna acquatica promosso dalla Comunità della Vallagarina in collaborazione con l Agenzia per la protezione dell ambiente, con l intento di far conoscere le modalità di monitoraggio e la qualità dei corsi d acqua del bacino territoriale di riferimento Il percorso educativo triennale è realizzato in classe dagli educatori ambientali della Rete trentina di educazione ambientale dell APPA che attraverso strumenti adeguati (materiali didattici, Kit per il monitoraggio, uscite sul territorio per la conoscenza diretta dell ecosistema) promuovono la conoscenza delle risorse idriche locali dal punto di vista ambientale e umano favorendone la conservazione e l uso sostenibile.
6 Conoscere i nostri fiumi 4 1 LA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 1.1 Come sta il fiume: monitoraggio chimico e biologico La qualità dell acqua di un fiume dipende da molti fattori attribuibili all attività umana fra i quali gli scarichi, che derivano dal trattamento dei reflui fognari e/o industriali e il dilavamento dei terreni agricoli a causa della pioggia portano al fiume sostanze estranee. Questi fattori contribuiscono all inquinamento di un corso d acqua e vengono evidenziati dall analisi chimica, che misura il contenuto nell acqua delle varie sostanze disciolte. La qualità del corso d acqua può essere peggiorata anche da profonde modifiche della morfologia del fiume, come ad esempio canalizzazioni, argini o briglie, o dal prelievo d acqua utilizzata per attività dell uomo. Per valutare la qualità dell ecosistema fluviale non è quindi sufficiente analizzare le sue acque chimicamente, ma è necessario studiare tutte le sue varie componenti. Per questo motivo è nata una nuova disciplina scientifica, il biomonitoraggio, che si basa sull analisi degli organismi che vivono nell ambiente fluviale e risentono di tutto ciò che avviene intorno a loro. Tali organismi possono essere utilizzati come registratori dello stato di salute dell ecosistema fluviale: a seconda di come questi esseri viventi, detti bioindicatori, rispondono a stimoli e pressioni provenienti dall esterno, gli studiosi possono dare dei giudizi di qualità, effettuando una analisi della comunità degli abitanti del fiume. Tra i bioindicatori dell ecosistema fluviale sono considerati particolarmente adegua- ti i macroinvertebrati e le diatomee. Questi organismi infatti sono: facilmente campionabili presenti in tutti i corsi d acqua e sensibili all inquinamento e alle alterazioni morfologiche. A seconda di quanto è inquinato o modificato il corso d acqua si osserva un cambiamento del numero delle specie presenti, la scomparsa di quelle più sensibili e l aumento del numero degli individui appartenenti a poche specie più resistenti. Per questo, studiando la struttura delle comunità di macroinvertebrati e delle diatomee, si riesce a stabilire la qualità del corso d acqua. Anche i pesci sono bioindicatori e il loro studio può dare indicazioni in merito alla qualità delle acque superficiali e all impatto delle alterazioni morfologiche. Foto: elaborazione di Giuseppe Sansoni
7 5 Conoscere i nostri fiumi 1.2 La nuova rete di monitoraggio dei corsi d acqua della provincia di Trento La Provincia autonoma di Trento ha costruito una rete di monitoraggio basata sull analisi delle componenti ambientali chimico-fisiche e biologiche, secondo quanto previsto dalle leggi europee in materia (D.Lgs. 152/06). Lo scopo è quello di raggiungere lo stato chimico ed ecologico buono entro il 2015 per tutti i corsi d acqua nazionali. Lo stato buono significa che le sostanze chimiche derivanti dalle attività umane sono inferiori a limiti stabiliti dalla normativa e che le comunità biologiche sono molto simili a quelle presenti in un corso d acqua naturale non alterato, che viene considerato come sito di riferimento Frequenza del monitoraggio I programmi di monitoraggio durano sei anni; il primo periodo va dal 2010 al Il monitoraggio si articola su 4 tipi diversi di controllo: 1. il monitoraggio di sorveglianza, realizzato ogni sei anni su corsi d acqua in buono stato; 2. il monitoraggio operativo, effettuato ogni tre anni su corpi idrici che sono a rischio di non raggiungere l obiettivo di qualità buono a causa di pressioni diffuse come l agricoltura, pressioni puntiformi quali scarichi urbani od industriali, oppure ancora da modificazioni della morfologia, quali briglie, argini, variazioni di livello dovute ad uso idroelettrico; 3. il monitoraggio della rete nucleo, realizzato ogni tre anni su corpi idrici di riferimento (cioè interessati pochissimo dalle attività umane) e su quelli sottoposti a pressioni particolarmente significative quali ad esempio lo scarico di un depuratore, un opera di presa importante, etc.; 4. il monitoraggio di indagine, non programmabile, si effettua di volta in volta su quei corsi d acqua dove sono necessari controlli per situazioni di allarme Scelta dei corpi idrici da monitorare La nuova rete di monitoraggio è costituita da 104 punti e comprende 27 punti storici collocati sulle aste principali dei corsi d acqua del reticolo idrografico trentino, più alcune stazioni sui corsi d acqua secondari. Sul totale dei corsi d acqua monitorati in Trentino, 43 punti appartengono al monitoraggio di sorveglianza, 39 a quello operativo e 22 alla rete nucleo. Nell arco di 6 anni ( ) in tali stazioni di monitoraggio si eseguono le analisi chimiche e quelle sulle componenti biologiche (macroinvertebrati, diatomee, comunità ittica). In tabella sono elencate le stazioni della rete di monitoraggio della provincia di Trento con specificato il tipo di monitoraggio attuato, localizzate in Vallagarina, riportate anche in Figura 1. nome stazione FIUME ADIGE - Sacco ROVERETO FIUME ADIGE - ex Montecatini MORI FIUME ADIGE - ponte di Borghetto TORRENTE ARIONE - CIMONE TORRENTE ARIONE - ALDENO FOSSA MAESTRA NOMI RIO CAVALLO RIO MOLINI - VILLA LAGARINA TORRENTE LENO DI TERRAGNOLO - Loc. GEROLI TORRENTE LENO DI VALLARSA (Loc.Spino) TORRENTE LENO - ponte delle Zigherane TORRENTE CAMERAS TORRENTE ALA - Loc. Acque Nere TORRENTE ALA - foce CANALE MEDIO ADIGE O BIFFIS - AVIO tipo monitoraggio Operativo Operativo Rete Nucleo Sorveglianza Operativo Operativo Operativo Operativo Rete Nucleo Sorveglianza Rete Nucleo Operativo Rete Nucleo Sorveglianza Rete Nucleo Tabella 1. Elenco delle stazioni di monitoraggio della Vallagarina
8 Conoscere i nostri fiumi 6 Legenda!. Punti di Monitoraggio Fiumi Laghi Principale Fossa Condotta Comunità di Valle Comuni 4 R I M O N E R I O G A G G I O Monitoraggio delle acque della Vallagarina Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Torr. Arione - Cimone!. Carta redatta dal S.I.A. dell'a.p.p.a. Piazza A. Vittoria, Trento R I O V A L S O R D A Dati aggiornati al Scala Km R F I U M E S A R C A I O S A L O N E R I O S A L A G O N I!.!.!. Fossa Maestra - Nomi VILLA LAGARINA NOMI POMAROLO Rio Molini - Villa Lagarina NOGAREDO Torr. Arione - Aldeno Torr. Cavallo - Calliano VOLANO!. R I O S E CALLIANO BESENELLO R T O C C O I O D I V A L D I R R E N T E C G O L A A V A L L O RONZO-CHIENIS ISERA Fiume Adige - Sacco!. Torr. Leno - Ponte delle Zigherane!. L E N O D I T E R R A G N O L O T O R R. MORI C A M E R A Torr. Cameras - Mori ROVERETO Leno di Vallarsa - Loc. Spino!. Fiume Adige - ex Montecatini S!.!. Leno di Terragnolo - Loc. Geroli TERRAGNOLO T O R R E N T E O R C O TRAMBILENO!. L E N O D R I O S O R BRENTONICO N A I V A L L A R S A R I I O F O X AVIO Torr. Ala - Foce - Ala Canale medio Adige o Biffis!. F!. I U M E A D I G E R I O S ALA. V A L E N T O R R E N T E T A L A I N O VALLARSA L E N O D I V A L L A R S A Torr. Ala - Loc. Acque Nere!.!. Fiume Adige - Ponte di Borghetto Figura 1. Mappa delle stazioni di monitoraggio sui corsi d acqua della Vallagarina
9 7 Conoscere i nostri fiumi Metodi di monitoraggio dei corsi d acqua La normativa vigente prevede che la qualità dei corpi idrici sia classificata sulla base dello Stato Chimico e dello Stato Ecologico. Per la valutazione dello Stato Chimico è stata definita a livello di Comunità europea una lista di sostanze pericolose dette prioritarie, per le quali sono previsti dei limiti europei chiamati Standard di Qualità Ambientale. Lo Stato Chimico si classifica in Non Buono o Buono in base al superamento o meno di questi limiti. Le sostanze identificate come prioritarie, che concorrono a definire lo stato chimico, comprendono ad esempio alcuni tipi fitofarmaci, di idrocarburi o metalli pesanti, pericolosi nell ambiente perché possono accumularsi all interno degli organismi viventi. Per la valutazione dello Stato Ecologico è previsto il monitoraggio di alcune componenti biologiche e l analisi di alcuni parametri chimico-fisici: a) Parametri chimico fisici I parametri chimico-fisici misurati per descrivere lo stato ecologico sono quattro: ossigeno in percentuale di saturazione, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale. I risultati analitici numerici di questi parametri vengono elaborati attraverso un indice sintetico previsto dall attuale normativa, detto LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori). b) Altri inquinanti Per definire lo stato ecologico si valuta anche la presenza o meno di una serie sostanze definite altri inquinanti. Esse comprendono degli inquinanti specifici diversi dalle sostanze prioritarie (ad esempio altri tipi di fitofarmaci o metalli) utilizzate per determinare lo stato chimico. c) Elementi di qualità biologica Il nuovo sistema di classificazione dello stato ecologico prevede che per tutte le comunità biologiche considerate, il risultato venga espresso come scostamento dalla condizione di riferimento che si rinviene negli ambienti privi di pressioni antropiche, attraverso il rapporto tra il valore riscontrato nei siti di monitoraggio e quello dei siti di riferimento. Gli elementi di qualità biologica da considerare per il monitoraggio dei corsi d acqua alpini ai fini della classificazione per lo Stato Ecologico sono la fauna ittica, i macroinvertebrati e le diatomee. Il risultato peggiore ottenuto tra le analisi descritte determina lo stato ecologico. d) Elementi di qualità idromorfologica Qualora il corpo idrico risulti con stato ecologico elevato, è necessario confer-
10 Conoscere i nostri fiumi 8 mare questo giudizio con l analisi degli elementi di qualità idromorfologica. Per alcuni tratti fluviali infatti si valuta la presenza di elementi artificiali (quali briglie, argini, dighe, etc.) ed il loro impatto sulle condizioni della morfologia fluviale naturale. Per valutare tali differenze tra la morfologia attuale e quella naturale si utilizza l Indice di Qualità Morfologica IQM, che è costituito da una serie di domande riferite alla morfologia fluviale (es. struttura del fondo dell alveo, presenza di vegetazione sulle sponde, etc.) 1.3 Gli elementi di qualità biologica L analisi dei parametri biologici necessari per definire lo stato ecologico merita un approfondimento. biomonitoraggio, grazie ai seguenti vantaggi: abbastanza stabili e poco mobili; relativamente facili da campionare; forniscono un metodo di indagine veloce, che permette di formulare giudizi di qualità immediati; hanno cicli vitali relativamente lunghi, per cui registrano i cambiamenti ambientali che avvengono a lungo termine. La classificazione dei macroinvertebrati bentonici si basa su alcune caratteristiche del loro organismo, utilizzate per identificarli secondo la chiave semplificata riportata in Figura Macrobenthos, cos è? Il Macrobenthos o macroinvertebrati bentonici rappresentano una comunità biologica che vive sul fondo dei fiumi; tale comunità è costituita da organismi generalmente più grandi di un millimetro, appartenenti a differenti gruppi sistematici: larve di Insetti acquatici, molluschi, irudinei (sanguisughe), planarie, oligocheti (vermi) e crostacei. Questi organismi effettuano solo piccoli spostamenti per alimentarsi o compiere il proprio ciclo vitale e vivono almeno una parte della loro vita sui substrati disponibili del corso d acqua (Figura 2), adottando una varietà di accorgimenti per resistere alla corrente. I macroinvertebrati vengono utilizzati come indicatori o spie dell' inquinamento perché i differenti gruppi sistematici hanno una diversa sensibilità alle alterazioni dell ambiente (inquinamento chimico, sbalzi di temperatura o di portata). I plecotteri ad esempio vivono solo in ambienti privi di inquinamento. I macroinvertebrati bentonici sono gli organismi finora maggiormente utilizzati nel Figura 2. Gli ambienti dove si rifugiano i macroinvertebrati bentonici Figura 3. I macroinvertebrati bentonici fluviali
11 Figura 4. Chiave semplificata per la classificazione dei macroinvertebrati bentonici fluviali (fonte APPA) 9 Conoscere i nostri fiumi
12 Conoscere i nostri fiumi 10 Come si campiona il macrobenthos? Gli operatori entrano in acqua, muniti di stivaloni da pescatore e con un apposito retino catturano gli organismi che si trovano sul fondo del fiume o nascosti sotto i sassi: è necessario campionare una superficie complessiva di un metro quadrato sui diversi microhabitat presenti nell alveo (massi, ciottoli, ghiaia, etc vedi Figura 5 ). Si puliscono i sassi e si smuove il fondo per permettere agli organismi di entrare nel retino che è stato posizionato immediatamente a valle. Figura 5. Il campionamento in fiume con il retino per i macroinvertebrati Gli organismi così catturati vengono riversati in una bacinella e vengono classificati con l aiuto di apposite chiavi di determinazione; successivamente viene eseguita una stima della loro abbondanza. Una parte rappresentativa degli organismi catturati viene conservata in alcool 70 e portata in laboratorio per una conferma dell analisi svolta in campo (vedi Figura 6 e 6bis). Il campionamento deve essere effettuato tre volte nell anno di monitoraggio.
13 11 Conoscere i nostri fiumi Figura 6 e 6 bis. L identificazione dei macroinvertebrati in campo e allo stereoscopio. Come si valuta il macrobenthos? Per valutare la qualità del corso d acqua in base al macrobenthos si utilizza, secondo le indicazioni della nuova legislazione, l indice STAR_ICMi (Standardisation of River Classification Intercalibration Multimetric Index). Si tratta di un indice composto da 6 indicatori che considerano composizione e abbondanza della comunità macrobenthonica, rapporto tra organismi sensibili e organismi tolleranti, diversità, etc. fluviali, acque alcaline o acide) e colonizzano qualsiasi superficie (substrati duri quali massi o ciottoli, ma anche vegetali e fango). Costituiscono quella pellicola viscida, detta perifiton, che ricopre uniformemente l alveo bagnato dei corsi d acqua (vedi Figura 7). Questi organismi hanno una diversa sensibilità alle alterazioni dell ambiente, segnalando soprattutto la presenza di nutrienti. Anche l IBE (Indice Biotico Esteso) è un metodo che consente di valutare la qualità delle acque fluviali in base allo studio della comunità macrobentonica Diatomee, cosa sono? Sono alghe microscopiche, con dimensioni che vanno da 5 a 700 μm: possono vivere come singole unità o in colonie, in tutti gli ambienti ove vi sia un velo d acqua (acque dolci e salate, ambienti lacustri e
14 Conoscere i nostri fiumi 12 Figura 7. Pellicola di perifiton, costituita prevalentemente da diatomee Figura 8. Diatomee bentoniche fluviali, visione al microscopio (ingrandimento 1000X) Le diatomee hanno una parete cellulare silicea, detta frustulo (Figura 8), formata da due parti, le valve, simili ad una scatola col suo coperchio. Molte specie di diatomee presentano sulle valve una fessura longitudinale, il rafe, attraverso la quale possono emettere del materiale che permette loro di scivolare sui diversi substrati del fondo. Il riconoscimento delle diverse specie, si basa principalmente sulla forma delle valve, sulla presenza e posizione del rafe e sull eventuale ornamentazione: linee punteggiate, forma dell area centrale, spine etc. Nello schema di Figura 9 vengono riportate alcune semplici nozioni di sistematica delle diatomee per la loro classificazione. rafe frustulo
15 13 Conoscere i nostri fiumi Figura 9. Chiave semplificata per la classificazione delle diatomee bentoniche con alcuni esempi
16 Conoscere i nostri fiumi 14 Come si campionano le diatomee? Si raccolgono alcuni ciottoli immersi nel corso d acqua e si raschia la loro superficie con uno spazzolino (Figura 10). Il campione così raccolto viene ossidato in laboratorio: rimangono quindi solo i frustuli silicei che vengono poi identificati al microscopio (Figura 11 e 12). Il campionamento deve essere effettuato due volte nell anno di monitoraggio. Figura 10. Campionamento con lo spazzolino delle diatomee bentoniche Come si valutano le diatomee? Per valutare la qualità del corpo idrico mediante le diatomee viene utilizzato l ICMi (Intercalibration Common Metric Index). Si tratta di un indice dato dalla combinazione di due indici, uno austriaco ed uno francese, che valutano la sensibilità delle specie di diatomee agli inquinanti.
17 15 Conoscere i nostri fiumi Figura 12. Foto di una diatomea in vivo (a sinistra) e dopo il trattamento di ossidazione in laboratorio (a destra) e l identificazione al microscopio Figura 11. Preparazione in laboratorio del campione di diatomee da osservare al microscopio I pesci, cosa sono? I pesci sono organismi vertebrati a respirazione branchiale e a sangue freddo, ossia la loro temperatura varia in base a quella dell ambiente circostante. Come per gli altri organismi acquatici, la loro distribuzione lungo il corso d acqua è condizionata da fattori quali la temperatura, la quantità di ossigeno disponibile e la possibilità di trovare cibo, zone di rifugio per la deposizione delle uova. Per questo i popolamenti ittici variano in base alle condizioni ambientali e sono dunque indagati nel biomonitoraggio. Inoltre, poiché molte specie di pesci hanno una vita relativamente lunga, l analisi a livello di popolazione (es. struttura in classi di taglia o d età) e di popolamento (es. lista delle specie, rapporto tra di esse) può costituire una documentazione a lungo termine delle variazioni ambientali.
18 Conoscere i nostri fiumi 16 Come si campionano i pesci? Per effettuare il monitoraggio del popolamento ittico si utilizza le pesca elettrica, eseguita nel tratto fluviale scelto come sito di campionamento con un elettrostorditore (Figura 13). Questo metodo consente di catturare i pesci, identificarli e registrarne alcune caratteristiche (es.taglia) per poi liberarli di nuovo in fiume. Il periodo più idoneo per questo tipo di monitoraggio è la stagione estiva. Figura 13. Cattura della fauna ittica per il monitoraggio con elettrostorditore (Foto archivio FEM-IASMA). Come si valuta la comunità dei pesci? Per l elemento di qualità della fauna ittica, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente utilizza i dati forniti dal Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento, che li raccoglie per la compilazione della carta ittica avvalendosi della collaborazione della Fondazione Edmund Mach. Per valutare la qualità del corpo idrico mediante la fauna ittica si utilizza l indice ISE- CI (Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittica). Si tratta di un indice basato su cinque indicatori con diverso peso: la presenza di specie indigene, la condizione biologica delle popolazioni indigene, la presenza di ibridi, di specie aliene e di specie endemiche. Il campionamento deve essere effettuato una volta per tutti i corpi idrici nell arco di sei anni. Il metodo è ancora sperimentale e dovrà essere modificato e/o validato con i risultati dei primi anni di monitoraggio sul reticolo idrografico nazionale.
19 17 Conoscere i nostri fiumi 1.4 La valutazione ecologica fai da te Per avere uno visione ancora più ampia dell ecosistema fluviale è necessario disporre di uno strumento che possa prendere in considerazione tutte le interazioni e le funzioni che un fiume è in grado di offrire. Per questo è stato sviluppato un indice ecologico chiamato Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) che raccoglie e valuta molte informazioni sul corso d acqua, comprendendo sia la fascia riparia sia gli aspetti morfologici e biologici. Per coloro che vogliono cimentarsi nella valutazione ecologica di un fiume è stato pensata una versione light dell Indice di Funzionalità Fluviale. È sufficiente prendere in considerazione un tratto di corso d acqua che sia omogeneo (anche qualche centinaio di metri). Il materiale necessario comprende solo la scheda di valutazione, materiale per scrivere e l abbigliamento adatto (gli stivali di gomma aiutano molto...). La scheda è divisa in 7 domande (la domanda 2 è doppia per la sponda sinistra e destra): 1. Area dove scorre il fiume. Con questa domanda si valuta quale è la pressione del territorio sul corso d acqua. Bisogna osservare il territorio attraversato dal tratto che si sta considerando dando maggior peso a ciò che c è nelle vicinanze del fiume. 2. Vegetazione sulle rive (sinistra e destra). La vegetazione, in particolare quella riparia, ha grande importanza per il fiume come fonte di energia, filtro naturale e corridoio. Bisogna valutare su ognuna delle sponde se è presente vegetazione o no cercando di dare un giudizio che possa mediare sul tratto le situazioni puntuali. Non va considerata la vegetazione che cresce all esterno degli argini. 3. Fondo del fiume. Si valuta se il fondo è stabile e vario per capire come è la ritenzione e la presenza di habitat diversificati. 4. Opere dell uomo. Bisogna osservare se nel tratto vi sono opere lungo le sponde o il fondo, che impoveriscono la diversità morfologica del corso d acqua. 5. Profondità dell acqua. Un fiume con profondità diverse è molto più diversificato e crea zone di rapida e di calma utili per i pesci e per le altre comunità biologiche del corso d acqua. 6. Corso del fiume. Un corso d acqua a curve è in grado di formare zone in cui il materiale trasportato si accumula e si erode. Questo aiuta il processo di autodepurazione e offre ambienti ricchi di biodiversità. 7. Sopra i sassi. Per valutare la qualità dell acqua è possibile osservare la patina viscida che si forma sui sassi. Questa pellicola (perifiton) diventa più visibile e spessa in presenza di inquinamento nell acqua. Per calcolare il punteggio finale, come si evidenzia nelle tabelle riportate, è sufficiente sommare i punteggi dati per ogni singola domanda. Il punteggio finale può variare da 7 a 35. A questo punteggio è possibile associare un giudizio di qualità ecologica e un colore da sovrapporre su una cartina al tratto di fiume che viene valutato. In questo modo, analizzando più tratti, è possibile mappare il fiume con diversi colori a seconda della sua qualità ecologica.
20 Conoscere i nostri fiumi 18 Corso d acqua: Data: Nome rilevatore: Località - Tratto: N Titolo Punt. Risposta 1 Area dove scorre il fiume 1 Naturale 2 Terreni coltivati, prati 3 Coltivazioni, poche case 5 Paese o città 2 Vegetazione sulla riva sinistra (guardando verso 1 Vegetazione rigogliosa con alberi la foce) 2 Vegetazione mista alberi, arbusti e canneto 3 Vegetazione con arbusti e/o canneto, pochi alberi 5 Rive nude, prato, vegetazione assente 2 Vegetazione sulla riva destra (guardando verso 1 Vegetazione rigogliosa con alberi la foce) 2 Vegetazione mista alberi, arbusti e canneto 3 Vegetazione con arbusti e/o canneto, pochi alberi 5 Rive nude, prato, vegetazione assente 3 Fondo del fiume 1 Prevalenza di massi e grossi ciottoli 2 Prevalenza di ciottoli e ghiaia 3 Prevalenza di ghiaia e sabbia 5 Prevalenza di sabbia e limo. Fondo cementato 4 Opere dell uomo 1 Nessuna 2 Intervento almeno su una sponda o in alveo 3 Sponde consolidate in maniera visibile, interventi sul letto del fiume 5 Presenza evidente di interventi artificiali, canalizzazione 5 Profondità dell acqua 1 Profondità dell acqua è molto differente e varia spesso 3 La profondità dell acqua varia per ampi tratti 5 Il fiume ha la stessa profondità quasi dappertutto 6 Corso del fiume 1 Andamento molto sinuoso e a curve 2 Andamento sinuoso con qualche curva 3 Andamento prevalentemente diritto con poche curve 5 Canalizzato o scorre quasi completamente dritto 7 Pietre 1 Lisce e pulite 2 Presentano una patina scivolosa 3 Escrescenze verdi o marroni, alghe verdi 5 Abbondante e spessa patina viscida, escrescenze foglie verdi TOTALE GIUDIZIO DI QUALITÀ ECOLOGICA
21 19 Conoscere i nostri fiumi Punteggio Giudizio Colore Descrizione 7-11 ELEVATO Azzurro Tratto di fiume di elevata qualità ecologica con processi che favoriscono l autodepurazione e la presenza di una flora e fauna ben diversificate BUONA Verde Tratto di fiume con una buona qualità ecologica. La funzionalità rimane accettabile anche se si notano alcuni effetti dell azione dell uomo SUFFICIENTE Giallo Tratto di fiume con una sufficiente qualità ecologica. Il fiume però non possiede più alcuni importanti aspetti ecologici INSUFFI- CIENTE Arancione Tratto di fiume con una insufficiente qualità ecologica. L ecosistema fiume è compromesso e gli interventi dell uomo sono evidenti. > 27 SCARSO Rosso Tratto di fiume con una scarsa qualità ecologica. Settore fluviale ampiamente manomesso, i processi funzionali sono praticamente assenti.
22 Conoscere i nostri fiumi 20
23 21 Conoscere i nostri fiumi 2 La qualità delle acque superficiali della Vallagarina Le acque dei corsi d acqua della Vallagarina sono monitorate dal Settore informazione e monitoraggi dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente in 15 stazioni definite ognuna con una frequenza diversa come da tabella sottostante. N. scheda Stazione di Monitoraggio monitoraggio Scheda 1 FIUME ADIGE - Sacco ROVERETO Operativo Scheda 2 FIUME ADIGE - ex Montecatini MORI Operativo Scheda 3 FIUME ADIGE - ponte di Borghetto Rete Nucleo Scheda 4 TORRENTE ARIONE - CIMONE Sorveglianza Scheda 5 TORRENTE ARIONE - ALDENO Operativo Scheda 6 FOSSA MAESTRA NOMI Operativo Scheda 7 RIO CAVALLO Operativo Scheda 8 RIO MOLINI - VILLA LAGARINA Operativo Scheda 9 TORRENTE LENO DI TERRAGNOLO - Loc. GEROLI Rete Nucleo Scheda 10 TORRENTE LENO DI VALLARSA (Loc.Spino) Sorveglianza Scheda 11 TORRENTE LENO - ponte delle Zigherane Rete Nucleo Scheda 12 TORRENTE CAMERAS Operativo Scheda 13 TORRENTE ALA - Loc. Acque Nere Rete Nucleo Scheda 14 TORRENTE ALA - foce Sorveglianza Scheda 15 CANALE MEDIO ADIGE O BIFFIS - AVIO Rete Nucleo I risultati del controllo, parziali in quanto il monitoraggio non è ancora concluso, si possono leggere nella mappa sotto riportata. Nelle pagine successive si riportano i dati rilevati in ogni stazione con un commento conclusivo.
24 Conoscere i nostri fiumi 22 Legenda Stato ecologico R E R A Fiumi Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo N.R. Laghi Principale Fossa Condotta Comunità di Valle Comuni R Z I O S A L O N E 4 Stato ecologico delle acque della Vallagarina Provincia Autonoma di Trento Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente T O R R E N T E F I U M E A R I O N E VILLA LAGARINA POMAROLO R I O M O L I N I NOGAREDO A D Carta redatta dal S.I.A. dell'a.p.p.a. Piazza A. Vittoria, Trento I G E NOMI R I O CALLIANO VOLANO S E T O R R E N R C C O BESENELLO I O D I V A L D I T E C A V A L Dati aggiornati al Scala Km G O L A L O T A RONZO-CHIENIS ISERA L E N O D I V A L L A R S A L E N O D I T E R R A G N O L O MORI T O R R. C A M E R A S ROVERETO T O R R E N T E O R C O TERRAGNOLO L E N O D TRAMBILENO BRENTONICO R I O S O R N A I V A L L A R S A R I I O F O X VALLARSA L E N O D I V A L L A R S A R I O S. V A L E N T I N O AVIO R T O R A V E N T E I A N A M E D I O A D I G E O B I F F I S ALA T O R R E N T E A L A C A N A L E A titolo di esempio si riportano i dati rilevati in ognuna delle 15 stazioni.
25 23 Conoscere i nostri fiumi 2.1 Fiume Adige - Sacco Rovereto COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale. Le componenti biologiche presentano entrambe giudizi di qualità buona. I risultati del monitoraggio sono ancora provvisori, perché riferiti ad una sola campagna di monitoraggio sulle tre previste per il 2012.
26 Conoscere i nostri fiumi Fiume Adige - ex Montecatini Mori COMMENTI: l indice del macrobenthos porta il corpo idrico in stato sufficiente. i risultati del monitoraggio sono ancora provvisori, perché riferiti ad una sola campagna di monitoraggio sulle tre previste per il 2012.
27 25 Conoscere i nostri fiumi 2.3 Fiume Adige - Ponte di Borghetto COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale. Le componenti biologiche presentano entrambe giudizi di qualità buona. i risultati del monitoraggio sono ancora provvisori, perché riferiti ad una sola campagna di monitoraggio sulle tre previste per il La qualità biologica si è assestata sul buono, migliorando rispetto alla situazione precedente che era piuttosto altalenante.
28 Conoscere i nostri fiumi Torrente Arione - Cimone COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Va detto comunque che il giudizio si riferisce ad una sola campagna di monitoraggio sulle tre previste per il 2012, per cui il giudizio di qualità non è ancora definitivo
29 27 Conoscere i nostri fiumi 2.5 Torrente Arione - Aldeno COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Va detto comunque che il giudizio si riferisce ad una sola campagna di monitoraggio sulle tre previste per il 2012, per cui il giudizio di qualità non è ancora definitivo.
30 Conoscere i nostri fiumi Fossa Maestra Nomi COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Risulta molto alterata la morfologia del corso d acqua.
31 29 Conoscere i nostri fiumi 2.7 Rio Cavallo COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale.
32 Conoscere i nostri fiumi Rio Molini - Villa Lagarina COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Va detto comunque che il valore sufficiente si riferisce a due campagne di monitoraggio sulle tre previste per il 2012, per cui il giudizio di qualità è suscettibile di variazioni.
33 31 Conoscere i nostri fiumi 2.9 Torrente Leno di Terragnolo - Loc. Geroli COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale. Il corpo idrico è un sito di riferimento per la qualità biologica ai sensi del D.lgs. 152/06.
34 Conoscere i nostri fiumi Torrente Leno di Vallarsa (Loc.Spino) COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale.
35 33 Conoscere i nostri fiumi 2.11 Torrente Leno - ponte delle Zigherane COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Va detto comunque che il valore sufficiente si riferisce ad una campagna di monitoraggio sulle tre previste per il 2012, per cui il giudizio di qualità è suscettibile di variazioni.
36 Conoscere i nostri fiumi Torrente Cameras COMMENTI: il corpo idrico è a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il Risulta molto alterata la morfologia del corso d acqua.
37 35 Conoscere i nostri fiumi 2.13 Torrente Ala - loc. Acque Nere COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale.
38 Conoscere i nostri fiumi Torrente Ala - foce COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale.
39 37 Conoscere i nostri fiumi 2.15 Canale Medio Adige o Biffis Avio COMMENTI: il corpo idrico attualmente ha raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale. Lo stato ecologico è determinato dai soli parametri chimico fisici, in quanto il corpo idrico è artificiale e non risulta possibile effettuare il monitoraggio di macrobenthos e diatomee.
40 Conoscere i nostri fiumi 38 3 Glossario Alveo bagnato Porzione dell alveo dove è presente l acqua. Questa porzione può cambiare sensibilmente a seconda delle stagioni dell anno Analisi chimica L insieme degli esami che si conducono per identificare e quantificare una o più sostanze chimiche Azoto ammoniacale e Azoto nitrico Nelle acque naturali e in quelle di scarico l elemento azoto si trova in tre diversi stadi di ossidazione sottoforma di ione nitrato, nitrito e ammonio. Tra i vari composti dell azoto si instaura un ciclo continuo di trasformazioni Se nell acqua è presente ossigeno disciolto sufficiente, tutta l ammoniaca viene trasformata in nitrato.i nitrati, con il fosforo, contribuiscono al processo di eutrofizzazione delle acque Bioindicatore Animali o piante (o un insieme di questi) che cambiano a seconda della qualità dell ecosistema. Gli esseri viventi, chiamati per questo bioindicatori, registrano quello che succede all interno degli ecosistemi e reagiscono di conseguenza Biomonitoraggio Viene utilizzato per indicare l insieme delle metodologie che studiano lo stato di salute dell ambiente attraverso l impiego di organismi viventi chiamati biondicatori (vedi testo) Diatomee Alghe che hanno la particolarità di avere un astuccio di silice che le avvolge. Gli ambienti d acqua sono ricche di diatomee che spesso rimangono attaccate ai ciottoli dei fiumi formando una patina viscida Dilavamento dei terreni Erosione superficiale dei terreni con asportazione graduale di suolo o roccia a causa di agenti atmosferici come il vento o l acqua o semplicemente per caduta a causa della gravità. Quando piove intensamente i corsi d acqua si colorano di marrone proprio per il suolo che è stato dilavato e viene trasportato dalla corrente Fitofarmaci Prodotti che vengono utilizzati per proteggere le piante da organismi nocivi, eliminano piante o parte di esse indesiderate e conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi) Fosfoto totale L elemento fosforo è presente nelle acque naturali; l immissione di scarichi legati alle attività umane aumenta il tenore in fosforo. L aumento del tenore in fosforo può attivare nelle acque lente e stagnanti il fenomeno di eutrofizzazione Idrocarburi Sono composti chimici, che contengono soltanto atomi di carbonio e di idrogeno IBE (Indice biotico esteso) Verifica la qualità di ecosistemi in acque correnti sulla base di cambiamenti nelle comunità dei macroinvertebrati. E ampiamente usato in Italia ed è stato il primo metodo ufficiale di monitoraggio biologico dei fiumi Indice sintetico Un indice che esprime un giudizio combinando più informazioni e variabili per dare un risultato sintetico IQM indice di qualità morfologica Un indice che si usa per il monitoraggio
41 39 Conoscere i nostri fiumi dei corsi d acqua. Valuta la struttura del fiume (es. il fondo, la portata, l erosione etc.) per esprime un giudizio di qualità della morfologia ISECI (Indice dello Stato ecologico della Comunità ittica) Metodo usato in Italia per la valutare la qualità ecologico dei corsi d acqua usando come biondicatori i pesci Macrodescrittori: alcuni composti principali che caratterizzano la qualità chimica dei fiumi, ad esempio ossigeno e fosforo Macroinvertebrati bentonici Insieme di organismi più grandi di un millimetro che vivono sul fondo (bentos) dei laghi e dei fiumi. I macroinvertebrati sono composti per la maggior parte da insetti, crostacei, molluschi e vermi Metalli pesanti Il termine metallo pesante si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici che hanno una densità relativamente alta e sono tossici in basse concentrazioni. Esempi di metalli pesanti includono il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), ed il piombo (Pb). I metalli pesanti sono pericolosi perché tendono a bioaccumularsi. Bioaccumulazione significa un aumento nella concentrazione di un prodotto chimico in un organismo biologico col tempo Nutrienti Le sostanze indispensabili alla crescita delle piante. Quelle che hanno maggior importanza per laghi e fiumi sono i composti dell azoto e del fostoro Oligocheti Vermi ben segmentati. Sono un gruppo di animali di cui si conoscono oltre 3000 Il gruppo è rappresentato da organismi di acqua dolce e di terra, ma anche da diverse forme marine interstiziali. Un noto rappresentante del suolo di questa sottoclasse è il comune lombrico del suolo Ossigeno in percentuale di saturazione Quantità di ossigeno presente rispetto al valore massimo, preso uguale a cento, che si può avere nelle stesse condizioni di salinità, di temperatura e pressione atmosferica Perifiton Comunità di microrganismi come alghe, batteri e funghi che vive nell acqua su substrati duri (ciottoli, massi etc.). Questa comunità costituisce una sottile pellicola scivolosa al tatto che rappresenta il primo sistema di autodepurazione dei fiumi Planarie Organismi simili a vermi, di pochi centimetri che vivono nel fondo sabbioso o fangoso di laghi e fiumi. Il loro corpo è appiattito o allungato Plecotteri Ordine degli insetti. Vivono la vita allo stato di larva in ambienti acquatici (di solito acque pulite e ben ossigenate). La loro presenza indica condizioni ambientali prive di forti pressioni antropiche e per questo sono considerati indicatori di ecosistemi acquatici in buona salute Scarichi urbani Le acque di scarico che provengono da abitazioni. Sono scarichi civili ad esempio le acque che vengono dal lavello della cucino o oppure dal bagno (doccia, gabinetto, lavatrice) Scarichi industriali Acque di scarico che provengono da attività produttive come ad esempio una fabbrica oppure un laboratorio artigianale Specie aliene Una specie che per opera dell'uomo o
42 Conoscere i nostri fiumi 40 per un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo ambiente naturale originario. Un esempio può essere il pesce persico sole importato dagli stati uniti a fine del 900 e che adesso è diffuso ampiamente in Trentino Specie endemiche Una specie che appartiene in maniera esclusiva ad un determinato territorio STAR_ICMi (standardisation of River Classification Intercalibratio Multimetric Index) Metodo di calcolo usato in Europa per confrontare i giudizi di qualità dei corsi d acqua usata nei diversi paesi. (standardizzazione dell indice mutlimetrico di intercalibrazione per la classificazione dei fiumi) Stima dell'abbondanza Valutazione dell abbondanza della singola specie all interno della comunità animale o vegetale
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI
 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE METADATI Introduzione... 2 Area Tematica: Acqua superficiale Corsi d acqua... 3 Diatomee... 3 LIMeco... 4 Macrobenthos... 5 Macrofite... 6 tato Ecologico... 7 Area Tematica:
I fiumi. La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia
 I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
I fiumi La scienza che si occupa di studiare le acque di superficie si chiama idrologia I corsi d acqua rappresentano la fase terrestre del ciclo dell acqua I corsi d acqua sono masse d acqua che fluiscono
Piano di Tutela delle Acque aprile Primo Forum di partecipazione pubblica
 Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Daniela Gerbaz, Sara Isabel, Silvia Piovano, Valeria Roatta, Luciana Vicquéry Ruolo centrale delle comunità biologiche
Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Daniela Gerbaz, Sara Isabel, Silvia Piovano, Valeria Roatta, Luciana Vicquéry Ruolo centrale delle comunità biologiche
13 dicembre Descrizione dell attività didattica
 13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
13 dicembre 2007 Descrizione dell attività didattica 13 dicembre 2007 Modulo didattico 3 interventi per le scuole superiori (lezione frontale in aula + uscita di campo + laboratorio) 2 interventi per le
MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE. Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO)
 MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE 25 maggio 2016 Marco Bertoli Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO) I macroinvertebrati bentonici Alcune
MACROINVERTEBRATI BENTONICI E QUALITÀ DELLE ACQUE 25 maggio 2016 Marco Bertoli Isola della Cona, Riserva Naturale Regionale della Foce dell Isonzo, Staranzano (GO) I macroinvertebrati bentonici Alcune
Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE
 Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE ACQUA ED ECOSISTEMI Biomonitoraggio dei torrenti BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE Bios = vita controllo della vita Gli esseri viventi sono adattati a vivere
Centro di Educazione Ambientale L'ACQUA SOSTENIBILE ACQUA ED ECOSISTEMI Biomonitoraggio dei torrenti BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE Bios = vita controllo della vita Gli esseri viventi sono adattati a vivere
A cura di: Chiara Defrancesco e Paolo Negri
 Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente Settore tecnico per la tutela dell ambiente La qualità dei corsi d acqua e dei laghi nella Rete di Riserve del Basso Sarca Elaborazione dei dati della
Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente Settore tecnico per la tutela dell ambiente La qualità dei corsi d acqua e dei laghi nella Rete di Riserve del Basso Sarca Elaborazione dei dati della
IL FIUME: solo acqua che scorre?????
 RIFLESSIONI SULLA QUALITA AMBIENTALE DEI FIUMI MISA E NEVOLA CONTRATTO DIFIUME Senigallia 20 marzo 2017 IL FIUME: solo acqua che scorre????? Il FIUME è ACQUA in movimento.....ma la CORRENTE che alimenta
RIFLESSIONI SULLA QUALITA AMBIENTALE DEI FIUMI MISA E NEVOLA CONTRATTO DIFIUME Senigallia 20 marzo 2017 IL FIUME: solo acqua che scorre????? Il FIUME è ACQUA in movimento.....ma la CORRENTE che alimenta
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione
 Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione Catia Monauni, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante le comunità diatomiche: prime esperienze di classificazione Catia Monauni, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali
 Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
Workshop Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle zone vulnerabili Milano, 13 febbraio 2014 Revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Acque superficiali ARPA LOMBARDIA
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE. Un esempio di applicazione delle nuove metodologie di biomonitoraggio
 IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE Un esempio di applicazione delle nuove metodologie di biomonitoraggio A. CINGOLANI, F. CHARAVGIS, G.RAPI, A. SANTUCCI U.O.T.
IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE Un esempio di applicazione delle nuove metodologie di biomonitoraggio A. CINGOLANI, F. CHARAVGIS, G.RAPI, A. SANTUCCI U.O.T.
ALLEGATO AL PUNTO 50 a, b
 Tratta AV / AC Milano Verona Lotto Funzionale Brescia - Verona R ID_ VIP: 2854 Procedura di VIA Speciale (ex artt. 166,167 comma 5 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) Progetto Definitivo opere in variante
Tratta AV / AC Milano Verona Lotto Funzionale Brescia - Verona R ID_ VIP: 2854 Procedura di VIA Speciale (ex artt. 166,167 comma 5 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) Progetto Definitivo opere in variante
Università degli Studi di Torino DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI. Biodiversità ed Ecosistemi
 Università degli Studi di Torino DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI Biodiversità ed Ecosistemi Cos è un ECOSISTEMA? Insieme degli organismi viventi e dell ambiente che li circonda
Università degli Studi di Torino DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI Biodiversità ed Ecosistemi Cos è un ECOSISTEMA? Insieme degli organismi viventi e dell ambiente che li circonda
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
DEFINIZIONE DELL ALGORITMO DI CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DANIELA IERVOLINO Regione Friuli Venezia Giulia TOLMEZZO 5 maggio 2015 Linee di indirizzo Corsi d acqua/tratti
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2016
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2016 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2016 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
Monitoraggio dei corpi idrici fluviali
 Monitoraggio dei corpi idrici fluviali Decreto 14 aprile 2009, n. 56 Simone Ciadamidaro 1 e Gabriela Scanu 2 1 ENEA Centro Ricerche Saluggia 2 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Monitoraggio dei corpi idrici fluviali Decreto 14 aprile 2009, n. 56 Simone Ciadamidaro 1 e Gabriela Scanu 2 1 ENEA Centro Ricerche Saluggia 2 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del
LA VALLE STURA E IL SUO FIUME. note sparse di ecologia
 LA VALLE STURA E IL SUO FIUME note sparse di ecologia NEL NOVEMBRE 1992 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (C.I.PR.A.), NEL RAPPORTO INTITOLATO "GLI ULTIMI FIUMI NATURALI DELLE
LA VALLE STURA E IL SUO FIUME note sparse di ecologia NEL NOVEMBRE 1992 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (C.I.PR.A.), NEL RAPPORTO INTITOLATO "GLI ULTIMI FIUMI NATURALI DELLE
IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA
 servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
servizio idraulica DERIVAZIONI IDROELETTRICHE: IMPATTI INDOTTI SU UN CORSO D ACQUA Ing. Federica Lippi Malnisio,, 16 giugno 2011 Le filiere dell energia Energia idroelettrica PREMESSA L acqua rappresenta
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2017
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2017 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2017 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
CON-VIVIAMO IL FIUME. Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri. A cura di STEFANO BRIGHENTI
 Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri CON-VIVIAMO IL FIUME A cura di STEFANO BRIGHENTI Filone B- Protezione civile e cultura del rischio naturale Oggi parliamo di fiumi! Ok...ma cosa è un fiume???
10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO
 10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO Pagina 94 10.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Tavollo è incuneato fra quelli del Ventena e del Foglia. Il bacino del torrente Tavollo ha una superficie complessiva
10 IL BACINO DEL TORRENTE TAVOLLO Pagina 94 10.1 GENERALITÀ Il bacino del torrente Tavollo è incuneato fra quelli del Ventena e del Foglia. Il bacino del torrente Tavollo ha una superficie complessiva
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/2010.
 Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
Invaso Trinità (TP): prima classificazione dello stato ecologico in base al DM n. 260/. Il recente Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali,
DIRETTIVA 2000/60/CE ARPA VENETO PIANO DI MONITORAGGIO
 DIRETTIVA 2000/60/CE ARPA VENETO PIANO DI MONITORAGGIO 2010 2012 Francesca Ragusa Settore Acque - Direzione Tecnica - ARPAV UDINE, 26 aprile 2010 RETICOLO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO Vengono considerati
DIRETTIVA 2000/60/CE ARPA VENETO PIANO DI MONITORAGGIO 2010 2012 Francesca Ragusa Settore Acque - Direzione Tecnica - ARPAV UDINE, 26 aprile 2010 RETICOLO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO Vengono considerati
Contenuti del Piano di Gestione. ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.
 Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.Lgs 152/99 LIM Esprime lo stato di qualità dei corsi d acqua principalmente dal punto di vista chimico Fiume Serchio: Livello 1 Livello
Aggiornamento stato qualitativo acque superficiali: ai sensi del D.Lgs 152/99 LIM Esprime lo stato di qualità dei corsi d acqua principalmente dal punto di vista chimico Fiume Serchio: Livello 1 Livello
Indicatore Trofico Fiumi
 Indicatore Trofico Fiumi 2010-2017 Contesto di riferimento Il territorio regionale del Lazio contiene un ampia e diversificata varietà di ambienti fluviali, che spaziano dai territori degli apparati vulcanici
Indicatore Trofico Fiumi 2010-2017 Contesto di riferimento Il territorio regionale del Lazio contiene un ampia e diversificata varietà di ambienti fluviali, che spaziano dai territori degli apparati vulcanici
Monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci
 Monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci (art. 85 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.) Anno 2015 FIUME CIANE 1 Autori: Anna Maria Abita ARPA Sicilia Direttore ST 2 Monitoraggi Ambientali
Monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci (art. 85 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.) Anno 2015 FIUME CIANE 1 Autori: Anna Maria Abita ARPA Sicilia Direttore ST 2 Monitoraggi Ambientali
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica
 Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Le analisi chimiche dell acqua del fiume Padrongianus Scienze Integrate Chimica Nell ambito del Progetto relativo all esame dell ecosistema costituito dal Parco Fluviale del Padrongianus sono stati coinvolti
Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio
 Sperimentazione sugli effetti dei rilasci dagli sbarramenti Enel Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio 30.04.2009 2 Presentazione Mario Lagorio URS Italia S.p.A. Società multinazionale di consulenza
Sperimentazione sugli effetti dei rilasci dagli sbarramenti Enel Lucca, Autorità di Bacino del fiume Serchio 30.04.2009 2 Presentazione Mario Lagorio URS Italia S.p.A. Società multinazionale di consulenza
Relazioni tra qualità dell habitat e indici di qualità biologica: effetti sulla classificazione di qualità
 Relazioni tra qualità dell habitat e indici di qualità biologica: effetti sulla classificazione di qualità Giuseppe Morabito, Marzia Ciampittiello, Martina Austoni, Angela Boggero, Aldo Marchetto, Paolo
Relazioni tra qualità dell habitat e indici di qualità biologica: effetti sulla classificazione di qualità Giuseppe Morabito, Marzia Ciampittiello, Martina Austoni, Angela Boggero, Aldo Marchetto, Paolo
Piano di Tutela delle Acque
 Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
Piano di Tutela delle Acque E lo strumento di Pianificazione territoriale attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttive Europee. In quanto Piano di valenza territoriale
UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D ACQUA E STRUMENTO DI MONITORAGGIO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
 2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
2 Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale Riqualificazione fluviale e gestione del territorio 6-7 novembre 2012, Bolzano UTILIZZO DEGLI ODONATI COME INDICATORI DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI
Stato ambientale delle acque in Piemonte
 Il Piano di Gestione del fiume Po 2 ciclo di pianificazione 2015-2021 Incontro regionale di informazione pubblica Stato ambientale delle acque in Piemonte Antonietta Fiorenza ARPA Piemonte Struttura Specialistica
Il Piano di Gestione del fiume Po 2 ciclo di pianificazione 2015-2021 Incontro regionale di informazione pubblica Stato ambientale delle acque in Piemonte Antonietta Fiorenza ARPA Piemonte Struttura Specialistica
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo
 PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
PROGRAMMA CORSO ECOLOGIA APPLICATA Dott. Fabrizio Scialanca - Limnologo 1. CENNI DI ECOLOGIA I principali cicli biogeochimici Le catene trofiche 2. FATTORI ED ELEMENTI CLIMATICI Caratteristiche chimico-fisiche
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia
 Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Applicazione dell Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia Pizzul E., D Aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A., Zorza R., Mattassi
Il fiume Serchio: conoscerlo, amarlo, rispettarlo
 Il fiume Serchio: conoscerlo, amarlo, rispettarlo (Percorso guidato per piccoli lucchesi alla scoperta del Serchio) Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio COM È FATTO UN FIUME LA CONTINUITÀ FLUVIALE
Il fiume Serchio: conoscerlo, amarlo, rispettarlo (Percorso guidato per piccoli lucchesi alla scoperta del Serchio) Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio COM È FATTO UN FIUME LA CONTINUITÀ FLUVIALE
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada
 Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Materiale: Retini Pipette Vaschette Microscopi Vetrini a orologio Stivali in gomma Località del campionamento: Comune di Molare, Torrente Orba nei pressi della
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Materiale: Retini Pipette Vaschette Microscopi Vetrini a orologio Stivali in gomma Località del campionamento: Comune di Molare, Torrente Orba nei pressi della
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada
 Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Attraverso l'analisi della fauna macrobentonica delle acque si può conoscere la condizione di un corso d'acqua. La classificazione di questi organismi viene fatta
Istituto Comprensivo Sandro Pertini Ovada Attraverso l'analisi della fauna macrobentonica delle acque si può conoscere la condizione di un corso d'acqua. La classificazione di questi organismi viene fatta
INDICE DI FUNZIONALITA FLUVIALE
 ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche CONVEGNO ACQUE SUPERFICIALI: ATTIVITA DI PREVENZIONE PER L AMBIENTE, LA SALUTE E IL TEMPO LIBERO INDICE DI FUNZIONALITA FLUVIALE Relatore
ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche CONVEGNO ACQUE SUPERFICIALI: ATTIVITA DI PREVENZIONE PER L AMBIENTE, LA SALUTE E IL TEMPO LIBERO INDICE DI FUNZIONALITA FLUVIALE Relatore
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI ASPETTI ECOLOGICI E NORMATIVA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE CORRENTI: CONFRONTO TRA
Il progetto LIFE+ INHABIT e il suo contributo al Sistema MacrOper
 Il progetto LIFE+ INHABIT e il suo contributo al Sistema MacrOper Antonietta Fiorenza, Teo Ferreo, Arianna Nicola, Elio Sesia ARPA Piemonte www.life-inhabit.it con la collaborazione di Stato dell arte
Il progetto LIFE+ INHABIT e il suo contributo al Sistema MacrOper Antonietta Fiorenza, Teo Ferreo, Arianna Nicola, Elio Sesia ARPA Piemonte www.life-inhabit.it con la collaborazione di Stato dell arte
F O R M A T O E U R O P E O
 F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Qualifica Amministrazione Incarico attuale LUCCHINI DANIELA DIRIGENTE ARPAE RESPONSABILE DI UNITÀ ANALITICA
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Qualifica Amministrazione Incarico attuale LUCCHINI DANIELA DIRIGENTE ARPAE RESPONSABILE DI UNITÀ ANALITICA
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Il Piano di Tutela delle acque descrive la qualità dei corpi idrici e le misure necessarie da adottare per risanare i corpi idrici non buoni e mantenere lo stato di qualità
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Il Piano di Tutela delle acque descrive la qualità dei corpi idrici e le misure necessarie da adottare per risanare i corpi idrici non buoni e mantenere lo stato di qualità
Nome indicatore DPSIR Fonte dati Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Disponibilità dati *** R
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2014 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2014 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
Stato ecologico dei corsi d'acqua
 Acqua Le acque dolci sono distinte in prima battuta tra superficiali - ovvero quelle che formano fiumi, torrenti e laghi e che sono direttamente accessibili e visibili ai nostri occhi e sotterranee che
Acqua Le acque dolci sono distinte in prima battuta tra superficiali - ovvero quelle che formano fiumi, torrenti e laghi e che sono direttamente accessibili e visibili ai nostri occhi e sotterranee che
Fiume ADDA. Cornate d Adda. Dati biologici. Dati generali. Caratteristiche ambientali. Stato biologico. Tendenza
 Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
Fiume ADDA Cornate d Adda Periodo di campionamento: - Numero campionamenti: Numero dati : POADCN Cornate d Adda Frazione Porto d Adda m km Caratteristiche ambientali Il territorio circostante è coperto
La qualità dell acqua del torrente Correcchio
 La qualità dell acqua del torrente Correcchio Classe 2C CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) Istituto Tecnico Luigi Paolini Imola per Scuola secondaria di primo grado Sante Zennaro Indice degli argomenti
La qualità dell acqua del torrente Correcchio Classe 2C CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) Istituto Tecnico Luigi Paolini Imola per Scuola secondaria di primo grado Sante Zennaro Indice degli argomenti
Glossario e architettura del piano
 Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
Ing. Andrea Braidot dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Glossario essenziale del piano dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci
 Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Classificazione relativa allo stato di qualità ambientale e idoneità alla vita dei pesci Dott.. Ferdinando De Rosa, Presidente Ordine Regionale dei Chimici delle Marche Direttore Tecnico Scientifico ARPAM
Estratto dalla RELAZIONE ANNUALE Dipartimento di Sanità Pubblica. Dati di Attività Programmazione Ambiente
 Estratto dalla RELAZIONE ANNUALE Dipartimento di Sanità Pubblica. Dati di Attività 2015 - Programmazione 2016 Ambiente Da tempo è noto che l ambiente in cui viviamo rappresenta un importante determinante
Estratto dalla RELAZIONE ANNUALE Dipartimento di Sanità Pubblica. Dati di Attività 2015 - Programmazione 2016 Ambiente Da tempo è noto che l ambiente in cui viviamo rappresenta un importante determinante
6 METODOLOGIA qualità chimico-fisica
 6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
6 METODOLOGIA Si è ritenuto opportuno considerare e valutare in maniera non dettagliata anche l intero bacino, soprattutto tramite dati esistenti, per ottenere un quadro generale e andare, così, oltre
Nome indicatore DPSIR Fonte dati Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Disponibilità dati *** R
 ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2015 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2015 Qualità dei corpi idrici superficiali e ambiente marino costiero - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) Nome indicatore DPSIR
PROGETTAZIONE DELLE PRIME RETI DI MONITORAGGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROGETTAZIONE DELLE PRIME RETI DI MONITORAGGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA Prima rete di monitoraggio: punto di partenza per la progettazione futura Giornate di Studio PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Strategie,
PROGETTAZIONE DELLE PRIME RETI DI MONITORAGGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA Prima rete di monitoraggio: punto di partenza per la progettazione futura Giornate di Studio PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Strategie,
I RISULTATI DI INDAGINI PLURIENNALI SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN PROVINCIA DI VERONA
 I RISULTATI DI INDAGINI PLURIENNALI SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN PROVINCIA DI VERONA A cura di: Ottorino Piazzi Attilio Tacconi Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona Introduzione L acqua,
I RISULTATI DI INDAGINI PLURIENNALI SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN PROVINCIA DI VERONA A cura di: Ottorino Piazzi Attilio Tacconi Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona Introduzione L acqua,
Acqua Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE.
 Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE. In questi ultimi 30 anni la normativa italiana sulla risorsa idrica ha subito una progressiva evoluzione passando
Aspetti qualitativi della risorsa acqua: applicazione in Italia della Direttiva WFD 2000/60CE. In questi ultimi 30 anni la normativa italiana sulla risorsa idrica ha subito una progressiva evoluzione passando
ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI
 ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI Periodicamente ad APPA giungono segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di schiume o colorazioni anomale nelle
ACQUA ANOMALIE AMBIENTALI: SCHIUME E COLORAZIONI NELLE ACQUE SUPERFICIALI Periodicamente ad APPA giungono segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di schiume o colorazioni anomale nelle
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO
 LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
LINEE GUIDA PER I PIANI DI ADEGUAMENTO Valido per il CRITERIO n. 1 e 2 (da consegnare entro il 7 agosto 2006) 1. DESCRIZIONE DELLA DERIVAZIONE IN ATTO 1.1 Inquadramento geografico della derivazione in
Convegno sulla qualità delle acque del fiume Seveso
 Aula Consiliare, Cesano Maderno (MB) 2 aprile 2019 Convegno sulla qualità delle acque del fiume Seveso ARPA Lombardia: il monitoraggio delle acque del Torrente Seveso Seveso a Cesano Maderno Il monitoraggio
Aula Consiliare, Cesano Maderno (MB) 2 aprile 2019 Convegno sulla qualità delle acque del fiume Seveso ARPA Lombardia: il monitoraggio delle acque del Torrente Seveso Seveso a Cesano Maderno Il monitoraggio
Le sorgenti pietrificanti
 Con il contributo di: Idee, strumenti e ricette del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone Le sorgenti pietrificanti 25 ottobre 2008 Lezione a cura di C. Bollini e A. Leone, mod. relatrice
Con il contributo di: Idee, strumenti e ricette del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone Le sorgenti pietrificanti 25 ottobre 2008 Lezione a cura di C. Bollini e A. Leone, mod. relatrice
Valutazione della qualita delle acque dei torrenti della Comunita Montana del Sebino Bresciano mediante l utilizzo dell Indice Biotico Esteso (IBE).
 Comunità Montana del Sebino Bresciano Servizio di vigilanza ecologica volontaria Valutazione della qualita delle acque dei torrenti della Comunita Montana del Sebino Bresciano mediante l utilizzo dell
Comunità Montana del Sebino Bresciano Servizio di vigilanza ecologica volontaria Valutazione della qualita delle acque dei torrenti della Comunita Montana del Sebino Bresciano mediante l utilizzo dell
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO
 MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
MONITORAGGIO BIOLOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E COSTIERE DR. TOMMASO PAGLIANI 1. INTRODUZIONE La qualità delle acque, specie quelle superficiali correnti, rappresenta indubbiamente lo specchio
L.R. 11/2015, art. 14 B.U.R. 18/1/2017, n. 3 D.lgs. 152/2006, art DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres.
 L.R. 11/2015, art. 14 B.U.R. 18/1/2017, n. 3 D.lgs. 152/2006, art. 114 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres. Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione
L.R. 11/2015, art. 14 B.U.R. 18/1/2017, n. 3 D.lgs. 152/2006, art. 114 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres. Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione
Fiume Marecchia e torrente Ausa
 Fiume Marecchia e torrente Ausa Fiume Marecchia Lo Stato Ecologico del Corso d Acqua (SECA) è risultato nel 2003 di classe 3 per le prime due stazioni a monte (Marecchia 1 e 2) e di classe 4 nelle stazioni
Fiume Marecchia e torrente Ausa Fiume Marecchia Lo Stato Ecologico del Corso d Acqua (SECA) è risultato nel 2003 di classe 3 per le prime due stazioni a monte (Marecchia 1 e 2) e di classe 4 nelle stazioni
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
GAIALAB:INCONTRIAMO L AMBIENTE IN LABORATORIO
 LABORATORIO DI CHIMICA Analizziamo le acque del nostro fiume Il ruolo dell'acqua Sulla terra l'acqua è presente nei suoi 3 stati di aggregazione: solido, liquido, gassoso. Liquido Solido Vapore 1 E' essenziale
LABORATORIO DI CHIMICA Analizziamo le acque del nostro fiume Il ruolo dell'acqua Sulla terra l'acqua è presente nei suoi 3 stati di aggregazione: solido, liquido, gassoso. Liquido Solido Vapore 1 E' essenziale
Centrale termoelettrica. di Porto Tolle. Allegato /II
 Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
Allegato 2.1.3.1/II LA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA DEI CORSI D ACQUA DEL VENETO (abstract) ANNO 2002, 2001 E BIENNIO 2001-2002 ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. approvata dalla Regione Veneto
GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori
 GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori Dip. di Scienze dell Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT). Università degli
GLI ECOSISTEMI ACQUATICI DEL PARCO PINETA ~ Gestione e Riqualificazione delle Aree Umide ~ Laura Sartori Dip. di Scienze dell Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT). Università degli
Gli impatti antropici
 Gli impatti antropici L'uomo interviene sugli ecosistemi con tre tipi di disturbo: DISTURBO FISICO Alterazioni fisiche dell'alveo e della zona riparia: Prelievi idrici Costruzione di sbarramenti Disboscamento
Gli impatti antropici L'uomo interviene sugli ecosistemi con tre tipi di disturbo: DISTURBO FISICO Alterazioni fisiche dell'alveo e della zona riparia: Prelievi idrici Costruzione di sbarramenti Disboscamento
Ruolo del monitoraggio nella redazione dei piani di gestione
 Ruolo del monitoraggio nella redazione dei piani di gestione Scanu Gabriela Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Segreteria tecnica Ministro scanu.gabriela@minambiente.it Giornate
Ruolo del monitoraggio nella redazione dei piani di gestione Scanu Gabriela Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Segreteria tecnica Ministro scanu.gabriela@minambiente.it Giornate
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO
 CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO 2014-2016 RELAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO SETTEMBRE 2015 Premessa Le attività condotte durante il secondo anno della
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSORZIO PLEMMIRIO E ARPA SICILIA TRIENNIO 2014-2016 RELAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO SETTEMBRE 2015 Premessa Le attività condotte durante il secondo anno della
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME
 SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
SCUOLA 21 VERIFICA DI BIOLOGIA COGNOME CLASSE DATA NOME 1 Completa con i termini mancanti. a) L...si occupa delle interazioni tra individui della stessa specie, tra individui di specie diverse e tra gli
5 IL BACINO DEL FIUME USO
 5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
5 IL BACINO DEL FIUME USO Pagina 39 5.1 GENERALITÀ Il bacino idrografico del fiume Uso è costituito da una superficie, stretta e lunga, di 141 km 2 compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Savio, Rubicone
Progetto SNAC Elementi per l elaborazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
 Progetto SNAC Elementi per l elaborazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore: Ecosistemi di acque interne e di transizione: biodiversità, e funzioni e servizi dell
Progetto SNAC Elementi per l elaborazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Settore: Ecosistemi di acque interne e di transizione: biodiversità, e funzioni e servizi dell
I RISULTATI WQI 1) BOD
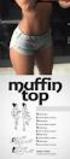 WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
WQI I RISULTATI I parametri raccolti permettono di calcolare il Il WQI; questo è un indice combinato in un singolo numero che rappresenta il livello di qualità dell acqua, eliminando le valutazioni soggettive
ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE
 ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE Carlo Lombardi FIUMI INDAGATI PO (a valle del confine provinciale PC-PV) ADDA (tratto sublacuale) OGLIO (tratto sublacuale) MINCIO (tratto
ANALISI AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DELLO STORIONE COBICE Carlo Lombardi FIUMI INDAGATI PO (a valle del confine provinciale PC-PV) ADDA (tratto sublacuale) OGLIO (tratto sublacuale) MINCIO (tratto
Annuario dei dat ambientali della Toscana. Firenze, 13 settembre 2018
 Annuario 2018 dei dat ambientali della Toscana Firenze, 13 settembre 2018 1 Lo stato dell ambiente toscano attraverso l analisi di 70 indicatori, classificati secondo i 5 elementi del modello DPSIR e suddivisi
Annuario 2018 dei dat ambientali della Toscana Firenze, 13 settembre 2018 1 Lo stato dell ambiente toscano attraverso l analisi di 70 indicatori, classificati secondo i 5 elementi del modello DPSIR e suddivisi
Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso
 Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso L.Gautero, M.Battegazzore, G.Cavallera, A.Gaggino, E.Gastaldi, L.Giordano, I.Mattone, G.Moletta, P.Molineri Progetto 2010-2012: Monitoraggio e studio
Indagini biologiche e morfologiche sul torrente Gesso L.Gautero, M.Battegazzore, G.Cavallera, A.Gaggino, E.Gastaldi, L.Giordano, I.Mattone, G.Moletta, P.Molineri Progetto 2010-2012: Monitoraggio e studio
BIOMONITORAGGIO DEL FIUME BRENTA
 BIOMONITORAGGIO DEL FIUME BRENTA Istituto Comprensivo di Teolo Classe 1^ C Docenti: Ornella Grigolin e Antonio D Errico ECCOCI TUTTI ASSIEME 1. AMPEZZI EMILY 2. BARISON GIUSTINA 3. BAZZEA LINDA 4. BOARETTO
BIOMONITORAGGIO DEL FIUME BRENTA Istituto Comprensivo di Teolo Classe 1^ C Docenti: Ornella Grigolin e Antonio D Errico ECCOCI TUTTI ASSIEME 1. AMPEZZI EMILY 2. BARISON GIUSTINA 3. BAZZEA LINDA 4. BOARETTO
OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI. Claudia Orlandi ARPA FVG
 OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI Claudia Orlandi ARPA FVG 27 GENNAIO 2011 RIPENSARE L IDROELETTRICO Energia rinnovabile o energia da rinnovare?, 8 giugno 2013 WATER FRAME
OLTRE IL DEFLUSSO MINIMO VITALE VERSO LO STATO ECOLOGICO DEI FIUMI Claudia Orlandi ARPA FVG 27 GENNAIO 2011 RIPENSARE L IDROELETTRICO Energia rinnovabile o energia da rinnovare?, 8 giugno 2013 WATER FRAME
Qualità delle acque e dei sedimenti: approccio ecosistemico e Direttiva quadro comunitaria 2000/60 sul bacino del Tevere
 Qualità delle acque e dei sedimenti: approccio ecosistemico e Direttiva quadro comunitaria 2000/60 sul bacino del Tevere 3. Approccio ecosistemico. L Indice di Funzionalità Fluviale PROGETTO PIANO STRALCIO
Qualità delle acque e dei sedimenti: approccio ecosistemico e Direttiva quadro comunitaria 2000/60 sul bacino del Tevere 3. Approccio ecosistemico. L Indice di Funzionalità Fluviale PROGETTO PIANO STRALCIO
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2012-2013
 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2012-2013 Le seguenti attività si svolgono presso il laboratorio ambientale dell area verde Palazzina del Comune di Curtarolo
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2012-2013 Le seguenti attività si svolgono presso il laboratorio ambientale dell area verde Palazzina del Comune di Curtarolo
Il metodo di calcolo del DMV proposto dall Autorità di Bacino Regionale è il seguente:
 Calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) Per la valutazione della portata istantanea derivabile dal fiume Cesano alla sezione di interesse risulta indispensabile la preliminare valutazione della portata
Calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) Per la valutazione della portata istantanea derivabile dal fiume Cesano alla sezione di interesse risulta indispensabile la preliminare valutazione della portata
Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica. Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente
 LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DERIVAZIONI IDRICHE SULLO STATO DI QUALITA DEI CORPI IDRICI Università di Trento
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DERIVAZIONI IDRICHE SULLO STATO DI QUALITA DEI CORPI IDRICI Università di Trento
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017
 SINTESI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA TA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017 Il individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, le
SINTESI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA TA DEI PESCI (art. 85 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ANNO 2017 Il individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, le
Torrente LURA. Lomazzo (CO) Dati generali. Dati biologici. Caratteri ambientali. Stato biologico. Tendenza
 Torrente LURA Lomazzo (CO) POLSOSLUCN Como Lomazzo Cascina Bissago m km Il territorio circostante è coperto da vegetazione boschiva. La vegetazione riparia è di tipo arboreo. La larghezza dell alveo bagnato
Torrente LURA Lomazzo (CO) POLSOSLUCN Como Lomazzo Cascina Bissago m km Il territorio circostante è coperto da vegetazione boschiva. La vegetazione riparia è di tipo arboreo. La larghezza dell alveo bagnato
Sedimenti fini nei fiumi alpini: risposta delle comunità bentoniche
 Giornate di Studio CISBA Napoli 12-13 Aprile 2018 Indici e Indicatori per le valutazioni di impatto negli ecosistemi fluviali Sedimenti fini nei fiumi alpini: risposta delle comunità bentoniche F.Bona,
Giornate di Studio CISBA Napoli 12-13 Aprile 2018 Indici e Indicatori per le valutazioni di impatto negli ecosistemi fluviali Sedimenti fini nei fiumi alpini: risposta delle comunità bentoniche F.Bona,
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante la comunità macrobentonica: i siti di riferimento trentini
 Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante la comunità macrobentonica: i siti di riferimento trentini Catia Monauni, Paolo Negri, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
Valutazione dello stato ecologico delle acque correnti mediante la comunità macrobentonica: i siti di riferimento trentini Catia Monauni, Paolo Negri, Raffaella Canepel, Chiara Defrancesco www.appa.provincia.tn.it
Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) E ,1 6,7
 Rio Lambin Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) E151020000 27,1 6,7 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data L
Rio Lambin Codice RASTA Area bacino (Kmq) Lunghezza totale (Km) E151020000 27,1 6,7 Tabella 1: Punteggio, livello, giudizio IFF reale e relativ o Descrizione tratto IFF reale IFF relativo Codice Data L
GLI ECOSISTEMI 114 SCIENZE
 La vita è presente in ogni luogo della Terra. Moltissime specie di viventi vivono nell acqua, nell aria e sopra il terreno (il suolo), ma anche sottoterra. Ogni organismo vivente vive insieme a moltissimi
La vita è presente in ogni luogo della Terra. Moltissime specie di viventi vivono nell acqua, nell aria e sopra il terreno (il suolo), ma anche sottoterra. Ogni organismo vivente vive insieme a moltissimi
Lo stato dell Ambiente in Liguria 75
 Nel mese di aprile 2006 entra in vigore il nuovo testo unico in materia ambientale che, nella parte inerente le acque, per alcuni aspetti, stravolge profondamente il contenuto del monitoraggio così come
Nel mese di aprile 2006 entra in vigore il nuovo testo unico in materia ambientale che, nella parte inerente le acque, per alcuni aspetti, stravolge profondamente il contenuto del monitoraggio così come
Sicurezza alimentare C O N TA MINAZIONE C H I MICA
 Sicurezza alimentare C O N TA MINAZIONE C H I MICA CONTAMINAZIONE CHIMICA Causata dalla presenza di contaminanti chimici di varia natura. 2 Contaminazione chimica Le principali contaminazioni chimiche
Sicurezza alimentare C O N TA MINAZIONE C H I MICA CONTAMINAZIONE CHIMICA Causata dalla presenza di contaminanti chimici di varia natura. 2 Contaminazione chimica Le principali contaminazioni chimiche
Stato Ecologico e Stato Chimico dei Corsi d acqua. Periodo di monitoraggio
 Stato Ecologico e Stato Chimico dei Corsi d acqua Periodo di monitoraggio 2015- Lo stato di qualità ambientale delle acque è determinato dalla valutazione di una serie di indicatori rappresentativi delle
Stato Ecologico e Stato Chimico dei Corsi d acqua Periodo di monitoraggio 2015- Lo stato di qualità ambientale delle acque è determinato dalla valutazione di una serie di indicatori rappresentativi delle
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 01_MOR
 a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 0700800801 Confine stato (Comune Ventimiglia) Punta della Rocca (Comune Ventimiglia) 7,9 * Il codice è costruito con
a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Denominazione Codice inizio fine Lunghezza (km) 0700800801 Confine stato (Comune Ventimiglia) Punta della Rocca (Comune Ventimiglia) 7,9 * Il codice è costruito con
Presentazione Compendio di ingegneria naturalistica per docenti e professionisti: analisi, casistica ed elementi di progettazione
 Paolo Cornelini AIPIN in collaborazione con Simona De Bartoli Regione Lazio Presentazione Compendio di ingegneria naturalistica per docenti e professionisti: analisi, casistica ed elementi di progettazione
Paolo Cornelini AIPIN in collaborazione con Simona De Bartoli Regione Lazio Presentazione Compendio di ingegneria naturalistica per docenti e professionisti: analisi, casistica ed elementi di progettazione
Dighe ed ecologia delle acque
 HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
HYDROS e SE Hydropower Gruppo SEL Dighe ed ecologia delle acque Bolzano, 15 maggio 2014 Vito Adami Laghi artificiali Dal punto di vista qualitativo, ecologico e funzionale, i laghi artificiali non possono
corso d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce,
 Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Corsi d acqua Un corso d acqua origina da una sorgente e termina con una foce, che può essere il mare o un titolo corso d acqua copertina più grande. Dalla sorgente alla foce sono riconoscibili tratti
Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto
 Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Architettura del piano Il modello DPSIR EEA Environmental
Pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche determinate dal comparto agricolo sui corpi idrici del Veneto dei fiumi Isonzo, Tagliamento, del fiume Adige Architettura del piano Il modello DPSIR EEA Environmental
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E MISURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IDRICHE. Raffaella Canepel Settore tecnico per la tutela dell ambiente
 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E MISURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IDRICHE Raffaella Canepel Settore tecnico per la tutela dell ambiente INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Finalità
IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E MISURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IDRICHE Raffaella Canepel Settore tecnico per la tutela dell ambiente INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Finalità
Lo stato ambientale dei corsi d'acqua della Regione Campania, con particolare riguardo a quelli del Bacino Idrografico del fiume Sarno
 Corso di laurea triennale in Ingegneria per l ambiente e il territorio (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe L-7) Lo stato ambientale dei corsi d'acqua della Regione Campania,
Corso di laurea triennale in Ingegneria per l ambiente e il territorio (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe L-7) Lo stato ambientale dei corsi d'acqua della Regione Campania,
Indice di Funzionalità Fluviale:
 Indice di Funzionalità Fluviale: la sua naturale evoluzione in aderenza agli indirizzi della Comunità Europea Gian Luigi Rossi CISBA Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale ENEA Sezione Biologia Ambientale
Indice di Funzionalità Fluviale: la sua naturale evoluzione in aderenza agli indirizzi della Comunità Europea Gian Luigi Rossi CISBA Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale ENEA Sezione Biologia Ambientale
REPORT INTERMEDIO. INDAGINE AMBIENTALE Campagna di misura della Qualità dell aria PAT/RFS305-14/01/
 PAT/RFS305-14/01/2019-0021123 AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. aria, agenti fisici e bonifiche Via Mantova, 16 38122 Trento P +39 0461
PAT/RFS305-14/01/2019-0021123 AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Settore tecnico per la tutela dell ambiente U.O. aria, agenti fisici e bonifiche Via Mantova, 16 38122 Trento P +39 0461
