ASSOCIAZIONE PORDENONESE DI ASTRONOMIA
|
|
|
- Giovanni Biondi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ASSOCIAZIONE PORDENONESE DI ASTRONOMIA
2 MONTEREALE VALCELLINA PORDENONE LO SCOPO DI QUESTO NOTIZIARIO IN QUESTO NUMERO Un nuovo rifrattore per l A.P.A.... pag. 1 I crateri sui prati del Sirente... pag. 4 Recenti immagini Deep-Sky dall osservatorio Montereale... pag. 8 Parliamo un po del nostro Sole... pag. 12 Notiziario stampato in proprio e distribuito ai Soci Comitato di redazione: Carrozzi Giampaolo Bradaschia Filippo Cauz Omar De Giusti Luigi
3 UN NUOVO RIFRATTORE PER L'A.P.A (di Bradaschia Filippo e Cauz Omar) Da un po' di tempo si discuteva, nelle riunioni del direttivo che si svolgono mensilmente tra tutti i soci, della necessità di sostituire, oppure reintubare il rifrattore Jaeger 152 F/10, affetto da una notevole aberrazione cromatica dovuta, molto probabilmente, alla mancanza di diaframmi interni. Finalmente, da Agosto, in dotazione al nostro osservatorio abbiamo un nuovo telescopio; si tratta di un rifrattore acromatico Ziel, di produzione cinese da 150mm di diametro e 1,2 m di focale, il Cosmo3, donatoci dal nostro sponsor, Centro Ottico San Marco. In una delle prime sere di cielo sereno, abbiamo effettuato un test ottico per valutare le reali prestazioni di questo strumento che per l'occasione è stato montato su una montatura SkyWatcher EQ6 anch'essa di produzione cinese. Ci siamo concentrati prima di tutto, visto la luna che incombeva, sui principali oggetti deep-sky visibili nel cielo estivo. Gli ammassi globulari M13 e M92 apparivano luminosi ed entrambi risolti fino al nucleo (M92 in minore grado) utilizzando un oculare al lantanio da 10mm a 120X; splendida è risultata sopratutto la visione del primo, viste anche le generose dimensioni angolari. E' stata quindi la volta delle nebulose planetarie M27 "Dumbell" nella Volpecula, molto contrastata a 60X sul fondo cielo, e M57 la famosa "ring nebula" della Lyra, che mostrava un bel "buco" nel mezzo, impossibile però vedere la stella centrale di 15 a mag. Negli ultimi minuti di buio concessi dal nostro satellite naturale, abbiamo rivolto lo sguardo alle costellazioni che ci terranno compagnia in autunno e inverno, ed è stato facile puntare il doppio ammasso di Perseo che, con oculare al lantanio da 20mm, si mostrava in tutta la sua bellezza, anche se non rimaneva del tutto all'interno del campo dell'oculare; per questo tipo di oggetti sarebbero infatti più indicati oculari con un angolo di campo maggiori tipo gli LVW. Abbiamo quindi puntato la Luna, oggetto sul quale ogni rifrattore può fornire elevate prestazioni. Figura 1 Hercules e Atlas L'immagine che il rifrattore mostrava era molto buona, anche se come ci si poteva aspettare, presso il terminatore e, soprattutto, sul bordo lunare in piena luce si notava l alone blu tipico di questo tipo di strumenti. Tale aspetto non dava comunque fastidio più di tanto e, cosa per noi molto importante, era inoltre più contenuto rispetto a quello mostrato dallo Jaeger sinora utilizzato. Supportati da un seeing quasi buono (peccato che la Luna fosse ancora bassa sull orizzonte più o meno 15 ), abbiamo montato la webcam per poter fare qualche immagine in alta risoluzione. I risultati ottenuti si possono vedere qui sotto. 1
4 Figura 2 Il cratere Macrobius Figura 3 I crateri Messier A e B escono dalla penombra 2
5 Figura 4 L'area degli Altopiani lunari presso il cratere Janssen Notevole vero? Il test in Hi-res si è fermato qui, vista la mancanza dei maggiori pianeti nel cielo estivo di questo In conclusione, le prime impressioni sono state molto positive, personalmente non ci aspettavamo delle prestazioni del genere da uno strumento che come ordine di prezzo è ormai (diciamo ormai perchè non molti anni fa era il punto di arrivo di molti astrofili) alla portata delle tasche di tutti. Il telescopio si candida ora come sostituto del Jaeger 152 F/10 per poter essere utilizzato come strumento di ripresa nel campo planetario e a medio campo (in accoppiata al ns. CCD si potranno avere circa 30' di lato). Per l utilizzo come l'autoguida, il sistema di decentramento del vecchio rifrattore potrebbe essere rimpiazzato da vitoni registrabili a mano al posto degli attuali a brugola. In alternativa si potrebbe utilizzare il Cosmo3 come strumento didattico durante le visite del pubblico in osservatorio. Nel prossimo direttivo verrà presa la decisione su quale destinazione dare ad entrambi gli strumenti. Un particolare ringraziamento al Centro Ottico San Marco di Pordenone per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso l Associazione perché, offrendo questo validissimo strumento, ci ha posto nelle migliori condizioni per ulteriormente potenziare le nostre attività di ricerca ed osservazione, specie nel campo del profondo cielo. Il Presidente dell A.P.A. 3
6 di Dino Abate I CRATERI SUI PRATI DEL SIRENTE Nel periodo di ferie mi trovavo in Abruzzo, e leggendo la stampa locale sono venuto a sapere di questo sito, che probabilmente rappresenta l unico luogo in territorio italiano ove sia stata accertata la presenza di crateri da impatto meteorico. Dico probabilmente perché non tutti gli studiosi sono concordi nell attribuire un origine cosmica alle conformazioni presenti sui Prati del Sirente, anche se le autorità locali (il Municipio di Secinaro) danno la cosa per scontata. In ogni caso, ho deciso comunque di intraprendere questa gita archeo-astronomica. Il cratere principale, ai piedi del Massiccio del Sirente (m 2348) I Prati del Sirente si trovano una cinquantina di chilometri a sud-est dell Aquila, nei pressi del massiccio del Sirente (2348 m), distante 13 chilometri da Secinaro. Il sito comprende un cratere principale, che si riempie stagionalmente d acqua, e funge così da abbeveratoio per il bestiame che popola l altopiano, e da altri 17 crateri minori (difficilmente individuabili). Il cratere principale è ben conservato, e risulta compatibile con un cratere da impatto su terreno soffice. Analisi al radiocarbonio hanno indicato l età di formazione della struttura, situandola verso il IV-V secolo d.c. L energia liberata durante l impatto dell oggetto con l atmosfera terrestre sarebbe stata di circa 100 ton TNT (l equivalente di una piccola bomba atomica ), provocando la devastazione della zona circostante. Questi effetti risulterebbero compatibili con alcune testimonianze storiche, tra cui quella famosa visione che ebbe Costantino, poco prima della battaglia contro Massenzio alle porte di Roma (Saxa Rubra), nei primi anni dal IV secolo d.c.. L imperatore, volgendo gli occhi verso il sole ormai al tramonto, avrebbe visto sopra il sole una croce di fuoco con l iscrizione in hoc signo vinces. I prati del Sirente si trovano a 80 km in linea d aria da Roma, proprio sulla traiettoria ovest-est di ingresso nell atmosfera terrestre di un gran masso cosmico, che si rese dapprima visibile nei cieli serali di Roma, e, dopo qualche secondo, potrebbe aver impattato il suolo di A- bruzzo, proprio nei pressi del Monte Sirente. 4
7 Al di là delle testimonianze storiche, i cui dettagli spesso sconfinano abbondantemente nel mito, soprattutto quando sono in gioco significati teologici e interpretazioni religiose, potrebbe comunque esserci una compatibilità cronologica e funzionale tra questi due episodi. Il cratere principale, ai piedi del Massiccio del Sirente (m 2348) 5
8 Il cratere principale, guardando verso Ovest (verso Roma) Il laghetto formatosi all interno del cratere 6
9 La mia impressione personale è che l impatto meteorico costituisca un illazione piuttosto fondata, anche perché, visto il contesto paesaggistico circostante, non mi sembrano plausibili altre ipotesi sulla formazione del cratere. Ma, non essendo un geologo, il mio parere è assolutamente opinabile. In ogni caso, la località è davvero incantevole: francamente non credo che, da sola, meriti un viaggio, però ne consiglio caldamente la visita se qualcuno dovesse trovarsi da quelle parti. 7
10 RECENTI IMMAGINI DEEP-SKY DALL OSSERVATORIO MONTERALE VALCELLINA A margine dei lavori di fotometria CCD sulle stelle variabili, iniziati nel mese di luglio all Osservatorio, utilizzando il CCD DTA Discovery 260 montato sul Newton Orion Optics UK da 200 mm F6, sono state effettuate alcuni frames deep-sky, al fine verificare l efficienza del sensore e, in generale, la funzionalità del sistema di ripresa. Dal momento che le immagini ottenute ci sono sembrate, tutto sommato, suggestive, abbiamo deciso di presentarvele, e di inserirle nel nostro sito web. M101 in UMA frame singolo di 120 con sottrazione di dark CCD DTA 260E - Newton 400 mm F5 settembre
11 M27 in VUL frame singolo di 60 (sopra) e 45 (sotto) con sottrazione di dark - CCD DTA 260E - Newton 200 F6 (sopra) e 400 mm F5 (sotto) luglio e settembre
12 M33 in TRI frame singolo di 40 (sopra) e 120 (sotto) con sottrazione di dark - CCD DTA 260E - Newton 200 F6 (sopra) e 400 mm F5 (sotto) luglio e settembre
13 NGC 7293 in AQR (Helix Nebula) frame singolo di 120 con sottrazione di dark - CCD DTA 260E - Newton 400 mm F5 settembre 2004 NGC 891 in AND frame singolo di 120 con sottrazione di dark - CCD DTA 260E - Newton 400 mm F5 settembre
14
15 di Dino Abate RECENTI IMMAGINI DEL SOLE Alcune immagini del Sole, riprese a luglio con un rifrattore Tele Vue 102 con prisma di Herschel, filtri B+W ND 1000X e 64X, pellicola negativa e positiva da 100ASA, filtro IR-cut Segue una sequenza variamente ingrandita del gruppo di macchie NOAA 0652, visibile a luglio anche a occhio nudo: La tecnica di ripresa è quella sopra indicata, interponendo tra prisma e pellicola una lente di Barlow 3X (alla pagina seguente) e una Powermate 5X (sotto) Il gruppo NOAA 0652 Infine, ripropongo un immagine di una protuberanza solare in luce H- febbraio del Rifrattore Stein Optics 77/910 con apparecchiatura CromixSun a tre stadi filtranti, digicam Epson con metodo afocale. 13
16 Infine, ripropongo un immagine di una protuberanza solare in luce H- del Rifrattore Stein Optics 77/910 con apparecchiatura CromixSun a tre stadi filtranti, digicam Epson con metodo afocale. 14
17
18
19
20
LUNA - Eclissi Totale
 DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione
 Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione Lo scorpione a me sembra la più ricca e bella costellazione del cielo, ma è oggettivamente molto difficile da osservare
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione Lo scorpione a me sembra la più ricca e bella costellazione del cielo, ma è oggettivamente molto difficile da osservare
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica
 Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
Astronomia Osservazione del cielo
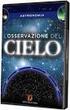 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Progetto di Astronomia all interno del piano ISS. Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12
 Istituto Comprensivo Moncalieri - Moriondo Progetto di Astronomia all interno del piano ISS Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12 Referente: Ins. Rosella Villata CLASSI COINVOLTE : TERZA
Istituto Comprensivo Moncalieri - Moriondo Progetto di Astronomia all interno del piano ISS Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12 Referente: Ins. Rosella Villata CLASSI COINVOLTE : TERZA
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013
 ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013 Di seguito trovate un analisi dei dati raccolti dal 2008 ad oggi (Dicembre 2013), in tutti questi anni ho visto crescere l attività solare e ho raccolto molta esperienza
ANALISI ATTIVITA SOLARE DAL 2008 AL 2013 Di seguito trovate un analisi dei dati raccolti dal 2008 ad oggi (Dicembre 2013), in tutti questi anni ho visto crescere l attività solare e ho raccolto molta esperienza
Corso di astronomia pratica
 Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane.
 Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
LEZIONE 6. L Universo al telescopio
 L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior. Problemi con soluzioni
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni hanno comunque un indubbio valore storico/culturale, oltre a permettere un facile orientamento nel cielo
 LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle.
 1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
Prestazioni dei telescopi
 Prestazioni dei telescopi Commento. Siamo partiti con fasci di raggi paralleli provenienti da una sorgente, per finire nuovamente con fasci di raggi paralleli che escono dall oculare. Questa condizione
Prestazioni dei telescopi Commento. Siamo partiti con fasci di raggi paralleli provenienti da una sorgente, per finire nuovamente con fasci di raggi paralleli che escono dall oculare. Questa condizione
Calendario serate d osservazione astronomica 2017
 Calendario serate d osservazione astronomica 2017 Sabato 15 aprile La costellazione della Vergine a sud-est e le stelle brillanti Spica e Porrima con numerosi ammassi e galassie. Molto interessanti M49,
Calendario serate d osservazione astronomica 2017 Sabato 15 aprile La costellazione della Vergine a sud-est e le stelle brillanti Spica e Porrima con numerosi ammassi e galassie. Molto interessanti M49,
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA TECNICHE FOTOGRAFICHE
 FOTOGRAFIA ASTRONOMICA TECNICHE FOTOGRAFICHE Le tecniche di astrofotografia si differenziano dalla fotografia tradizionale per l uso della strumentazione e dei soggetti da fotografare. La principale differenza
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA TECNICHE FOTOGRAFICHE Le tecniche di astrofotografia si differenziano dalla fotografia tradizionale per l uso della strumentazione e dei soggetti da fotografare. La principale differenza
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI
 IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
L osservazione visuale e la ripresa fotografica di Daniele Gasparri
 L osservazione visuale e la ripresa fotografica di Daniele Gasparri In questo articolo spiego quali e quante sono le differenze tra l osservazione visuale e la ripresa fotografica: due applicazioni totalmente
L osservazione visuale e la ripresa fotografica di Daniele Gasparri In questo articolo spiego quali e quante sono le differenze tra l osservazione visuale e la ripresa fotografica: due applicazioni totalmente
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania. Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Il taccuino dell esploratore
 Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
*COMUNICATO STAMPA* Almanacco astronomico del mese di giugno
 *COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
*COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
Astronomia Digitale. L' universo dal giardino di casa. Marco Paolilli Progetto CCD UAI
 Astronomia Digitale L' universo dal giardino di casa Marco Paolilli Progetto CCD UAI Che differenza c'è fra queste due immagini? Helix Nebula NGC 7293 Che differenza c'è fra queste due immagini? Helix
Astronomia Digitale L' universo dal giardino di casa Marco Paolilli Progetto CCD UAI Che differenza c'è fra queste due immagini? Helix Nebula NGC 7293 Che differenza c'è fra queste due immagini? Helix
Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo
 Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo Nel 1610 Galilei scoprì col suo cannocchiale che intorno al Pianeta Giove ruotavano quattro satelliti, scomparendo e ricomparendo continuamente.
Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo Nel 1610 Galilei scoprì col suo cannocchiale che intorno al Pianeta Giove ruotavano quattro satelliti, scomparendo e ricomparendo continuamente.
Vi propongo esempi di due serate osservative con relativa analisi dei dati ricavati.
 ESPERIENZE COL CCD Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, l'astronomia ha fatto passi da gigante (basti pensare alle immagini dell'hubble Space Telescope, ai dati raccolti dalle sonde interplanetarie,
ESPERIENZE COL CCD Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, l'astronomia ha fatto passi da gigante (basti pensare alle immagini dell'hubble Space Telescope, ai dati raccolti dalle sonde interplanetarie,
Universo invisibile: a caccia di Raggi X
 Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
La Luna e le sue fasi
 La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO. Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011.
 Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Fisica II - CdL Chimica. Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici
 Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO
 L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
Astronomia Lezione 23/1/2012
 Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Fenomeni astronomici del Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti
 Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
Oltre il Sistema Solare
 Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
Corso di astronomia pratica Oltre il Sistema Solare Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae LE STELLE Nascita di una stella Una nube di gas (soprattutto idrogeno) Inizia a collassare sotto l azione della
1 p. 1 q 1 R. altrimenti se il mezzo circostante ha un indice di rifrazione n 0. , al posto di n si deve usare
 2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Il cannocchiale di Galileo
 Alessandro Marchini Osservatorio Astronomico, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Siena Il cannocchiale di Galileo Progetto Lauree Scientifiche Stage Le conquiste della fisica moderna Riserva
Alessandro Marchini Osservatorio Astronomico, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Siena Il cannocchiale di Galileo Progetto Lauree Scientifiche Stage Le conquiste della fisica moderna Riserva
CON IL NASO ALL INSÙ
 Direzione Didattica 2 circolo Sassuolo (Mo) Scuola dell infanzia Walt Disney Sez.5 anni CON IL NASO ALL INSÙ A.s. 2010/11 Ins. Giacobbe Francesca Cassandra Marilena Premessa Il cielo fa parte dell immaginario
Direzione Didattica 2 circolo Sassuolo (Mo) Scuola dell infanzia Walt Disney Sez.5 anni CON IL NASO ALL INSÙ A.s. 2010/11 Ins. Giacobbe Francesca Cassandra Marilena Premessa Il cielo fa parte dell immaginario
ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA
 ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA Competenza in matematica: soluzioni a situazioni Competenze digitali: Saper utilizzare i linguaggi e le diverse tecniche della comunicazione
ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA Competenza in matematica: soluzioni a situazioni Competenze digitali: Saper utilizzare i linguaggi e le diverse tecniche della comunicazione
Esercizi di Fisica LB - Ottica
 Esercizi di Fisica LB - Ottica Esercitazioni di Fisica LB per ingegneri - A.A. 2003-2004 Esercizio Un sistema ottico centrato è costituito (da sinistra a destra) da una lente sottile biconcava (l indice
Esercizi di Fisica LB - Ottica Esercitazioni di Fisica LB per ingegneri - A.A. 2003-2004 Esercizio Un sistema ottico centrato è costituito (da sinistra a destra) da una lente sottile biconcava (l indice
Studio di stabilità per una curva di luce ottenuta con CCD SBIG ST10XME e software di elaborazione MaximDL. (A cura di Fabio Zara)
 Studio di stabilità per una curva di luce ottenuta con CCD SBIG ST10XME e software di elaborazione MaximDL (A cura di Fabio Zara) Introduzione La fotometria stellare in genere riguarda lo studio di una
Studio di stabilità per una curva di luce ottenuta con CCD SBIG ST10XME e software di elaborazione MaximDL (A cura di Fabio Zara) Introduzione La fotometria stellare in genere riguarda lo studio di una
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017. Scuola di Astronomia. Contenuti dei corsi e dei seminari.
 Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti
 ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
relat ore Iras GAD Iras/
 data ora argomento 1/8/2013 ago-13 Le stelle del Palio (astronomia in citta', in Molo Italia / Passeggiata 21,00 Morin - osservazione pubblica del cielo con i telescopi dell') relat ore org luogo Molo
data ora argomento 1/8/2013 ago-13 Le stelle del Palio (astronomia in citta', in Molo Italia / Passeggiata 21,00 Morin - osservazione pubblica del cielo con i telescopi dell') relat ore org luogo Molo
Per andare avanti, fai click!! Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna?
 Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna? La Luna non è una stella, perché le stelle sono grandissime sfere di gas che brillano di luce propria. Come il nostro Sole La Luna non
Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna? La Luna non è una stella, perché le stelle sono grandissime sfere di gas che brillano di luce propria. Come il nostro Sole La Luna non
AUTUNNO. Programma di osservazione
 AUTUNNO Programma di osservazione 1 Il programma osservativo dell Autunno Tipo Nome Cost A.R. Dec Mag Sep Diam ** Gamma Ari 01h 54m +19 20 3.9-3.9 7.7 ** Gamma And 02h 04m +42 22 2.1-4.8 9.8 ** Zeta Psc
AUTUNNO Programma di osservazione 1 Il programma osservativo dell Autunno Tipo Nome Cost A.R. Dec Mag Sep Diam ** Gamma Ari 01h 54m +19 20 3.9-3.9 7.7 ** Gamma And 02h 04m +42 22 2.1-4.8 9.8 ** Zeta Psc
Osservazioni al telescopio: esperienze, calcoli, dimostrazioni.
 Osservazioni al telescopio: esperienze, calcoli, dimostrazioni. Candidato: Francesco Pivetta Classe: V As Anno Scolastico: 2000-2001 Indice 1 Introduzione 2 2 Il diametro angolare del Sole 3 2.1 Scopo
Osservazioni al telescopio: esperienze, calcoli, dimostrazioni. Candidato: Francesco Pivetta Classe: V As Anno Scolastico: 2000-2001 Indice 1 Introduzione 2 2 Il diametro angolare del Sole 3 2.1 Scopo
telescopi brs JUNIOR Refractor Telescope 70/900 EL brs JUNIOR 60/700 AZ1 Refractor Telescope
 catalogo 2016 1 telescopi 8845001.brs JUNIOR Refractor Telescope 70/900 EL immagini ricche di dettagli della luna E DEI pianeti Puo essere utilizzato anche per l osservazione della natura Lunghezza del
catalogo 2016 1 telescopi 8845001.brs JUNIOR Refractor Telescope 70/900 EL immagini ricche di dettagli della luna E DEI pianeti Puo essere utilizzato anche per l osservazione della natura Lunghezza del
LARGE BINOCULAR TELESCOPE
 LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT: LARGE BINOCULAR TELESCOPE LBT, con i due specchi da 8.4 metri di diametro su un unica montatura meccanica, è il più grande telescopio esistente. La sua configurazione binoculare
La fotografia del Cielo. Strumentazione e tecniche per catturare emozioni
 La fotografia del Cielo Strumentazione e tecniche per catturare emozioni Gli strumenti di ripresa digitali webcam CCD Alcuni concetti base Il cielo notturno e gli oggetti che lo popolano hanno solitamente
La fotografia del Cielo Strumentazione e tecniche per catturare emozioni Gli strumenti di ripresa digitali webcam CCD Alcuni concetti base Il cielo notturno e gli oggetti che lo popolano hanno solitamente
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015
 FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
4 CORSO DI ASTRONOMIA
 4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
Bande elettromagnetiche, brillanza superficiale, intensità specifica
 Corso di introduzione all'astrofisica secondo modulo Programma svolto A.A. 2010-2011 Astronomia ad occhio nudo Il funzionamento dell'occhio umano Il meccanismo della visione Sensibilità spettrale 1. Potere
Corso di introduzione all'astrofisica secondo modulo Programma svolto A.A. 2010-2011 Astronomia ad occhio nudo Il funzionamento dell'occhio umano Il meccanismo della visione Sensibilità spettrale 1. Potere
1 S/f. M = A t = A + CT = 1 S f
 Ot Una lente sottile con focale f 50 mm è utilizzata per proiettare su di uno schermo l immagine di un oggetto posto a 5 m. SI determini la posizione T dello schermo e l ingrandimento che si ottiene La
Ot Una lente sottile con focale f 50 mm è utilizzata per proiettare su di uno schermo l immagine di un oggetto posto a 5 m. SI determini la posizione T dello schermo e l ingrandimento che si ottiene La
L UNIONE ASTROFILI ITALIANI. la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano
 L UNIONE ASTROFILI ITALIANI la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano La Sede UAI è presso l Osservatorio Astronomico Fuligni a Rocca di Papa. Il fenomeno dell Astrofilia in Italia Si
L UNIONE ASTROFILI ITALIANI la passione abita qui! Uno spazio per l astrofilo italiano La Sede UAI è presso l Osservatorio Astronomico Fuligni a Rocca di Papa. Il fenomeno dell Astrofilia in Italia Si
SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$
![SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$ SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$](/thumbs/54/35044472.jpg) &$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
&$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016
 FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016 Il 1 luglio, intorno alle 02:00 T.U., in direzione dell orizzonte Est troviamo la Luna (mag. -10.75, fase 15%, calante) in Taurus, prossima all ammasso aperto delle Pleiadi
FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016 Il 1 luglio, intorno alle 02:00 T.U., in direzione dell orizzonte Est troviamo la Luna (mag. -10.75, fase 15%, calante) in Taurus, prossima all ammasso aperto delle Pleiadi
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo con la collaborazione di Salvo Massaro Perché un laboratorio di ottica
Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo con la collaborazione di Salvo Massaro Perché un laboratorio di ottica
Il Sole: struttura e produzione di energia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
RELAZIONE SU AVVISTAMENTO DI OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO (*) ( O.V.N.I.)
 Stato Maggiore Aeronautica Militare: Modulo di segnalazione O.V.N.I.. RELAZIONE SU AVVISTAMENTO DI OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO (*) ( O.V.N.I.) ISTRUZIONI: Il modulo seguente deve essere utilizzato
Stato Maggiore Aeronautica Militare: Modulo di segnalazione O.V.N.I.. RELAZIONE SU AVVISTAMENTO DI OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO (*) ( O.V.N.I.) ISTRUZIONI: Il modulo seguente deve essere utilizzato
Collimazione dei telescopi Newtoniani e Schmidt-Cassegrain
 Collimazione dei telescopi Newtoniani e Schmidt-Cassegrain La collimazione delle ottiche di un telescopio è una operazione fondamentale, che a seconda dello strumento utilizzato e delle nostre esigenze
Collimazione dei telescopi Newtoniani e Schmidt-Cassegrain La collimazione delle ottiche di un telescopio è una operazione fondamentale, che a seconda dello strumento utilizzato e delle nostre esigenze
Test MTF. SP AF 60mm f/2 Macro. SP AF 10-24mm f/
 Test MTF Due Tamron per il formato APS-C La progettazione ottica ha le sue regole e questi due Tamron non fanno eccezione: il mm f/ Macro è progettato per fornire buoni risultati, mentre al -mm f/.-. si
Test MTF Due Tamron per il formato APS-C La progettazione ottica ha le sue regole e questi due Tamron non fanno eccezione: il mm f/ Macro è progettato per fornire buoni risultati, mentre al -mm f/.-. si
Tecnosky tripletto APO 115/800 Prove ed impressioni
 Tecnosky tripletto APO 115/800 Prove ed impressioni Ho recentemente provato ed in seguito acquistato, visti i risultati molto positivi, il nuovo rifrattore della Tecnosky tripletto Apocromatico con obiettivo
Tecnosky tripletto APO 115/800 Prove ed impressioni Ho recentemente provato ed in seguito acquistato, visti i risultati molto positivi, il nuovo rifrattore della Tecnosky tripletto Apocromatico con obiettivo
LE LENTI GRAVITAZIONALI. Luca Ciotti
 LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
 SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra
 Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI. Cap.5 STRUMENTI OTTICI
 DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI Cap.5 STRUMENTI OTTICI Ing. Fabrizio Liberati Cap. 5 STRUMENTI OTTICI Gli strumenti ottici utilizzati direttamente dall occhio umano,
DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI Cap.5 STRUMENTI OTTICI Ing. Fabrizio Liberati Cap. 5 STRUMENTI OTTICI Gli strumenti ottici utilizzati direttamente dall occhio umano,
IL PIANETA INESPLORATO
 PLUTONE Ma Plutone è realmente un pianeta? Ecco quello che gli astronomi hanno discusso negli anni passati, quando alcuni membri dell Unione Astronomica Internazionale hanno dimostrato che Plutone ha una
PLUTONE Ma Plutone è realmente un pianeta? Ecco quello che gli astronomi hanno discusso negli anni passati, quando alcuni membri dell Unione Astronomica Internazionale hanno dimostrato che Plutone ha una
I buchi ne!: piccoli. e gran" cannibali
 I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
Circolare n. 8 Gennaio 2015
 Circolare n. 8 Gennaio 2015 a cura di: Aldo Tonon 1. Le foto della Sezione di Ricerca Luna UAI... pag. 2 2. Librazioni lunari... pag. 10 3. Transient Lunar Phenomena... pag. 14 4. Lo sapevi che...... pag.
Circolare n. 8 Gennaio 2015 a cura di: Aldo Tonon 1. Le foto della Sezione di Ricerca Luna UAI... pag. 2 2. Librazioni lunari... pag. 10 3. Transient Lunar Phenomena... pag. 14 4. Lo sapevi che...... pag.
Telescopi astronomici
 Telescopi astronomici 2017 Il piacere della scoperta Immaginate l emozione e la sorpresa del primo uomo che, secoli fa, osservando il cielo con un telescopio rudimentale, scoprì un oggetto lontano, invisibile
Telescopi astronomici 2017 Il piacere della scoperta Immaginate l emozione e la sorpresa del primo uomo che, secoli fa, osservando il cielo con un telescopio rudimentale, scoprì un oggetto lontano, invisibile
Misure su pianeti extrasolari e blazars all'oarpaf. Chiara Righi Università degli studi di Genova 24 Settembre 2015
 Misure su pianeti extrasolari e blazars all'oarpaf. Chiara Righi Università degli studi di Genova 24 Settembre 2015 1 Dove si trova l osservatorio? L osservatorio Astronomico Regionale del Parco Antola,
Misure su pianeti extrasolari e blazars all'oarpaf. Chiara Righi Università degli studi di Genova 24 Settembre 2015 1 Dove si trova l osservatorio? L osservatorio Astronomico Regionale del Parco Antola,
sfera celeste e coordinate astronomiche
 sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS
 M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium
M.PAOLILLO (E IL GRUPPO DI ASTROFISICA) ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI ASTRONOMICHE CON IL TELESCOPIO DE RITIS PRINCIPI DI OTTICA: RIFRATTORE RITCHEY- CHRÉTIEN Il Planewave CDK 20 della Baader Planetarium
Ciao! Ma puoi sapere qualcos altro dalla luce?
 Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte III fra la coda del serpente e la volpetta
 Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte III fra la coda del serpente e la volpetta Risalendo la via lattea verso declinazioni meno negative c è un lungo tragitto di equatore
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte III fra la coda del serpente e la volpetta Risalendo la via lattea verso declinazioni meno negative c è un lungo tragitto di equatore
STUDIO DEI SATELLITI DI GIOVE CON UN TELESCOPIO AMATORIALE D. Trezzi 01/02/2012, rev. 03/02/2012
 ARTICOLI di ASTRONOMIA AMATORIALE STUDIO DEI SATELLITI DI GIOVE CON UN TELESCOPIO AMATORIALE D. Trezzi (datrezzi@alice.it) 01/02/2012, rev. 03/02/2012 ABSTRACT A poco più di quattrocento anni dalla scoperta
ARTICOLI di ASTRONOMIA AMATORIALE STUDIO DEI SATELLITI DI GIOVE CON UN TELESCOPIO AMATORIALE D. Trezzi (datrezzi@alice.it) 01/02/2012, rev. 03/02/2012 ABSTRACT A poco più di quattrocento anni dalla scoperta
Misure di fenomeni di aberrazione di una lente
 Padova, gennaio 00 Misure di fenomeni di aberrazione di una lente Indicare il numero identificativo e le caratteristiche geometriche della lente utilizzata: Lente num. =... Spessore =... Spigolo =... Indice
Padova, gennaio 00 Misure di fenomeni di aberrazione di una lente Indicare il numero identificativo e le caratteristiche geometriche della lente utilizzata: Lente num. =... Spessore =... Spigolo =... Indice
18-50mm f/ DC OS HSM Centro Studi Progresso Fotografico
 Test MTF Un corredo stabilizzato in due obiettivi Sigma Da mm a mm, che diventano mm e mm in quanto sono obiettivi per il formato APS-C. Il livello è amatoriale, come per altro confermano i prezzi. Presentiamo
Test MTF Un corredo stabilizzato in due obiettivi Sigma Da mm a mm, che diventano mm e mm in quanto sono obiettivi per il formato APS-C. Il livello è amatoriale, come per altro confermano i prezzi. Presentiamo
Nane bianche e stelle di neutroni. di Roberto Maggiani
 Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
Nane bianche e stelle di neutroni di Roberto Maggiani Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il maggior peso di quest ultima, infatti, nello stesso volume
IL PIANETA URANO. Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL.
 IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
Le Stelle. Collana a cura di Corrado Lamberti
 Le Stelle Collana a cura di Corrado Lamberti L Universo in 25 cm Daniele Gasparri ISBN 978-88-470-1904-1 e-isbn 978-88-470-1905-8 DOI 10.1007/978-88-470-1905-8 Springer-Verlag Italia 2011 Questo libro
Le Stelle Collana a cura di Corrado Lamberti L Universo in 25 cm Daniele Gasparri ISBN 978-88-470-1904-1 e-isbn 978-88-470-1905-8 DOI 10.1007/978-88-470-1905-8 Springer-Verlag Italia 2011 Questo libro
di CHIRURGIA della CATARATTA e REFRATTIVA LA VOCE Nuove tecnologie in chirurgia della cataratta
 F O C U ASSOCIAZIONE ITALIANA di CHIRURGIA della CATARATTA e REFRATTIVA LA VOCE aiccer RIVISTA SCIENTIFICA DI INFORMAZIONE S Nuove tecnologie in chirurgia della cataratta 2016 FGE S.r.l. - Reg. Rivelle
F O C U ASSOCIAZIONE ITALIANA di CHIRURGIA della CATARATTA e REFRATTIVA LA VOCE aiccer RIVISTA SCIENTIFICA DI INFORMAZIONE S Nuove tecnologie in chirurgia della cataratta 2016 FGE S.r.l. - Reg. Rivelle
LA RETE DI ERATOSTENE
 LA RETE DI ERATOSTENE CHE COS È LA RETE DI ERATOSTENE? La Rete di Eratostene ha come uno delle principali la misurazione della terra. Questo lavoro si svolge attraverso una collaborazione tra più scuole.
LA RETE DI ERATOSTENE CHE COS È LA RETE DI ERATOSTENE? La Rete di Eratostene ha come uno delle principali la misurazione della terra. Questo lavoro si svolge attraverso una collaborazione tra più scuole.
Osservazioni astronomiche in remoto in ambiente web collaborativo
 Università del Salento Dipartimento di Fisica Gruppo di Astrofisica Osservazioni astronomiche in remoto in ambiente web collaborativo D.Licchelli*, A. Blanco*,, M. Bochicchio**, A. Bernardo**, S. Fonti*,
Università del Salento Dipartimento di Fisica Gruppo di Astrofisica Osservazioni astronomiche in remoto in ambiente web collaborativo D.Licchelli*, A. Blanco*,, M. Bochicchio**, A. Bernardo**, S. Fonti*,
!L'UOMO È ANDATO VERAMENTE SULLA LUNA?
 !L'UOMO È ANDATO VERAMENTE SULLA LUNA? Apollo 11 è la missione della N.A.S.A. con la quale definiamo il lancio e lo sbarco riuscito sulla luna, nel 1969 dagli Americani Neil Amstrong e Buzz Aldrin e Michael
!L'UOMO È ANDATO VERAMENTE SULLA LUNA? Apollo 11 è la missione della N.A.S.A. con la quale definiamo il lancio e lo sbarco riuscito sulla luna, nel 1969 dagli Americani Neil Amstrong e Buzz Aldrin e Michael
Alla ricerca di un altra Terra!
 Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
5 CORSO DI ASTRONOMIA
 5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia
 Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
Il Cielo come Laboratorio
 Il Cielo come Laboratorio Progetto Educativo per le Scuole Superiori VI Edizione Promosso da Dipartimento di Astronomia Università degli Studi di Padova in collaborazione con Centro Servizi Amministrativi
Il Cielo come Laboratorio Progetto Educativo per le Scuole Superiori VI Edizione Promosso da Dipartimento di Astronomia Università degli Studi di Padova in collaborazione con Centro Servizi Amministrativi
Telescopi ed aberrazioni ottiche
 Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa Emanuele Schembri Telescopi ed aberrazioni ottiche Siracusa,, 30 aprile 2010 Definizione Le aberrazioni ottiche sono difetti apparenti del comportamento
Vivi l Universo e la Natura. Strumenti Ottici di Qualità
 Vivi l Universo e la Natura Strumenti Ottici di Qualità Telescopi Entry-Level per iniziare il viaggio nell affascinante mondo dell Astronomia. L eccellente qualità ottica combinata alla stabile montatura
Vivi l Universo e la Natura Strumenti Ottici di Qualità Telescopi Entry-Level per iniziare il viaggio nell affascinante mondo dell Astronomia. L eccellente qualità ottica combinata alla stabile montatura
*COMUNICATO STAMPA* Archeoastronomia: le pietre che segnano il tempo
 *COMUNICATO STAMPA* Venerdì 24/6 - ore 21.30 - Archeoastronomia: le pietre che segnano il tempo seguirà osservazione notturna al telescopio Sabato 25/6 - ore 16.00 - Le erbe magiche di San Giovanni passeggiata
*COMUNICATO STAMPA* Venerdì 24/6 - ore 21.30 - Archeoastronomia: le pietre che segnano il tempo seguirà osservazione notturna al telescopio Sabato 25/6 - ore 16.00 - Le erbe magiche di San Giovanni passeggiata
Telescopi astronomici
 Telescopi astronomici 2 Il piacere della scoperta Immaginate l emozione e la sorpresa del primo uomo che, secoli fa, osservando il cielo con un telescopio rudimentale, scoprì un oggetto lontano, invisibile
Telescopi astronomici 2 Il piacere della scoperta Immaginate l emozione e la sorpresa del primo uomo che, secoli fa, osservando il cielo con un telescopio rudimentale, scoprì un oggetto lontano, invisibile
CORSI DI ASTRONOMIA 2010
 Rodolfo Calanca CORSI DI ASTRONOMIA 2010 PREMESSA Nel seguito propongo alcuni corsi di astronomia e di storia della scienza che possono essere svolti all interno di strutture pubbliche o private (Biblioteche
Rodolfo Calanca CORSI DI ASTRONOMIA 2010 PREMESSA Nel seguito propongo alcuni corsi di astronomia e di storia della scienza che possono essere svolti all interno di strutture pubbliche o private (Biblioteche
Il nostro Universo. Che cos è il Big Bang? Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011
 Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Misurare la lunghezza focale di uno specchio Newton
 Misurare la lunghezza focale di uno specchio Newton Da gerlos http://gerlos.altervista.org/misurare-lunghezza-focale-specchio-newton In questa pagina mostro un semplice metodo per misurare la lunghezza
Misurare la lunghezza focale di uno specchio Newton Da gerlos http://gerlos.altervista.org/misurare-lunghezza-focale-specchio-newton In questa pagina mostro un semplice metodo per misurare la lunghezza
Salve ragazzi e ragazze!
 1 Salve ragazzi e ragazze! Cominciamo con questa pagina la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avventureremo, nelle prossime pagine, oltre il nostro Sistema Solare per scoprire le stelle. Sì,
1 Salve ragazzi e ragazze! Cominciamo con questa pagina la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avventureremo, nelle prossime pagine, oltre il nostro Sistema Solare per scoprire le stelle. Sì,
Le Galassie I mattoni dell Universo
 Le Galassie I mattoni dell Universo Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Da Terra vediamo solo una grande fascia di stelle, gas e polveri Questa ad esempio è la zona della costellazione
Le Galassie I mattoni dell Universo Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Da Terra vediamo solo una grande fascia di stelle, gas e polveri Questa ad esempio è la zona della costellazione
Di cosa parliamo stasera
 1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
