RECENTI SVILUPPI NEL SETTORE DEGLI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Mario Collepardi
|
|
|
- Angela Dini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RECENTI SVILUPPI NEL SETTORE DEGLI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Mario Collepardi ENCO, Engineering Concrete Via delle Industrie, 18/20, Ponzano Veneto (TV), Italy Sommario. In questi ultimi anni gli additivi per calcestruzzo presentano significative innovazioni finalizzate fondamentalmente al processo produttivo o al miglioramento prestazionale. In questo articolo l'esame della situazione è limitata a tre categorie di prodotti: - i riduttori di acqua di impasto per incrementare le prestazioni meccaniche; - i riduttori del ritiro igrometrico ed autogeno; - i prodotti destinati a migliorare la durabilità a lungo termine. Gli additivi finalizzati alla riduzione di acqua di impasto hanno subito un rivoluzionario cambiamento soprattutto per la possibilità di incrementare le prestazioni meccaniche alle brevi stagionature anche in condizioni non favorevoli allo sviluppo della resistenza meccanica (basse temperature). Per la eliminazione delle fessure da ritiro si sono impiegati additivi riduttori del ritiro ( SRA da Shrinkage Reducing Admixture) in combinazione con agenti espansivi e superfluidificanti. Per il miglioramento della durabilità a lungo termine (anche oltre 100 anni come previsto nel recente DM del 14 Settembre 2005) si possono adottare due strategie entrambe finalizzate principalmente alla protezione del "punto debole" delle strutture in c.a. : le armature metalliche. Una prima strategia è incentrata sul comportamento dell'acciaio e prevede l'impiego di acciai inossidabili, acciai protetti da resine epossidiche, impiego di inibitori di corrosione, ecc. Una seconda strategia si basa sull'impiego di un calcestruzzo meno permeabile accoppiato ad un copriferro di maggior spessore : una modellazione matematica molto semplice prevede di stabilire, con sufficiente sicurezzza, spessore e qualità di copriferro per le strutture in "classe 2 " (vita utile di servizio > 100 anni). 239
2 1 INTRODUZIONE Negli ultimi dieci anni gli additivi per calcestruzzo hanno giocato un ruolo determinante nel miglioramento delle strutture in calcestruzzo armato, in termini di prestazioni meccaniche, di stabilità dimensionale, e di durabilità a lungo termine. In questo articolo vengono esaminati i più significativi progressi degli additivi per calcestruzzo destinati al miglioramento delle strutture in c.a. ed in particolare dei : - riduttori di acqua di impasto per aumentare le prestazioni meccaniche anche in condizioni avverse; - riduttori del ritiro per migliorare la stabilità dimensionale, - prodotti e tecnologie per soddisfare le richieste di durabilità a lungo termine. 2 ADDITIVI SUPER-RIDUTTORI DI ACQUA DI IMPASTO Agli inizi degli anni 1970, la famiglia dei riduttori di acqua (a base di ligninsolfonato, un residuo dell estrazione della cellulosa dal legno) fu tecnicamente sovrastata dai super-riduttori di acqua (high-range water reducers) prodotti per sintesi chimica. In sostanza si potrebbe dire che le prestazioni di questi ultimi, nel seguito descritte, sono circa quattro volte più efficaci rispetto a quelle dei riduttori di acqua. Va la pena di precisare che l azione di riduzione di acqua deve avvenire senza penalizzare la lavorabilità dell impasto. Tutti gli additivi riduttori di acqua sono basati su polimeri idrosolubili. I primi ad essere immessi sul mercato erano basati su poli-naftalen-solfonati (PNS) o su polimelammin-solfonati (PMS). Più recentemente verso l inizio del 1990 sono stati introdotti i poli-carbossilati (PC) che formano una famiglia molto vasta di nuovi polimeri tutti caratterizzati dall assenza dei gruppi solfonici presenti nei PNS e PMS [4]. Da un punto di vista prestazionalegli additivi a base di PC sono capaci di ridurre l acqua di impasto molto di più che non quelli a base di PNS o PMS. Ma soprattutto gli additivi policarbossilici conservano meglio la lavorabilità durante il trasporto in climi caldi. In linea di massima la quantità di additivo impiegata, rispetto alla massa del cemento, si aggira sull 1%. Ovviamente diminuendo o aumentando l additivo (di solito non oltre il 2%) si riduce o si incrementa l effetto dell additivo. 2.1 IL MECCANISMO DELLA DEFLOCCULAZIONE L effetto deflocculante dell additivo sui granuli di cemento dispersi in un mezzo acquoso è illustrato in Figura 1. Una miscela di cemento molto diluita in acqua, depositata su vetro trasparente illuminato dal basso in alto con una lampada, osservata con microscopio ottico si presenta come nella foto della Figura 1.A: i granuli di cemento, opachi alla luce, si presentano come macchie nere mentre la parte bianca della foto corrisponde alla presenza dell acqua che è trasparente alla luce. Salvo pochissimi granuli, che corrispondono alle macchie puntiformi nere, la maggior parte dei granuli di cemento si presenta in forma di agglomerati di molti granuli di cemento. Questo fenomeno noto come flocculazione deriva dall attrazione di natura elettrostatica tra i vari granuli di cemento a seguito delle cariche elettrostatiche di segno opposto che si sono formate sulle superfici dei granuli per effetto della macinazione (e della rottura dei 240
3 legami ionici presenti nei costituenti del clinker) durante il processo produttivo del cemento. Figura 1 : Osservazione al microscopio ottico di una pasta di cemento flocculata (A) e dispersa (B) per la presenza di additivo superfluidificante In presenza degli additivi riduttori di acqua, noti anche come additivi i superfluidificanti, i diversi granuli sono deflocculati, cioè dispersi (Figura 1.B) a seguito di uno dei due possibili meccanismi: adsorbimento sulla superficie dei granuli di cemento delle molecole di superfluidificante e formazione di cariche elettrostatiche (zeta potential) dello stesso segno (negative) apportate dai gruppo anionici dei superfluidificanti PNS e PMS che provoca una repulsione elettrostatica tra i granuli di cemento (Fig. 2); Figura 2 : Deflocculazione per repulsione elettrostatica adsorbimento sulla superficie dei granuli di cemento delle molecole di superfluidificante PA che, grazie alla ingombrante presenza delle catene laterali, impedisce ai granuli di cemento di avvicinarsi a causa dell impedimento sterico (steric hindrance) e di flocculare (Figura 3): i gruppi carbossilici (COO ) sono responsabili dell adsorbimento sulla superficie dei granuli di cemento, mentre le catene laterali impediscono la collisione dei granuli di cemento e quindi la loro flocculazione. Figura 3 : Deflocculazione per impedimento sterico 241
4 Recentemente sono stati messi a punto diversi tipi di superfluidificanti, tutti a base di polimeri policarbossilici (PC), ciascuno dei quali con una funzione specifica in relazione al loro impiego (Figura 4): PA (Poli-Acrilato) PE (Poli-Etere) SLCA (Slump Loss Controlling Agent). Figura 4 : Schematizzazione delle strutture molecolari dei polimeri PA e PE 2.2 ADDITIVI PER CALCESTRUZZI PREFABBRICATI Nella Figura 5 sono mostrate schematicamente le strutture molecolari dei polimeri PA e PE: si può notare che il PA è caratterizzato dalla presenza di catene laterali a base di polimero di etilen-ossido (EO) relativamente corte; nei polimeri PE, invece, aumenta la lunghezza delle catene laterali EO responsabili della deflocculazione e diminuisce il numero dei gruppi carbossilici responsabili dell adsorbimento del polimero sulla superficie del cemento e quindi dell effetto fluidificante. Nella Figura 5 vengono mostrati i meccanismi di azione degli additivi a base di PA e PE rispettivamente: si può vedere in Figura 5A che la superficie del granulo di cemento è quasi tutta coperta dai polimeri di PA per l elevato numero di gruppi carbossilici COO responsabili dell adsorbimento del polimero sulla superficie del cemento; questa situazione comporta un rallentamento iniziale nella idratazone del cemento con l acqua. In presenza del polimero PE, invece, il numero dei gruppi carbossilici adsorbiti sulla superficie del cemento è minore (Figura 5B) e questa situazione comporta una maggiore velocità iniziale nella reazione del cemento, la cui superficie è più esposta al contatto diretto con l acqua, e conseguentemente un più rapido indurimento del calcestruzzo con PE rispetto a quello con PA (Figura 6). Figura 5 : Effetto disperdente per impedimento sterico dei polimeri PA (A) ed effetto disperdente per impedimento sterico dei polimeri PE (B) A B 242
5 Figura 6 : Influenza del tipo di polimero poli-carbossilico (PE o PA) sullo sviluppo iniziale della resistenza meccanica I risultati mostrati nella Figura 6 indicano che il superfluidificante PE è più adatto nel campo della prefabbricazione dove a sole 12 ore, ed in assenza di maturazione a vapore, raggiunge valori di resistenza meccanica (20 MPa) accettabili per la sformatura. Il polimero PA, invece presenta inizialmente un lento sviluppo della resistenza meccanica per il ritardo nella idratazione del cemento a causa dell elevato numero di molecole adsorbite sulla superficie del cemento; tuttavia in meno di 2 giorni la prestazione meccanica del calcestruzzo con PA raggiunge quella del calcestruzzo con PE. Un altro aspetto che contraddistingue il comportamento dei calcestruzzi con gli additivi a base di PA o PE riguarda la perdita di lavorabilità nella fase di trasporto e di messa in opera. Le Figure 7 e 8 mostrano il comportamento reologico di calcestruzzi rispettivamente con superfluidificante PA e PE. Si può osservare che il polimero PA è più efficace del PE per la migliore conservazione di lavorabilità durante il trasporto e quindi più adatto per i calcestruzzi preconfezionati che debbono essere trasportati per minuti dall impianto di betonaggio al cantiere. Il polimero PE, invece, perde lavorabilità più rapidamente e pertanto è più adatto per i calcestruzzi prefabbricati che nel giro di qualche minuto dopo la miscelazione sono messi in opera. Figura 7 : Influenza della temperatura nella perdita di lavorabilità dei calcestruzzi con PA 243
6 Figura 8 : Influenza della temperatura nella perdita di lavorabilità dei calcestruzzi con PE 2.3 ADDITIVI PER CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI Il maggior problema dei calcestruzzi preconfezionati consiste nella perdita di lavorabilità durante il trasporto dalla centrale di betonaggio al cantiere. Se si richiede una conservazione della lavorabilità più lunga, specialmente in condizioni avverse quando la temperatura supera 20 C, è necessario ricorrere alla miscelazione dei polimeri PA o PE con il polimero SLCA (Slump Loss Controlling Agent). Nella Fig. 10 è mostrato comparativamente il comportamento reologico del calcestruzzo fresco a 30 C in presenza di PE, di SLCA e di una miscela di questi polimeri (PE+SLCA). Il singolare comportamento dell additivo SLCA, che fa aumentare la lavorabilità del calcestruzzo durante le prime ore di trasporto prima di provocare la presa del conglomerato (Figura 9), è spiegato con il meccanismo d azione illustrato nella Figura 10. Inizialmente l additivo SLCA fluidifica poco perché è presente in una forma che contiene un numero limitato di gruppi carbossilici (COO ) responsabili dell adsorbimento dell additivo sulla superficie dei granuli di cemento; i gruppi COO sono infatti presenti prevalentemente in forma di COOR incapaci di essere adsorbiti e quindi fluidificare il calcestruzzo. Nell ambiente basico (ph=13) che si crea nell acqua d impasto per la formazione di idrossido di calcio, il gruppo COOR si idrolizza come è mostrato in Figura 10 liberando il gruppo COO secondo lo schema: COOR + OH COO + ROH Figura 9 : Perdita di lavorabilità di calcestruzzi con superfluidificante PE, SLCA o PE+SLCA a 30 C 244
7 Figura 11 : Meccanismo di azione del polimero SLCA nella fluidificazione ritardata Il gruppo COO è capace di essere adsorbito sulla superficie dei granuli di cemento e favorisce quindi la dispersione e quindi la fluidificazione del calcestruzzo fresco. L additivo SLCA non viene in genere impiegato da solo in quanto la lavorabilità al momento del getto cambierebbe (aumentando) in funzione del tempo trascorso dal mescolamento. Si preferisce, invece, mescolare il polimero PE con una percentuale opportuna di SLCA in modo da conservare la stessa lavorabilità dell impianto di betonaggio per un tempo sufficientemente lungo (circa 2 ore) anche in climi caldi: questo straordinario comportamento di assenza nella perdita di lavorabilità durante il trasporto è rappresentato dalla curva PE+SLCA della Figura 9. 3 IL RITIRO IGROMETRICO: CAUSE E CONSEGUENZE Il calcestruzzo a differenza di altri materiali come l acciaio, il vetro, la ceramica, ecc oltre a subire una contrazione di origine termica a seguito del raffreddamento ambientale, subisce anche una contrazione di origine igrometrica determinata dall essiccazione indotta da un ambiente insaturo di vapore (UR < 95%). Questa seconda contrazione - solitamente chiamata ritiro - risulta essere molto più pericolosa in quanto può raggiungere valori molto più elevati (fino a µm/m) che non le contrazioni legate alle variazioni termiche ambientali in servizio. La ragione per la quale il ritiro è molto temuto in una struttura in c.a. è dovuta al fatto che in realtà il calcestruzzo non è libero di contrarsi, ma risulta essere impedito dalla presenza di vincoli quali i ferri di armatura, gli attriti per il contatto con sottofondi, ed i collegamenti con altre strutture. Ne consegue che il ritiro (ε), che si sarebbe verificato se la struttura fosse libera di muoversi, si trasforma in realtà in una sollecitazione a trazione (σ t ) secondo l equazione (1): σ t = E ε (1) dove E è il modulo elastico del calcestruzzo. In realtà la sollecitazione σt può essere in parte mitigata dal rilassamento della tensione provocata dallo scorrimento viscoso noto anche come creep (C): σ t = E (ε-c) (2) 245
8 Si può stabilire se la sollecitazione a trazione σ t è in grado o meno di fessurare il calcestruzzo se si conosce l andamento nel tempo di σ t e di R t (resistenza a trazione). In Figura 11 sono mostrate tre situazioni in corrispondenza delle quali si verifica: A) una mediocre stagionatura che favorisce lo sviluppo del ritiro ε, e quindi l instaurazione di una forte sollecitazione a trazione (σ t ) che supera la resistenza a trazione R t con conseguente fessurazione al tempo t 1 ; B) una stagionatura umida iniziale (1-2 giorni) che ritarda lo sviluppo del ritiro ε, e quindi della tensione di trazione σ t : la fessurazione viene ritardata al tempo t 2 > t 1 ; C) una stagionatura umida così accurata e prolungata (almeno 7 giorni) da favorire un forte rallentamento iniziale nello sviluppo del ritiro e nell insorgere della tensione σ t, al punto che la resistenza a trazione R t - favorita invece dalla stagionatura umida - non viene più raggiunta dalla tensione di trazione σ t : in questo caso la fessurazione non avviene mai. La situazione rappresentata dalla situazione C) in Figura 11 è piuttosto rara perché comporta una stagionatura umida prolungata durante il cui periodo cresce R t mentre ε e σ t rimangono nulli. La stagionatura umida, o quanto meno la protezione della superficie con teli o membrane anti-evaporanti, dovrebbe essere attuata immediatamente al momento della scasseratura soprattutto quando l ambiente si presenta asciutto, caldo e ventilato. Nel caso dei pavimenti la situazione è ancora più grave perché la superficie del calcestruzzo rimane subito e sempre in balia delle condizioni termo-igrometriche dell ambiente, a meno che non venga immediatamente protetta nella fase di presa e/o bagnata subito dopo il suo indurimento. Figura 11 : Andamento della sollecitazione a trazione (σ t ) e della resistenza meccanica a trazione (R t ) in funzione del tempo Le fessure indotte dal ritiro igrometrico rappresentano un attentato alla durabilità delle opere in c.a. in quanto - nonostante il basso rapporto a/c adottato in conformità della norma UNI EN la presenza delle fessure consente agli agenti aggressivi ambientali di penetrare il calcestruzzo e di raggiungere eventualmente i ferri di armatura. Inoltre, nel caso dei pavimenti industriali, in corrispondenza delle fessure le sollecitazioni meccaniche dovute al transito di carrelli possono ulteriormente aggravare la situazione di degrado. Per eliminare le fessure indotte dal ritiro sono possibili due approcci: ridurre il ritiro e in modo che la curva della tensione di trazione σ t in funzione del tempo t non raggiunga mai la resistenza a trazione R t come si verifica per il caso A di Figura 12; 246
9 annullare il ritiro e in modo che la curva della tensione di trazione σ t in funzione del tempo t rimanga sempre adagiata sull ascissa o addirittura risulti in posizione opposta a quella della sollecitazione di trazione, e cioè in condizione di una sollecitazione di compressione σ c estremamente favorevole ad una situazione di stabilità dimensionale (caso B di Figura 12): questa situazione è simile a quella che si instaura nel calcestruzzo precompresso caratterizzato, appunto, da una sollecitazione di compressione σ c nel calcestruzzo e di trazione σ t nei ferri di armatura. Figura 12 : Andamento della resistenza meccanica a trazione (R t ) e della sollecitazione a trazione σ t (caso A) o della sollecitazione a compressione σ c (caso B) 3.1 CALCESTRUZZO CON RITIRO RIDOTTO Esistono oggi materiali capaci di ridurre il ritiro anche in condizioni sfavorevoli di mancata stagionatura umida del calcestruzzo dopo la rimozione delle casseforme. Si tratta di additivi denominati SRA (Shrinkage-Reducing Admixtures) capaci di attenuare il ritiro igrometrico di circa il 50% nel periodo iniziale e di circa il 30% a tempi più lunghi (> 1 mese) come è schematicamente illustrato in Figura 13 [5]. Nel caso l additivo SRA sia impiegato congiuntamente con un additivo PC superriduttore di acqua si sommano due benefici effetti per la riduzione del ritiro: la riduzione della tensione superficiale dell acqua contenuta nei pori capillari per la presenza dell SRA con conseguente diminuzione della pressione capillare che spinge l una verso l altra le particelle di cemento; la riduzione dell acqua di impasto e del contenuto di cemento a pari rapporto acqua/cemento con conseguente aumento del contenuto degli aggregati che provoca una diminuzione del ritiro. La Figura 14 mostra schematicamente il comportamento del ritiro in: un calcestruzzo non additivato (control); un calcestruzzo con meno acqua di impasto a seguito dell aggiunta di un superriduttore policarbossilico (PC); un calcestruzzo con additivo SRA congiuntamente con additivo PC. 247
10 Figura 13 : Andamento del tempo del ritiro (ε) in un calcestruzzo normale ed in uno additivato con SRA Figura 14 : Influenza sul ritiro di un additivo policarbossilico (PC) e di un additivo policarbossilico (PC/SRA) che, oltre a ridurre l acqua, riduce anche il ritiro 3.2 CALCESTRUZZO A RITIRO RIDOTTO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI SENZA RETE METALLICA Una versione ulteriormente migliorata di calcestruzzo a ritiro ridotto prevede l aggiunta di macro-fibre polimerche (Figura 15), che grazie al loro rapporto d aspetto (lunghezza/diametro) molto elevato ed al comportamento post-fessurativo a trazione (Figura 16), possono bloccare lo sviluppo delle eventuali micro-fessure iniziali. In queste condizioni (in presenza di additivo PC e di SRA) il rischio di una propagazione delle fessure è ridotto dalla presenza delle fibre che intercettano e bloccano le eventuali poche fessure appena formate. Questa strategia si sta rivelando particolarmente favorevole nel settore delle pavimentazioni industriali, dove l impiego di calcestruzzo a ritiro ridotto e fibro-rinforzato ha portato a ridurre e perfino ad eliminare le armature metalliche con grandi vantaggi nella esecuzione pratica delle pavimentazioni [6]. Figura 15 : Fibre polimeriche per ridurre/bloccare la crescita delle fessure del ritiro 248
11 Figura 16 : Curva di sforzo-deformazione in travetti di calcestruzzo (10x10,50 cm) senza e con fibre 3.3 IL CALCESTRUZZO A RITIRO NULLO Il precursore del calcestruzzo a ritiro nullo (ShFC, Shrinkage-Free Concrete) è noto con il nome di calcestruzzo a ritiro compensato (ShCC, Shrinkage-Compensating Concrete). Tuttavia, nel settore delle nuove costruzioni il calcestruzzo a ritiro compensato ha avuto uno scarso successo per la difficoltà operativa di dover bagnare con acqua la superficie del manufatto subito dopo la presa. La difficoltà a realizzare questa operazione risiede nel fatto che la maggior parte dei manufatti - ad eccezione delle pavimentazioni industriali - non sono scasserabili e pertanto diventa impossibile bagnare con acqua la superficie del calcestruzzo subito dopo la presa. La necessità di bagnare risiede nel fatto che, nel calcestruzzo a ritiro compensato ShCC, è presente un agente chimico capace di provocare un azione opposta al ritiro, cioè un azione espansiva. Se l espansione si verifica dopo la presa, quando il calcestruzzo ha cominciato ad indurire e ad aderire ai ferri di armatura, si verifica un benefico effetto di co-azione che consiste nella messa in trazione delle armature metalliche ed in una compressione del calcestruzzo. Questo principio di funzionamento richiede però che il materiale venga costantemente bagnato in superficie durante l espansione (Figura 17 A) nel periodo compreso tra la presa e il termine dell espansione (da uno a sette giorni a seconda del particolare agente espansivo). Questa operazione è praticamente possibile solo nel caso di calcestruzzo per pavimenti industriali o di conglomerato spruzzato come per esempio si verifica nel restauro del calcestruzzo degradato riparato mediante applicazione a spruzzo di malte premiscelate a ritiro compensato. Anche in queste situazioni, dove la tecnologia dell ShCC è potenzialmente applicabile, si sono talvolta verificati frustranti insuccessi (pavimenti fessurati e malte distaccate) per il mancato rispetto da parte dell impresa a mantener bagnata la superficie tra il tempo di presa e la fine dell espansione (Figura 17 B). Figura 17 : Espansione contrastata dello stesso calcestruzzo con agente espansivo in caso di stagionatura sotto acqua per tre giorni (A) oppure di protezione con teli (B) 249
12 Con la nuova tecnologia del calcestruzzo a ritiro nullo ShFC, la bagnatura della superficie del calcestruzzo non è più necessaria nè subito dopo la presa, nè a tempi successivi [7, 8]. Questa novità rende agevole l adozione di questa tecnologia per la possibilità di eliminare alla radice qualsiasi forma di ritiro nella quale si possa manifestare (ritiro plastico, ritiro autogeno e ritiro igrometrico). Il pricipio dell ShFC risiede nella combinata applicazione dell additivo SRA, del quale si è parlato nel precedente paragrafo, con un agente espansivo capace di esplicare l espansione dopo la presa e prima della sformatura delle cassaforme (1-2 giorni). L ossido di calcio, CaO, purché cotto ad una temperatura di 1000 C e macinato in modo da avere un assortimento granulometrico tra 10 e 200 µm, si presta molto bene a questa tempistica giacché, reagendo con l acqua di impasto, si trasforma in calce idrata, Ca(OH) 2 generando una espansione della matrice cementizia ormai indurita. Questa espansione, come si è già detto, non può avvenire, se non in modo trascurabile, in assenza di una bagnatura. Essa si manifesta, invece, anche in assenza di qualsiasi stagionatura umida se la calce è accompagnata dalla presenza di SRA. Inoltre, a seguito dell effetto tensioattivo, il ritiro che segue l espansione risulta fortemente ridotto con la conseguenza di lasciare il sistema acciaio-calcestruzzo in uno stato di permanente coazione favorevole all assenza di ritiro nel calcestruzzo (Figura 18). Figura 18 : Comportamento del calcestruzzo senza ritiro (CaO+PC+SRA) in confronto al calcestruzzo a ritiro compensato (CaO) ed al calcestruzzo ordinario (Control) La tecnologia del calcestruzzo a ritiro nullo anche in assenza di stagionatura raggiunge il massimo della prestazione se l agente riduttore del ritiro SRA è impiegato in combinazione con il super-riduttore di acqua PC - per la somma di tre effetti che partecipano alla eliminazione del ritiro: riduzione dell acqua di impasto e riduzione del ritiro igrometrico per l azione del PC; riduzione della tensione superficiale dell acqua nei pori capillari per azione e dell SRA; presenza dell agente espansivo che, anche in assenza di stagionatura umida, provoca un azione opposta a quella del ritiro igrometrico grazie alla presenza dell additivo SRA CALCESTRUZZO A RITIRO NULLO PER COSTRUZIONI SENZA GIUNTI Questa strategia si presenta particolarmente interessante in tutte le costruzioni (solai, gallerie, muri, pavimentazioni industriali) dove l assenza di stagionatura umida al 250
13 momento della sformatura è fonte di indesiderati problemi fessurativi provocati dal ritiro. Normalmente per ovviare a questi difetti si provvede al taglio del manufatto per programmarne la fessurazione in corrispondenza dei cosiddetti giunti di contrazione. Con la tecnologia del calcestruzzo a ritiro nullo è possibile aumentare la distanza fra i giunti di contrazione senza ulteriori trattamenti stagionanti delle superfici scasserate almeno dopo 1 giorno dal getto. Inoltre, è possibile realizzare pavimentazioni industriali fino a metri quadrati senza giunti di contrazione, ma lasciando soltanto il giunto di costruzione al termine della giornata lavorativa per la ripresa della pavimentazione nei giorni successivi. L unico accorgimento da adottare consiste nel proteggere con teli impermeabili, per almeno 1 giorno, la superficie del pavimento al termine dell applicazione dello spolvero indurente: questa operazione è equivalente alla stagionatura che si realizza nelle strutture casserate e sformate ad 1 giorno. 4. DURABILITA DELLE STRUTTURE IN C.A. La durabilità del materiale, intesa come rispetto della composizione ed in particolare del massimo rapporto acqua-cemento (a/c) e del minimo dosaggio di cemento (c), come viene intesa nella norma UNI EN 206-1, è solo condizione necessaria ma non sufficiente per la durabilità della struttura. Questa, infatti, risente moltissimo della cura o dell incuria con cui viene realizzata la posa in opera e la maturazione della struttura dopo la scasseratura. Anche nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), emanate con D.M. del 14 Settembre 2005, si fanno ripetuti riferimenti alla posa in opera ed alle regole di maturazione che il progettista deve indicare per la realizzazione della struttura accanto alle indicazioni sulla classe di resistenza del materiale che tenga conto anche dell ambiente dove sorgerà l opera (classe di esposizione) e del tempo di vita utile di progetto previsto per la struttura. 4.1 VITA UTILE DI PROGETTO Seco ndo le nuove NTC (paragrafo 2.5) il Committente ed il Progettista, di concerto, debbono dichiarare nel progetto la vita utile della struttura. La scelta di questa importante caratteristica che rappresenta un significativo cambiamento rispetto alle precedenti norme di legge sulle costruzioni in c.a. è facilitata dalla Tabella nel testo originale della G.U. e riportata qui come Tabella 1. VITA UTILE DI PROGETTO (anni) TIPOLOGIA DI STRUTTURA S trutture provvisorie o temporanee in fase costruttiva Componenti strutturali sostituibili (giunti, appoggi, ecc.) 50 Strutture in Classe Strutture in Classe 2 Tabella 1 Vita utile di progetto in funzione della tipologia strutturale 251
14 A parte le strutture provvisorie ed i componenti strutturali sostituibili di immediata interpretazione, le costruzioni vengono suddivise nelle due classi in base ai seguenti criteri: - Classe 1 con vita utile di 50 anni; essa include le normali costruzioni viarie o ferroviarie la cui eventuale interruzione non provoca situazioni di emergenza, le costruzioni per industrie con attività non pericolose, edifici e costruzioni con normali affollamenti, costruzioni senza funzioni pubbliche e sociali di rilevante importanza. - Classe 2 con vita utile di 100 anni; essa include costruzioni con affollamenti significativi in esercizio, reti ferroviarie e viarie le cui interruzioni possono provocare situazioni di emergenza, industrie con attività pericolosa per l ambiente. Le NTC non escludono che in casi straordinari possano essere previste costruzioni con una vita utile maggiore di 100 anni, purché si valutino le azioni con appositi studi: si pensi ad esempio ad opere come il MOSE a Venezia o il Ponte sullo Stretto di Messina. Se il Committente è una pubblica amministrazione, un ente pubblico o un industria, non avrà certo problemi nell indicare al Progettista con quale Classe di costruzione debba essere identificata la struttura in corso di progettazione. Se il Committente è, invece, un privato o un azienda non esperta nel settore delle costruzioni, si deve intendere che sia il Progettista ad intervistare il Committente per interpretarne la volontà circa la vita attesa di servizio in base alle esigenze espresse sull attività destinata a queste costruzioni. 4.2 IMPORTANZA DELLA POSA IN OPERA Si è più volte discusso della importanza della posa in opera intesa come getto e compattazione del conglomerato fresco all interno delle casseforme: un inadeguata compattazione del calcestruzzo in opera può provocare macrovuoti dentro e sulla superficie del calcestruzzo con pesanti penalizzazioni della resistenza attuale del calcestruzzo in opera (R c ) rispetto alla resistenza caratteristica (R ck ) che si riferisce alla resistenza convenzionale dei provini cubici compattati al massimo della densità possibile. Se si definisce g c il grado di compattazione, inteso come rapporto tra la densità della carota estratta dalla struttura (D s ) e quella del provino (D p ) costipato al massimo della densità possibile, si trova la seguente equa zione sperimentale: R (%)= 100 (R ck - R c )/ R ck = 500 (1-g c ) (3) dove g c vale D s /Dp, R c è la resistenza cubica della carota, e R è la caduta percentuale della resistenza attuale nella struttura rispetto alla resistenza convenzionale del provino. Per esempio, in una struttura che presenti una densità di 2300 kg/m 3 contro una densità del provino di 2370 kg/m 3, il grado di compattazione g c è 2300/2370 = 0,97 che inserito nella (3) porta ad una caduta della resistenza attuale R del 15 % rispetto a quella convenzionale R ck. Un grado di compattazione di 0,97 è spesso registrato nella gran parte delle strutture reali realizzate con calcestruzzo in classe di consistenza S4 (fluida) o S5 (superfluida); questo dato sembra essere confermato dalla proposta delle Norme Tecniche per le Costruzioni di considerare accettabile una resistenza cubica del calcestruzzo nella struttura pari all 85% della resistenza caratteristica del provino. Vale la pena di precisare che solo con un conglomerato autocompattante SCC si può teoricamente raggiungere una densità nella struttura pari a quella del provino (g c =1) e 252
15 quindi in questo caso non si dovrebbero registrare cadute di resistenza meccanica ( R) passando dal materiale (provino) alla struttura. Se, d altra parte, si impiega un calcestruzzo meno lavorabile (per esempio in classe di consistenza S3) la caduta di resistenza nella struttura rispetto a quella convenzionale del provino può arrivare fino al 35% (considerata inaccettabile dalle Norme Tecniche per le Costruzioni) in corrispondenza di una inadeguata posa in opera quantificata da un grado di compattazione di 0,93. Val la pena di segnalare che, oltre alla caduta prestazionale nella struttura in termini di minore resistenza meccanica, un difetto di questo tipo che si manifesta in forma di macrovuoti nel calcestruzzo comporta anche un più facile accesso degli agenti aggressivi verso i ferri della struttura con conseguente carente durabilità rispetto alla vita utile di progetto. 4.3 IMPORTANZA DELLA MATURAZIONE La maturazione del calcestruzzo è intesa come protezione del materiale in opera dopo la rimozione delle casseforme. Si tratta di un argomento tanto importante, per l influenza sulla durabilità della struttura, quanto disattesa dalle imprese sui cantieri di tutto il mondo per l assenza nel progetto di specifiche su questo aspetto. Val la pena di ricordare che la qualità del calcestruzzo in opera cresce con il tempo purché il materiale sia conservato in ambiente umido. La crescita va intesa in tutti gli aspetti delle prestazioni del conglomerato: non solo della resistenza meccanica, che come tutti sanno a 1 giorno è molto minore che a 28 giorni, ma anche della permeabilità e della durabilità. Un calcestruzzo a 1 giorno non è né resistente meccanicamente né durabile chimicamente come quello che diventerà per esempio a 28 giorni purché venga maturato adeguatamente in funzione delle condizioni ambientali e della sua composizione. Il punto debole della struttura è rappresentato dal copriferro che, per proteggere adeguatamente le sottostanti armature metalliche, deve innanzitutto rimanere integro. In altre parole una struttura con il copriferro fessurato non sarà in grado di esercitare la sua funzione protettiva anche se il rapporto acqua/cemento dovesse essere molto basso e se il grado di compattazione g c fosse eguale a 1. La causa di questa fessurazione dipende in gran parte dal ritiro igrometrico ε r che può coinvolgere la superficie della struttura quando si asciuga subito dopo la rimozione dei casseri e l ambiente è insaturo di umidità (UR < 95%) mentre la parte più interna rimane ancora umida e non si ritira. Questa situazione si tramuta, come è noto, in uno stato tensionale di trazione (σ t ) nella parte corticale del calcestruzzo che può provocare la fessurazione del copriferro se il calcestruzzo sulla superficie non ha raggiunto nel frattempo una resistenza a trazione R t superiore a σ t. Val la pena di sottolineare che le Norme Tecniche per le Costruzioni, mentre fanno obbligo al progettista di indicare le regole di maturazione lasciano alla libera responsabilità del progettista la specifica misura da adottare nel progetto ed imporre all Appaltatore sotto il controllo del Direttore dei Lavori che è responsabile della corretta applicazione della misura protettiva. Questa flessibilità nella scelta del progettista, circa la precisa norma applicativa da adottare per la maturazione, consente di scegliere anche tra altre norme internazionali collaudate (tipo ACI, ASCE, BS, ecc.), o di avvalersi di nuove norme pubblicate dopo l emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni o perfino di nuove tecnologie innovative che servano a risolvere il problema che nel caso specifico è la eliminazione 253
16 delle fessure sul copriferro: a questo scopo, per esempio, l impiego di additivi SRA e macro-fibre polimeriche, potrebbe risolvere il problema della fessurazione anche con una semplice maturazione all aria dopo la scasseratura a 1 giorno. L importante è che nel progetto sia indicata la tecnica scelta per la maturazione, tra le varie disponibili, e che questa sia capace di risolvere il problema a giudizio del Direttore dei Lavori, prima, e del Collaudatore dopo DURABILITA PER LE STRUTTURE IN CLASSE 1 E 2 Come si è già evidenziato in Tabella 1, secondo le NTC le opere in c.a. possono essere suddivise in strutture di Classe 1 o 2 a seconda che la vita utile di servizio sia progettata per 50 o 100 anni. Per le strutture di Classe 1 sono disponibili dei riferimenti normativi nella scelta del calcestruzzo (norma UNI 11104) e dello spessore di copriferro (Eurocodice 2). Per esempio una struttura in c.a. esposta all aria ed alla pioggia, e quindi in classe di esposizione XC4 (Tabella 2), debbono soddisfare i seguenti requisiti per evitare il rischio di corrosione delle armature metalliche promossa dalla carbonatazione: - rapporto acqua/cemento R ck 40 MPa - spessore di copriferro 30 mm Se si vuole affrontare il problema della corrosione dei ferri attraverso una modellazione della velocità di carbonatazione del calcestruzzo occorre far riferimento alla equazione (4): x = k t (4) dove x è lo spessore di calcestruzzo carbonatato, cioè penetrato dall anidride carbonica, t è il tempo impiegato dall anidride carbonica, e k è il cosiddetto coefficiente di carbonatazione [9] che dipende dalla porosità del calcestruzzo. Se si vuole garantire una vita utile di servizio di 50 anni per una struttura esposta a carbonatazione che possiede un copriferro di 30 mm, il valore di k è così calcolabile: x = 30 mm = k t = k 50 k = 30 / 50 = 4 mm anno -1/2 Il valore di k così calcolato può essere aggiunto alle altre prescrizioni di capitolato (riguardanti il rapporto acqua/cemento, la R ck e lo spessore di copriferro) e verificato attraverso prove di prequalifica misurando la pendenza della retta x in funzione di t dopo una esposizione all aria di qualche mese (Figura 19). Figura 19: Velocità di carbonatazione del calcestruzzo in funzione di t o t 254
17 Per le strutture in Classe 2, cioè quelle di opere in c.a. progettate per una durabilità a lungo termine con una vita di servizio maggiore o eguale a 100 anni, sono possibili due strategie, entrambe finalizzate alla protezione del punto debole della struttura e cioè delle armature metalliche: Classe di esposizione XC1 XC2 XC3 Ambiente Asciutto Bagnato raramente asciutto Moderatamente umido Ciclicamente XC4 asciutto e bagnato * Valore minimo Esempi di strutture che si trovano nella classe di esposizione - Interni di edifici con U.R. bassa - Strutture idrauliche - Fondazioni e strutture interrate - Interni di edifici con umidità relativa moderata/alta - Strutture esterne protette dal contatto diretto con la pioggia - Strutture esterne esposte all acqua piovana Max a/c Min R ck MPa Dosaggio minimo di cemento (kg/m 3 ) Spessore di copriferro * (mm) c.a. c.a.p Tabella 2 : Requisiti di accettazione per una struttura esposta a carbonatazione Per le strutture in Classe 2, cioè quelle di opere in c.a. progettate per una durabilità a lungo termine con una vita di servizio maggiore o eguale a 100 anni, sono possibili due strategie, entrambe finalizzate alla protezione del punto debole della struttura e cioè delle armature metalliche: Una prima strategia è incentrata sul comportamento dell'acciaio e prevede l'impiego di acciai inossidabili, acciai protetti da resine epossidiche e impiego di inibitori di corrosione : questa strategia è quella adottata dai corrosionisti. Una seconda strategia, adottata dai tecnologi del calcestruzzo, si basa sull'impiego di un conglomerato meno permeabile all anidride carbonica accoppiato ad un copriferro di maggior spessore in modo tale che il fronte dell anidride carbonica impieghi almeno 100 anni per arrivare a toccare i ferri di armatura. Nella Figura 20 sono riportati i. risultati estrapolati a 100 anni basati su rilevamenti sperimentali di carbonatazione su tre calcestruzzi per alcuni anni nelle condizioni più favorevoli alla carbonatazione (U.R.=70%). 255
18 Figura 20: Carbonatazione di calcestruzzi con diversa R ck Il calcestruzzo con R ck 35 MPa è stato confezionato con cemento di classe 32.5 R e con un rapporto acqua/cemento di 0,55. Il coefficiente di carbonatazione misurato sperimentalmente è di 7 mm anno -1/2. Con questo calcestruzzo occorrono 100 anni per carbonatare uno spessore di 70 mm e pertanto i ferri di armatura non sono depassivati ed esposti a rischio di corrosione se si adotta un copriferro di almeno 70 mm. Naturalmente un copriferro di questo spessore va rinforzato con una rete metallica in acciaio inossidabile, o più agevolmente con macro-fibre polimeriche ed additivo SRA come illustrato nel paragrafo 3.2, per evitare la fessurazione del copriferro. Il calcestruzzo con R ck 45 MPa è stato confezionato con cemento di classe 32.5 MPa e con rapporto acqua/cemento di 0,45. Il coefficiente di carbonatazione misurato su questo calcestruzzo nelle condizioni più favorevoli alla cabonatazione (U.R.= 70%) è apri a 5 mm. anno -1/2. La Fig. 22 indica che con questo calcestruzzo occorrono 100 anni per carbonatare uno spessore di 50 mm. Pertanto per produrre strutture in c.a. in Classe di struttura 2, cioè progettate per 100 anni di vita utile di servizio, occorre adottare di un copriferro di almeno 50 mm. Anche in questo caso è prudente rinforzare il copriferro con una rete in acciaio inossidabile o con macro-fibre polimeriche accopiate ad un additivo SRA. Il calcestruzzo con R ck 60 MPa è stato confezionato con cemento di classe 32.5 R e con un rapporto acqua/cemento così basso (0,35) da rendere indispensabile l impiego di un super-riduttore di acqua PC per conservare una lavorabilità (slump = 210 mm) congruente con la messa in opera in una struttura molto armata. Con questo calcestruzzo il valore del coefficiente di carbonatazione, misurato nelle condizioni più favorevoli alla carbonatazione, è 3 mm anno -1/2. La Figura 19 indica che occorrono 100 anni per carbonatare 30 mm di calcestruzzo. Pertanto per una struttura in Classe 2 occorre adottare un copriferro di almeno 30 mm per impedire all anidride carbonica di carbonatare tutto il copriferro e mettere a rischio di corrosione i ferri di armatura. Come si può notare dalle osservazioni sperimentali sopra illustrate sono possibili diverse combinazioni di rapporto acqua/cemento (a/c), di resistenza caratteristica (R ck ) e di coefficiente di carbonatazione (k) per assicurare almeno 100 anni di vita utile di servizio nelle strutture in c.a. La Tabella 3 mostra sinteticamente questi requisiti composizionali e prestazionali per progettare strutture in Classe 2 con una vita utile di servizio di almeno 100 anni. Val la pena di osservare che le prescrizioni composizionali 256
19 (come quelle che riguardano il rapporto a/c), a differenza delle prescrizioni prestazionali sono di difficile accertamento in fase di prequalifica ed in corso d opera. a/c 0.55 R ck 35 MPa k 7 mm anno -1/2 copriferro 30 mm a/c 0.45 R ck 45 MPa k 5 mm anno -1/2 copriferro 50 mm a/c 0.35 R ck 60 MPa k 3 mm anno -1/2 copriferro 70 mm Tabella 3 : Requisiti per strutture in Classe 2 con vita utile di servizio di almeno 100 anni CONCLUSIONI Il progresso negli ultimi dieci anni nel settore degli additivi per calcestruzzo ha consentito di migliorare le prestazioni delle strutture in c.a. in termini di resistenza meccanica e di durabilità. In particolare si segnalano, per i benefici effetti su queste prestazioni, i seguenti additivi : - additivi super-riduttori di acqua (high-range water reducers) di tipo policarbossilico PE che consentono di ridurre l acqua di impasto, e quindi il rapporto acqua/cemento, per la produzione di calcestruzzi ad alta resistenza meccanica, bassa porosità, e di più lunga durabilità; - additivi super-riduttori di acqua di tipo policarbossilico PC accoppiati a prodotti SLCA (Slump Loss Controlling Agent)per produrre calcestruzzi con basso rapporto acqua/cemento molto lavorabili e quindi piùfacili da mettere in opera anche in condizioni avverse (alta temperatura e lungo tempo di trasporto; - additivi per ridurre il ritiro SRA (Shrinkage-Reducing Admixtures) e migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo soprattutto in combinazione con super-riduttori di acqua di tipo PC ed agenti espansivi a base di ossido di calcio per produrre calcestruzzi privi di ritiro (Shrinkage-Free Concretes) o in combinazione con macrofibre polimeriche per produrre calcestruzzi senza fessurazioni da ritiro; - combinazioni di additivi super-riduttori di acqua e riduttori di ritiro per strutture in c.a. di Classe 2 con una vita utile di servizio di almeno 100 anni. BIBLIOGRAFIA [1] M. Collepardi, Admixture-Enhancing Concrete Performance, Proceedings of 6th International Congress "Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities", Dundee, UK, 5-7 July, pp , (2005). [2] M. Collepardi, M. Valente, Recent Developments in Superplasticizers, Proceedings of 8th International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Sorrento (Italy), 29 October - 1 November, pp. 1-14, (2006). [3] M. Collepardi, Chemical Admixture Today, Proceedings of Second International Symposium on Concrete Tecnology for Sustainable February - Development with Emphasis on Infrastructure, Hyderabad, India, 27 February - 3 March (2005) pp [4] Y. Zhang, M. Collepardi, L. Coppola, W. Guan, P. Zaffaroni, Optimization of the High-Strength Superplaticized Concrete for the 3 George Dam in China, Proceedings of Seventh CANMET/ACI International Conference on 257
20 Superplasticizers and Other Chemical Admixtures In Concrete, Berlin, Germany, October (2003), Supplementary Papers, pp [5] N.S. Berke, L.Li, M.C.Hicks, j.bal, Improving Concrete Performance with Shrinkage-Reducing Admixtures, Proceedings of the Seventh CANMET/ACI Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures, Berlin, Editor V.M. Malhotra, pp 37-50,2003 [6] A. Borsoi, M. Collepardi, J.J. Ogoumah Olagot, R. Troli, E. Strazzer, Combined Use of Chemical Admixtures and Polymer Macro-Fibers in Crack-Free Industrial Concrete Floors Without Wire-Mesh, Supplementary Papers of the Proceedings of 8th International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Sorrento (Italy), 29 October - 1 November, pp , (2006). [7] M. Collepardi, A. Borsoi, S. Collepardi, J.J. Ogoumah Olagot, R. Troli, Effects of Shrinkage Reducing Admixture in Shrinkage Compensating Concrete Under nonwet Curing Conditions, Cement and Concrete Composities, Volume 27, Issue 6, 2005, pp [8] M. Collepardi, A. Borsoi, S. Collepardi, J.J. Ogoumah Olagot and R. Troli,Effects of Shrinkage Reducing Admixture in Shrinkage Compensating Concrete, Proceedings of Kenji Sakata Symposium on Properties of Concrete, Montreal (Canada) 29 May - 2 June, pp. 1-16, (2006). [9] M. Collepardi, Il Nuovo Calcestruzzo, Quarta Edizione, Edizioni Tintoretto, Marzo
IL CALCESTRUZZO 3-SC PER COSTRUZIONI COMPLESSE DI DIFFICILE ESECUZIONE. Mario Collepardi ACI Honorary Member
 IL CALCESTRUZZO 3-SC PER COSTRUZIONI COMPLESSE DI DIFFICILE ESECUZIONE Mario Collepardi ACI Honorary Member Calcestruzzo 3-SC La sigla 3-SC indica un calcestruzzo che presenta le seguenti tre caratteristiche:
IL CALCESTRUZZO 3-SC PER COSTRUZIONI COMPLESSE DI DIFFICILE ESECUZIONE Mario Collepardi ACI Honorary Member Calcestruzzo 3-SC La sigla 3-SC indica un calcestruzzo che presenta le seguenti tre caratteristiche:
INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
 INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA Anno XIII - Numero 41-2008 Antoni Borsoi, Jean Jacob Ogoumah Olagot e Roberto Troli info@encosrl.it
INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO SULLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA Anno XIII - Numero 41-2008 Antoni Borsoi, Jean Jacob Ogoumah Olagot e Roberto Troli info@encosrl.it
Indice. Prefazione. 2 Altri ingredienti del calcestruzzo Miscele cementizie e loro ingredienti 55
 000V_X_ 29-01-2007 09:34 Pagina V Prefazione XI 1 I leganti 1 1.1 Inquadramento normativo generale 1 1.2 I leganti e le miscele leganti 2 1.2.1 Leganti idraulici 3 1.3 Cemento Portland 4 1.3.1 Composti
000V_X_ 29-01-2007 09:34 Pagina V Prefazione XI 1 I leganti 1 1.1 Inquadramento normativo generale 1 1.2 I leganti e le miscele leganti 2 1.2.1 Leganti idraulici 3 1.3 Cemento Portland 4 1.3.1 Composti
[ 3] CLS ad alta ed altissima resistenza. CLS ad alta ed altissima resistenza [ 2] Cementi ad alta qualità e microcementi. $ 0.
![[ 3] CLS ad alta ed altissima resistenza. CLS ad alta ed altissima resistenza [ 2] Cementi ad alta qualità e microcementi. $ 0. [ 3] CLS ad alta ed altissima resistenza. CLS ad alta ed altissima resistenza [ 2] Cementi ad alta qualità e microcementi. $ 0.](/thumbs/67/57610035.jpg) EQUAZIONI DI POWERS V p = 100(a / c) " 36.15# Vg = 67.90# $ V 'n g ) = Kx n Rc = K & &V + V ) % p g( Anni 50, teoria di Powers: se si riduce a/c diminuisce Pc e cresce Rc fino al massimo teorico di 250
EQUAZIONI DI POWERS V p = 100(a / c) " 36.15# Vg = 67.90# $ V 'n g ) = Kx n Rc = K & &V + V ) % p g( Anni 50, teoria di Powers: se si riduce a/c diminuisce Pc e cresce Rc fino al massimo teorico di 250
LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA. cls normale
 1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
1.6 TIPI DI CLS cls normale 2000 2600 Cls normale: conglomerato cementizio caratterizzato in generale da rapporto a/c > 0,45 e con resistenza caratteristica cubica 55 (N/mm 2 ) ovvero 550 (dan/cm 2 ) cls
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA. Esempi di domande a risposta multipla. Prof. Ing. Luigi Coppola
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola La calce, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola La calce, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008
 page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
page 30 RIFERIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO «MATERIALE DA COSTRUZIONE» NELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2008 Riferimenti sulle caratteristiche del calcestruzzo nelle NTC 2008 CAPITOLO
Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela
 Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela Silvia Collepardi 1, Mario Collepardi 1, Roberto Troli 1 e Wolfram Franke 2 1 ENCO, Ponzano Veneto, Italia 2 YARA, Porsgrunn,
Impiego del nitrato di calcio come additivo accelerante dei cementi di miscela Silvia Collepardi 1, Mario Collepardi 1, Roberto Troli 1 e Wolfram Franke 2 1 ENCO, Ponzano Veneto, Italia 2 YARA, Porsgrunn,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA. Esempi di domande a risposta multipla. Prof. Ing. Luigi Coppola
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola Il gesso, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA Esempi di domande a risposta multipla Prof. Ing. Luigi Coppola Il gesso, come legante, può essere impiegato nel confezionamento di impasti per la
VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEGLI ADDITIVI PENETRON ADMIX E PENESAL FH NELLA RIDUZIONE DEL RITIRO IN CALCESTRUZZI CON VARIE STAGIONATURE
 Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 5609 del 07/11/2008) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 5609 del 07/11/2008) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO. gennaio
 PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO gennaio 2015 1 DEFINIZIONI PROVINO = singolo cilindro / singolo cubo CAMPIONE (EN 12350-1) = Quantità prelevata da una massa di calcestruzzo, pari a 1,5 volte il necessario
PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO gennaio 2015 1 DEFINIZIONI PROVINO = singolo cilindro / singolo cubo CAMPIONE (EN 12350-1) = Quantità prelevata da una massa di calcestruzzo, pari a 1,5 volte il necessario
Tema della tesi: Mix-design standard Agenti espansivi, Additivi SRA e superfluidificanti Casseri chiusi
 Tema della tesi: Mix-design standard Agenti espansivi, Additivi SRA e superfluidificanti Casseri chiusi Mo.vazioni Vantaggi u.lizzo di armature non convenzionali Miglioramento della duttilità strutturale;
Tema della tesi: Mix-design standard Agenti espansivi, Additivi SRA e superfluidificanti Casseri chiusi Mo.vazioni Vantaggi u.lizzo di armature non convenzionali Miglioramento della duttilità strutturale;
R.02.D.8 - Relazione sui materiali
 Via XXV Aprile, 18 - Rovato COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI FLERO PROGETTO DEFINITIVO R.02.D.8 - Relazione sui materiali Rovato,
Via XXV Aprile, 18 - Rovato COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI FLERO PROGETTO DEFINITIVO R.02.D.8 - Relazione sui materiali Rovato,
PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.)
 PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.) Il calcestruzzo dovrà possedere i seguenti requisiti: - CLASSE DI RESISTENZA:
PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.) Il calcestruzzo dovrà possedere i seguenti requisiti: - CLASSE DI RESISTENZA:
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI
 ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI PREMESSA L obiettivo principale della nostra attività è quello di contribuire a sviluppare ulteriormente la competitività dei clienti, migliorando le prestazioni dei loro calcestruzzi
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI PREMESSA L obiettivo principale della nostra attività è quello di contribuire a sviluppare ulteriormente la competitività dei clienti, migliorando le prestazioni dei loro calcestruzzi
Ma, col passare del tempo, la qualità dei materiali utilizzati (in particolare la qualità del cemento armato) è ancora quella originaria?
 IL DEGRADO DEL CALCESTRUZZO ARMATO Come proteggere le strutture dalla carbonatazione. La Norma Europea UNI EN 1504. di Gianfranco Capillo ** 1 Le nostre costruzioni in cemento armato sono davvero antisismiche?
IL DEGRADO DEL CALCESTRUZZO ARMATO Come proteggere le strutture dalla carbonatazione. La Norma Europea UNI EN 1504. di Gianfranco Capillo ** 1 Le nostre costruzioni in cemento armato sono davvero antisismiche?
PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola
 PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola Appello del 4 Settembre 2006 ESERCIZIO Lungo la nuova tratta autostradale di collegamento tra Belluno e Cortina d Ampezzo
PROVA DI ESAME SCRITTO DI MATERIALI STRUTTURALI PER L EDILIZIA Prof. Luigi Coppola Appello del 4 Settembre 2006 ESERCIZIO Lungo la nuova tratta autostradale di collegamento tra Belluno e Cortina d Ampezzo
Cosa si intende per mix design?
 Cosa si intende per mix design? Il mix-design, letteralmente progetto della miscela, è il procedimento per il calcolo della composizione del calcestruzzo (in termini di quantità dicemento, di acquae di
Cosa si intende per mix design? Il mix-design, letteralmente progetto della miscela, è il procedimento per il calcolo della composizione del calcestruzzo (in termini di quantità dicemento, di acquae di
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica. Docente: Dr. Giorgio Pia
 Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
Corso di Tecnologia dei Materiali ed Elementi di Chimica Docente: Dr. Giorgio Pia Proprietà allo stato fresco Proprietà allo stato fresco Il Calcestruzzo fresco deve poter essere Questo è possibile se
Architettura Tecnica I. prof. ing. Vincenzo Sapienza
 Ingegneria Edile-Architettura Architettura Tecnica I IL CALCESTRUZZO (CLS) prof. ing. Vincenzo Sapienza TIPI DI CONGLOMERATI BOIACCA = legante + acqua MALTA = legante + acqua + sabbia CALCESTRUZZI = cemento
Ingegneria Edile-Architettura Architettura Tecnica I IL CALCESTRUZZO (CLS) prof. ing. Vincenzo Sapienza TIPI DI CONGLOMERATI BOIACCA = legante + acqua MALTA = legante + acqua + sabbia CALCESTRUZZI = cemento
CORSO DI QUALIFICA ESPERTO DI SETTORE
 (Estratto dal corso di 2 giorni sulla certificazione degli impianti di calcestruzzo preconfezionato) CORSO DI QUALIFICA ESPERTO DI SETTORE IL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO
(Estratto dal corso di 2 giorni sulla certificazione degli impianti di calcestruzzo preconfezionato) CORSO DI QUALIFICA ESPERTO DI SETTORE IL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO
Più il materiale è fluido, più. cono si abbassa. veloce è la colata, e si possono riempire forme complesse
 Definizione Materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.
Definizione Materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.
Lezione Il calcestruzzo armato I
 Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
Lezione Il calcestruzzo armato I Sommario Il calcestruzzo armato Il comportamento a compressione Il comportamento a trazione Il calcestruzzo armato Il cemento armato Il calcestruzzo armato Il calcestruzzo
VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DELL ADDITIVO PENETRON ADMIX IN CALCESTRUZZI CON VARIE CLASSI DI RESISTENZA E DURABILITA
 Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO
 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO Firenze, lunedì 8 gennaio 2007 miscelazione di uno o più leganti con acqua, inerti fini (sabbia), inerti grossi ed eventuali additivi
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IL CALCESTRUZZO Firenze, lunedì 8 gennaio 2007 miscelazione di uno o più leganti con acqua, inerti fini (sabbia), inerti grossi ed eventuali additivi
Corso di Laurea in Ingegneria Edile
 Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Dip. di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale Università Federico II di Napoli Corso di Laurea in Ingegneria Edile Corso di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Prof.
Cause del degrado. Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità. Corrosione. Passivazione dell armatura. Carbonatazione.
 Cause del degrado Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità 1 - Corrosione delle armature promossa da: - carbonatazione; - dal cloruro. - Attacco solfatico della matrice cementizia i -esterno; - interno.
Cause del degrado Degrado del calcestruzzo armato e Durabilità 1 - Corrosione delle armature promossa da: - carbonatazione; - dal cloruro. - Attacco solfatico della matrice cementizia i -esterno; - interno.
CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R
 CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 97- CEM II/A-LL 42,5 R stagionatura Questo cemento contiene dal 80% al 94% di clinker e dal 6% al 20% di calcare. Da questi valori sono esclusi, secondo la UNI EN 97-,
CEMENTO PORTLAND AL CALCARE UNI EN 97- CEM II/A-LL 42,5 R stagionatura Questo cemento contiene dal 80% al 94% di clinker e dal 6% al 20% di calcare. Da questi valori sono esclusi, secondo la UNI EN 97-,
Requisiti per il calcestruzzo fresco Consistenza:
 Definizione I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi Materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue
Definizione I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi Materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue
4 Durabilità delle strutture 1.a parte
 4 Durabilità delle strutture 1.a parte Una struttura in cemento armato è soggetta a molteplici azioni che intaccano i materiali che la costituiscono con il suo inevitabile degrado. Il deterioramento del
4 Durabilità delle strutture 1.a parte Una struttura in cemento armato è soggetta a molteplici azioni che intaccano i materiali che la costituiscono con il suo inevitabile degrado. Il deterioramento del
DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola L. Coppola Concretum Introduzione alla durabilità D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO INTRODUZIONE Prof. Ing. Luigi Coppola L. Coppola Concretum Introduzione alla durabilità D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE
VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEL PENETRON STANDARD IN CALCESTRUZZI POROSI O FESSURATI
 Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Laboratorio AUTORIZZATO dal Ministero dei Lavori Pubblici (per prove secondo L 1086/71 DM 52655 del 24/11/2004) RICONOSCIUTO dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (art.
Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione
 Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione PRESCRIZIONE DURABILITA classi di esposizione CONTROLLI DI ACCETTAZIONE page 71 Prescrizione APPROFONDIMENTI PRESTAZIONE GARANTITA Classe di resistenza
Prescrizione, Durabilità, Controlli di accettazione PRESCRIZIONE DURABILITA classi di esposizione CONTROLLI DI ACCETTAZIONE page 71 Prescrizione APPROFONDIMENTI PRESTAZIONE GARANTITA Classe di resistenza
Tecnocomponenti S.p.A.
 Ing. Andrea riboli Tecnocomponenti http://www.tecnocomponenti.com ING. ANDREA RIBOLI Pagina 1 PREMESSA La fessurazione è il problema tecnico più frequente che si manifesta nei pannelli prefabbricati principalmente
Ing. Andrea riboli Tecnocomponenti http://www.tecnocomponenti.com ING. ANDREA RIBOLI Pagina 1 PREMESSA La fessurazione è il problema tecnico più frequente che si manifesta nei pannelli prefabbricati principalmente
STRUTTURE DI ELEVAZIONE IN CLIMI TEMPERATI
 2 STRUTTURE DI ELEVAZIONE IN CLIMI TEMPERATI Questa sezione è dedicata al calcestruzzo destinato alle strutture di elevazione di edifici residenziali, edifici pubblici o adibiti ad attività commerciali
2 STRUTTURE DI ELEVAZIONE IN CLIMI TEMPERATI Questa sezione è dedicata al calcestruzzo destinato alle strutture di elevazione di edifici residenziali, edifici pubblici o adibiti ad attività commerciali
Durabilità e classe di esposizione del calcestruzzo
 Durabilità e classe di esposizione del Durabilità Per garantire la durabilità delle strutture in armato ordinario o precompresso, esposte all azione dell ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti
Durabilità e classe di esposizione del Durabilità Per garantire la durabilità delle strutture in armato ordinario o precompresso, esposte all azione dell ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti
FLUECO 80 T VANTAGGI CAMPI DI IMPIEGO ZER CRACK. LINEA RESTAURO e PROTEZIONE.
 LINEA RESTAURO e PROTEZIONE MALTE TIXOTROPICHE A BASE CEMENTIZIA PER IL RESTAURO EN 1504-2 1504-3 UNI EN 1504-3 ZER CRACK TECHNOLOGY TECHNOLOGY NEW! NEW FORMULA SO42- SULPHATE RESISTANT LAYER THICKNESSES
LINEA RESTAURO e PROTEZIONE MALTE TIXOTROPICHE A BASE CEMENTIZIA PER IL RESTAURO EN 1504-2 1504-3 UNI EN 1504-3 ZER CRACK TECHNOLOGY TECHNOLOGY NEW! NEW FORMULA SO42- SULPHATE RESISTANT LAYER THICKNESSES
INDICE. Premessa, 1. Parte I Introduzione ai materiali
 INDICE Premessa, 1 Parte I Introduzione ai materiali 1. Struttura dei materiali, 5 1.1 Proprietà dei materiali, 6 1.2 Studio della struttura dei materiali, 7 1.2.1 Struttura a livello macroscopico, 10
INDICE Premessa, 1 Parte I Introduzione ai materiali 1. Struttura dei materiali, 5 1.1 Proprietà dei materiali, 6 1.2 Studio della struttura dei materiali, 7 1.2.1 Struttura a livello macroscopico, 10
CONTESTAZIONI NELLE OPERE IN C.A. ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI (D.M. 14 GENNAIO 2008)
 CONTESTAZIONI NELLE OPERE IN C.A. ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI (D.M. 14 GENNAIO 2008) Anno XIII - Numero 42-2008 Silvia Collepardi, Direttore del Laboratorio Prove Materiali Enco,
CONTESTAZIONI NELLE OPERE IN C.A. ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI (D.M. 14 GENNAIO 2008) Anno XIII - Numero 42-2008 Silvia Collepardi, Direttore del Laboratorio Prove Materiali Enco,
I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1 Prof. Ing. Luigi Coppola NORMATIVA NORMA EUROPEA EN 197-1 regola la produzione dei cementi: requisiti composizionali,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA I CEMENTI COMUNI E LA NORMA EN 197-1 Prof. Ing. Luigi Coppola NORMATIVA NORMA EUROPEA EN 197-1 regola la produzione dei cementi: requisiti composizionali,
LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SECONDO LE NORMATIVE ITALIANA ED EUROPEA
 LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SECONDO LE NORMATIVE ITALIANA ED EUROPEA M. Collepardi* V. Corinaldesi +, S. Monosi +, A. Nardinocchi + *(ENCO, PONZANO VENETO) + (Università Politecnica
LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SECONDO LE NORMATIVE ITALIANA ED EUROPEA M. Collepardi* V. Corinaldesi +, S. Monosi +, A. Nardinocchi + *(ENCO, PONZANO VENETO) + (Università Politecnica
Lezione. Prof. Pier Paolo Rossi Università degli Studi di Catania
 Lezione PONTI E GRANDI STRUT TURE Prof. Pier Paolo Rossi Università degli Studi di Catania 1 RITIRO DEL CALCESTRUZZO 19 Ritiro del calcestruzzo Generalità Il termine ritiro indica la contrazione che si
Lezione PONTI E GRANDI STRUT TURE Prof. Pier Paolo Rossi Università degli Studi di Catania 1 RITIRO DEL CALCESTRUZZO 19 Ritiro del calcestruzzo Generalità Il termine ritiro indica la contrazione che si
Performo CEM I 52,5 R
 Performo CEM I 52,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Performo è un prodotto che viene utilizzato quasi esclusivamente per la confezione di calcestruzzi per i quali
Performo CEM I 52,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Performo è un prodotto che viene utilizzato quasi esclusivamente per la confezione di calcestruzzi per i quali
LE FUNZIONI BASE. Prof. Ing. Luigi Coppola UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
LE FUNZIONI BASE. Prof. Ing. Luigi Coppola UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA LE FUNZIONI BASE Prof. Ing. Luigi Coppola EQ. di POWERS e FUNZIONI BASE La funzione base per la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo
MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4
 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA PROVINCIA DI VITERBO RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA PROVINCIA DI VITERBO RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI PS_ST.R4 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
43 LA MATURAZIONE DEI GETTI
 43 LA MATURAZIONE DEI GETTI L a realizzazione di strutture in calcestruzzo armato eccellenti dal punto di vista della durabilità, delle capacità portanti e dei livelli di sicurezza generali dell opera
43 LA MATURAZIONE DEI GETTI L a realizzazione di strutture in calcestruzzo armato eccellenti dal punto di vista della durabilità, delle capacità portanti e dei livelli di sicurezza generali dell opera
Comune di MINERBIO REALIZZAZIONE DI n.2 ROTATORIE SU VIA RONCHI INFERIORE Progetto ESECUTIVO Relazione sui materiali SOMMARIO
 SOMMARIO 1 PREMESSA... 2 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 3 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 4 3.1 Calcestruzzo per magrone... 4 3.2 Calcestruzzo per fondazioni ed elevazioni... 4 3.3 Acciaio per cemento
SOMMARIO 1 PREMESSA... 2 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 3 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 4 3.1 Calcestruzzo per magrone... 4 3.2 Calcestruzzo per fondazioni ed elevazioni... 4 3.3 Acciaio per cemento
RETANOL EKA MATURITÀ DI POSA DOPO SOLI 5 GIORNI. GARANTITO. PCT ITALIA PERFORMANCE CHEMICALS
 RETANOL EKA MATURITÀ DI POSA DOPO SOLI 5 GIORNI. GARANTITO. PCT ITALIA PERFORMANCE CHEMICALS 3 RETANOL EKA SUBITO PRONTO PER LA POSA. 1. IMPIEGO Retanol EKA è l additivo ideale per realizzare massetti
RETANOL EKA MATURITÀ DI POSA DOPO SOLI 5 GIORNI. GARANTITO. PCT ITALIA PERFORMANCE CHEMICALS 3 RETANOL EKA SUBITO PRONTO PER LA POSA. 1. IMPIEGO Retanol EKA è l additivo ideale per realizzare massetti
Concreto CEM II/A-LL 42,5 R
 Concreto CEM II/A-LL 42,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Concreto è un prodotto che viene utilizzato per la confezione di calcestruzzi con resistenza caratteristica
Concreto CEM II/A-LL 42,5 R CEMENTO PER RIPRISTINI ED APPLICAZIONI STRUTTURALI Come si utilizza Concreto è un prodotto che viene utilizzato per la confezione di calcestruzzi con resistenza caratteristica
acqua cemento superfluidificante 10 nm Trimestrale Anno X Numero 32
 2006 Trimestrale Anno X Numero 32 Focus - Via delle Industrie, 18/20-31050 Ponzano Veneto (TV). Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N 46) art. 1, comma 1 DCB TV acqua
2006 Trimestrale Anno X Numero 32 Focus - Via delle Industrie, 18/20-31050 Ponzano Veneto (TV). Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N 46) art. 1, comma 1 DCB TV acqua
RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI DI IMPIEGO PER IL C.A.
 RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI DI IMPIEGO PER IL C.A. I sottoscritti progettisti delle strutture in cemento armato relative ai lavori in epigrafe, per l esecuzione delle strutture così come previste ed
RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI DI IMPIEGO PER IL C.A. I sottoscritti progettisti delle strutture in cemento armato relative ai lavori in epigrafe, per l esecuzione delle strutture così come previste ed
CALCESTRUZZI SPECIALI
 Il calcestruzzo e le strutture armate Calcestruzzi speciali INDICE 7 CALCESTRUZZI SPECIALI 7.2 7.4 CALCESTRUZZI PESANTI CALCESTRUZZI FIBRO- RINFORZATI 7.6 CALCESTRUZZI A RITIRO COMPENSATO 7.1 CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo e le strutture armate Calcestruzzi speciali INDICE 7 CALCESTRUZZI SPECIALI 7.2 7.4 CALCESTRUZZI PESANTI CALCESTRUZZI FIBRO- RINFORZATI 7.6 CALCESTRUZZI A RITIRO COMPENSATO 7.1 CALCESTRUZZI
#smartfiber. Calcestruzzi strutturali fibrorinforzati DESCRIZIONE E APPLICAZIONI
 DESCRIZIONE E APPLICAZIONI I calcestruzzi denominati commercialmente con il termine #smartfiber sono confezionati mediante l impiego di un rinforzo discreto in forma di fibre in aggiunta ai tradizionali
DESCRIZIONE E APPLICAZIONI I calcestruzzi denominati commercialmente con il termine #smartfiber sono confezionati mediante l impiego di un rinforzo discreto in forma di fibre in aggiunta ai tradizionali
MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA MECCANISMI DI IDRATAZIONE E MICROSTRUTTURA DELLA PASTA CEMENTIZIA Prof. Ing. Luigi Coppola IL MECCANISMO DI IDRATAZIONE DEL CEMENTO: PRESA E INDURIMENTO
Planitop Rasa & Ripara R4
 Planitop Rasa & Ripara R4 MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R4 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo Planitop
Planitop Rasa & Ripara R4 MALTA CEMENTIZIA DI CLASSE R4 A PRESA RAPIDA PER LA RIPARAZIONE E LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO solo prodotto per rasare e ripristinare le superfi ci in 1calcestruzzo Planitop
29/09/2011 OBBLIGHI DI LEGGE
 OBBLIGHI DI LEGGE LineeGuidaper la Produzione, iltrasportoe ilcontrollodel Calcestruzzo Preconfezionato del 07/02/2003 (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) Par. 5.3.1 Tipo e quantità di ogni eventuale
OBBLIGHI DI LEGGE LineeGuidaper la Produzione, iltrasportoe ilcontrollodel Calcestruzzo Preconfezionato del 07/02/2003 (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) Par. 5.3.1 Tipo e quantità di ogni eventuale
LEZIONE 8. PROGETTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Parte I. Il materiale. Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A.
 Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 8 PROGETTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Parte I. Il materiale BIBLIOGRAFIA
Corso di TECNICA DELLE COSTRUZIONI Chiara CALDERINI A.A. 2007-2008 Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova LEZIONE 8 PROGETTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Parte I. Il materiale BIBLIOGRAFIA
ing. Lorenzo De Carli Divisione Grandi Progetti Progettare e costruire con Mapei 2019
 ing. Lorenzo De Carli Divisione Grandi Progetti Progettare e costruire con Mapei 2019 DAL RIPRISTINO AL RINFORZO DEGLI EDIFICI EISISTENTI APPROCCIO ORGANICO TRA DIAGNOSTICA, SOLUZIONI DI INTERVENTO E MATERIALI
ing. Lorenzo De Carli Divisione Grandi Progetti Progettare e costruire con Mapei 2019 DAL RIPRISTINO AL RINFORZO DEGLI EDIFICI EISISTENTI APPROCCIO ORGANICO TRA DIAGNOSTICA, SOLUZIONI DI INTERVENTO E MATERIALI
Pavimenti industriali in calcestruzzo senza rete metallica in assenza di stagionatura umida
 Pavimenti industriali in calcestruzzo senza rete metallica in assenza di stagionatura umida Mario Collepardi, Silvia Collepardi, Jean Jacob Ogoumah Olagot, Roberto Troli Enco srl (info@encosrl.it) 1. INTRODUZIONE
Pavimenti industriali in calcestruzzo senza rete metallica in assenza di stagionatura umida Mario Collepardi, Silvia Collepardi, Jean Jacob Ogoumah Olagot, Roberto Troli Enco srl (info@encosrl.it) 1. INTRODUZIONE
C E R T I F I CAT I. Ruredil. Microfibre
 PRODOTTI C E R T I F I CAT I Ruredil Microfibre INNOVAZIONE STRUTTURALE RUREDIL X Fiber 19 Fibra STRUTTURALE sintetica Ruredil X Fiber 19 è una fibra sintetica strutturale che migliora la durabilità e
PRODOTTI C E R T I F I CAT I Ruredil Microfibre INNOVAZIONE STRUTTURALE RUREDIL X Fiber 19 Fibra STRUTTURALE sintetica Ruredil X Fiber 19 è una fibra sintetica strutturale che migliora la durabilità e
ESERCITAZIONI: Strutture massive
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI: Strutture massive Prof. Ing. Luigi Coppola STRUTTURE MASSIVE Nelle STRUTTURE DI GRANDE SPESSORE a causa della modesta conducibilità
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA ESERCITAZIONI: Strutture massive Prof. Ing. Luigi Coppola STRUTTURE MASSIVE Nelle STRUTTURE DI GRANDE SPESSORE a causa della modesta conducibilità
RINFORZO A PRESSO-FLESSIONE DI PILASTRI IN C.A. INCAMICIATURA CON MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI MECCANICHE
 RINFORZO A PRESSO-FLESSIONE DI PILASTRI IN C.A. INCAMICIATURA CON MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI MECCANICHE Descrizione modalità di crisi Crisi per presso-flessione o per
RINFORZO A PRESSO-FLESSIONE DI PILASTRI IN C.A. INCAMICIATURA CON MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI MECCANICHE Descrizione modalità di crisi Crisi per presso-flessione o per
ESERCITAZIONI: Strutture massive
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE ESERCITAZIONI: Strutture massive Prof. Ing. Luigi Coppola STRUTTURE MASSIVE Nelle STRUTTURE DI GRANDE SPESSORE a causa della
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE ESERCITAZIONI: Strutture massive Prof. Ing. Luigi Coppola STRUTTURE MASSIVE Nelle STRUTTURE DI GRANDE SPESSORE a causa della
ANALISI DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO IN C.A. DELLA AIUOLE INTERNE AL CORTILE
 ANALISI DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO IN C.A. DELLA AIUOLE INTERNE AL CORTILE Anomalie riscontrate Localizzazione Espulsione del copriferro, efflorescenza sulla superficie, fessurazione, mancanza di
ANALISI DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO IN C.A. DELLA AIUOLE INTERNE AL CORTILE Anomalie riscontrate Localizzazione Espulsione del copriferro, efflorescenza sulla superficie, fessurazione, mancanza di
Effetto combinato di agente espansivo e additivo riduttore di ritiro sulle prestazioni di malte fibrorinforzate
 Effetto combinato di agente espansivo e additivo riduttore di ritiro sulle prestazioni di malte fibrorinforzate V. Corinaldesi 1, S. Monosi 1, A. Nardinocchi 1, M. Collepardi 2 1 Dipartimento SIMAU, Università
Effetto combinato di agente espansivo e additivo riduttore di ritiro sulle prestazioni di malte fibrorinforzate V. Corinaldesi 1, S. Monosi 1, A. Nardinocchi 1, M. Collepardi 2 1 Dipartimento SIMAU, Università
Prodotti per calcestruzzi e massetti
 Prodotti per calcestruzzi e massetti Prodotti per calcestruzzi e massetti Mapei S.p.A. contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali
Prodotti per calcestruzzi e massetti Prodotti per calcestruzzi e massetti Mapei S.p.A. contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali
STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA
 4 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA Questa sezione è dedicata alle opere per le quali si richiedono requisiti di tenuta idraulica e, pertanto, essa riguarda le prescrizioni di capitolato per le strutture interrate
4 STRUTTURE A TENUTA IDRAULICA Questa sezione è dedicata alle opere per le quali si richiedono requisiti di tenuta idraulica e, pertanto, essa riguarda le prescrizioni di capitolato per le strutture interrate
Calcestruzzo indurito
 Calcestruzzo indurito Proprietà principali durabilità proprietà meccaniche scorrimento viscoso (creep) proprietà termiche (a) proprietà meccaniche la elevata resistenza meccanica del calcestruzzo deriva
Calcestruzzo indurito Proprietà principali durabilità proprietà meccaniche scorrimento viscoso (creep) proprietà termiche (a) proprietà meccaniche la elevata resistenza meccanica del calcestruzzo deriva
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE IL DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: ANALISI, DIAGNOSI ED INTERVENTI DI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE IL DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: ANALISI, DIAGNOSI ED INTERVENTI DI
IN.TEC. Soc. Cooperativa
 L I S T I N O E T A R I F F E Decorrenza : 04-05-2015 Pagina : 21 CC001 CC002 CC003 PRELIEVO, in cantiere o all'impianto, di CALCESTRUZZO FRESCO, determinazione della TEMPERATURA del calcestruzzo ( UNI
L I S T I N O E T A R I F F E Decorrenza : 04-05-2015 Pagina : 21 CC001 CC002 CC003 PRELIEVO, in cantiere o all'impianto, di CALCESTRUZZO FRESCO, determinazione della TEMPERATURA del calcestruzzo ( UNI
Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato.
 ESERCIZIO 1 Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato. a) Indicare quali prodotti si formano durante la presa del cemento portland e spiegare perché le armature
ESERCIZIO 1 Un importante materiale da costruzione nell ingegneria civile è il calcestruzzo armato. a) Indicare quali prodotti si formano durante la presa del cemento portland e spiegare perché le armature
Dal progetto, al cantiere. Pavimentazione strutturale per impianto sportivo polifunzionale Molteno (LC)
 Dal progetto, al cantiere -- Pavimentazione strutturale per impianto sportivo polifunzionale Molteno (LC) Introduzione Le pavimentazioni in calcestruzzo spesso vengono concepite come struttura completamente
Dal progetto, al cantiere -- Pavimentazione strutturale per impianto sportivo polifunzionale Molteno (LC) Introduzione Le pavimentazioni in calcestruzzo spesso vengono concepite come struttura completamente
INDICE INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA... 2 MATERIALI... 3 INDICE... 1
 INDICE INDICE... 1 INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA... 2 MATERIALI... 3 INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA Il presente progetto strutturale è finalizzato all adeguamento sismico della struttura della Scuola Materna Nicholas
INDICE INDICE... 1 INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA... 2 MATERIALI... 3 INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA Il presente progetto strutturale è finalizzato all adeguamento sismico della struttura della Scuola Materna Nicholas
DEPOSITO SISMICO del Progetto Strutturale per l Ampiamento e Completamento di Area Attrezzata per Emergenze della Protezione Civile Rolo (RE) INDICE
 Pag. 1 di 10 INDICE 3 RELAZIONE SUI MATERIALI... 2 3.1 Elenco dei materiali impiegati e loro modalità di posa in opera... 2 3.2 Valori di calcolo... 3 3.3 Note specifiche per la posa in opera e la certificazione
Pag. 1 di 10 INDICE 3 RELAZIONE SUI MATERIALI... 2 3.1 Elenco dei materiali impiegati e loro modalità di posa in opera... 2 3.2 Valori di calcolo... 3 3.3 Note specifiche per la posa in opera e la certificazione
RELAZIONE SUI MATERIALI
 CALCESTRUZZO... 2 ACCIAIO PER ARMATURE C.A.... 3 ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA... 4 BULLONI... 5 INDICAZIONI GENERALI... 6 TENSIONI DI PROGETTO (SLU)... 8 1/8 RELAZIONE SUI MATERIALI (ai sensi dell'art.
CALCESTRUZZO... 2 ACCIAIO PER ARMATURE C.A.... 3 ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA... 4 BULLONI... 5 INDICAZIONI GENERALI... 6 TENSIONI DI PROGETTO (SLU)... 8 1/8 RELAZIONE SUI MATERIALI (ai sensi dell'art.
CALCESTRUZZO... Errore. Il segnalibro non è definito. ACCIAIO PER ARMATURE C.A... 3 INDICAZIONI GENERALI... 4 TENSIONI DI PROGETTO (SLU)...
 CALCESTRUZZO... Errore. Il segnalibro non è definito. ACCIAIO PER ARMATURE C.A.... 3 INDICAZIONI GENERALI... 4 TENSIONI DI PROGETTO (SLU)...6 1/7 RELAZIONE SUI MATERIALI (ai sensi dell'art. 65 del D.P.R.
CALCESTRUZZO... Errore. Il segnalibro non è definito. ACCIAIO PER ARMATURE C.A.... 3 INDICAZIONI GENERALI... 4 TENSIONI DI PROGETTO (SLU)...6 1/7 RELAZIONE SUI MATERIALI (ai sensi dell'art. 65 del D.P.R.
11.1 11.2 11.3 11.4 INDICE. Degradi del calcestruzzo e prevenzioni DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CAUSE CHIMICHE CORROSIONE DELLE ARMATURE
 INDICE 11 11.2 11.4 DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CORROSIONE DELLE ARMATURE CAUSE MECCANICHE- STRUTTURALI 11.1 CAUSE CHIMICHE 11.3 CAUSE FISICHE DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI 11 DEGRADI
INDICE 11 11.2 11.4 DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI CORROSIONE DELLE ARMATURE CAUSE MECCANICHE- STRUTTURALI 11.1 CAUSE CHIMICHE 11.3 CAUSE FISICHE DEGRADI DEL CALCESTRUZZO E PREVENZIONI 11 DEGRADI
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Linee guida per l utilizzo di travi travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell autorizzazione
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Linee guida per l utilizzo di travi travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell autorizzazione
1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione
 1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione La presente relazione illustra i materiali il cui uso è prescritto per la realizzazione delle opere previste in progetto e
1. Premesse, Normative di riferimento criteri di qualificazione e accettazione La presente relazione illustra i materiali il cui uso è prescritto per la realizzazione delle opere previste in progetto e
BBC Betonrossi Basic Concrete a cura di Luigi Coppola e del Servizio Tecnologico di Betonrossi S.p.A.
 44 IL GETTO DEL CALCESTRUZZO IN CLIMA CALDO O FREDDO I l confezionamento, la posa in opera e la maturazione del calcestruzzo avvengono a temperature che possono oscillare, almeno nei nostri climi, nel
44 IL GETTO DEL CALCESTRUZZO IN CLIMA CALDO O FREDDO I l confezionamento, la posa in opera e la maturazione del calcestruzzo avvengono a temperature che possono oscillare, almeno nei nostri climi, nel
ESERCITAZIONI TEMI DI ESAME
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE ESERCITAZIONI TEMI DI ESAME Prof. Ing. Luigi Coppola ESERCIZIO Si debba realizzare una pavimentazione di un piazzale esterno
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE ESERCITAZIONI TEMI DI ESAME Prof. Ing. Luigi Coppola ESERCIZIO Si debba realizzare una pavimentazione di un piazzale esterno
Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi
 Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi Il calcestruzzo con aggregati di riciclo: problematiche tecnologiche e caratteristiche Ing. Luca Cominoli
Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi Il calcestruzzo con aggregati di riciclo: problematiche tecnologiche e caratteristiche Ing. Luca Cominoli
BBC Betonrossi Basic Concrete a cura di Luigi Coppola e del Servizio Tecnologico di Betonrossi S.p.A.
 8 I CEMENTI COMUNI E LA NORMA UNIEN 1971 I cementi disponibili in commercio sono principalmente costituiti da miscele di cemento Portland con materiali pozzolanici, materiali pozzolanici a comportamento
8 I CEMENTI COMUNI E LA NORMA UNIEN 1971 I cementi disponibili in commercio sono principalmente costituiti da miscele di cemento Portland con materiali pozzolanici, materiali pozzolanici a comportamento
CENERE PESANTE DA INCENERITORI DI RESIDUI SOLIDI URBANI IN CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI AD ALTE PRESTAZIONI
 CENERE PESANTE DA INCENERITORI DI RESIDUI SOLIDI URBANI IN CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI AD ALTE PRESTAZIONI Silvia Collepardi*, Mario Collepardi*, Giacomo Iannis**, Alessandro Quadrio Curzio*** *Enco,
CENERE PESANTE DA INCENERITORI DI RESIDUI SOLIDI URBANI IN CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI AD ALTE PRESTAZIONI Silvia Collepardi*, Mario Collepardi*, Giacomo Iannis**, Alessandro Quadrio Curzio*** *Enco,
Mario Collepardi Politecnico Milano - Dipartimento di Chimica-Fisica Applicata
 IL MATERIALE NON E LA STRUTTURA. E LA CAROTA NON E IL PROVINO INTRODUZIONE Mario Collepardi Politecnico Milano - Dipartimento di Chimica-Fisica Applicata La resistenza meccanica del materiale calcestruzzo,
IL MATERIALE NON E LA STRUTTURA. E LA CAROTA NON E IL PROVINO INTRODUZIONE Mario Collepardi Politecnico Milano - Dipartimento di Chimica-Fisica Applicata La resistenza meccanica del materiale calcestruzzo,
CALCESTRUZZI DUREVOLI
 CALCESTRUZZI DUREVOLI In base alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, la durabilità di una struttura in c.a. è il risultato dell azione di quattro attori che intervengono alla sua realizzazione: Il
CALCESTRUZZI DUREVOLI In base alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, la durabilità di una struttura in c.a. è il risultato dell azione di quattro attori che intervengono alla sua realizzazione: Il
Prof. Ing. Luigi Coppola. L. Coppola Cum Solidare Introduzione al restauro delle strutture in calcestruzzo
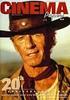 INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
INTRODUZIONE AL RESTAURO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola SISTEMI E PRODOTTI PER L ANCORAGGIO Per ancorare le armature al calcestruzzo Per sigillare o riempire cavità al fine di
CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI
 CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI Negli ambienti naturali, cui sono esposte la maggior parte delle infrastrutture e costruzioni civili le reazioni di corrosione seguono un meccanismo elettrochimico.
CORROSIONE DELL ACCIAIO NEGLI AMBIENTI NATURALI Negli ambienti naturali, cui sono esposte la maggior parte delle infrastrutture e costruzioni civili le reazioni di corrosione seguono un meccanismo elettrochimico.
POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola RESISTENZA A COMPRESSIONE paste
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTA DI INGEGNERIA POROSITA DELLA MATRICE CEMENTIZIA E RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Prof. Ing. Luigi Coppola RESISTENZA A COMPRESSIONE paste
Sommario 1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Calcestruzzi Materiali metallici RELAZIONE SUI MATERIALI Pag.
 Sommario 1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 2 1.1.1 Calcestruzzi... 2 1.1.2 Materiali metallici... 3 RELAZIONE SUI MATERIALI Pag. 1 di 4 1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Per le strutture in oggetto, sono
Sommario 1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI... 2 1.1.1 Calcestruzzi... 2 1.1.2 Materiali metallici... 3 RELAZIONE SUI MATERIALI Pag. 1 di 4 1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Per le strutture in oggetto, sono
IL RUOLO DEGLI ADDITIVI ACRILICI NELL SCC. Ing.. M. Casali Comitato Tecnico Promozionale ASSIAD
 IL RUOLO DEGLI ADDITIVI ACRILICI NELL SCC Ing.. M. Casali Comitato Tecnico Promozionale ASSIAD Definizione Si definisce autocompattante un calcestruzzo che possiede allo stato fresco: elevata fluidità
IL RUOLO DEGLI ADDITIVI ACRILICI NELL SCC Ing.. M. Casali Comitato Tecnico Promozionale ASSIAD Definizione Si definisce autocompattante un calcestruzzo che possiede allo stato fresco: elevata fluidità
Chimica Edile Group & CHIMICA EDILE S.R.L.
 Chimica Edile Group & CHIMICA EDILE S.R.L. Presentano il nuovo additivo per il miglioramento dei calcestruzzi e per la realizzazione di pavimenti industriali senza giunti. DRY D1 NG Additivo/aggiunta per
Chimica Edile Group & CHIMICA EDILE S.R.L. Presentano il nuovo additivo per il miglioramento dei calcestruzzi e per la realizzazione di pavimenti industriali senza giunti. DRY D1 NG Additivo/aggiunta per
Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo
 Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo Bologna, 20 Giugno 2007 Roberto Marino 1 Quadro legislativo Legge n 1086 del 5/11/ 71 D.M.del 9/1/96 Circolare Ministero LL.PP. (15 ottobre 1996)
Cause di degrado e prescrizioni minime del calcestruzzo Bologna, 20 Giugno 2007 Roberto Marino 1 Quadro legislativo Legge n 1086 del 5/11/ 71 D.M.del 9/1/96 Circolare Ministero LL.PP. (15 ottobre 1996)
PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP
 Giornata di Aggiornamento su Degrado e Consolidamento delle Strutture in Cemento Armato Firenze, 30 novembre 2007. PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP prof. ing. Sergio Tattoni Università
Giornata di Aggiornamento su Degrado e Consolidamento delle Strutture in Cemento Armato Firenze, 30 novembre 2007. PROGETTARE LA DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CA E CAP prof. ing. Sergio Tattoni Università
BBC Betonrossi Basic Concrete a cura di Luigi Coppola e del Servizio Tecnologico di Betonrossi S.p.A.
 48 I CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI C on il termine di calcestruzzi fibrorinforzati (o fibrosi) si identificano quei conglomerati prodotti impiegando oltre alle tradizionali materie prime un rinforzo discreto
48 I CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI C on il termine di calcestruzzi fibrorinforzati (o fibrosi) si identificano quei conglomerati prodotti impiegando oltre alle tradizionali materie prime un rinforzo discreto
Ossature portanti di calcestruzzo armato. Generalità
 Generalità Generalità Generalità / il telaio Generalità / il telaio I vincoli esterni devono essere sovrabbondanti TELAI TRAVI (A PORTALE) Generalità / comportamento del telaio soggetto al carico P P P
Generalità Generalità Generalità / il telaio Generalità / il telaio I vincoli esterni devono essere sovrabbondanti TELAI TRAVI (A PORTALE) Generalità / comportamento del telaio soggetto al carico P P P
