Costanzo Di Girolamo Modernità dei Siciliani
|
|
|
- Marcellina Poletti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tabulae del Centro studi federiciani 23 (2011) Costanzo Di Girolamo Modernità dei Siciliani Costanzo Di Girolamo è professore di Filologia e linguistica romanza all Università di Napoli Federico II. COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA DELL AUTORE
2 Costanzo Di Girolamo Modernità dei Siciliani La recente edizione de I poeti della Scuola siciliana, apparsa nel 2008, ha riproposto, offrendolo a una nuova valorizzazione, il prezioso tesoro della lirica italiana d arte delle origini 1. Questa è una sua breve scheda. L edizione del 2008 è la prima edizione critica, integrale e accompagnata da un puntuale e ampio commento, dei poeti federiciani e siculo-toscani. La precedente edizione critica, pubblicata nel da Bruno Panvini ( ), era infatti senza commento 2. Anche senza commento era l edizione di Giacomo da Lentini allestita da Roberto Antonelli nel 1979, di cui apparve solo il vol. I (il vol. II avrebbe ospitato il commento) 3. La nuova edizione riprende, con diverse modifiche e aggiunte che riguardano principalmente i poeti siculo-toscani, il canone di Panvini, già recepito e ritoccato da Antonelli nel suo Repertorio metrico 4. L edizione in numeri pagine. Il lavoro ha avuto la durata di 11 anni: iniziato nel 1998, si è concluso nel Ha visto la partecipazione di 14 editori 1 I poeti della Scuola siciliana. Edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani: vol. I. Giacomo da Lentini, edizione critica con commento a cura di R. ANTONELLI; vol. II. Poeti della corte di Federico II, edizione critica con commento diretta da C. DI GIROLAMO; vol. III. Poeti siculo-toscani, edizione critica con commento diretta da R. COLUCCIA, Milano, Mondadori, 2008 (qui sopra e avanti citata con la sigla PSs seguita dal numero d ordine dell autore e, per ciascun autore, del componimento). 2 B. PANVINI, Le rime della Scuola siciliana, I. Introduzione, testo critico, note, II. Glossario, Firenze, Olschki, Giacomo da Lentini, Poesie, edizione critica a cura di R. ANTONELLI, I. Introduzione, testo, apparato, Roma, Bulzoni, R. ANTONELLI, Repertorio metrico della Scuola poetica siciliana, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani,
3 (uno per il vol. I; 9 per il vol. II; 5 per il vol. III, di cui uno in comune con il vol. II); 3 curatori (uno per volume; per il vol. I: curatore = editore). In 11 anni, cioè in 132 mesi, la somma dei mesi di lavoro dei 14 editori è stata di 1848 mesi, cioè di 154 anni. Se l editore fosse stato uno solo, avrebbe dunque impiegato 154 anni per terminare l opera. E ho tenuto fuori dal conto il lavoro dei curatori. Il corpus dei Siciliani in senso stretto, cioè dei poeti cosiddetti federiciani, con esclusione dei Siculo-toscani, annovera 25 autori, titolari di 120 componimenti, a cui vanno aggiunti 30 componimenti anonimi. Quello dei Siculo-toscani presenta un numero leggermente inferiore di autori, 23, a cui si assegnano 69 componimenti, ma un numero molto maggiore di componimenti anonimi, 109. Per i Siculo-toscani qui i numeri sono ovviamente quelli ricavabili dal nuovo canone di Coluccia, che come ho già detto modifica quello di Panvini e di Antonelli. Resta il fatto che, se si possono identificare con una certa facilità i primi continuatori dei Siciliani, è poi problematico chiudere l elenco in basso, perché l influenza dei padri fondatori nell Italia centrale si prolunga, più o meno diluita, per molti decenni fino all inizio del Trecento. La distinzione tra Siciliani e Siculo-toscani è quindi in qualche misura convenzionale e si basa principalmente sulla disposizione dei testi nel grande canzoniere Vaticano latino 3793, essenziale soprattutto per individuare i primi: ma di alcuni poeti etichettati come Siciliani non sappiamo nulla; di altri, come Stefano Protonotaro, sappiamo che erano sicuramente posteriori all epoca di Federico II; di altri ancora, come il senese Ruggeri Apugliese, che erano del tutto estranei all ambiente e ai luoghi della corte imperiale. Problematica è anche la collocazione dei componimenti anonimi nell ambito federiciano o in quello siculo-toscano: tuttavia, se prendiamo in blocco ciascuno dei due gruppi, le differenze di lingua e di stile poetico sono percepibili. Le etichette di cui ci stiamo servendo, Scuola siciliana e Siculotoscani, risalgono entrambe ai titoli di due libri: si sa che nei titoli bisogna essere concisi, a volte sommari e quando è necessario coraggiosi. Di «si- 28
4 cilianische Dichterschule» parlò per primo l italianista tedesco Adolf Gaspary ( ), che per un breve periodo fu allievo di Francesco De Sanctis a Napoli, in un libro del 1878 poi tradotto in italiano 5 : quella di scuola è nella storiografia letteraria un idea forte, messa in discussione in molti altri casi (a cominciare dal dolce stil novo e dal petrarchismo), che porta con sé il problema di distinguere i solisti dal coro; nel caso dei Siciliani, tuttavia, essa è passata finora in giudicato e senza pregiudizio per i non pochi solisti. L aggettivo (rimatori) «siculo-toscani» compare invece nel frontespizio di una raccolta di poeti del Duecento del 1915, curata da Guido Zaccagnini ( ) e Amos Parducci ( ) 6. Chi sono i Siciliani? La risposta più felice e sintetica l ha data Gianfranco Contini ( ): [Sono] i nostri primi rimatori cortesi, i trovatori in volgare d Italia; insomma, la colonia italiana della poesia occitanica, parallela, con qualche decennio di ritardo, alla francese del Nord, al Minnesang, alle cantigas de amor galaico-portoghesi 7. Entriamo a questo punto nel dettaglio delle colonie. Posto che le più antiche composizioni del primo trovatore a noi noto, Guglielmo di Poitiers ( ), risalgono presumibilmente alla fine del secolo XI, le prime colonie si affermano, contemporaneamente, a circa una settantina di anni dalla fondazione in lingua d oc: le più antiche canzoni dei trovieri e dei Minnesänger risalgono al 1170 circa. Seguono i lirici galegoportoghesi intorno all anno 1200 (il galego-portoghese non è una lingua 5 A. GASPARY, Die sicilianische Dichterschule des dreizehnten Jahrhunderts, Berlin, Weidmann, 1878; trad. it., La scuola poetica siciliana, Livorno, Vigo, Il libro era la sua tesi di dottorato presentata all Università di Berlino. 6 Rimatori siculo-toscani del Dugento. Serie I. Pistoiesi, Lucchesi, Pisani, a cura di G. ZACCAGNINI e A. PARDUCCI, Bari, Laterza, Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, 2 voll., Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, vol. I, p
5 mista medievale, come lo sono invece il franco-veneto o il francooccitano, bensì quella parlata nell attuale Galizia e Portogallo, una varietà all epoca unitaria e differenziatasi con il tempo per motivi storici). Tutte queste date vanno prese filosoficamente: è impensabile che il primo trovatore creasse dal nulla e da solo una poetica complessa, e lo stesso vale per le colonie: prima delle date che abbiamo indicato certamente ci sarà stata una produzione lirica di qualche tipo (importante e di una certa consistenza quella tedesca anteriore all influsso occitano). In tutte le aree il salto di qualità deve essere attribuito a due fattori: da un lato l adesione al modello lirico riconosciuto universalmente come il più alto e prestigioso, cioè quello dei trovatori; dall altro l intervento di personalità che hanno autorizzato (conferito autorità a) manifestazioni artistiche che prima dovevano essere di esclusiva competenza dei professionisti dell intrattenimento (i giullari), ammettendole a corte e semmai impregnandole di significati ideologici. È quanto deve essere avvenuto anche nel caso dei Siciliani. Riepiloghiamo, con qualche arrotondamento delle date, i segmenti cronologici su cui si dispongono le varie tradizioni liriche europee di matrice trobadorica e l entità del patrimonio testuale tramandatoci (qui pure con qualche arrotondamento delle cifre), che è sicuramente una frazione piccolissima di quello originariamente prodotto. PERIODO TESTI MELODIE Trovatori Trovieri Minnesänger ? 180 Trovatori galego-portoghesi Siciliani Siculo-toscani Come si potrà notare, noi siamo in grado di segnare anche la fine di 30
6 queste tradizioni, che in un paio di casi coincide con la fine della tradizione madre (1300 circa). Naturalmente, la data finale non significa il tramonto definitivo di una tradizione in una determinata lingua, ma in quasi tutti i casi (non in quello della poesia occitana, che decade irrimediabilmente) il suo rinnovamento, il suo trasformarsi in qualcosa d altro. La nostra tabella merita qualche altra spiegazione e considerazione. Anzitutto, per il corpus dei Minnesänger, nella colonna dei testi non c è un numero ma un punto interrogativo. Questo dipende dal fatto che i filologi germanici contano, codice per codice, non i componimenti ma le strofi. Non mi è stato perciò possibile trovare nella bibliografia questo dato. L ultima colonna registra il numero di melodie sopravvissute. Infatti, tutti i componimenti erano normalmente musicati dagli stessi autori dei testi (in occitano si distingue tra so suono, melodia e motz parole ) e cantati dai giullari o a volte dagli stessi autori. È evidente che il numero di melodie rappresenta una sottofrazione dei testi, perfino irrisoria per i galego-portoghesi. Ciò è in parte spiegabile con la difficoltà (e il costo) di allestire dei canzonieri musicali, che richiedevano l intervento di copisti in grado di trascrivere le melodie. In corrispondenza degli italiani non abbiamo nessun numero (e torneremo su questa anomalia). Infine, è degna di nota l esiguità del corpus italiano, che va poi necessariamente distinto nelle sue due componenti, benché la data del 1250, anno di morte di Federico II, sia meramente simbolica come termine della Scuola, come lo è quella del 1300 per i Siculo-toscani. E in realtà questi ultimi dipendono ancora dal modello transalpino principalmente attraverso i Federiciani. Molto schematicamente, ciascuna delle colonie innova in tre modi: 1) lasciando cadere alcuni caratteri della poetica dei trovatori; 2) modificandone sensibilmente alcuni caratteri; 3) aggiungendo nuovi caratteri. Cominciando dai trovieri, certamente la loro poesia è molto più monotona e, si è detto, formale ; mancano tra le loro file personalità forti, 31
7 inconfondibili, come nei trovatori; d altra parte, i trovieri sperimentano melodie molto articolate, veloci, adatte alla danza, che ammiccano a modalità popolareggianti. In alcuni Minnesänger la dama non è più l inaccessibile castellana ma, spesso, una donna di ceto più basso, il che permette il cosiddetto amore reciproco ; una parte della loro produzione è di carattere moralistico o sentenzioso (nel genere dello Spruch sentenza ), una vena poco diffusa tra i trovatori. I poeti galego-portoghesi, ripetitivi e lamentosi nelle canzoni d amore (le cantigas de amor), compongono canzoni in voce femminile (le cantigas de amigo), nelle quali introducono tecniche complesse e molto particolari (il procedimento parallelistico detto anche del leixa-pren, una sorta di ripetizione gradualmente variata); nasce inoltre un genere satirico specifico, vivace e virulento, quello delle cantigas de escarnho e de maldizer. E veniamo a questo punto alla colonia siciliana. I trovatori e i loro coloni continentali, come ho già detto, componevano, di regola, testo e melodia: erano cioè dei poeti e nello stesso tempo dei musicisti. Dei Siciliani non solo non ci è giunta nessuna melodia, ma non esiste nemmeno nessuna testimonianza dell uso di mettere in musica i testi, se non qualche rarissimo riferimento (più che alla musica, al ballo, e quindi indirettamente anche alla musica) interno ai componimenti, sicché si è pensato che formassero l unica colonia ad avere abbandonato la musica. In effetti questo è facilmente spiegabile. Quando parliamo della corte di Federico II dobbiamo immaginarci una corte mobile, che, del resto, solo per un tempo limitato ha avuto sede nell isola. Il luogo ideale per i poeti di acquisire competenze musicali è appunto la corte, dove sarebbero venuti a contatto con i musicisti, che sicuramente non mancavano mai attorno a re e baroni. Ma i Federiciani erano in buona parte funzionari di stato, non residenti stabili presso il loro signore, come potevano esserlo i trovatori e i giullari. Nonostante ciò, gli ultimi studi non escludono che almeno un esiguo numero di componimenti possa essere stato musicato, 32
8 non sappiamo se dagli autori o da musici professionisti. In ogni caso, è corretto pensare che con la Scuola siciliana nasce la prima poesia lirica in volgare per la lettura (da un libro) o più probabilmente per la recitazione davanti a un piccolo pubblico. Rispetto a tutte le altre tradizioni, viene meno il genere politico e satirico, particolarmente coltivato dai trovatori (con il sirventese) e dai galego-portoghesi (con la cantiga de escarnho e de maldizer). Si è sospettato che ciò sia imputabile alla censura imperiale; è però vero che i poeti greci della corte di Federico II intervenivano spesso su questioni politiche. Anche altri generi scompaiono, come per esempio la pastorella e l alba. E scompare anche la poesia feudale. I trovatori e i loro seguaci continentali mettevano in primo piano la metafora feudale: la dama è il signore, al maschile, rispetto all amante-vassallo, in occitano midons mio signore, in galego-portoghese mia senhor mia signore. Nei poeti federiciani la metafora feudale non è del tutto assente (come quando in Giacomo da Lentini leggiamo «Ben sai ch e son vostr omo» [PSs 1.13, v. 49], dove omo sta appunto per vassallo ), ma non è più centrale. Sulla bellezza della dama (e sulla religione) si può perfino scherzare, come nel sonetto di Giacomo da Lentini Io m aggio posto in core a Dio servire 8 : Io m aggio posto in core a Dio servire, com io potesse gire in paradiso, al santo loco ch aggio audito dire, o si mantien sollazzo, gioco e riso. Sanza mia donna non vi voria gire, quella ch à blonda testa e claro viso, che sanza lei non poteria gaudere, estando da la mia donna diviso. 8 Non tutte le citazioni che seguono sono di facile lettura: rimando ovviamente ai commenti dell edizione. 33
9 Ma no lo dico a tale intendimento perch io pecato ci vellesse fare, se non veder lo suo bel portamento e lo bel viso e 1 morbido sguardare: che l mi teria in gran consolamento veggendo la mia donna in ghiora stare. (Giacomo da Lentini, PSs 1.27; ed. R. Antonelli) E l amante può addirittura cantare di gioia, cosa alquanto eccezionale nei trovatori, per i quali il joy, il raggiungimento della felicità in amore, può esistere solo nel ricordo, nell attesa o nel sogno: Gioiosamente canto e vivo in allegranza, ca per la vostr amanza, madonna, gran gioia sento. S eo travagliai cotanto, or agio riposanza; ben agia disïanza che vene a compimento; ca tuto mal talento torna in gioi, quandunque la speranza vien dipoi; und eo m alegro di grande ardimento: un giorno vene, che val più di cento. (Guido delle Colonne, PSs 4.2, vv. 1-12; ed. C. Calenda) Situazione simile nella canzone di Stefano Protonotaro: Pir meu cori allegrari, ki multu longiamenti senza alligranza e ioi d amuri è statu, mi riturno in cantari, ca forsi levimenti la dimuranza turniria in usatu 34
10 di lu troppu taciri; e quandu l omu à rasuni di diri, ben di cantari e mustrari alligranza, ca senza dimustranza ioi siria sempri di pocu valuri; dunca ben de cantar onni amaduri. (PSs 11.3, vv. 1-12; ed. M. Pagano) Dove al primo verso il Pir introduce qui non una finale ( Per, Allo scopo di rallegrare il mio cuore ), ma, secondo una rara costruzione della parlata siciliana oggi ancora in vita (un infinitiva retta da per con un soggetto e- spresso distinto da quello della principale e preposto al verbo), una causale ( Poiché il mio cuore si rallegra, è pieno di gioia ; allegrari è impiegato in forma intransitiva non pronominale, rallegrarsi ). La canzone di Stefano è l unico componimento (a parte qualche frammento) nella lingua originale, o quasi, dei Siciliani, mentre tutto il resto del corpus ci è giunto toscanizzato ad opera dei copisti. La sua conservazione è dovuta a circostanze fortuite, riassunte dal filologo Santorre Debenedetti ( ): Giammaria Barbieri, espertissimo filologo modenese ( ), la trascrisse, con più altre composizioni provenienti da un codice oggi perduto, in un suo zibaldone, parimente sfuggito a tutte le ricerche, ch egli chiama Libro siciliano. Per nostra ventura il Barbieri l inserì nel trattato dell Arte del rimare, o Rimario, composto sul finire della vita e interrotto dalla morte, e rimasto oltre due secoli inedito, sinché [Girolamo] Tiraboschi [ ] non lo pubblicò [nel 1790], intitolandolo Origine della poesia rimata 9. 9 S. DEBENEDETTI, Le canzoni di Stefano Protonotaro: Parte I. La canzone siciliana (1932), rist. in ID., Studi filologici, con una nota di C. Segre, Franco Angeli, Milano 1986, p
11 La poesia dei trovatori e quella della maggior parte dei loro continuatori è fondata, tematicamente, sulla situazione dell adulterio, su quello che è stato chiamato da Aurelio Roncaglia ( ) il compromesso cortese 10, corollario del «paradosso amoroso» teorizzato dal critico viennese Leo Spitzer ( ) 11. Il paradosso consiste nel mirare a qualcosa di vietato e di perennemente inaccessibile: la dama è infatti sposata e inoltre di alto rango. Questo aspetto tragico appare attenuato nei Siciliani, anche se il personaggio di un marito (il gilos geloso dei trovatori, l antagonista per eccellenza) è evocato in un articolata maledizione che chiude un componimento anonimo, Amor voglio blasmare: Chi ntra noi partimento s intramise di fare agia da Dio tal guerra che nnonn-apara piui; così come lo vento la polver fa llevare che face de la terra, sì divegna di lui. No lle sia più marito, moia non-sopellito; chi da gioia e diporto ne levao e conforto sïa morto come gli ò profetato; vile troante, a lato bochi torto. (PSs 25.4, vv ; ed. M. Spampinato Beretta) 10 A. RONCAGLIA, Trobar clus : discussione aperta, «Cultura neolatina», 29, pp alle pp L. SPITZER, L amour lointain de Jaufré Rudel et le sens de la poésie des troubadours (1944), rist. in ID., Romanische Literaturstudien ( ), Tübingen, Niemeyer, 1959, pp
12 In un altra canzone anonima, L altrieri fui in parlamento, una malmaritata si lamenta con l amante della sua infelicità: L altrieri fui in parlamento con quella cui agio amata; fecemi grande lamento ch a forza fu maritata; e dissemi: «Drudo mio, merzé ti chero, or m aiuta, che tu sè in terra il mi dio, ne le tuo man so arenduta; per te collui non voglio io.... Drudo mio, da llui mi parte e trami d esta travaglia; mandamene in altra parte, che m è in piacer sanza faglia». «Donna, del tuo maritare lo mio cor forte mi duole; cosa nonn-è da disfare, rasgion so ben che nol vuole; ch io t amo sì lealmente, non vo che facie fallanza che ti biasmasse la gente ed io ne stesse in dotanza: dico il vero fermamente.... Così voglio che tu faccia, ed averai molta gioia: cando t avrò nuda in braccia 37
13 tuta andrà via la tua noia. Di così far ti procaccia!» (PSs 25.7, vv. 1-9, 28-36, 41-45; ed. M. Spampinato Beretta) Qui l uomo cerca di convincere la sua amante ad accettare le cose come stanno: è inutile fare follie ed essere criticati dalla gente; ci basteranno, per consolarci, i nostri incontri segreti. Il compromesso cortese si trasforma in compromesso borghese. E siamo anche lontani dalla tragedia in quest altro incontro clandestino, in cui la donna dà una piccola lezione di galateo amoroso all amante: Se avete fretta, andatevene subito, perché non è buona educazione smettere di punto in bianco di fare l amore e scappare via (m adomandai è 2 a o 3 a persona: mi dicesti o mi disse ): La dolce cera piasente e li amorosi sembianti lo cor m allegra e la mente quando le sono davanti. Sì volentieri la veio quella cui ëo amai, la bocca ch ëo basai ancor l aspetto e disio. L aulente bocca e le menne de lo petto le toccai, a le mie bracia la tenne; basando m adomandai: «Messere, se ve n ate a gire, non faciate adimoranza, che non è bona usanza lassar l amore e partire». (Giacomino Pugliese, PSs 17.6, vv. 1-16; ed. G. Brunetti) 38
14 In rapporto con l esiguità del corpus, si può dire che i Siciliani riservino un certo spazio alla voce delle donne, come nelle canzoni dialogate che abbiamo ora citato. Tutta al femminile è l accesa discussione, con insulti reciproci, tra una madre e una figlia in un componimento anonimo: alla giovane che vuole un marito la madre risponde con stantie immagini cortesi (l amore che confonde, la dolce saetta), esortandola ad avere pazienza; ma alle sue rinnovate rimostranze, comincia a sospettare che la figlia abbia già provato ciò che chiede. L epiteto vechia trenta cuoia significa vecchia befana, spaventapasseri :... «Oi madre bella, lungo tempo è passato ch io degio aver marito, e tu no llo m ài dato; quest è malvagio invito, ch io sofro, tapinella». La madre le risponde: «Figlia mia benedetta, se l amor ti confonde, de la dolce saetta ben ti puoi soferire: tempo non è passato, che tu porai avere ciò ch ài disiderato; rattèntene in distretta». «Per parole mi mene, tutor così dicendo; questo patto non fine, ed io tuta ardo e ncendo».... «Oi figlia, non pensai sì fosse mala tosa, 39
15 che ben conosco ormai di che se golïosa; che tanto m ài parlato non s avene a pulcella, credo che ll ài provato, sì ne sai la novella. Lascioti, dolorosa». «Oi vechia trenta cuoia, non mi stare in tenzone, se non vuoli ch io muoia o perda la persone; che lo cor mi sollaza membrando quella cosa che le donne sollaza, per ch amor ne riposa, ed io ne sto n arsione!» (PSs 25.15, vv. 4-31, 37-54; ed. M. Spampinato Beretta) Oltre alle voci femminili che affiorano nei dialoghi, il corpus contiene tre vere e proprie chansons de femme: due di Rinaldo d Aquino (PSs 7.6 e 7.10) e una anonima (PSs 25.1). Una delle due di Rinaldo è una canzone di crociata, Giamai non mi conforto, conosciuta anche come Lamento dell amante del crociato. In realtà si tratta di una canzone di crociata alla rovescia, perché la donna non nasconde il suo risentimento verso l imperatore e addirittura verso la croce, che sono la causa della sua separazione: Giamai non mi conforto né mi voglio ralegrare, le navi so giute al porto e vogliono collare, vassene lo più gente in tera d oltramare: 40
16 oimè, lassa dolente, como degio fare?... La croce salva la gente e me face disvïare, la croce mi fa dolente e non mi val Dio pregare. Oi croce pellegrina, perché m ài sì distrutta? Oimé, lassa tapina, ch i ardo e ncendo tuta! Lo mperadore con pace tuto lo mondo mantene ed a meve guerra face, che m à tolta la mia spene. Oit alta potestate temuta e dottata, la mia dolze amistate vi sia acomandata! (PSs 7.6, vv. 1-8, 25-40; ed. A. Comes) E c è infine un altro componimento, che per tanti aspetti, non in ultimo per la sua prorompente teatralità, si presenta come un unicum e in cui, come nelle pastorelle galloromanze, la voce femminile si alterna, strofe dopo strofe, a quella maschile: Rosa fresca aulentisima (PSs 16.1), uno dei capolavori della Scuola. Come si vede, se è vero che i Siciliani trasferiscono in un volgare italiano l inimitabile modello trobadorico, si rivelano poi in grado di rinnovarlo e di interpretarlo in maniera autonoma e originale dal punto di vista sia tematico sia anche formale, metrico in particolare: l abbandono della componente musicale è infatti come bilanciato da una maggiore 41
17 complessità della versificazione, soprattutto nella struttura della stanza della canzone, dettagliatamente descritta da Dante nel De vulgari eloquentia; e si aggiunga a ciò l invenzione della prima forma fissa della lirica europea, il sonetto. Si giustifica pertanto il titolo di queste pagine. I Siciliani sono moderni nella doppia accezione, medievale e (mi scuso per il gioco di parole) moderna dell aggettivo: alla loro epoca erano attuali, percepiti come nuovi, al punto che gettarono le basi della tradizione poetica italiana, a cui non poco deve, tramite il Trecento toscano, l intera tradizione europea; e sono moderni oggi, nell accezione più recente dell aggettivo, non antico, non superato, nel senso che, una volta scavalcati da parte nostra alcuni prevedibili ostacoli linguistici e interpretativi, i loro versi conservano un incisività e una freschezza che molta letteratura a noi più vicina nel tempo ha irrimediabilmente perduto. 42
La metrica: la canzone. Cfr. Beltrami, Gli strumenti della poesia, p
 La metrica: la canzone Cfr. Beltrami, Gli strumenti della poesia, p. 99-102 De vulgari eloquentia II 3 Ma cerchiamo ora di indagare accuratamente in quale forma metrica si debbano stringere i temi che
La metrica: la canzone Cfr. Beltrami, Gli strumenti della poesia, p. 99-102 De vulgari eloquentia II 3 Ma cerchiamo ora di indagare accuratamente in quale forma metrica si debbano stringere i temi che
Matematica e poesia. alla ricerca di un numero misterioso
 Matematica e poesia alla ricerca di un numero misterioso Il sonetto È possibile fare uno studio di tipo matematico su una poesia? C'è un rapporto fra i numeri di cui si serve la matematica e le parole
Matematica e poesia alla ricerca di un numero misterioso Il sonetto È possibile fare uno studio di tipo matematico su una poesia? C'è un rapporto fra i numeri di cui si serve la matematica e le parole
La scuola siciliana prima metà XIII sec.
 La scuola siciliana prima metà XIII sec. Giacomo da Lentini Amor è uno desio che ven da core Amor è uno desio che ven da core per abbondanza di gran piacimento; e li occhi in prima generan l'amore e lo
La scuola siciliana prima metà XIII sec. Giacomo da Lentini Amor è uno desio che ven da core Amor è uno desio che ven da core per abbondanza di gran piacimento; e li occhi in prima generan l'amore e lo
LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO. Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo
 LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo La lirica d arte Poesia scritta con l intento di scrivere opere d arte Poeti impegnati ad usare uno stile e una lingua
LA POESIA D ARTE DEL XIII SECOLO Scuola siciliana, siculo toscana e dolce stil novo La lirica d arte Poesia scritta con l intento di scrivere opere d arte Poeti impegnati ad usare uno stile e una lingua
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL
 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA Classe III H a. s.20123 / 2014 prof. ssa Marina Lorenzotti M. Sambugar, G. Salà LETTERATURA 1 SEZIONE 1 : IL MEDIOEVO IL CONTESTO STORICO E POLITICO IL MEDIOEVO: La definizione
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: ITALIANO Classe 3^ sezione G Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
CLASSE II F a.s Letteratura Italiana. 1. Le Origini
 Letteratura Italiana 1. Le Origini Argomenti In questa lezione vedremo le cause della nascita del volgare e della lenta sparizione del latino Esamineremo anche a sommi capi le prime letterature in volgare
Letteratura Italiana 1. Le Origini Argomenti In questa lezione vedremo le cause della nascita del volgare e della lenta sparizione del latino Esamineremo anche a sommi capi le prime letterature in volgare
EURO IN FORMAZIONE ON LINE ANNO III MATERIA: LETTERATURA ITALIANA LEZIONE 1. Premessa
 Premessa La Letteratura riguarda tutte le opere scritte in una certa lingua e comprende varie tipologie, come i testi narrativi, quelli lirici o drammatici testi filosofici, politici, scientifici, ecc.).
Premessa La Letteratura riguarda tutte le opere scritte in una certa lingua e comprende varie tipologie, come i testi narrativi, quelli lirici o drammatici testi filosofici, politici, scientifici, ecc.).
amor cortese dolce stil novo
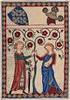 Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
Lirica d amore Italiana 1230-1300 ca. nasce alla Corte di Federico II (scuola siciliana) deriva dall imitazione della Poesia provenzale Schema dell amor cortese= rapporto di sudditanza fra l amante e la
BENVENUTO IO HO UNA GIOIA NEL CUORE
 Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
Marina di Carrara, 12 ottobre 2014 BENVENUTO Benvenuto benvenuto, benvenuto a te! (x2) Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che... l'amore ci unisce nel Signore. (x2) IO HO UNA GIOIA NEL CUORE Io ho una gioia
PROGRAMMA DI ITALIANO
 I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
I.I.S. ENZO FERRARI ROMA Sede Via Contardo Ferrini, 83 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III SEZIONE B - A F M Anno Scolastico 2015/2016 Per il recupero delle insufficienze gli alunni verranno sottoposti a
Scuola poetica siciliana
 Scuola poetica siciliana La scuola poetica siciliana, sorta attorno al 1230 nella corta dell l'imperatore e re di Sicilia Federico II di Svevia, produsse la prima lirica in volgare italiano. L attività
Scuola poetica siciliana La scuola poetica siciliana, sorta attorno al 1230 nella corta dell l'imperatore e re di Sicilia Federico II di Svevia, produsse la prima lirica in volgare italiano. L attività
I.I.S. Delfico-Montauti LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO TERAMO. Anno Scolastico Classe V Ginnasio Sez. A Prof.ssa Castagna Tiziana
 I.I.S. Delfico-Montauti LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO TERAMO Anno Scolastico 2015-2016 Classe V Ginnasio Sez. A Prof.ssa Castagna Tiziana Programma di Italiano A. Il linguaggio della poesia Leggere
I.I.S. Delfico-Montauti LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO TERAMO Anno Scolastico 2015-2016 Classe V Ginnasio Sez. A Prof.ssa Castagna Tiziana Programma di Italiano A. Il linguaggio della poesia Leggere
LICEO SCIENTIFICO STATALE ANTONIO GRAMSCI Via del Mezzetta, FIRENZE Tel. 055/ Fax 055/608400
 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/16 MATERIA: ITALIANO CLASSE: 2 SEZIONE: E DOCENTE: Rossella Baldini CONTENUTI L ASCOLTO LA LETTURA Ascolto di brani (anche musicali) come introduzione o completamento ad argomenti
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/16 MATERIA: ITALIANO CLASSE: 2 SEZIONE: E DOCENTE: Rossella Baldini CONTENUTI L ASCOLTO LA LETTURA Ascolto di brani (anche musicali) come introduzione o completamento ad argomenti
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 3 SEZIONE I. a.s. 2015/2016 DOCENTE: BALDASSARRE DANIELA DISCIPLINE: ITALIANO - STORIA
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Di Poppa-Rozzi Via F. Barnabei, 2 Teramo Cod. Fisc. 8003110675 tel.pres. 0861/248215 Segr.0861/247248 Fax : 0861/243136
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE Di Poppa-Rozzi Via F. Barnabei, 2 Teramo Cod. Fisc. 8003110675 tel.pres. 0861/248215 Segr.0861/247248 Fax : 0861/243136
Liceo Classico Mario Cutelli. classe I sez. F. anno scolastico
 Liceo Classico Mario Cutelli Programma di Lingua e Letteratura Italiana classe I sez. F anno scolastico 2014-2015 Prof.ssa Domenica Emanuela Nicotra Testo: Barberi Squarotti, Giorgio, Amoretti Giangiacomo,
Liceo Classico Mario Cutelli Programma di Lingua e Letteratura Italiana classe I sez. F anno scolastico 2014-2015 Prof.ssa Domenica Emanuela Nicotra Testo: Barberi Squarotti, Giorgio, Amoretti Giangiacomo,
365 Volte NON TEMERE
 365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
365 Volte NON TEMERE Cari lettori, è ormai da diverso tempo che scrivo per questa rubrica e spero che voi tutti ne stiate traendo dei benefici. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per il tempo che dedicate
L età cortese XI-XIII secolo. Pearson Italia S.p.a.
 L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
L età cortese XI-XIII secolo Cultura e mentalità in Francia verso la fine dell XI secolo rafforzamento della cavalleria esigenza di una nuova produzione letteraria in lingua volgare cavalleria: classe
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/ anno
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE Corso di laurea in Lettere Anno accademico 2016/2017-1 anno FILOLOGIA ROMANZA 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento MARIO PAGANO Email: mapagano@unict.it
III LICEO SCIENTIFICO _::. 4 ITALIANO Riassunto del Programma
 III LICEO SCIENTIFICO _::. 4 ITALIANO Riassunto del Programma EPICA MEDIEVALE Dopo il crollo dell'impero romano, iniziarono in Europa le migrazioni dei popoli germanici. Con l'emergere di nuovi popoli,
III LICEO SCIENTIFICO _::. 4 ITALIANO Riassunto del Programma EPICA MEDIEVALE Dopo il crollo dell'impero romano, iniziarono in Europa le migrazioni dei popoli germanici. Con l'emergere di nuovi popoli,
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
 SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 COGNOME E NOME: Livio Sbardella QUALIFICA: Professore associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-Fil-Let/02, Lingua e letteratura greca INSEGNAMENTO: Letteratura
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 COGNOME E NOME: Livio Sbardella QUALIFICA: Professore associato SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-Fil-Let/02, Lingua e letteratura greca INSEGNAMENTO: Letteratura
seconda stella a destra 6
 seconda stella a destra 6 copyright 2014 Euno Edizioni 94013 Leonforte - Via Dalmazia 5 Tel. e fax 0935 905877 www.eunoedizioni.it info@eunoedizioni.it ISBN: 978-88-6859-012-3 Copertina di: Mattia Mentastro
seconda stella a destra 6 copyright 2014 Euno Edizioni 94013 Leonforte - Via Dalmazia 5 Tel. e fax 0935 905877 www.eunoedizioni.it info@eunoedizioni.it ISBN: 978-88-6859-012-3 Copertina di: Mattia Mentastro
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti
 Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
Un fiore colto nel giardino del pensiero la voce dei poeti Edoardo Santi UN FIORE COLTO NEL GIARDINO DEL PENSIERO LA VOCE DEI POETI www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Edoardo Santi Tutti i diritti
PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI Associazione Culturale Artemide
 PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI 2012 Associazione Culturale Artemide Artemid E EDUC AZIONE E DUCERE da fuori.portare dentro AGENZIE EDUCATIVE LA FAMIGLIA LA SCUOLA LA COMUNITA» PARROCCHIA» ATTIVITA SPORTIVE»
PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI 2012 Associazione Culturale Artemide Artemid E EDUC AZIONE E DUCERE da fuori.portare dentro AGENZIE EDUCATIVE LA FAMIGLIA LA SCUOLA LA COMUNITA» PARROCCHIA» ATTIVITA SPORTIVE»
Verso l invalsi. Allora... in un tempo assai lunge felice fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora!
 Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
di Tania Ferro e Simona Angelone Liceo Scientifico dell Aquila
 di Tania Ferro e Simona Angelone Liceo Scientifico dell Aquila Francia del Sud nel XII secolo Sicilia nella corte di Federico II fra il 1230 e il 1250 Comune di Firenze nell ultimo decennio del 1200 chierici
di Tania Ferro e Simona Angelone Liceo Scientifico dell Aquila Francia del Sud nel XII secolo Sicilia nella corte di Federico II fra il 1230 e il 1250 Comune di Firenze nell ultimo decennio del 1200 chierici
Gli amanti si baciano sempre
 Gli amanti si baciano sempre Gli amanti si baciano sempredi Giuseppe Baiocchi del 16/06/2016 Tutta la ricerca pittorica e il pensiero di Magritte sembrano essere condizionati da un shock in adolescenza:
Gli amanti si baciano sempre Gli amanti si baciano sempredi Giuseppe Baiocchi del 16/06/2016 Tutta la ricerca pittorica e il pensiero di Magritte sembrano essere condizionati da un shock in adolescenza:
Michael Jackson un ANGELO sulla Terra... Rimarrai sempre nei Nostri Cuori
 Michael Jackson un ANGELO sulla Terra... Rimarrai sempre nei Nostri Cuori Chiara Tognotti Michael Jackson un ANGELO sulla Terra... Rimarrai sempre nei Nostri Cuori poesie e pensieri Dedico questo libro
Michael Jackson un ANGELO sulla Terra... Rimarrai sempre nei Nostri Cuori Chiara Tognotti Michael Jackson un ANGELO sulla Terra... Rimarrai sempre nei Nostri Cuori poesie e pensieri Dedico questo libro
Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli
 Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno
Francesco Petrarca ( )
 Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
Francesco Petrarca (1304 1374) Il Canzoniere Opera scritta dal Petrarca in lingua volgare. Il titolo iniziale dato dall autore era Francisci Petrarche laureati poete Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti
IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO
 IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Docente _Poli Chiaretta Maria Materia LIANO Classe _3AA Indirizzo SOCIO-SANRIO 1. ARGOMENTI /MODULI SVOLTI PREVISTI DAL
IIS CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Docente _Poli Chiaretta Maria Materia LIANO Classe _3AA Indirizzo SOCIO-SANRIO 1. ARGOMENTI /MODULI SVOLTI PREVISTI DAL
Schede di comprensione e analisi delle canzoni del Festival di Sanremo 2016
 Laboratorio di Comunicazione Canzoni per educare e migliorare Laboratorio di Italiano come Interculturale e Didattica l apprendimento dell italiano lingua straniera Università Ca Foscari, Venezia Schede
Laboratorio di Comunicazione Canzoni per educare e migliorare Laboratorio di Italiano come Interculturale e Didattica l apprendimento dell italiano lingua straniera Università Ca Foscari, Venezia Schede
NASCE IL POEMA CAVALLERESCO-MEDIEVALE CHE RIPRENDE IL MODELLO DEL POEMA CLASSICO PER DUE MOTIVI
 MEDIOEVO ( 800-1300 d.c.) NASCE IL POEMA CAVALLERESCO-MEDIEVALE CHE RIPRENDE IL MODELLO DEL POEMA CLASSICO PER DUE MOTIVI 1. ESALTARE LA CULTURA DI UNA NAZIONE: I FRANCHI CHE LOTTANO CONTRO L AVANZATA
MEDIOEVO ( 800-1300 d.c.) NASCE IL POEMA CAVALLERESCO-MEDIEVALE CHE RIPRENDE IL MODELLO DEL POEMA CLASSICO PER DUE MOTIVI 1. ESALTARE LA CULTURA DI UNA NAZIONE: I FRANCHI CHE LOTTANO CONTRO L AVANZATA
PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE
 INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
INSEGNANTE: Maggi Francesca ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 CLASSE: III Scientifico MATERIA: Italiano Scienze Applicate PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE ANNUALE UDA 1: Ripasso: la letteratura delle origini Ripasso
LICEO SCIENTIFICO G.D ALESSANDRO CONSUNTIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO
 LICEO SCIENTIFICO G.D ALESSANDRO A.S. 2010/11 CLASSE 3 A LIBRI DI TESTO Romano Luperini - Pietro Cataldi - Lidia Marchiani - Franco Marchese - Letteratura Storia Immaginario 1 (Dalle origini al Medioevo)
LICEO SCIENTIFICO G.D ALESSANDRO A.S. 2010/11 CLASSE 3 A LIBRI DI TESTO Romano Luperini - Pietro Cataldi - Lidia Marchiani - Franco Marchese - Letteratura Storia Immaginario 1 (Dalle origini al Medioevo)
La scuola siciliana prima metà XIII sec.
 La scuola siciliana prima metà XIII sec. Giacomo da Lentini Amor è uno desio che ven da core Amor è uno desio che ven da core per abbondanza di gran piacimento; e li occhi in prima generan l'amore e lo
La scuola siciliana prima metà XIII sec. Giacomo da Lentini Amor è uno desio che ven da core Amor è uno desio che ven da core per abbondanza di gran piacimento; e li occhi in prima generan l'amore e lo
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (L 11 e L12) Prof. Aggregato Beatrice Fedi a.a. 2014-2015. VI esempi EDIZIONI DI TESTI ITALOROMANZI
 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (L 11 e L12) Prof. Aggregato Beatrice Fedi a.a. 2014-2015 VI esempi EDIZIONI DI TESTI ITALOROMANZI Poesia italiana del Duecento NOZIONI GENERALI Scuola siciliana: produzione
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA (L 11 e L12) Prof. Aggregato Beatrice Fedi a.a. 2014-2015 VI esempi EDIZIONI DI TESTI ITALOROMANZI Poesia italiana del Duecento NOZIONI GENERALI Scuola siciliana: produzione
I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO
 I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 LETTERATURA: Le origini della letteratura romanza : La lingua latina e le lingue neolatine o
I.I.S FEDERICO II DI SVEVIA PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III AA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 LETTERATURA: Le origini della letteratura romanza : La lingua latina e le lingue neolatine o
I.T.I. Giordani Caserta
 I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
I.T.I. Giordani Caserta Prof.ssa De Iorio Rosaria Programma di Italiano A.S. 2014/2015 Classe 3^A T.L. IL MEDIOEVO Il contesto storico e politico La rinascita delle città e la fioritura comunale in Italia
MA COME POSSO PARLARTI, MIO DIO?
 MA COME POSSO PARLARTI, MIO DIO? Incontri biblici sui SALMI A cura di Antonella Jori Parrocchia di s. Ugo Roma 2013-14 Con la collaborazione di LUCIA PANTANI per la parte linguistico-letteraria «Interminati
MA COME POSSO PARLARTI, MIO DIO? Incontri biblici sui SALMI A cura di Antonella Jori Parrocchia di s. Ugo Roma 2013-14 Con la collaborazione di LUCIA PANTANI per la parte linguistico-letteraria «Interminati
Programma di Italiano A.S. 2012/2013
 Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" Palermo Programma di Italiano A.S. 2012/2013 Classe: III E Prof.ssa Calogera Rita Tiranno Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" Palermo Programma di Italiano A.S. 2012/2013 Classe: III E Prof.ssa Calogera Rita Tiranno Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura
Rerum vulgarium fragmenta
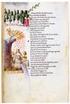 Rerum vulgarium fragmenta Storia di un capolavoro Petrarca per tutta la vita raccoglie e ordina le sue rime: dal 1336-8 (prima raccolta di riferimento, non ancora un libro organico).....al 18 luglio del
Rerum vulgarium fragmenta Storia di un capolavoro Petrarca per tutta la vita raccoglie e ordina le sue rime: dal 1336-8 (prima raccolta di riferimento, non ancora un libro organico).....al 18 luglio del
Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse
 Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse di Elisa Guccione - 15, Gen, 2016 http://www.siciliajournal.it/sebastiano-lo-monaco/ di Elisa Guccione Foto Servizio Vincenzo Musumeci 1 / 5 CATANIA A poche
Sebastiano Lo Monaco: Vi racconto il mio Ulisse di Elisa Guccione - 15, Gen, 2016 http://www.siciliajournal.it/sebastiano-lo-monaco/ di Elisa Guccione Foto Servizio Vincenzo Musumeci 1 / 5 CATANIA A poche
Programma Didattico Annuale
 LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
Iacopo da Lentini: Amor è uno desio
 Iacopo da Lentini: Amor è uno desio È un sonetto, di cui è protagonista la fenomenologia della genesi dell'amore N.b. Fenomenologia: descrizione del modo in cui si manifesta una realtà Fa parte di una
Iacopo da Lentini: Amor è uno desio È un sonetto, di cui è protagonista la fenomenologia della genesi dell'amore N.b. Fenomenologia: descrizione del modo in cui si manifesta una realtà Fa parte di una
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina?
 Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
Scintille d amore... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Enzo Casagni SCINTILLE D AMORE... Come può il mondo continuare a vivere senza Cristina? Diario autobiografico www.booksprintedizioni.it
RAVVEDITI. Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò
 RAVVEDITI Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò Hai nome tu di vivere, eppur sei morto, Rafferma ciò che
RAVVEDITI Non ho trovato compiute le tue opere Davanti a Me Tu dici, o Signore Hai perso il tuo amore di una volta: Ravvediti che presto tornerò Hai nome tu di vivere, eppur sei morto, Rafferma ciò che
1.3 La lirica in volgare
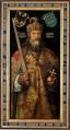 1.3 La lirica in volgare Per approfondire: A. STUSSI, Versi d amore in volgare tra la fine del secolo XII e l inizio del XIII, in «Cultura Neolatina», LIX (1999), pp. 1-69 (26) V. FORMENTIN, Poesia italiana
1.3 La lirica in volgare Per approfondire: A. STUSSI, Versi d amore in volgare tra la fine del secolo XII e l inizio del XIII, in «Cultura Neolatina», LIX (1999), pp. 1-69 (26) V. FORMENTIN, Poesia italiana
Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia. Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto
 Amen. Maranathà! Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia a cura di: Franco Gomiero Paola Talamini 2008 - by Casa Musicale Edizioni
Amen. Maranathà! Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia a cura di: Franco Gomiero Paola Talamini 2008 - by Casa Musicale Edizioni
Enrico Strobino IL CORO DELLE INCUDINI
 Enrico Strobino IL CORO DELLE INCUDINI Il progetto che segue consiste in un attività di musica d insieme in cui un brano ritmico può essere orchestrato in vari modi, scegliendo l organico in base a un
Enrico Strobino IL CORO DELLE INCUDINI Il progetto che segue consiste in un attività di musica d insieme in cui un brano ritmico può essere orchestrato in vari modi, scegliendo l organico in base a un
1876 deve interrompere gli studi per aver aderito a una manifestazione contro il Ministero della Pubblica Istruzione Si avvicina alle posizioni
 GIOVANNI PASCOLI La vita Nasce a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1885 (quarto di 10 figli) 10 agosto 1867 viene ucciso il padre 1871 dopo la morte della madre e di due fratelli deve lasciare il collegio
GIOVANNI PASCOLI La vita Nasce a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1885 (quarto di 10 figli) 10 agosto 1867 viene ucciso il padre 1871 dopo la morte della madre e di due fratelli deve lasciare il collegio
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE "ARTURO FERRARIN" CATANIA
 Anno Scolastico 2015-2016 PROGRAMMA ITALIANO CLASSE III E Prof. ssa Alberti Rosa Testo: La Letteratura, Dalle origini al Cinquecento Autori: G: Barberi Squarotti, G. Balbis, G. Genghini IL MEDIOEVO Capitolo
Anno Scolastico 2015-2016 PROGRAMMA ITALIANO CLASSE III E Prof. ssa Alberti Rosa Testo: La Letteratura, Dalle origini al Cinquecento Autori: G: Barberi Squarotti, G. Balbis, G. Genghini IL MEDIOEVO Capitolo
IO PER TE... TU PER NOI. Daniela Maria Tortorici
 2 IO PER TE... TU PER NOI Daniela Maria Tortorici 3 A mio marito che ha creduto in me e mi ha convinta a scrivere questo libro. A mia figlia che è la ragione della mia vita. Ai miei genitori che sono dei
2 IO PER TE... TU PER NOI Daniela Maria Tortorici 3 A mio marito che ha creduto in me e mi ha convinta a scrivere questo libro. A mia figlia che è la ragione della mia vita. Ai miei genitori che sono dei
A cura di Chiesacattolica.it e LaChiesa.it. PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
 NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
Paola Olestini PENSIERI SCIOLTI
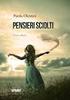 Pensieri sciolti Paola Olestini PENSIERI SCIOLTI prosa e poesia www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Paola Olestini Tutti i diritti riservati Volevo dedicare questo libro a tutte quelle persone che,
Pensieri sciolti Paola Olestini PENSIERI SCIOLTI prosa e poesia www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Paola Olestini Tutti i diritti riservati Volevo dedicare questo libro a tutte quelle persone che,
RAMIN BAHRAMI NONNO BACH
 RAMIN BAHRAMI NONNO BACH La musica spiegata ai bambini BOMPIANI 2015 Bompiani / RCS Libri S.p.A. Via Angelo Rizzoli 8 20132 Milano ISBN 978-88-452-7989-8 Prima edizione Bompiani settembre 2015 Dedico questo
RAMIN BAHRAMI NONNO BACH La musica spiegata ai bambini BOMPIANI 2015 Bompiani / RCS Libri S.p.A. Via Angelo Rizzoli 8 20132 Milano ISBN 978-88-452-7989-8 Prima edizione Bompiani settembre 2015 Dedico questo
Il Romanticismo. In Europa e in Italia
 Il Romanticismo In Europa e in Italia Classici e Romantici Classicismo L arte è imitazione di modelli di perfezione sempre uguali; Ricerca equilibrio e armonia Romanticismo La vita è un eterno cambiamento:
Il Romanticismo In Europa e in Italia Classici e Romantici Classicismo L arte è imitazione di modelli di perfezione sempre uguali; Ricerca equilibrio e armonia Romanticismo La vita è un eterno cambiamento:
Direttamente da Uomini e Donne Beatrice Valli, testimonial di GUFO:"stile e modernità"
 Direttamente da Uomini e Donne Beatrice Valli, testimonial di GUFO:"stile e modernità" di Redazione Sicilia Journal - 06, ott, 2015 http://www.siciliajournal.it/direttamente-da-uomini-e-donne-beatrice-valli-testimonial-di-gufostile-emodernita/
Direttamente da Uomini e Donne Beatrice Valli, testimonial di GUFO:"stile e modernità" di Redazione Sicilia Journal - 06, ott, 2015 http://www.siciliajournal.it/direttamente-da-uomini-e-donne-beatrice-valli-testimonial-di-gufostile-emodernita/
Verifica di italiano
 Verifica di italiano Cognome Nome Classe Data Rispondere alle seguenti domande scegliendo una sola risposta: 1. L età del Romanticismo è: tra la fine del secolo X e la metà del secolo XIX tra la fine del
Verifica di italiano Cognome Nome Classe Data Rispondere alle seguenti domande scegliendo una sola risposta: 1. L età del Romanticismo è: tra la fine del secolo X e la metà del secolo XIX tra la fine del
Gli inni nazionali europei delle semifinali di Euro2016
 Gli inni nazionali europei delle semifinali di Euro2016 Gli inni nazionali sono espressione dell identità di un popolo e qui vi voglio raccontare storia e curiosità degli inni nazionali europei delle quattro
Gli inni nazionali europei delle semifinali di Euro2016 Gli inni nazionali sono espressione dell identità di un popolo e qui vi voglio raccontare storia e curiosità degli inni nazionali europei delle quattro
L ILIADE DI OMERO. Un introduzione PERCHE STUDIARLA?
 L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
L ILIADE DI OMERO Un introduzione PERCHE STUDIARLA? L ILIADE È UNO DEI PIÙ GRANDI POEMI MAI SCRITTI, CHE È ALLA BASE DELLA NOSTRA CULTURA E DELLA NOSTRA CONCEZIONE DEL MONDO. LEGGENDO QUESTO POEMA SI RIESCE
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Liceo Scientifico dell Aquila Vanessa Basso. dal sito di Luisa Nardecchia
 Liceo Scientifico dell Aquila Vanessa Basso dal sito di Luisa Nardecchia www.didacta.altervista.org Letteratura latina (classici) Provenza (corte di G. d Aquitania) Lingua d oc e d oil Temi e sensibilità
Liceo Scientifico dell Aquila Vanessa Basso dal sito di Luisa Nardecchia www.didacta.altervista.org Letteratura latina (classici) Provenza (corte di G. d Aquitania) Lingua d oc e d oil Temi e sensibilità
BENEDETTO CROCE E LA LETTERATURA Percorso bibliografico nelle collezioni della Biblioteca del Senato
 BENEDETTO CROCE E LA LETTERATURA Percorso bibliografico nelle collezioni della Biblioteca del Senato Avvertenza: in considerazione dell'elevato numero di opere presenti all'interno delle collezioni della
BENEDETTO CROCE E LA LETTERATURA Percorso bibliografico nelle collezioni della Biblioteca del Senato Avvertenza: in considerazione dell'elevato numero di opere presenti all'interno delle collezioni della
UNO SU MILLE -Gianni Morandi-
 UNO SU MILLE -Gianni Morandi- 1) Leggi il testo della canzone. Trova e sottolinea tutte le particelle pronominali ci. Se sei a terra non strisciare mai se ti diranno sei finito non ci credere devi contare
UNO SU MILLE -Gianni Morandi- 1) Leggi il testo della canzone. Trova e sottolinea tutte le particelle pronominali ci. Se sei a terra non strisciare mai se ti diranno sei finito non ci credere devi contare
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CLASSE 3^A ITT
 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. MATTEI Via Boiardi, 5 29017 Fiorenzuola d Arda (PC) Telefono: 0523 942018 0523 983324 Mail: mattei@istitutomattei.com Codice Fiscale: 81002420339 ANNO SCOLASTICO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. MATTEI Via Boiardi, 5 29017 Fiorenzuola d Arda (PC) Telefono: 0523 942018 0523 983324 Mail: mattei@istitutomattei.com Codice Fiscale: 81002420339 ANNO SCOLASTICO
Prima della lettura. Non si dimentica il primo amore, dice Ginevra. Sei d accordo con questa affermazione?
 Prima della lettura Non si dimentica il primo amore, dice Ginevra. Sei d accordo con questa affermazione? Episodio 3 È arrivato il primo piatto: un classico di Milano, il risotto con lo zafferano e come
Prima della lettura Non si dimentica il primo amore, dice Ginevra. Sei d accordo con questa affermazione? Episodio 3 È arrivato il primo piatto: un classico di Milano, il risotto con lo zafferano e come
Mario Esposito VERSI DI CACCIA E D AMORE DI UCCELLI RAPACI DIURNI E NOTTURNI
 Mario Esposito VERSI DI CACCIA E D AMORE DI UCCELLI RAPACI DIURNI E NOTTURNI Inizio. ORIGINE DELLA COLPA NELLE SPECIE A parlare è il giudice. Non ha principio né fine questo processo. Un uomo non è più
Mario Esposito VERSI DI CACCIA E D AMORE DI UCCELLI RAPACI DIURNI E NOTTURNI Inizio. ORIGINE DELLA COLPA NELLE SPECIE A parlare è il giudice. Non ha principio né fine questo processo. Un uomo non è più
La maschera del cuore
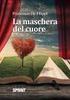 La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III A RICEVIMENTO (ACCOGLIENZA TURISTICA) A.S DOCENTE ANDREA GIUSEPPE GRAZIANO
 PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III A RICEVIMENTO (ACCOGLIENZA TURISTICA) A.S. 2015-2016 DOCENTE ANDREA GIUSEPPE GRAZIANO SI PRESENTA COPIA DEL REGISTRO ELETTRONICO DELLA CLASSE V A R COMPRENDENTE ARGOMENTI
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III A RICEVIMENTO (ACCOGLIENZA TURISTICA) A.S. 2015-2016 DOCENTE ANDREA GIUSEPPE GRAZIANO SI PRESENTA COPIA DEL REGISTRO ELETTRONICO DELLA CLASSE V A R COMPRENDENTE ARGOMENTI
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ
 Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Il formato "classico" dei giornali italiani è il 55x40 cm, la grandezza per esempio del Corriere della Sera. Anche se oggi un po' tutti i giornali
 Il formato "classico" dei giornali italiani è il 55x40 cm, la grandezza per esempio del Corriere della Sera. Anche se oggi un po' tutti i giornali quotidiani hanno introdotto il colore, fino a pochi anni
Il formato "classico" dei giornali italiani è il 55x40 cm, la grandezza per esempio del Corriere della Sera. Anche se oggi un po' tutti i giornali quotidiani hanno introdotto il colore, fino a pochi anni
Il numero della Bestia
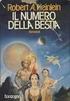 6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ
 GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
La nascita delle lingue romanze
 La nascita delle lingue romanze La società cortese e la nascita della letterature europee 1 Dal latino parlato alle lingue romanze Sermo provincialis Sermo militaris Primi due secoli dopo Cristo Sermo
La nascita delle lingue romanze La società cortese e la nascita della letterature europee 1 Dal latino parlato alle lingue romanze Sermo provincialis Sermo militaris Primi due secoli dopo Cristo Sermo
DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE SCUOLA DI CANTO DCPL08 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO
 DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE SCUOLA DI CANTO DCPL08 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO Obiettivi formativi Al termine degli studi relativi al Diploma
DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE SCUOLA DI CANTO DCPL08 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO Obiettivi formativi Al termine degli studi relativi al Diploma
Una pulce sull albero di Babbo Natale?!!! Recita insieme ai tuoi compagni.
 Una pulce sull albero di Babbo Natale?!!! Recita insieme ai tuoi compagni. PERSONAGGI Babbo Natale Angioletto Elefante Pulce Regina Fiore Mela Marziano Gufo Elfi Entrano in scena gli Elfi, Babbo Natale
Una pulce sull albero di Babbo Natale?!!! Recita insieme ai tuoi compagni. PERSONAGGI Babbo Natale Angioletto Elefante Pulce Regina Fiore Mela Marziano Gufo Elfi Entrano in scena gli Elfi, Babbo Natale
Le 3 strade per liberarti dal giudizio del cliente
 Le 3 strade per liberarti dal giudizio del cliente Ciao E ti do il benvenuto in questo Video Articolo dal titolo Le 3 Strade per liberarti dal giudizio del cliente. Spesso anche se con il cliente si è
Le 3 strade per liberarti dal giudizio del cliente Ciao E ti do il benvenuto in questo Video Articolo dal titolo Le 3 Strade per liberarti dal giudizio del cliente. Spesso anche se con il cliente si è
SESTA LEZIONE Il ritorno del fratello: pronominali ( tenerci farla passare ecc.) - lite: roleplay chi ha ragione? - la dignità uso di manco
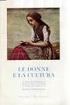 MOTIVAZIONE Significato dell'espressione Mine vaganti e breve recensione Prima scena: dove siamo? Chi è la sposa? Chi sono l'uomo e l'anziana? Perché cerca di uccidersi? Provate a fare ipotesi. [VISIONE
MOTIVAZIONE Significato dell'espressione Mine vaganti e breve recensione Prima scena: dove siamo? Chi è la sposa? Chi sono l'uomo e l'anziana? Perché cerca di uccidersi? Provate a fare ipotesi. [VISIONE
Le poesie del divino amore
 Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
Le poesie del divino amore Fernando Isacco Benato LE POESIE DEL DIVINO AMORE Poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2016 Fernando Isacco Benato Tutti i diritti riservati L amore di due angeli Ho visto
ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non sanno più scrivere.
 di ALESSANDRA NEGLIA Che anche i Prof non sono poi tanto geni! Caro Governo, ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non
di ALESSANDRA NEGLIA Che anche i Prof non sono poi tanto geni! Caro Governo, ho letto sui giornali di questa lettera che 600 docenti universitari hanno scritto per denunciare il fatto che i ragazzi non
La partita. La vita è quella cosa che accade mentre tu stai facendo altri progetti. John Lennon. Capitolo 1
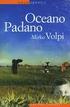 4 La vita è quella cosa che accade mentre tu stai facendo altri progetti. John Lennon Capitolo 1 Napoli. Ore 18.00. Una strana telefonata fra due amici. - Pronto, Margherita? - Ciao, Ciro. Dimmi. - Allora
4 La vita è quella cosa che accade mentre tu stai facendo altri progetti. John Lennon Capitolo 1 Napoli. Ore 18.00. Una strana telefonata fra due amici. - Pronto, Margherita? - Ciao, Ciro. Dimmi. - Allora
Dieci parole per essere umani
 Terebinto 14 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 14 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Lectio divina. Alla scuola di un Amore fuori misura. A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
 Lectio divina Alla scuola di un Amore fuori misura A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA Lectio Divina DOMENICA FRA L'OTTAVA DI NATALE SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA
Lectio divina Alla scuola di un Amore fuori misura A cura di Vito Cassone Anno II/7 26 dicembre 2010 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA Lectio Divina DOMENICA FRA L'OTTAVA DI NATALE SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana
 9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
PROGRAMMA di ITALIANO. STORIA e CITTADINANZA 3^A SIA
 ISTITUTO FERMI IGLESIAS Anno Scolastico 2014-2015 PROGRAMMA di ITALIANO STORIA e CITTADINANZA 3^A SIA L INSEGNANTE Prof.ssa ENNAS SILVANA ITALIANO Il Medioevo Il Contesto. Il quadro economico e sociale.
ISTITUTO FERMI IGLESIAS Anno Scolastico 2014-2015 PROGRAMMA di ITALIANO STORIA e CITTADINANZA 3^A SIA L INSEGNANTE Prof.ssa ENNAS SILVANA ITALIANO Il Medioevo Il Contesto. Il quadro economico e sociale.
Le attività Fragile (l ombra che resta)
 1 Le attività Fragile (l ombra che resta) 13 1. Fragile (l ombra che resta) Testo: Fabio Caon Musica: Marco Celegon, Fabio Caon Livelli degli studenti Elementi lessicali Elementi linguistico-grammaticali
1 Le attività Fragile (l ombra che resta) 13 1. Fragile (l ombra che resta) Testo: Fabio Caon Musica: Marco Celegon, Fabio Caon Livelli degli studenti Elementi lessicali Elementi linguistico-grammaticali
L idea progettuale. La tradizione del testo manoscritto. Un percorso didattico con la LIM sulla letteratura italiana del Duecento
 L idea progettuale Titolo dell Unità Didattica: La tradizione del testo manoscritto. Un percorso didattico con la LIM sulla letteratura italiana del Duecento Anno scolastico: 2010-2011 Docente: Carlo Mariani
L idea progettuale Titolo dell Unità Didattica: La tradizione del testo manoscritto. Un percorso didattico con la LIM sulla letteratura italiana del Duecento Anno scolastico: 2010-2011 Docente: Carlo Mariani
COME FACCIAMO A PARLARE?
 COME FACCIAMO A PARLARE? Caterina Caterina Burcin Vanessa Burcin Vanessa Proviamo tutti a pensare a cosa succede dentro di noi quando parliamo Secondo voi, come facciamo a parlare? Parliamo perché ci sono
COME FACCIAMO A PARLARE? Caterina Caterina Burcin Vanessa Burcin Vanessa Proviamo tutti a pensare a cosa succede dentro di noi quando parliamo Secondo voi, come facciamo a parlare? Parliamo perché ci sono
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO
 PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
Definizione del termine Barocco e origine. Contesto storico. Caratteristiche generali. Sperimentalismo. Generi Letterari Tematiche Linguistico
 IL BAROCCO Definizione del termine Barocco e origine Contesto storico Caratteristiche generali Sperimentalismo Generi Letterari Tematiche Linguistico Con termine Barocco indichiamo la produzione artistica
IL BAROCCO Definizione del termine Barocco e origine Contesto storico Caratteristiche generali Sperimentalismo Generi Letterari Tematiche Linguistico Con termine Barocco indichiamo la produzione artistica
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti
 NICCOLO' AMMANITI Scuola Secondaria di I gr. E. Panzacchi Ozzano dell' Emilia Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti Notizie su Niccolò Ammaniti Niccolò Ammaniti è nato a Roma il 25 settembre
NICCOLO' AMMANITI Scuola Secondaria di I gr. E. Panzacchi Ozzano dell' Emilia Giornalino della II E: Intervista a Niccolò Ammaniti Notizie su Niccolò Ammaniti Niccolò Ammaniti è nato a Roma il 25 settembre
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
L Ermetismo Italia anni comune atteggiamento critico Francesco Flora difficoltà comprendere dio greco Ermes
 L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
IL PIACERE DI RACCONTARE. Questo volume appartiene a
 IL PIACERE DI RACCONTARE Questo volume appartiene a Gianpiero Taverna LETTERE A GIULIA PER CAPIRE LA MUSICA In un originale corso di lezioni, un famoso direttore d orchestra guida il lettore, attraverso
IL PIACERE DI RACCONTARE Questo volume appartiene a Gianpiero Taverna LETTERE A GIULIA PER CAPIRE LA MUSICA In un originale corso di lezioni, un famoso direttore d orchestra guida il lettore, attraverso
1.2. Inserisci nel testo le parole che hai trovato con il cruciverba. Le parole sono elencate qui sotto in ordine alfabetico.
 da Caro Michele 1 Attività introduttiva 1.1 Completa il cruciverba. ORIZZONTALI 1 20.000 in lettere. 5 Participio passato del verbo incominciare. 7 Mattina, pomeriggio e 8 Articolo femminile. 9 6 in lettere.
da Caro Michele 1 Attività introduttiva 1.1 Completa il cruciverba. ORIZZONTALI 1 20.000 in lettere. 5 Participio passato del verbo incominciare. 7 Mattina, pomeriggio e 8 Articolo femminile. 9 6 in lettere.
EFREM RAIMONDI EASYREADING NADIA AFRAGOLA
 EFREM RAIMONDI EASYREADING NADIA AFRAGOLA LEGGERE? NO GRAZIE Era un capitolo per me molto importante, da scrivere intendo. Perché a viverlo avevo iniziato tempo prima. Per caso, quasi. Grazie a una donna:
EFREM RAIMONDI EASYREADING NADIA AFRAGOLA LEGGERE? NO GRAZIE Era un capitolo per me molto importante, da scrivere intendo. Perché a viverlo avevo iniziato tempo prima. Per caso, quasi. Grazie a una donna:
 ildeboscio.com http://www.ildeboscio.com/2016/03/14/sombrero-twist/ SOMBRERO TWIST Sombrero Twist è un profilo su Fb e su Instagram che seguiamo con profitto da qualche tempo e che pubblica dei ritratti
ildeboscio.com http://www.ildeboscio.com/2016/03/14/sombrero-twist/ SOMBRERO TWIST Sombrero Twist è un profilo su Fb e su Instagram che seguiamo con profitto da qualche tempo e che pubblica dei ritratti
Don Bosco, l operaio di Dio : un musical Made in Cisternino. Intervista a. organizzatrice e direttrice artistica dello spettacolo
 Don Bosco, l operaio di Dio : un musical Made in Cisternino. Intervista a Rosanna Nardelli, organizzatrice e direttrice artistica dello spettacolo Foto: Angelo Scarafile Un musical per don Bosco. Come
Don Bosco, l operaio di Dio : un musical Made in Cisternino. Intervista a Rosanna Nardelli, organizzatrice e direttrice artistica dello spettacolo Foto: Angelo Scarafile Un musical per don Bosco. Come
