Una testimonianza di verità e coraggio. Copyright 2013 Stefano Martini
|
|
|
- Clemente Beretta
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Una testimonianza di verità e coraggio
2 Responsabilità e coerenza
3 Dietrich Bonhoeffer nacque il 4 febbraio del 1906 a Breslavia (in polacco Wrocław, in tedesco Breslau: oggi città della Polonia sud-occidentale, ma parte della Germania fino al termine della seconda guerra mondiale), da una famiglia luterana dell alta borghesia, non particolarmente impegnata in campo religioso.
4 I genitori, Karl (psichiatra di origine berlinese) e Paula von Hase (insegnante), ebbero otto figli.
5 Sesto e settima furono,rispettivamente, Dietrich e la sorella gemella Sabine.
6 Dietrich compì i primi studi a Berlino, dimostrando grande versatilità nelle diverse discipline e in particolare nella musica. Benché inizialmente avesse intenzione di seguire le orme paterne, manifestò fin da ragazzo la volontà di diventare pastore evangelico.
7 Presa, quindi, la decisione di studiare teologia, frequentò per due semestri i corsi presso l università di Tubinga (1923/1924). Nel 1924 venne anche in Italia, fermandosi in particolare a Roma.
8 Dal semestre estivo del 1924 andò a studiare a Berlino, dove fu allievo di Adolf von Harnach ( ), uno dei più rilevanti teologi protestanti e storici della Chiesa della fine del XIX e inizio del XX secolo.
9 Nell inverno ebbe modo di leggere e apprezzare gli scritti di Karl Barth ( ), incontro che si sarebbe rivelato in seguito molto importante per lo sviluppo della propria teologia (più avanti, nel 1931, ne seguì per due settimane i corsi a Bonn).
10 Si laureò il 17 dicembre del 1927, a soli 21 anni, con Reinhold Seeberg ( ), presentando una tesi dal titolo Sanctorum Communio (pubblicata nel 1930).
11 Dopo un anno di attività pastorale a Barcellona ( ), tornò a Berlino, dove fu assistente di Wilhelm Lütgert tra il 1929 e il Lettera di Dietrich Bonhoeffer al fratello Karl-Friedrich da Barcellona ( )
12 Nel luglio del 1930 conseguì l abilitazione con Atto ed essere (Akt und Sein, 1931) e dall agosto 1931 ottenne la libera docenza presso la Facoltà teologica dell Università di Berlino.
13 Nell opera egli esaminava la filosofia di Kant e l ontologia di Heidegger, arrivando a concludere la loro inadeguatezza, se considerate come strumenti utili per esprimere Dio nella sua rivelazione: questa, infatti, non può essere formulata né in categorie di azione, né in categorie di essere.
14 Tra il 1930 e il 1931 trascorse circa un anno a New York, presso l Union Theological Seminary. Union Theological Seminary, New York Dietrich Bonhoeffer con il collega pacifista, Jean Lasserre, a New York nel 1931
15 Tale periodo fu di grande importanza, perché egli, da un lato, contribuì a far conoscere in America la teologia dialettica o della crisi (formatasi attorno alla rivista Tra i tempi [ Zwischen den Zeiten ], fondata nel 1921 da Friedrich Gogarten [ ], Barth e altri), dall altro, venne a contatto con un cristianesimo molto diverso da quello tedesco.
16 In particolare, egli fu attratto dalla corrente del social gospel (vangelo sociale) per la serietà con cui affrontava il tema del regno di Dio in relazione ai problemi sociali concreti di questo mondo e intuì, uno fra pochissimi, in tutta la sua gravità per la società americana, il problema razziale. Inoltre, questa permanenza fu l inizio di una serie di attività ecumeniche in cui si sarebbe impegnato per tutta la sua vita.
17 Dopo un breve soggiorno a Londra, sempre nel 1931, ritornò in Germania, per dedicarsi all insegnamento presso l Università di Berlino. Nel frattempo, dal 1 ottobre, fu assistente spirituale degli studenti presso la Technische Hochschule di Berlino e, l 11 novembre 1931, ricevette l ordinazione sacerdotale nella chiesa di San Mattia).
18 Qui iniziò anche la sua opposizione attiva al nuovo regime nazista. In concomitanza con la presa del potere di Hitler, nel febbraio del 1933, tenne per esempio una conferenza radiofonica (dai microfoni della Berliner Funkstunde) sull idea di Führer (Cambiamenti del Führerbegriff), nella quale criticò l aspirazione del popolo tedesco a trovare un Führer, che inevitabilmente rischiava di diventare un Verführer (un seduttore).
19 Nell aprile dello stesso anno, ne fece un altra dal titolo La Chiesa di fronte al problema degli ebrei (Die Kirche vor der Judenfrage) e in un articolo, pubblicato in giugno, egli invocava, data la gravità della situazione, la convocazione di un concilio evangelico che potesse prendere una posizione autorevole.
20 Nell agosto del 1933, venne divulgato Il paragrafo degli ariani nella Chiesa (Der Arierparagraph in der Kirche), con cui gli ebrei battezzati venivano dichiarati non ariani e si decretava che fossero espulsi dalla Chiesa Evangelica.
21 Alcuni pastori berlinesi, fra i quali Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller ( ), costituirono d urgenza un associazione, che dichiarò la incompatibilità con la fede cristiana del suddetto documento e organizzò l assistenza alle persone colpite dalle misure razziali.
22 Tale gruppo fu con il Movimento Neoriformatore (Jungreformatorische Bewegung), uno dei precursori della Chiesa confessante (Bekennende Kirche), costituitasi ufficialmente con il sinodo del maggio 1934 a Wuppertal-Barmen. Tessera della Chiesa confessante, Berlino-Dahlem 1934 (firma: Niemöller)
23 In tale occasione venne formulata da Karl Barth la Dichiarazione teologica di Barmen (Barmer Theologische Erklärung), la quale portò, nel sinodo di Dahlem dell ottobre dello stesso anno, alla rottura definitiva con la cosiddetta Chiesa del Reich (Reichkirche) e significò il fondamento teologico della Chiesa confessante, che avrebbe svolto un rilevante ruolo di opposizione e resistenza al regime nazionalsocialista.
24 Per Bonhoeffer, che era assente a quell evento (dal 1933 al 1935 fu, infatti, a Londra, per seguire due comunità evangeliche tedesche), esso rappresentò la vera data di nascita della Chiesa confessante e significò il conseguimento di ciò per cui aveva lottato lungamente.
25 Di nuovo a Berlino, Bonhoeffer accettò di dirigere prima presso la fattoria di Zingst (mar Baltico), poi a Finkenwalde, un seminario (Predigtseminar) affidatogli proprio dalla Chiesa confessante.
26 Tuttavia, il 2 dicembre 1935 apparve l ordinanza del ministro per le questioni religiose Hanns Kerrl per l applicazione della legge sulla sicurezza della Chiesa evangelica. Essa dichiarava come inammissibili tutte le disposizioni ecclesiastiche emanate da associazioni o gruppi.
27 Di conseguenza, anche l esistenza del seminario di predicazione (nella chiesa evangelica è un istituto di preparazione per l esame e l ordinazione) di cui Bonhoeffer era la guida, divenne illegale.
28 Nel 1936, radiato dall insegnamento per la sua opposizione alla chiesa ufficiale del Reich (i cristiani tedeschi, Deutschen Christen) e al regime, si dedicò completamente agli allievi di Finkenwalde, ma a metà ottobre del 1937 il seminario venne chiuso dalla Gestapo e 27 allievi furono imprigionati. A novembre uscì Sequela (Nachfolge).
29 Egli escogitò un ulteriore forma di collaborazione con i suoi candidati: quella del vicariato collettivo (Sammelvikariat), a Köslin e a Gross-Schlönwitz (oggi Slonowice) (quest ultimo si trasferì nel 1939 a Sigurdshof).
30 In seguito, nel 1938, su questa esperienza di religiosità vissuta comunitariamente, egli scrisse Vita comune (Gemeinsamens Leben, 1939).
31 Nel 1939 Bonhoeffer si recò negli Stati Uniti per un ciclo di conferenze.
32 Ricevuta, però, appena sbarcato, una lettera che gli dava la certezza dell imminente scoppio della guerra, rientrò immediatamente in patria: riteneva, infatti, di non aver diritto di partecipare a una futura ricostruzione se prima non avesse condiviso le prove del periodo bellico.
33 Pur avendo sostenuto posizioni pacifiste desiderava perfino andare in India a conoscere Mohandas Gandhi ( ), sin dall inizio delle ostilità si avvicinò alla resistenza e fu messo a conoscenza del piano per fermare Hitler prima dell inizio della guerra sul fronte occidentale, progetto poi sospeso.
34 A un compagno di prigionia italiano, che gli chiese come potesse un sacerdote partecipare a una cospirazione politica che prevedesse anche lo spargimento di sangue, disse: «Quando un pazzo lancia la sua auto sul marciapiede, io non posso, come pastore, contentarmi di sotterrare i morti e consolare le famiglie. Io devo, se mi trovo in quel posto, saltare e afferrare il conducente al suo volante».
35 Nel frattempo stava lavorando a un opera sull etica, di cui ci rimangono saggi e abbozzi composti in epoche diverse, ripresi, rielaborati, non portati a termine. In particolare, il capitolo più compiuto, Le cose ultime e penultime, fu scritto nella quiete del lungo soggiorno presso l abbazia benedettina di Ettal sui monti bavaresi, tra la fine del 1940 e l inizio del 1941.
36 Questi scritti furono dati alle stampe a Monaco nel 1949, col titolo di Etica (Ethik) dall amico fraterno Eberhard Bethge ( ), che ha curato la pubblicazione di tutta l opera inedita di Bonhoeffer.
37 Pure Eberhard Bethge era imparentato con Dietrich, avendone sposato la nipote Renate, figlia di Rüdiger Schleicher ( ), a sua volta marito di Ursula Bonhoeffer ( ).
38 Col fratello Klaus ( ) e il cognato Hans von Dohnanyi ( ) (la moglie, Christine Bonhoeffer, era sorella di Dietrich) egli era dunque entrato in contatto con l ammiraglio Wilhelm Canaris ( ), capo del servizio segreto militare (Abwehr).
39 Canaris e Dohnanyi verso la fine di ottobre del 1941 diedero avvio a un operazione per salvare un piccolo gruppo di ebrei. Con la collaborazione anche di Bonhoeffer, nel 1942 venne preparato e realizzato per loro un viaggio di salvataggio in Svizzera.
40 Proprio Canaris con altri ufficiali stava preparando una congiura per assassinare Hitler: si trattava dell attentato dinamitardo del 20 luglio 1944, organizzato dal colonnello Claus von Stauffenberg ( ), contro il quartier generale di Rastenburg, dove risiedeva il Führer, che però non avrebbe raggiunto lo scopo.
41 Già nel 1942 Bonhoeffer aveva incontrato George Bell, vescovo di Chichester nonché suo amico e sostenitore della Chiesa Confessante. In tale circostanza, gli comunicò i singoli dettagli, compresi i nomi dei partecipanti, del colpo di Stato che si stava progettando. Il governo inglese avrebbe dovuto appoggiare, in caso di riuscita, gli autori del colpo di Stato, così da metterli in condizione di creare un nuovo governo tedesco.
42 Nel novembre del 1942 Dietrich si fidanzò con Maria von Wedemeyer ( ).
43 La famiglia Bonhoeffer, nel marzo 1943, cinque giorni prima dell arresto di Dietrich (sulla sinistra). Sono nella foto pure il cognato Rüdiger Schleicher ( ), il fratello Klaus Bonhoeffer e l amico Friedrich Justus Perels ( ).
44 Il 5 aprile del 1943 il capo del tribunale militare Manfred Roeder e l agente della Gestapo criminale Sonderegger arrestarono Dietrich Bonhoeffer. Contemporaneamente vennero imprigionati Hans von Dohnanyi e il dott. Josef Müller, con le rispettive mogli.
45 Dietrich Bonhoeffer venne rinchiuso nel carcere di Tegel, nei sobborghi di Berlino. La vita in cella fu all inizio per Bonhoeffer un tormento: soffriva, infatti, dello stretto isolamento, poiché ai guardiani era proibito parlare con i politici.
46
47 Continuò con estremo impegno la sua attività di riflessione ed elaborazione, che consegnò a numerose lettere, inviate alla fidanzata, ai famigliari, agli amici, in particolare a Eberhard Bethge, che ne avrebbe curato l edizione. Queste sarebbero state raccolte e pubblicate nel 1951 a Monaco con un titolo tratto da una espressione usata in una lettera, Resistenza e resa (Winderstand und Ergebung).
48 Quando egli seppe del fallimento del colpo di Stato (già la sera dello stesso 20 luglio), perse ogni speranza e si preparò al peggio. La squadra della Gestapo tardava ad arrivare. Passarono giorni, settimane. In questo periodo prese in considerazione l idea di fuggire dal carcere. Il suo guardiano, il sottufficiale Knobloch, un operaio di Berlino nord, aveva collaborato, nel periodo di prigionia di Bonhoeffer, a far uscire la sua corrispondenza clandestina.
49 Una settimana dopo però il fratello Klaus, il cognato Rüdiger Schleicher e l amico Friedrich Perels vennero arrestati a causa della loro partecipazione al complotto, così Bonhoeffer non dette seguito al suo piano di fuga per non compromettere ulteriormente il fratello e i parenti (temeva cha anche altri famigliari potessero essere imprigionati).
50 Nel frattempo la Gestapo aveva trovato dei documenti della Abwehr che dimostravano la partecipazione alla congiura di Bonhoeffer fin dal Hitler era fuori di sé. Revocò l ordine di eliminazione immediata dei cospiratori al fine di accertare ulteriori ramificazioni. Questo spiega perché le esecuzioni furono rimandate per lungo tempo.
51 Dopo vari trasferimenti da un carcere all altro (da Tegel a quello della Gestapo in Prinz- Albrecht-Straße) o in diversi campi di concentramento (Buchenwald, Regensburg, Schönberg e infine Flossenbürg), Dietrich Bonhoeffer venne impiccato con un gancio da macellaio all alba del 9 aprile 1945, pochi giorni prima della fine della guerra.
52 Con lui a Flossenbürg vennero giustiziati pure Canaris e altri (Oster, Strünk e Gehre). Klaus Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher e F.J. Perels furono uccisi a Berlino il 23 aprile.
53 In una lettera al padre Karl, Dietrich Bonhoeffer, confrontando le loro generazioni, osservava come la sua fosse caratterizzata dall incompletezza e dalla frammentarietà. Vi sono, però, frammenti senza alcun significato e valore, e altri in cui, invece, è possibile distinguere come era impostata e progettata la struttura completa dell opera da cui derivano, e la cui importanza può durare nei secoli.
54 Ucciso a 39 anni, nel campo di Flossenbürg per la sua partecipazione alla resistenza antinazista, Bonhoeffer ha indubbiamente prodotto un opera frammentaria, una parte notevole della quale è costituita dalle lettere scritte in carcere, ma di tale qualità che nel frammento si intravede, a volte, la bellezza del tutto, altre volte si delineano nuove strade da percorrere.
55 Sempre emergono una estrema onestà intellettuale e il coraggio di porsi gli interrogativi più inquietanti, in un confronto esigente e radicale con la realtà contemporanea nelle sue caratteristiche positive e nei suoi drammi.
56 Scritti pubblicati in vita e postumi
57 In Italia, l edizione critica delle Opere di Dietrich Bonhoeffer, è stata pubblicata, in 10 volumi usciti dal 1991 al 2009, dall Editrice Queriniana di Brescia. In Germania, l edizione dell Opera omnia, prima come Gesammelte Schriften (Bd I-VI), a cura di Eberhard Bethge, , e poi come Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) (17 Bände und 2 Ergänzungsbänd), a cura di altri, , da Kaiser Gütersloher Verlagshaus di München.
58 Bonhoeffer, come in parte anticipato, aveva pubblicato nel 1930 Sanctorum Communio. Ricerca dogmatica sulla sociologia della chiesa (Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche), nel 1931 Atto ed essere. Filosofia trascendentale ed ontologia nella teologia sistematica (Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie), nel 1933 Creazione e caduta (Schöpfung und Fall), nel 1937 Sequela (Nachfolge), nel 1939 Vita comunitaria (Gemeinsamens Leben), nel 1940 Il libro di preghiera della Bibbia. Una introduzione ai Salmi (Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in die Psalmen).
59
60 Postume uscirono le opere che, secondo l autore, dovevano costituire il suo contributo maggiore: Etica (Ethik, 1949), Resistenza e resa. Lettere e appunti dal carcere (Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 1951), Tentazione (Versuchung, 1953), Il mondo maggiorenne (Die mündige Welt, ), Frammenti da Tegel (Fragmente aus Tegel. Drama und Roman, 1978).
61
62
63 Foto e disegni
64
65
66
67 Abbazia di Westminster Martiri del XX secolo
68
69
70 Fonti
71 E. Berti, F. Volpi, Storia della filosofia. Ottocento. Novecento, Laterza, Rom-Bari 1991; Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Milano 1993²; A. Gallas, La centralità del Dio inutile, Saggio introduttivo a D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988; I. Mancini, Ciò che è vivo e ciò che è morto nell Etica di Bonhoeffer, Introduzione a D. Bonhoeffer, Etica, Bompiani, Milano 1969; S. Tassinari, Storia della filosofia occidentale, 3**, Bulgarini, Firenze 1994; < >.
72 Etica e Resistenza e resa
73 Cose ultime e penultime
74 Come anticipato, cominceremo il nostro percorso da alcune pagine dell Etica di Bonhoeffer, in particolare dal suo capitolo più compiuto, Le cose ultime e penultime, «scritto nella quiete del lungo soggiorno passato nell abbazia benedettina di Ettal sui monti bavaresi tra la fine del 1940 e l inizio del 1941» (Mancini, Introduzione, cit., p. X).
75 Tale testo «potrà convincere il lettore di quanto Bonhoeffer si sia spinto a fondo nella elaborazione di un etica della vitalità concreta, non senza intendimenti polemici sia contro la derelizione secolare del protestantesimo che faceva della vita una quantité négligeable, sia contro la pratica nazista, soprattutto con il tema dell eutanasia e dell omicidio. Dr. Joseph Mengele
76 Tutta l Etica di Bonhoeffer può essere letta in chiave di opposizione al nazismo, per la presenza di certi temi tipici e soprattutto per la dottrina generale della responsabilità, comportante una radicale assunzione di responsabilità politica, che confina con una teoria della resistenza e della rivoluzione» (ibidem). vs
77 «Bonhoeffer si interroga sul compito che incombe ai cristiani e alla Chiesa in determinate situazioni nazismo o realtà assimilabili e polemizza con quanti evitano di affrontare sofferenze per una causa giusta [ ]. Egli denuncia come la Chiesa sia stata muta quando avrebbe dovuto gridare perché il sangue degli innocenti gridava al cielo.
78 Dietro questi atteggiamenti esistono però anche carenze a livello teorico: Bonhoeffer rifiuta, nella dottrina luterana dei due regni, una netta separazione che finisce per paralizzare l intervento nella sfera mondana. Il Dio che si è rivelato in Cristo è infatti Signore di tutti e due i regni: l autorità deve essere dunque giudicata non solo in riferimento alla Legge ma anche al Vangelo.
79 La carenza di impegno può essere anche letta in collegamento ad un altra posizione tipica del protestantesimo: la teoria della radicale corruzione della natura umana. Bonhoeffer ravvisa un vero vuoto teorico nell aver, di fatto, eliminato il concetto di naturale, lasciandolo alla Chiesa cattolica. In tal modo, per mancanza di strumenti concettuali adeguati, non si è riusciti a dire una parola chiara su questioni scottanti. [ ]
80 Bonhoeffer tenta una nuova teorizzazione del naturale, in un quadro interpretativo più vasto, caratterizzato da una nuova terminologia: egli parla di realtà ultime e penultime, rifiutando l immagine tradizionale di una realtà divisa in due sfere ambito secolare / spirituale, naturale / soprannaturale, sacro / profano.
81 La posizione luterana tradizionale sul rapporto ultimo-penultimo è da lui respinta e qualificata come radicalismo, frutto di odio conscio o inconscio per ciò che esiste [la creazione]. Ugualmente [viene] rifiutato il compromesso, proprio della posizione cattolica. Questa riconosce l autonomia delle realtà penultime, ma relega le realtà ultime talmente al di là del quotidiano, da finire per accettare di fatto acriticamente l esistente.
82 Per Bonhoeffer è certamente a partire dalla realtà ultima che bisogna pensare e fondare ciò che è penultimo. Ed è in Cristo, nel suo essere, che ultimo e penultimo sono dati insieme: nella sua umanità si scorge l amore di Dio per la creazione, nella sua crocifissione il Giudizio sul mondo, nella resurrezione la volontà di creare un mondo nuovo.
83 L essere uomo di Cristo esprime la valorizzazione del naturale, del penultimo, mentre la crocifissione ne rappresenta la contestazione e la relativizzazione, e la resurrezione la prefigurazione del futuro escatologico, della realtà ultima.
84 In questa ottica il naturale ha un suo spazio: denota un esser libero, secolare, che ha in sé un rimando a Dio, solo perché è definito dalla volontà divina di conservare la vita.
85 Si tratta di un concetto più libero da implicazioni teologiche di quello di creaturale e comunque sempre da pensare in relazione a Cristo che, nella sua incarnazione, fa sì che la vita naturale divenga il penultimo indirizzato verso l ultimo» (Tassinari, Storia della filosofia occidentale, cit., pp ).
86 ETICA (ETHIK)
87 CAPITOLO IV LE COSE ULTIME E PENULTIME (DIE LETZTEN UND DIE VORLETZTEN DINGE)
88 LE COSE ULTIME E PENULTIME La giustificazione in quanto Parola suprema Paolo di Tarso Martin Lutero
89 Le realtà penultime Henrik Ibsen
90 Le realtà penultime Fëdor Dostoevskij
91 Preparare la via Signore Gesù, nella tua bontà e misericordia, fa tu ch io sia pronto, misero qual sono, per questo tempo santo! Valentin Thilo
92 Il naturale
93 La vita naturale Immanuel Kant
94 Suum cuique
95 Suum cuique
96 Il diritto alla vita fisica Atteggiamento idealistico Corporeità strumento Atteggiamento cristiano Corporeità sia strumento sia fine a se stessa Atteggiamento materialistico Corporeità fine a se stessa
97 Il diritto alla vita fisica abitazione gioco cibo vestito sessualità bevanda ricreazione Tutto ciò mostra come il senso della vita del corpo non si esaurisca mai nella mera strumentalità, ma includa necessariamente la soddisfazione del desiderio di piacere che gli è inerente.
98 Il diritto alla vita fisica guerra riguardo agli ammalati eutanasia riguardo ai sani
99 Il diritto alla vita fisica Un caso limite Un bastimento sul quale scoppiasse la peste
100 Il diritto alla vita fisica Razionalismo + Biologizzazione della vita umana = Distruzione del diritto di vivere proprio di ogni creatura
101 Il suicidio patet exitus: si pugnare non vultis, licet fugere (la porta è aperta: se non volete lottare, è possibile fuggire [6, 7])
102 Il suicidio
103 Il suicidio
104 Il suicidio
105 Il suicidio Sant Agostino Padri della Chiesa
106 Procreazione e gestazione
107 Procreazione e gestazione Dopo il Sacra Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione sui matrimoni misti, 1966 Concilio Vaticano II ( ) Paolo VI, Matrimonia mixta, (1970), Lettera apostolica in forma di motu proprio, in cui vengono impartite norme sui matrimoni misti
108 Procreazione e gestazione
109 Procreazione e gestazione I. Kant San Paolo
110 Procreazione e gestazione Programma di sterilizzazione forzata su larga scala in India Indira Gandhi
111 La libertà della vita del corpo La Chiesa cattolica rifiuta categoricamente la sterilizzazione
112 La libertà della vita del corpo Tommaso d Aquino condannò la realtà della schiavitù Tommaso d Aquino
113 La libertà della vita del corpo Tortura e schiavitù
114 APPENDICE V CHE COSA SIGNIFICA DIRE LA VERITÀ?
115 CHE COSA SIGNIFICA DIRE LA VERITÀ? Alla parola autentica si sostituisce la chiacchiera
116 Che cosa significa dire la verità? I. Kant, Sul presunto diritto di mentire per amore degli uomini (1797)
117 Che cosa significa dire la verità? Scrittore, pittore, pedagogo austriaco Adalbert Stifter
118 Che cosa significa dire la verità?
119 Che cosa significa dire la verità? Ogni mente profonda ha bisogno di una maschera. Al di là dal bene e dal male, Lo spirito libero, 40. Friedrich Nietzsche
120 Che cosa significa dire la verità?
121 Che cosa significa dire la verità?
122 RESISTENZA E RESA. LETTERE E SCRITTI DAL CARCERE (WIDERSTAND UND ERGEBUND. BRIEFE UND AUFZEICHNUNGEN AUS DER HAFT)
123 PROLOGO DIECI ANNI DOPO. UN BILANCIO SUL LIMITARE DEL 1943
124 DIECI ANNI DOPO Coraggio politico? Martin Lutero
125 Del successo
126 Giustizia immanente Etica aristotelico-tomista
127 Fiducia
128 Presente e futuro
129 Cristianesimo in un mondo adulto
130 ALCUNE LETTERE
131 ALCUNE LETTERE Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Miquel de Cervantes
132 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Heinrich von Kleist
133 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 José Ortega y Gasset
134 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Karl Barth
135 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Rudolf Bultmann
136 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Liturgia della V Domenica di Pasqua Antifona d ingresso (Sal 97, 1-2) Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi; a tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit Dóminus; ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam, allelúia.
137 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Carl Friedrich von Weizsäcker
138 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944
139 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Adolf Schlatter, Paul Althaus e Paul Tillich
140 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Sbarco in Normandia
141 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Ernst Troeltsch Karl Heim
142 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Paul Althaus Paul Tillich
143 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944
144 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944
145 Sopravvivere fino al colpo di Stato. Aprile Luglio 1944 Paul Schütz
146 Dopo il fallimento. Luglio 1944 Febbraio 1945 Paul Gerhardt
147 Dopo il fallimento. Luglio 1944 Febbraio 1945 Martin Lutero
148 Dopo il fallimento. Luglio 1944 Febbraio 1945
149 POESIA STAZIONI SULLA VIA VERSO LA LIBERTÀ
150 FINE
Indice generale. Prefazione all edizione italiana di ALBERTO CONCI LONDRA
 Indice generale Prefazione all edizione italiana di ALBERTO CONCI 5 1933-1935 LONDRA I. Lettere e documenti 1. A Karl Barth (Londra, 24/10/1933) 15 2. Da Karl Barth (Bonn, 20/11/1933) 19 3. Dichiarazione
Indice generale Prefazione all edizione italiana di ALBERTO CONCI 5 1933-1935 LONDRA I. Lettere e documenti 1. A Karl Barth (Londra, 24/10/1933) 15 2. Da Karl Barth (Bonn, 20/11/1933) 19 3. Dichiarazione
TESTIMONI PER IL NOSTRO TEMPO: Geremia Dietrich Bonhoeffer
 Il profeta antico ed il profeta moderno: Geremia e Bonhoeffer Introduzione 1. VITE PARALLELE Dietrich Bonhoeffer: Da Berlino a Flossenbürg La tragedia di Geremia 2. LETTURA DI TESTI Geremia 20,7-18 [Passi
Il profeta antico ed il profeta moderno: Geremia e Bonhoeffer Introduzione 1. VITE PARALLELE Dietrich Bonhoeffer: Da Berlino a Flossenbürg La tragedia di Geremia 2. LETTURA DI TESTI Geremia 20,7-18 [Passi
Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Filosofia CHE FARE? COSCIENZA E UBBIDIENZA IN DIETRICH BONHOEFFER
 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Filosofia CHE FARE? COSCIENZA E UBBIDIENZA IN DIETRICH BONHOEFFER Tesi di Laurea di PAOLO MASSIMILIANO FOSSATI
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Filosofia CHE FARE? COSCIENZA E UBBIDIENZA IN DIETRICH BONHOEFFER Tesi di Laurea di PAOLO MASSIMILIANO FOSSATI
Indice generale GIOVENTÙ E PERIODO DEGLI STUDI
 Prefazione all edizione italiana di ALBERTO CONCI 5 1918-1927 GIOVENTÙ E PERIODO DEGLI STUDI I. Lettere, diari, documenti A)LA PRIMA GUERRA MONDIALE E GLI INIZI DELLA REPUBBLICA; GLI ULTIMI ANNI DI SCUOLA
Prefazione all edizione italiana di ALBERTO CONCI 5 1918-1927 GIOVENTÙ E PERIODO DEGLI STUDI I. Lettere, diari, documenti A)LA PRIMA GUERRA MONDIALE E GLI INIZI DELLA REPUBBLICA; GLI ULTIMI ANNI DI SCUOLA
14-25 APRILE 2010 I colori del 25 aprile. 16 aprile 2010 Incontro su Dietrich Bonhoeffer, l autore di Resistenza e resa
 14-25 APRILE 2010 I colori del 25 aprile 16 aprile 2010 Incontro su Dietrich Bonhoeffer, l autore di Resistenza e resa Cenni biografici Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo protestante tedesco, nasce
14-25 APRILE 2010 I colori del 25 aprile 16 aprile 2010 Incontro su Dietrich Bonhoeffer, l autore di Resistenza e resa Cenni biografici Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo protestante tedesco, nasce
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA
 Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CLASSE QUINTA. 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio. Attività Verifiche Valutazione. Conoscenze ( Contenuti)
 CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO
 CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
«In modo acerbo e sommario»
 Cristiano Massimo Parisi 3 «In modo acerbo e sommario» Attualità della proposta teologica di Dietrich Bonhoeffer 4Proprietà letteraria riservata. I diritti di traduzione in qualsiasi forma, di memorizzazione
Cristiano Massimo Parisi 3 «In modo acerbo e sommario» Attualità della proposta teologica di Dietrich Bonhoeffer 4Proprietà letteraria riservata. I diritti di traduzione in qualsiasi forma, di memorizzazione
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
DISCIPLINA: Religione Cattolica
 CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
Penitenza e unzione dei malati
 Angelo Maffeis Penitenza e unzione dei malati Queriniana Indice generale Introduzione.... 5 parte prima Penitenza 1. Il sacramento della penitenza tra passato e presente... 11 1. La confessione nella chiesa
Angelo Maffeis Penitenza e unzione dei malati Queriniana Indice generale Introduzione.... 5 parte prima Penitenza 1. Il sacramento della penitenza tra passato e presente... 11 1. La confessione nella chiesa
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Dietrich Bonhoeffer, un teologo contro Hitler
 Dietrich Bonhoeffer, un teologo contro Hitler di Anselmo Palini «Solo chi alza la voce in difesa degli Ebrei, può permettersi di cantare in gregoriano» 1. Queste parole, risalenti al 1935, sono di uno
Dietrich Bonhoeffer, un teologo contro Hitler di Anselmo Palini «Solo chi alza la voce in difesa degli Ebrei, può permettersi di cantare in gregoriano» 1. Queste parole, risalenti al 1935, sono di uno
Il Presidente della Repubblica
 VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA
 CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
TEOLOGIA FONDAMENTALE. FENOMENOLOGIA DELL EVENTO FONDATORE Antonelli don Mario Castiglioni don Luca
 tesario dei singoli corsi TEOLOGIA FONDAMENTALE FENOMENOLOGIA DELL EVENTO FONDATORE Antonelli don Mario Castiglioni don Luca Introduzione storica 1. Il disegno dell apologetica 1.1 Sguardo complessivo
tesario dei singoli corsi TEOLOGIA FONDAMENTALE FENOMENOLOGIA DELL EVENTO FONDATORE Antonelli don Mario Castiglioni don Luca Introduzione storica 1. Il disegno dell apologetica 1.1 Sguardo complessivo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI. Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo Grado - RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI
Attività di potenziamento e recupero. 1. Chi sono gli uomini che Gesù chiama attorno a sé all inizio della sua predicazione?
 Attività di potenziamento e recupero 5. La Chiesa La Chiesa (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Disegna su un cartellone la cartina del tuo paese o della tua città indicando le chiese più
Attività di potenziamento e recupero 5. La Chiesa La Chiesa (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Disegna su un cartellone la cartina del tuo paese o della tua città indicando le chiese più
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA. del.
 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA. I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche
 ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
ISTITUTO TEOLOGICO INTERDIOCESANO DI BASILICATA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA docente: Sac. Gianluca Bellusci PROGRAMMA I PARTE I L Antropologia teologica: storia e questioni epistemologiche 1.1:
Riforma protestante. scaricato da
 Riforma protestante A causa degli atteggiamenti criticabili della Chiesa cattolica in Europa, nel Cinquecento crebbe sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato da alcune consuetudini discutibili
Riforma protestante A causa degli atteggiamenti criticabili della Chiesa cattolica in Europa, nel Cinquecento crebbe sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato da alcune consuetudini discutibili
PROGRAMMA a.s
 1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. Sede di Brescia. Istituto Superiore di Scienze Religiose
 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Brescia Istituto Superiore di Scienze Religiose ANNO ACCADEMICO 2009/2010 Istituto Superiore di Scienze Religiose È promosso dall Università Cattolica del Sacro
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Brescia Istituto Superiore di Scienze Religiose ANNO ACCADEMICO 2009/2010 Istituto Superiore di Scienze Religiose È promosso dall Università Cattolica del Sacro
RELIGIONE CATTOLICA. Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione
 Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI
 CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
Indice. 1. Motivi e importanza della questione retrospettiva Le più antiche raccolte ed esposizioni complessive La Fonte dei discorsi 27
 Prefazione........................................ 5 1. Il nuovo inizio postpasquale...................... 9 1. Le più antiche formule di fede e di professione di fede 9 1.1. La formula della risurrezione
Prefazione........................................ 5 1. Il nuovo inizio postpasquale...................... 9 1. Le più antiche formule di fede e di professione di fede 9 1.1. La formula della risurrezione
370 Indice 13. Rudolf Bultmann, Qual è il senso del Natale oggi? (1964) Rudolf Bultmann, Teologia e ateismo (1969) Karl Barth, Lettera d
 Indice Prefazione 5 1. Adolf von Harnack, L essenza del cristianesimo: «Dio come padre e il valore infinito dell anima» (1900) 7 2. Ernst Troeltsch, Il cristianesimo nella storia delle religioni: «la grande
Indice Prefazione 5 1. Adolf von Harnack, L essenza del cristianesimo: «Dio come padre e il valore infinito dell anima» (1900) 7 2. Ernst Troeltsch, Il cristianesimo nella storia delle religioni: «la grande
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2016/2017 Classe Prima INDICATORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.
 EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
Biblioteca. I volumi sono suddivisi per argomenti, come sotto indicato, con due macro-suddivisioni: PASTORALE e SPIRITUALITA
 Biblioteca Tutti i libri e i periodici trovano posto in una serie di scaffali che sono collocati in due posizioni e piazzati a forma di due U contrapposte, in modo da consentire un facile accesso 'a' e
Biblioteca Tutti i libri e i periodici trovano posto in una serie di scaffali che sono collocati in due posizioni e piazzati a forma di due U contrapposte, in modo da consentire un facile accesso 'a' e
Lu c i a n o Ma n i c a r d i è nato a Campagnola Emilia (RE) il 26 novembre Laureato in Lettere indirizzo Classico presso l Università degli
 Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 10 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Credo la Chiesa. Conversazioni sulla comunità credente. QUALE CHIESA? Introduzione alla questione.
 QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
QUALE CHIESA? Introduzione alla questione. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione
 COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
VIII. Insegnamento religioso
 VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono
VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono
Disciplina d insegnamento: Religione cattolica
 CLASSE 1 A Che cos è la religione? Come si sono formate le religioni nel mondo? Un solo Dio, più dei Il mistero dell esistenza Il mistero della vita Stare con gli altri, il rapporto con l altro Stare nel
CLASSE 1 A Che cos è la religione? Come si sono formate le religioni nel mondo? Un solo Dio, più dei Il mistero dell esistenza Il mistero della vita Stare con gli altri, il rapporto con l altro Stare nel
Facoltà Valdese di Teologia Formazione biblica e teologica Certificati ~ Percorso uditori
 Facoltà Valdese di Teologia Formazione biblica e teologica Certificati ~ Percorso uditori I corsi di Certificato permettono una fruizione molto diversificata dell'offerta formativa della Facoltà. Rispetto
Facoltà Valdese di Teologia Formazione biblica e teologica Certificati ~ Percorso uditori I corsi di Certificato permettono una fruizione molto diversificata dell'offerta formativa della Facoltà. Rispetto
RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas
 RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
PROGRAMMA PRIMO CICLO - BACCELLIERATO AMMISSIONE PIANO DI STUDIO
 PROGRAMMA 2010-11 PRIMO CICLO - BACCELLIERATO Al primo ciclo sono ammessi coloro che: AMMISSIONE possono iscriversi all università nel Paese di provenienza; hanno frequentato un biennio filosofico di livello
PROGRAMMA 2010-11 PRIMO CICLO - BACCELLIERATO Al primo ciclo sono ammessi coloro che: AMMISSIONE possono iscriversi all università nel Paese di provenienza; hanno frequentato un biennio filosofico di livello
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
Totalitarismi a confronto
 Totalitarismi a confronto REGIMI TOTALITARI FASCISMO NAZISMO STALINISMO FONDATO 1919 1920 1927 INIZIO 1922 1933 1929 FINE 1943 (-1945) 1945 1953 FONDATORE B. MUSSOLINI A. HITLER J. STALIN I fasces lictoriae
Totalitarismi a confronto REGIMI TOTALITARI FASCISMO NAZISMO STALINISMO FONDATO 1919 1920 1927 INIZIO 1922 1933 1929 FINE 1943 (-1945) 1945 1953 FONDATORE B. MUSSOLINI A. HITLER J. STALIN I fasces lictoriae
RELAZIONE FINALE. Istituto di Istruzione Superiore telefono: ITALO CALVINO fax: via Guido Rossa ROZZANO MI
 Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,
Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,
I ANNO. Antico Testamento. Scopi. Materie fondamentali
 IL PIANO DI STUDI I ANNO TEOLOGIA ESEGETICA Antico Testamento 1. Promuovere la conoscenza di questa parte del Canone biblico 2. Studiare la storia biblica d'israele e la funzione del profetismo veterotestamentario
IL PIANO DI STUDI I ANNO TEOLOGIA ESEGETICA Antico Testamento 1. Promuovere la conoscenza di questa parte del Canone biblico 2. Studiare la storia biblica d'israele e la funzione del profetismo veterotestamentario
Pier Giordano Cabra LA VITA CONSACRATA. Appunti di teologia e spiritualità. terza edizione. Editrice Queriniana
 Pier Giordano Cabra LA VITA CONSACRATA Appunti di teologia e spiritualità terza edizione Editrice Queriniana Nota dell editore Queste pagine che escono con il titolo La vita consacrata. Appunti di teologia
Pier Giordano Cabra LA VITA CONSACRATA Appunti di teologia e spiritualità terza edizione Editrice Queriniana Nota dell editore Queste pagine che escono con il titolo La vita consacrata. Appunti di teologia
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia
 Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
Programmazione Didattica Scuola dell'infanzia Istitituti Comprensivi 15 e 17 di Bologna a.s. 2015-2016 Ins. Cice Maria Rosa Le attività in ordine all insegnamento della Religione Cattolica, per coloro
INDICE. Prefazione. digitalisiert durch IDS Basel/Bern, im Auftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek
 INDICE Prefazione Prologo AVERE UN CUORE CHE ASCOLTA Sulla della teologia di Benedetto XVI.... 9 Amicizia con il Dio vivente 9 2. Essere a servizio di un 3. Chiesa profeticamente mariana 13 Capitolo Primo
INDICE Prefazione Prologo AVERE UN CUORE CHE ASCOLTA Sulla della teologia di Benedetto XVI.... 9 Amicizia con il Dio vivente 9 2. Essere a servizio di un 3. Chiesa profeticamente mariana 13 Capitolo Primo
LA RIFORMA PROTESTANTE. 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO
 LA RIFORMA PROTESTANTE 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO MARTIN LUTERO CHI ERA? Un monaco agostiniano tedesco e professore di teologia a Wittenberg E il fondatore del PROTESTANTESIMO, una dottrina religiosa
LA RIFORMA PROTESTANTE 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO MARTIN LUTERO CHI ERA? Un monaco agostiniano tedesco e professore di teologia a Wittenberg E il fondatore del PROTESTANTESIMO, una dottrina religiosa
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO
 ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
BRESCIA a.a Corso di laurea. triennale e magistrale. Scienze religiose. Istituto Superiore di Scienze Religiose
 BRESCIA a.a. 2016-17 Corso di laurea triennale e magistrale Scienze religiose Istituto Superiore di Scienze Religiose Sommario Istituto Superiore di Scienze Religiose 3 Piani di studio 5 Laurea triennale
BRESCIA a.a. 2016-17 Corso di laurea triennale e magistrale Scienze religiose Istituto Superiore di Scienze Religiose Sommario Istituto Superiore di Scienze Religiose 3 Piani di studio 5 Laurea triennale
Liceo G. Galilei Trento
 Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
TEOLOGIA MORALE FAMILIARE a.a. 2016/2017. corso semestrale di 3 ects/cfu prof. p. Fabrizio Zorzan
 TEOLOGIA MORALE FAMILIARE a.a. 2016/2017 corso semestrale di 3 ects/cfu prof. p. Fabrizio Zorzan Il corso vuole essere una presentazione dei temi inerenti la vita coniugale e sessuale alla luce della riflessione
TEOLOGIA MORALE FAMILIARE a.a. 2016/2017 corso semestrale di 3 ects/cfu prof. p. Fabrizio Zorzan Il corso vuole essere una presentazione dei temi inerenti la vita coniugale e sessuale alla luce della riflessione
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006
 Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
Evangelium vitae III Non uccidere (la legge santa di Dio) AMCI Sezione di Torino 2006 Comandamento di Dio Comandamento = mezzo per entrare nella Vita (quella vera quella eterna) => Costruire il Regno di
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna. Introduzione
 Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 I LEZIONE L ignoranza delle Scritture
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 I LEZIONE L ignoranza delle Scritture
progetto di dio Meditazioni sulla creazione e la Chiesa
 Joseph RatzingeR Benedetto XVi progetto di dio Meditazioni sulla creazione e la Chiesa edizione italiana ampliata edizione italiana ampliata traduzione e indici a cura di Carlo Carniato Joseph Ratzinger/Benedetto
Joseph RatzingeR Benedetto XVi progetto di dio Meditazioni sulla creazione e la Chiesa edizione italiana ampliata edizione italiana ampliata traduzione e indici a cura di Carlo Carniato Joseph Ratzinger/Benedetto
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA. ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B
 PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
PROGRAMMA SCOLASTICO DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - Classe 4 SEZ. B La ricerca del pensiero Storia, testi e problemi della filosofia Volume 1B UNITA 5 SOCIETA E CULTURA NELL ETA ELLENISTICA CAPITOLO
LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIE CURIE. Programma di Religione Cattolica svolto dal docente Giannuzzi Tommaso. Classe I sez. E
 Classe I sez. E Classe I sez. F Classe I sez. G Classe II sez. F Presentazione della classe; Il fenomeno religioso; La risposta religiosa: in ricerca di Dio; Introduzione alle religioni del mondo; Introduzione
Classe I sez. E Classe I sez. F Classe I sez. G Classe II sez. F Presentazione della classe; Il fenomeno religioso; La risposta religiosa: in ricerca di Dio; Introduzione alle religioni del mondo; Introduzione
FACOLTÀ. di MISSIOLOGIA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA. 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato
 FACOLTÀ di MISSIOLOGIA 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA Altre offerte Accademiche Baccellierato in Missiologia Il Baccellierato
FACOLTÀ di MISSIOLOGIA 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA Altre offerte Accademiche Baccellierato in Missiologia Il Baccellierato
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
Andrea Chittolina & Germano Rossi. Conoscenze religiose in un gruppo di studenti delle superiori
 Andrea Chittolina & Germano Rossi Conoscenze religiose in un gruppo di studenti delle superiori Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale, Università degli Studi, Verona, Italy 1 Scopo della
Andrea Chittolina & Germano Rossi Conoscenze religiose in un gruppo di studenti delle superiori Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale, Università degli Studi, Verona, Italy 1 Scopo della
Il Presidente della Repubblica
 Il Presidente della Repubblica Visto Vista l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
Il Presidente della Repubblica Visto Vista l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
CLASSE PRIMA MACRO ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI COMPETENZE 1 2 3
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica
 La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica Angela Anna Tozzi LA BELLEZZA DELL AMORE NEGLI SCRITTI DI GIOVANNI PAOLO II: ETICA ED ESTETICA www.booksprintedizioni.it Copyright
La bellezza dell amore negli scritti di Giovanni Paolo II: Etica ed estetica Angela Anna Tozzi LA BELLEZZA DELL AMORE NEGLI SCRITTI DI GIOVANNI PAOLO II: ETICA ED ESTETICA www.booksprintedizioni.it Copyright
LA TRAMA l inizio di un amicizia speciale
 L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima
L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima
LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA
 Walter Kasper LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia di fronte alla crisi della modernità per una nuova cultura liturgica...
Walter Kasper LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia di fronte alla crisi della modernità per una nuova cultura liturgica...
Indice. Prefazione Introduzione... 9
 Indice Prefazione................... 5 Introduzione................... 9 I. LA CHIESA CATTOLICA (GEOrG HInTzEn)... 13 1. Storia 13 Antichità 13 Medioevo 14 Evo moderno 15 2. Situazione odierna 15 3. Costituzione
Indice Prefazione................... 5 Introduzione................... 9 I. LA CHIESA CATTOLICA (GEOrG HInTzEn)... 13 1. Storia 13 Antichità 13 Medioevo 14 Evo moderno 15 2. Situazione odierna 15 3. Costituzione
Prefazione... 5 Introduzione... 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E LA RELIGIONE... 19
 La liberta religiosa_la liberta religiosa 25/05/10 12.33 Pagina 331 331 Sommario Prefazione.................................. 5 Introduzione................................ 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E
La liberta religiosa_la liberta religiosa 25/05/10 12.33 Pagina 331 331 Sommario Prefazione.................................. 5 Introduzione................................ 9 CAPITOLO PRIMO LO STATO E
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
PROGRAMMA SVOLTO. CLASSE: 4 Alfa Classico - 4 Beta Classico MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE: SILVIA MANUNTA Anno Scolastico 2010/2011
 CLASSE: 4 Alfa Classico - 4 Beta Classico : SILVIA MANUNTA Cultura e religione I principali significati dei termini: cultura, religione; Il rapporto tra cultura italiana ed europea e la religione cattolica;
CLASSE: 4 Alfa Classico - 4 Beta Classico : SILVIA MANUNTA Cultura e religione I principali significati dei termini: cultura, religione; Il rapporto tra cultura italiana ed europea e la religione cattolica;
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
METODO DI CATALOGAZIONE (Dewey modificato)
 METODO DI CATALOGAZIONE (Dewey modificato) 220 220.1 220.2 220.3 220.4 221 221.1 221.2 221.3 221.4 222 223 224 225 225.1 225.2 225.3 225.4 226 227 228 229 Bibbia: testo Bibbia: introduzione Bibbia: dizionari
METODO DI CATALOGAZIONE (Dewey modificato) 220 220.1 220.2 220.3 220.4 221 221.1 221.2 221.3 221.4 222 223 224 225 225.1 225.2 225.3 225.4 226 227 228 229 Bibbia: testo Bibbia: introduzione Bibbia: dizionari
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO
 III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
Cattolicesimo e Protestantesimo
 Cattolicesimo e Protestantesimo Papa Leone X, ritratto da Raffaello Sanzio (particolare); dipinto a olio su tavola, Galleria degli Uffizi di Firenze Martin Lutero, ritratto da Lucas Cranach il Vecchio
Cattolicesimo e Protestantesimo Papa Leone X, ritratto da Raffaello Sanzio (particolare); dipinto a olio su tavola, Galleria degli Uffizi di Firenze Martin Lutero, ritratto da Lucas Cranach il Vecchio
vai alla scheda del libro su
 Margherita Redaelli Lezioni di libertà Hannah Arendt in America vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2014 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126
Margherita Redaelli Lezioni di libertà Hannah Arendt in America vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2014 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126
V ANNO TEOLOGIA SISTEMATICA. ANTROPOLOGIA TEOLOGICA-ESCATOLOGICA Scanziani don Francesco. PREMESSA. Chi è l uomo perché te ne curi? (sl 8).
 tesario dei singoli corsi V ANNO TEOLOGIA SISTEMATICA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA-ESCATOLOGICA Scanziani don Francesco PREMESSA. Chi è l uomo perché te ne curi? (sl 8). Il profilo e la vicenda dell Antropologia
tesario dei singoli corsi V ANNO TEOLOGIA SISTEMATICA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA-ESCATOLOGICA Scanziani don Francesco PREMESSA. Chi è l uomo perché te ne curi? (sl 8). Il profilo e la vicenda dell Antropologia
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
San Benedetto da Norcia e il monachesimo
 San Benedetto da Norcia e il monachesimo Il monachesimo fin dalle origini è conosciuto come una forma di vita ispirata alla ricerca della felicità. Ci sono diverse forme di monachesimo nella storia dell
San Benedetto da Norcia e il monachesimo Il monachesimo fin dalle origini è conosciuto come una forma di vita ispirata alla ricerca della felicità. Ci sono diverse forme di monachesimo nella storia dell
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione Prima Parte
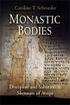 Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
Premessa... 5 Abbreviazioni... 6 Introduzione... 7 Prima Parte teologia biblica: Itinerari Capitolo 1 itinerario teoretico.............. 13 Una definizione... 14 1. Fondazione epistemologica e legittimità
ISSR di Crema Cremona Lodi Esame di Laurea comprensivo del I Triennio
 ISSR di Crema Cremona Lodi Esame di Laurea comprensivo del I Triennio In vista del prossimo esame di laurea triennale, porto alla conoscenza di tutti alcune note normative e qualche indicazione pratica.
ISSR di Crema Cremona Lodi Esame di Laurea comprensivo del I Triennio In vista del prossimo esame di laurea triennale, porto alla conoscenza di tutti alcune note normative e qualche indicazione pratica.
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE PER GRUPPI DIDATTICI
 MATERIA: I.R.C. CLASSI PRIME Riconoscere l importanza delle domande di senso per ogni uomo e orientarsi fra le varie proposte odierne con senso critico. Le domande di senso Dibattito. Riflessione personale.
MATERIA: I.R.C. CLASSI PRIME Riconoscere l importanza delle domande di senso per ogni uomo e orientarsi fra le varie proposte odierne con senso critico. Le domande di senso Dibattito. Riflessione personale.
Rinnovarsi nella libertà Anno II
 Centro Diocesano di Spiritualità Crema (Georges Braque, Oiseau bleu et gris) Proposte 2013 2014 Rinnovarsi nella libertà Anno II Presentazione del programma 2013-2014 Rinnovarsi nella libertà Ogni uomo
Centro Diocesano di Spiritualità Crema (Georges Braque, Oiseau bleu et gris) Proposte 2013 2014 Rinnovarsi nella libertà Anno II Presentazione del programma 2013-2014 Rinnovarsi nella libertà Ogni uomo
Introduzione Religione e senso della vita
 Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia
Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia
Dieci parole per essere umani
 Terebinto 14 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
Terebinto 14 Il Terebinto è una pianta diffusa nella macchia mediterranea. Nella Bibbia è indicata come l albero alla cui ombra venne a sedersi l angelo del Signore (Gdc 6,11); la divina Sapienza è descritta
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO.
 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
ANNI DI RIFORMA PROTESTANTE. Claudiana Paideia. letture per i tempi della Riforma
 ANNI DI RIFORMA PROTESTANTE Claudiana Paideia letture per i tempi della Riforma 1517-2017: 500 anni di Riforma protestante HEINZ SCHILLING Martin Lutero Ribelle in un epoca di cambiamenti radicali pp.
ANNI DI RIFORMA PROTESTANTE Claudiana Paideia letture per i tempi della Riforma 1517-2017: 500 anni di Riforma protestante HEINZ SCHILLING Martin Lutero Ribelle in un epoca di cambiamenti radicali pp.
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Nona lezione: La teologia contemporanea Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 12 gennaio 2009 Fratture
Introduzione alla Teologia Nona lezione: La teologia contemporanea Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 12 gennaio 2009 Fratture
