La Fisica Astroparticellare e del Neutrino
|
|
|
- Cornelia Nigro
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La Fisica Astroparticellare e del Neutrino 1. Introduzione La fisica del neutrino e delle astroparticelle è un settore in notevole espansione. L espressione fisica astroparticellare introdotta negli anni 90, indica ricerche comprendenti lo studio dei neutrini, la ricerca del decadimento del protone, l identificazione dei costituenti della materia oscura, la comprensione dell origine e della composizione dei raggi cosmici, la ricerca dell antimateria nella radiazione cosmica e la rivelazione diretta delle onde gravitazionali. La fisica astroparticellare è un settore interdisciplinare nuovo che coinvolge ricercatori che operano in ambiti diversi. Questo rende importante uno stretto coordinamento dell INFN con altri Enti di ricerca italiani quali INAF, per l astrofisica, ed ASI per le attività nello spazio. In ambito INFN le attivita di fisica astroparticellare e dei neutrini sono di competenza della CSN2 ( Le iniziative svolte, molto diverse tra loro per tematiche, tecnologie e risorse necessarie, sono raggruppate secondo le seguenti linee: 1) studi delle proprieta' del neutrino (condotte principalmente presso i LNGS) 2) misure di processi rari (condotte anch esse principalmente presso i LNGS) 3) studio della radiazione cosmica in superficie e nelle profondita' marine 4) studio della radiazione cosmica nello spazio 5) ricerca di onde gravitazionali 6) fisica generale (riguarda verifiche sperimentali di aspetti fondamentali della elettrodinamica e della meccanica quantistica). Nel presente documento sono riportate sinteticamente le attivita in corso (Sezione 2) e quelle previste per il prossimo quinquennio (Sezione 3); nella Sezione 5 viene presentata una valutazione delle esigenze finanziarie. 2. La fisica del neutrino I risultati recenti più importanti nella fisica del neutrino sono stati ottenuti dallo studio dei neutrini naturali (vedi figura 2.1). Negli ultimi anni è diventato evidente che le masse dei neutrini sono diverse da zero e che il cosiddetto fenomeno delle oscillazioni dei neutrini, previsto da Bruno Pontecorvo, mescola tra di loro le tre famiglie di neutrini Il presente documento costituisce una sintesi delle relazioni prodotte per le diverse linee di ricerca della CSN2 dai rispettivi gruppi di lavoro. Tali documenti sono disponibili all indirizzo
2 conosciute. Le oscillazioni sono state rivelate sia nei neutrini provenienti dal Sole (ν e ) che nei neutrini prodotti dall interazione dei raggi cosmici in atmosfera (ν µ ) e più recentemente con i neutrini artificiali prodotti ai reattori o con acceleratori di particelle. Figura 2.1 Il flusso di neutrini naturali in funzione dell energia La scoperta del fenomeno delle oscillazioni è stato l obiettivo di molti esperimenti dell INFN e alcuni tra questi, come GALLEX-GNO, MACRO e CHOOZ, hanno dato un contributo determinante. 2.1 Neutrini CNGS, solari e da SN La maggior parte degli esperimenti INFN dedicati alla fisica del neutrino si svolge ai laboratori sotterranei del Gran Sasso (LNGS). La roccia sovrastante i laboratori riduce il fondo indotto dai raggi cosmici. Le tre sale sperimentali dei LNGS sono tutte orientate in direzione del CERN. L orientazione fu decisa già al momento della costruzione dei laboratori (anni 80) in previsione di un loro possibile utilizzo per lo studio delle oscillazioni dei neutrini utilizzando un fascio artificiale di neutrini proveniente dal CERN. In seguito alla scoperta delle oscillazioni con i neutrini naturali, è stato approvato il cosiddetto programma CNGS che prevede la produzione di un fascio di neutrini dal CERN al Gran Sasso (figura 2.2) da dedicare allo studio dettagliato delle oscillazioni, in modo particolare alla conversione dei ν µ in ν τ, con gli esperimenti OPERA e ICARUS-T600. I primi neutrini del fascio CNGS saranno prodotti a metà del 2006.
3 Figura 2.2. Il fascio CNGS di neutrini dal CERN al Gran Sasso Nei LNGS sono ospitati altri esperimenti dedicati alla rivelazione dei neutrini prodotti nell esplosione delle supernovae (LVD), allo studio dei neutrini solari e geotermici (BOREX, figura 2.3) e a verificare se neutrino ed antineutrino coincidono. Figura 2.3. L interno del rivelatore Borex ai LNGS
4 2.2 La massa dei neutrini Se neutrino ed antineutrino coincidono è possibile il decadimento beta di nuclei senza emissione di neutrini (esperimenti CUORICINO, CUORE, GERDA). L osservazione di questi decadimenti permetterebbe inoltre di misurare il valore assoluto delle masse dei neutrini, cosa non possibile con lo studio delle sole oscillazioni. Cuoricino è un rivelatore criogenico costituito da 72 cristalli di tellurite con massa totale di 42 Kg, in funzione da vari anni al Gran Sasso. Negli anni prossimi continuerà la costruzione di un apparato più grande chiamato CUORE in collaborazione con gruppi degli Stati Uniti. CUORE sarà un grande rivelatore di 1000 cristalli di tellurite con massa totale 770Kg. L obiettivo primario è la misura del decadimento beta doppio, con una sensibilità per la massa del neutrino dell ordine del centesimo di ev. Nella ricerca del decadimento beta doppio senza neutrini è importante verificare i risultati con materiali diversi. Negli anni prossimi sempre al Gran Sasso e in collaborazione con gruppi tedeschi, continuerà la costruzione dell apparato GERDA, per la ricerca dei decadimenti beta doppio senza neutrini in cristalli di germanio. 2.3 La materia oscura Secondo le attuali conoscenze, la materia oscura costituisce la maggior parte della materia dell Universo; la sua ricerca è di importanza fondamentale sia per la comprensione della natura dell Universo che per la fisica delle particelle. Lo spazio che si ritiene vuoto, sarebbe in realtà pieno di particelle, la cui massa totale sarebbe molto superiore a quella della materia ordinaria. Le teorie supersimmetriche predicono una particella, il neutralino, che è un buon candidato costituente della materia oscura. Le particelle supersimmetriche saranno ricercate nei prossimi anni all LHC; tuttavia la loro esistenza non implicherebbe automaticamente che esse costituiscano la materia oscura Materia oscura: ricerche dirette La rivelazione diretta di segnali di materia oscura nella nostra galassia è lo scopo di due esperimenti al Gran Sasso (DAMA e WARP) basati su due tecniche diverse. DAMA è in funzione da alcuni anni e ricerca la materia oscura studiando la modulazione stagionale dei segnali dovuta al moto della terra attorno al sole. La caratteristica principale di WARP, che entrerà in funzione il prossimo anno, è l ottima discriminazione del segnale rispetto al fondo della radioattività ambiente
5 Un altro tipo di esperimento, come PVLAS, ricerca particelle che si accoppiano elettromagneticamente; PVLAS ha rivelato recentemente anomalie che potrebbero essere collegate alla presenza di nuove particelle e indirette La materia oscura viene ricercata anche in modo indiretto, cioè osservando la produzione di secondari che sarebbero prodotti nell annichilazione particella-antiparticella in zone dell Universo in cui è previsto un accumulo di materia oscura, come il centro della Galassia, il centro del Sole o il centro della Terra. Questa ricerca costituisce un sottoprodotto di esperimenti come PAMELA, AMS, ANTARES, NEMO, AGILE, GLAST. 2.4 Gli effetti quantistici del vuoto Oltre alla materia oscura, il vuoto è pieno delle coppie virtuali di particelle predette dalla meccanica quantistica. Gli effetti quantistici del vuoto sono studiati dall esperimento MIR. 2.5 Raggi cosmici, astronomia gamma e astronomia a neutrini Lo studio dei raggi cosmici e l astronomia con fotoni e neutrini di alta ed altissima energia permettono l indagine dell universo non termico. Queste componenti giocano un ruolo importante dal punto di vista energetico e dinamico nei diversi ambienti astrofisici come si può intuire osservando che l energia associata a queste radiazioni è confrontabile con l energia associata alla radiazione termica, cioè luce, raggi X ed onde elettromagnetiche I raggi cosmici Nonostante sia trascorso oltre un secolo dalla scoperta dei raggi cosmici, numerose domande sono ancora senza risposta. Ad esempio, qual e la composizione dei raggi cosmici di alta energia? Dove sono prodotti e come possono essere accelerati fino ad energie di ev? Esiste antimateria nella radiazione cosmica? A queste ed altre domande cercano di rispondere esperimenti come AUGER, AMS, PAMELA, CREAM L astronomia gamma I raggi cosmici sono particelle cariche che vengono deviate dai campi magnetici galattici e pertanto non conservano informazioni sul punto di produzione. Questo non e vero per particelle neutre come i fotoni e i neutrini. Dopo decenni di insuccessi dovuti alla scarsa sensibilità degli apparati, l astronomia gamma, con fotoni di energia >100 GeV, è
6 divenuta in tempi molto recenti una realtà con la rivelazione di alcune decine di sorgenti, osservate anche con molti dettagli. L INFN è impegnata in questo campo con due esperimenti a terra con tecniche complementari (ARGO, MAGIC) e due esperimenti nello spazio (AGILE, GLAST) L astronomia a neutrini L astronomia con neutrini non ha ancora raggiunto le sensibilità sufficienti per rivelare segnali, ma puo essere di importanza forse maggiore dell astronomia gamma per l osservazione del cuore di siti estremamente energetici, come i nuclei galattici attivi. I neutrini hanno una bassissima probabilità di interazione e riescono ad attraversare gli strati più interni e densi di sorgenti molto compatte fornendoci quindi informazioni sui processi energetici in atto. L INFN e impegnato in prima linea in questo tipo di attivita, con il progetto NEMO in Sicilia, dedicato allo studio di fattibilità di un rivelatore da 1 km 3 e con ANTARES, al largo di Tolone, che ha già avviato con successo la costruzione di un rivelatore da circa m 2 di accettanza. 2.6 Le onde gravitazionali La ricerca delle onde gravitazionali riveste un duplice interesse: la verifica della relatività generale con lo studio dettagliato delle onde e lo studio di oggetti compatti ed estremamente energetici, come sistemi binari, pulsars, buchi neri ecc. Da questo punto di vista questa ricerca è strettamente collegata all astronomia con fotoni e neutrini. Dopo 40 anni di notevole sviluppo tecnologico la sensibilità attuale è molto vicina a quella necessaria per la rivelazione di segnali. L INFN è fortemente impegnata in questo campo con piccoli rivelatori risonanti a barre (AURIGA, EXPLORER, NAUTILUS) e l interferometro VIRGO, dotato di due braccia di 3 km, realizzato in collaborazione con la Francia (figura 2.4). E in preparazione una missione spaziale chiamata LISA- PATHFINDER per verificare le tecnologie che saranno usate nell interferometro spaziale LISA.
7 Figura 2.4. L interferometro per Onde Gravitazionali VIRGO a Cascina 2.7 La gravita La gravità, nonostante sia la prima interazione ad essere stata studiata, è forse la meno conosciuta. L esperimento MAGIA si propone di migliorare la misura della costante gravitazionale, una delle costanti fondamentali note con minore precisione. 3. Gli esperimenti futuri Nel seguito vengono descritte brevemente le iniziative in considerazione per il prossimo quinquennio. L ordine segue quello delle diverse linee di ricerca di competenza della CSN Oscillazione dei neutrini La prima generazione di esperimenti con fasci di neutrini a lunga distanza potrà rispondere solo approssimativamente a domande quali il valore dell angolo di mixing Θ13 e la violazione di CP nel settore leptonico. Questo tipo di violazione potrebbe giocare un ruolo molto importante nell asimmetria materia antimateria nell Universo. La misura dell angolo di mixing Θ 13 e della violazione di CP richiede nuovi fasci di neutrini di maggiore intensità e rivelatori avanzati. Le difficoltà di queste misure sono connesse alla
8 bassissima frequenza di interazione dei neutrini. Il completamento della misura della matrice di mixing dei neutrini richiederà molto tempo e uno stretto coordinamento a livello mondiale. Figura 3.1 Evoluzione della sensibilità nella misura di sin 2 Θ 13 in funzione del tempo. Per ogni esperimento è mostrata la sensibilità mondiale in funzione del tempo (linea continua) e la sensibilità calcolata senza quell esperimento (linea tratteggiata). Il confronto delle due curve mostra il contributo di un dato esperimento. In nero è inoltre mostrato la sensibilita globale ottenuto combinando tutti gli esperimenti. L INFN sta valutando due possibili partecipazioni: T2K e NOvA. T2K è un esperimento approvato in Giappone che userà un rivelatore esistente (SuperKamiokande) con un nuovo fascio di neutrini da Tokay a Kamiokande. NOvA è una proposta nata negli Stati Uniti che si propone di utilizzare il fascio di neutrini esistente (NuMI a FNAL), con un aumento dell intensità, e un rivelatore da costruire a circa 1000 km di distanza in prossimita della frontiera con il Canada. Recentemente è stato annunciato che l aumento dell intensità del fascio è in bassa priorità nei programmi di Fermilab: ciò limiterebbe l interesse scientifico di NovA. Altri esperimenti con reattori sono complementari agli esperimenti sul fascio nella misura di Θ 13 non essendo sensibili agli effetti materia. L evoluzione temporale prevista della sensibilità alla misura di Θ 13 è mostrata in Figura 3.1. E interesse INFN continuare a partecipare a questa linea di ricerca i cui sviluppi futuri si proiettano molto lontano nel tempo, evitando però le duplicazioni e verificando le compatibilità con le risorse e con i programmi di fisica del neutrino al Gran Sasso. NOvA e
9 T2K probabilmente non daranno le risposte definitive per il completamento della matrice di mixing. E` importante continuare gli studi per il passo successivo che potrebbe interessare i laboratori del Gran Sasso. 3.2 La massa dei neutrini Come detto in precedenza un altra questione fondamentale della fisica del neutrino è la conoscenza del valore assoluto della scala delle masse. Se neutrino e antineutrino coincidono, questa scala potrà essere determinata dagli esperimenti che cercano i decadimenti nucleari con due elettroni senza neutrini. La misura della massa del ν e indipendente da assunzioni teoriche e possibile con misure cinematiche dirette basate sulla determinazione dell energia degli elettroni nel decadimento beta singolo. Sperimentalmente è difficile raggiungere con questa tecnica sensibilità inferiori a 1 ev, anche considerando i nuclei con più basso Q-valore come 187 Re o il 3 H (Q=2.5 kev e 18.6 kev, rispettivamente). L esperimento KATRIN con 3 H, in Germania, utilizza un grosso spettrometro magnetico e dovrebbe essere in grado di raggiungere una sensibilità di 0.2 ev. Questo valore rappresenta il limite tecnologico sia a causa delle dimensioni dello spettrometro, sia per gli effetti sistematici dovuti a correzioni nello stato finale e a perdite di energia nella sorgente. Un approccio completamente differente è costituito dagli esperimenti calorimetrici a bassa temperatura in cui il decadimento avviene all interno del rivelatore. Questa tecnica è stata sviluppata in Italia negli scorsi anni da gruppi INFN di Genova e Milano. La proposta MARE prevede due fasi: nella prima si potrebbe raggiungere una sensibilità di circa 2 ev, competitiva con le misure attuali, ma utilizzando una tecnica completamente diversa. In una seconda fase, dopo un esteso programma di ricerca e sviluppo. che vedrebbe coinvolti numerosi laboratori stranieri, si dovrebbe guadagnare almeno un ordine di grandezza in sensibilità. Questa tecnologia ha applicazioni anche in altri settori come nella rivelazione di raggi X in esperimenti spaziali. 3.3 La materia oscura Come accennato in precedenza il tema della materia oscura è di enorme interesse in tutto il mondo e giustifica investimenti in esperimenti che utilizzano tecniche complementari. Quando saranno disponibili i risultati di DAMA/LIBRA e di WARP, presumibilmente entro 3 anni da oggi, bisognerà procedere ad una accurata verifica scientifica per valutare proposte, già avanzate, per la realizzazione di rivelatori da 1 tonnellata. Questo sia per lo studio dettagliato del segnale di DAMA (se confermato), sia
10 per aumentare la sensibilità degli apparati (se il segnale non fosse confermato). A livello europeo è da incoraggiare la convergenza delle proposte per rivelatori che utilizzano tecniche simili, per evitare la duplicazione degli sforzi. 3.4 L astronomia a neutrini L astronomia a neutrini potrebbe aprire una nuova finestra di osservazione dei fenomeni più energetici nell Universo. Si e gia detto come, a differenza di altre particelle come fotoni e protoni che possono essere assorbiti alla produzione oppure nel cammino verso la terra, i neutrini possono sfuggire da sorgenti opache ai fotoni e percorrere distanze cosmologiche con una bassa probabilita di interazione. Tuttavia, proprio per quest ultima ragione, le dimensioni dei rivelatore debbono essere dell ordine del km 3. Due diverse tecniche si sono affermate negli ultimi anni. La prima utilizza una griglia di fototubi nel ghiaccio (progetto IceCube al polo Sud). I fototubi rivelano la luce Cherenkov emessa dai muoni e da altri secondari prodotti dall interazione dei neutrini nel ghiaccio. La seconda prevede una griglia di fototubi nel mare profondo. Il numero di eventi per un rivelatore di queste dimensioni varia da qualche decina di eventi all anno per i flussi di neutrini diffusi, a vari eventi all anno per ognuna delle sorgenti puntiformi più energetiche e a circa 50 eventi all anno per i neutrini associati alle sorgenti dei raggi cosmici. Figura 3.2. La zona oscura rappresenta, in coordinate galattiche, la regione inaccessibile ad un rivelatore al polo Sud (sinistra) e nel Mediterraneo (destra). Le due figure in basso mostrano il centro galattico, il disco galattico ed alcune potenziali sorgenti di segnali di neutrini. Come si vede la zona accessibile a un rivelatore nel Mediterraneo è di maggiore interesse rispetto a quella osservabile da un rivelatore al Polo Sud.
11 Un rivelatore da 1 km 3 potrebbe dare risultati molto importanti anche nello studio delle sezioni d urto dei neutrini ad altissime energie e nella ricerca indiretta di materia oscura. Il progetto KM3NET finanziato dalla comunità europea è iniziato quest anno con un piano di lavoro triennale che prevede la progettazione di un rivelatore da 1 km 3 da realizzarsi nel Mediterraneo. Questo rivelatore sarebbe complementare ad IceCube, al polo Sud, perchè avrebbe accesso a una zona del cielo diversa (figura 3.2), che comprende il centro galattico e la regione del disco galattico, zone dove sono concentrate molte delle sorgenti più interessanti e che sono inaccessibili a IceCube. I possibili siti in discussione nel Mediterraneo sono tre : il sito di NESTOR in Grecia, il sito di ANTARES e il sito di NEMO al largo di Capo Passero (Sicilia) a 3500 metri di profondità ed a 80 km dalla costa (figura 3.3). Le misure di trasparenza dell acqua e di fondo dei fototubi hanno mostrato che il sito di Capo Passero sarebbe perfettamente adeguato. Questo sito sarà tra breve equipaggiato con un cavo elettro-ottico per il trasporto della potenza elettrica e la ricezione dei segnali e con prototipi di torri di rivelazione. Nel 2009, al termine di questo studio e dopo aver dimostrato la maturità delle tecnologie usate, sarebbe possibile iniziare la costruzione del rivelatore, che terminerebbe nel Figura 3.3. Il sito candidato al rivelatore da 1 km 3 al largo di Capo Passero (Sicilia) E opportuno notare il carattere multi-disciplinare di questa attività, che coinvolge altri campi come la geofisica, la biologia e l oceanografia. Progetti di questo tipo sono in
12 grado di attrarre fondi da altri enti come le regioni, il MIUR e la comunità europea. Infine è da ricordare l esistenza a livello europeo di una larghissima convergenza di ricercatori per questa iniziativa. Complementare ai rivelatori sotterranei, e un diverso progetto, attualmente allo studio, che prevede un rivelatore dedicato, posto dietro una montagna, per l astronomia di neutrini con la rivelazione dei soli ν τ. 3.5 L astronomia gamma L astronomia gamma con rivelatori terrestri studia le sorgenti di fotoni di energia al di sopra dei 50 GeV e fino a qualche TeV. Negli ultimi anni questi esperimenti hanno ottenuto risultati molto interessanti; il numero di sorgenti identificate è quadruplicato e tra queste numerose sono extra-galattiche. La tecnica Cherenkov sembra la più adeguata per lo studio dettagliato delle sorgenti puntiformi. La collaborazione MAGIC ha proposto il raddoppio del telescopio con l aggiunta di un secondo telescopio ad 80 metri di distanza. Una nuova proposta nata in Europa, chiamata temporaneamente CTA, prevede l installazione di due grandi sistemi di telescopi. Questa nuova proposta, che raccoglie una larga partecipazione dei gruppi europei coinvolti nella astronomia gamma, prevede un aumento della sensibilità di almeno un ordine di grandezza rispetto ai rivelatori attuali nell intervallo da 10 GeV a 100 TeV, con una sovrapposizione significativa con l esperimento nello spazio GLAST. Figura 4: Le sorgenti di fotoni di altissima energia scoperte negli ultimi 15 anni
13 Il miglioramento della risoluzione angolare di questa nuova installazione permetterebbe uno studio più accurato della morfologia delle sorgenti. Dopo la fase di disegno la realizzazione di un installazione nell emisfero SUD potrebbe partire nel Un altra installazione è prevista nell emisfero Nord. 3.6 I raggi cosmici Lo studio della composizione dei raggi cosmici ad energie nella zona del ginocchio (10 15 ev) continuerà nel futuro con rivelatori di maggiore accettanza. L interesse è dovuto al fatto che a tale energia probabilmente cambiano i meccanismi di produzione dei raggi cosmici stessi. Sono in considerazione nuove missioni spaziali in collaborazione con ASI e opportune modifiche ai rivelatori a terra esistenti, come ARGO, tali da migliorarne le prestazioni anche per l astronomia gamma fino a 100 TeV, conservando la grande accettanza angolare. Lo studio dei raggi cosmici di altissima energia potrebbe richiedere un apparato simile ad AUGER nell emisfero Nord ed un esperimento spaziale, EUSO, che potrebbe essere inserito nelle missioni programmate dopo il Entrambi sarebbero significativi anche per i neutrini di altissima energia. Queste proposte dovranno prendere in considerazione i risultati scientifici di AUGER Sud. Lo studio dei raggi cosmici di altissima energia resta importante anche per la fisica delle particelle perché le energie in gioco sono e saranno inaccessibili agli acceleratori. 3.7 Le onde gravitazionali I prossimi anni potranno vedere la rivelazione diretta delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono emesse in processi astrofisici che coinvolgono moti violentissimi di oggetti di grande massa. Esse sono assorbite ancora meno dei neutrini, pertanto si potrà studiare l interno di oggetti molto densi e compatti come stelle di neutroni, buchi neri ecc. Lo studio e la rivelazione delle onde gravitazionali è pertanto di enorme interesse per la relatività generale e per l astrofisica. Lo spettro delle frequenze emesse può variare dalle frequenze ultrabasse (10-4 Hz) a frequenze fino a 10 4 Hz. La banda a frequenze ultra-basse può essere studiata con interferometri nelle spazio, mentre i rivelatori terrestri possono coprire la banda dalla decina di Hz in su. L INFN collabora alla realizzazione di LISA che prevede una prima missione tecnica chiamata LISA-PathFinder nel 2009 seguita, nel 2015 circa, da LISA. La realizzazione di questi apparati sarà a cura delle agenzie spaziali (ASI, ESA e NASA). L INFN darà il
14 supporto ai gruppi scientifici per la parte relativa all analisi dati e per lo sviluppo di prototipi, alcuni dei quali saranno studiati all interno del laboratorio del Gran Sasso, particolarmente immune da rumori a bassissima frequenza. Poiche un rivelatore di onde gravitazionali fornisce in genere un solo segnale in uscita, non è possibile di solito ricostruire le componenti indipendenti del tensore dell onda e determinare quindi informazioni come la direzione di arrivo. Diverso è il caso per un rivelatore di forma sferica che può fornire in uscita 5 informazioni indipendenti corrispondenti ai 5 modi quadrupolari di oscillazione della sfera. Nuove proposte sono state avanzate per miglioramenti di VIRGO (VIRGO+, Advanced VIRGO) e per nuovi progetti nel campo dei rivelatori acustici. DUAL è un nuovo tipo di rivelatore acustico costituito da due rivelatori concentrici di forma cilindrica.. DUAL necessiterà di un lungo periodo di tempo per lo sviluppo delle tecniche necessarie. In una prima fase è prevista la costruzione di un dimostratore di dimensioni ridotte. Con VIRGO+ si intende apportare una serie di miglioramenti alle sospensioni, all ottica ed al sistema laser. Le sensibilità di VIRGO+ e dei rivelatori acustici nel periodo sono riportate in figura 3.6 e sono paragonate a quelle previste per uno dei tre interferometri LIGO e a quella di GEO. Tutte le curve riportate si riferiscono a sensibilità di progetto. Il vantaggio principale di VIRGO sarà alle basse frequenze; la rivelazione di un segnale continuo dovuta all emissione di una pulsar dovrebbe essere possibile. Per un tal tipo di segnale non è necessario operare in coincidenza con altri rivelatori. Studi si stanno avviando per interferometri di nuova generazione con sensibilità molto maggiori delle attuali. Per ridurre il rumore newtoniano dovuto agli spostamenti del suolo, bisognerà probabilmente costruire questi nuovi apparati sottoterra. Recentemente è iniziata una presa dati molto lunga che vede coinvolti i tre rivelatori interferometrici di LIGO negli Stati Uniti, l interferometro GEO in Germania e 4 rivelatori acustici, di cui 3 italiani. Nell estate del 2006 anche VIRGO si inserirà in questo programma di ricerca con un accordo di collaborazione stretta con l interferometro LIGO. I risultati di questa campagna di misure in cui sono coinvolti rivelatori con sensibilità mai raggiunte fino ad ora, saranno molto importanti per definire le strategie future. Se dopo questo run non saranno visti segnali di onde gravitazionali; è chiaro che il passo successivo sarà di puntare a rivelatori di sensibilità molto più elevata di quella ad esempio dei rivelatori acustici, anche avanzati, come la Sfera.
15 10-19 h/ Hz Pulsars LIGO+ SNR with h, max 1 year integration Virgo Network SFERA (Quantum Limit) DUAL Demonstrator (200 hbar, starting 2011) Core 10 Mpc ms 10 kpc - 20 days int. time GEO HF starting 2009/2010 ε = ns-ns 100 Mpc Hz 10 4 BH-BH 100 Mpc Figura 3.6. Le sensibilità dei rivelatori di onde gravitazionali nel periodo La gravitazione Oltre alla ricerca delle onde gravitazionali sono stati proposti altri esperimenti molto importanti sulla forza di gravità. Essi sono: l esperimento GG, nello spazio, per la verifica del principio di equivalenza, l esperimento MICRA per lo studio dell andamento in funzione della distanza della forza di gravità e l esperimento LARES per lo studio dettagliato dell effetto Lense-Thirring previsto dalla relatività generale. L equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale è stata verificata fin ora fino a precisioni dell ordine di ; lo scopo di Galileo Galilei (GG) è portare questa precisione fino a circa L INFN ha dato supporto per le sperimentazioni a terra delle tecniche usate (GGG, Galileo Galilei on the Ground). GG e stato ufficialmente inserito nel piano triennale dell Agenzia Spaziale Italiana. Possibili deviazioni dall andamento 1/r 2 della gravità a distanze sub-millimetriche sono previste dalle teorie di superstringhe, le uniche al momento in grado di unificare la gravitazione insieme alle altre forze. Esperimenti per la misura di queste deviazioni sono molto difficili perché a piccolissime distanze intervengono altre forze, come quelle quantistiche dovute all effetto Casimir, e forze di superficie. Lo scopo dell esperimento LARES è lo studio molto accurato del moto di un satellite passivo inseguito via laser da Terra. Tale studio può fornire informazioni molto importanti
16 sulla forza di gravità e sull effetto di frame dragging dovuto al momento angolare della Terra. 4. Alcune note conclusive La maggior parte delle attività descritte nel presente documento si svolgono e si svolgeranno in ambito internazionale, in particolare europeo. Gli enti finanziatori della fisica astroparticellare in Europa hanno costituito un organismo, denominato ApPEC, per il coordinamento delle attività di questo campo di ricerca. E in corso in ApPEC un censimento dei progetti ed è in preparazione un documento per lo sviluppo coordinato del settore in Europa, che vede incluse quasi tutte le tematiche scientifiche discusse in questo documento. L astronomia con fotoni, neutrini, onde gravitazionali e lo studio dei raggi cosmici costituisce un campo culturale strettamente correlato, al di là delle differenze nelle tecniche sperimentali e nelle metodologie. Ciò è vero anche per l astronomia con raggi X e l astronomia con fotoni di bassa energia, temi questi in Italia tradizionalmente di competenza dell Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). E importante sottolineare che la collaborazione tra le diverse comunità di fisici sperimentali e con i teorici è essenziale per questo tipo di studi che utilizza tutti i messaggeri disponibili a tutte le frequenze possibili. Non è escluso quindi che in alcuni settori, come l astronomia X, ci possa essere una partecipazione più diretta dell INFN, per esempio per la costruzione di rivelatori in cui l INFN ha una specifica competenza. 5. Esigenze finanziarie In tabella 1 la prima riga si riferisce alle esigenze degli esperimenti approvati fino ad ora, la seconda riga include le nuove attività descritte nel presente documento, con l eccezione del rivelatore per l astronomia dei neutrini da 1 km 3, dei miglioramenti su VIRGO e della SFERA. E inclusa la parte di R&D per lo sviluppo del rivelatore da 1 km 3 (ANTARES, NEMO). Non è inclusa la frazione del costo di CUORE a carico USA. Non sono inclusi inoltre i fondi ASI per le attività spaziali. Non sono incluse contingenza ed inflazione.
17 Tabella 1. Esigenze finanziarie degli esperimenti della CSN Solo attività in corso Con nuove attività
Oscillazione Neutrini Figura 1. Evoluzione della sensibilità nella misura di sin2
 La prima generazione di esperimenti con fasci di neutrini a lunga distanza potrà rispondere solo approssimativamente a domande quali il valore dell angolo di mixing Θ 13 e la violazione di CP nel settore
La prima generazione di esperimenti con fasci di neutrini a lunga distanza potrà rispondere solo approssimativamente a domande quali il valore dell angolo di mixing Θ 13 e la violazione di CP nel settore
Fisica dei fenomeni fondamentali senza acceleratori
 Fisica dei fenomeni fondamentali senza acceleratori Campo di ricerca che trova normalmente finanziamento nell ambito delle attività della Commissione Scientifica Nazionale II dell Istituto Nazionale di
Fisica dei fenomeni fondamentali senza acceleratori Campo di ricerca che trova normalmente finanziamento nell ambito delle attività della Commissione Scientifica Nazionale II dell Istituto Nazionale di
La Sezione di Padova dell INFN
 La Sezione di Padova dell INFN Le sedi INFN 19 Sezioni 11 Gruppi collegati 4 Laboratori Centro Nazionale di Calcolo VIRGO : European Gravitational Observatory F. Murtas La missione dell INFN Promuovere,
La Sezione di Padova dell INFN Le sedi INFN 19 Sezioni 11 Gruppi collegati 4 Laboratori Centro Nazionale di Calcolo VIRGO : European Gravitational Observatory F. Murtas La missione dell INFN Promuovere,
Il neutrino e la materia oscura: fra curiosità e precarietà. Gianfranca De Rosa Dip. di Scienze Fisiche & INFN
 Il neutrino e la materia oscura: fra curiosità e precarietà Gianfranca De Rosa Dip. di Scienze Fisiche & INFN Di contratto in contratto Produzione di Charm in interazioni di neutrino Ricerca di Oscillazioni
Il neutrino e la materia oscura: fra curiosità e precarietà Gianfranca De Rosa Dip. di Scienze Fisiche & INFN Di contratto in contratto Produzione di Charm in interazioni di neutrino Ricerca di Oscillazioni
Cosmologia e particelle
 Cosmologia e particelle Ivan De Mitri Dipartimento di Fisica Università di Lecce Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Due domande fondamentali: Quali sono i costituenti fondamentali della materia? Quali
Cosmologia e particelle Ivan De Mitri Dipartimento di Fisica Università di Lecce Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Due domande fondamentali: Quali sono i costituenti fondamentali della materia? Quali
Alla scoperta dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 Alla scoperta dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Dove si trovano? Struttura esterna Struttura sotterranea Perchè andare sottoterra? Le caratteristiche del
Alla scoperta dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Dove si trovano? Struttura esterna Struttura sotterranea Perchè andare sottoterra? Le caratteristiche del
Che cosa sono? Dove sono? Come si vedono? A che cosa servono? Paolo Lipari Frascati 6 ottobre 2004
 I NEUTRINI Che cosa sono? Dove sono? Come si vedono? A che cosa servono? Paolo Lipari Frascati 6 ottobre 2004 Di che cosa e' Fatta la Materia? Di che cosa e' Fatta la Materia? ARIA FUOCO ACQUA TERRA Atomo
I NEUTRINI Che cosa sono? Dove sono? Come si vedono? A che cosa servono? Paolo Lipari Frascati 6 ottobre 2004 Di che cosa e' Fatta la Materia? Di che cosa e' Fatta la Materia? ARIA FUOCO ACQUA TERRA Atomo
Ricostruzione di tracce in un telescopio erenkov sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia
 Tesi di Laurea in Fisica Ricostruzione di tracce in un telescopio erenkov sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Candidato Dario Benvenuti
Tesi di Laurea in Fisica Ricostruzione di tracce in un telescopio erenkov sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Candidato Dario Benvenuti
Ricerche sperimentali in fisica delle interazioni fondamentali.
 Ricerche sperimentali in fisica delle interazioni fondamentali Giovanni Batignani Dipartimento di Fisica e I.N.F.N. Pisa Gli esperimenti : gruppo 1 = fisica alle macchine acceleratrici gruppo 2 = fisica
Ricerche sperimentali in fisica delle interazioni fondamentali Giovanni Batignani Dipartimento di Fisica e I.N.F.N. Pisa Gli esperimenti : gruppo 1 = fisica alle macchine acceleratrici gruppo 2 = fisica
Università degli Studi di Milano. Percorsi della laurea Magistrale in Fisica
 Università degli Studi di Milano Percorsi della laurea Magistrale in Fisica Docente Tutor: prof. Emanuela Meroni Corsi Obbligatori AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo Elettrodinamica Classica
Università degli Studi di Milano Percorsi della laurea Magistrale in Fisica Docente Tutor: prof. Emanuela Meroni Corsi Obbligatori AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo Elettrodinamica Classica
Tutti i colori dell Universo. Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004
 Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Ferrara. Interna'onal Physics Masterclasses 17 Marzo 2016
 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Ferrara Interna'onal Physics Masterclasses 17 Marzo 2016 L Istituto Nazionale di Fisica Nucleare L INFN è un ente pubblico di ricerca vigilato dal
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Ferrara Interna'onal Physics Masterclasses 17 Marzo 2016 L Istituto Nazionale di Fisica Nucleare L INFN è un ente pubblico di ricerca vigilato dal
0.1 Introduzione... 1
 Indice 0.1 Introduzione............................ 1 1 Raggi cosmici e interazioni adroniche 5 1.1 Composizione dei raggi cosmici................. 5 1.2 Spettro dei raggi cosmici.....................
Indice 0.1 Introduzione............................ 1 1 Raggi cosmici e interazioni adroniche 5 1.1 Composizione dei raggi cosmici................. 5 1.2 Spettro dei raggi cosmici.....................
La Fisica nello Spazio: Astroparticelle
 La Fisica nello Spazio: Astroparticelle Elisa Antolini Università di Perugia & INAF Dario Gasparrini INFN sez. Perugia ASI Science Data Center Fisica delle Astroparticelle Radiazione elettromagnetica ad
La Fisica nello Spazio: Astroparticelle Elisa Antolini Università di Perugia & INAF Dario Gasparrini INFN sez. Perugia ASI Science Data Center Fisica delle Astroparticelle Radiazione elettromagnetica ad
Le Stringhe alla base del nostro Universo
 Le Stringhe alla base del nostro Universo Michele Cicoli DESY, Amburgo Pesaro, 17 Dicembre 2009 Sommario Stato della conoscenza attuale sulle leggi alla base del nostro Universo Problemi fondamentali Soluzione:
Le Stringhe alla base del nostro Universo Michele Cicoli DESY, Amburgo Pesaro, 17 Dicembre 2009 Sommario Stato della conoscenza attuale sulle leggi alla base del nostro Universo Problemi fondamentali Soluzione:
L'Insostenibile Velocità del Neutrino
 L'Insostenibile Velocità del Neutrino Roberto Ferrari Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Liceo Scientifico Marconi - Sommario 1: i neutrini 2: la produzione 3: la rivelazione 2 2 1. i neutrini 3 3 i
L'Insostenibile Velocità del Neutrino Roberto Ferrari Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Liceo Scientifico Marconi - Sommario 1: i neutrini 2: la produzione 3: la rivelazione 2 2 1. i neutrini 3 3 i
Effetto Cherenkov - 1
 Effetto Cherenkov - 1 Particelle cariche, che attraversano un mezzo denso con velocità superiore a quella con cui si propaga la luce nello stesso mezzo, emettono radiazione elettromagnetica che si propaga
Effetto Cherenkov - 1 Particelle cariche, che attraversano un mezzo denso con velocità superiore a quella con cui si propaga la luce nello stesso mezzo, emettono radiazione elettromagnetica che si propaga
Le stelle e i neutrini
 Le stelle e i neutrini Luciano Trasatti Istituto Nazionale Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati resp. loc. esperimento NEMO luciano.trasatti@lnf.infn.it NEMO astronomia con neutrini ovvero
Le stelle e i neutrini Luciano Trasatti Istituto Nazionale Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati resp. loc. esperimento NEMO luciano.trasatti@lnf.infn.it NEMO astronomia con neutrini ovvero
CUORE: Bolometri di grande massa per la ricerca del doppio decadimento
 CUORE: Bolometri di grande massa per la ricerca del doppio decadimento SERGIO DI DOMIZIO UNIVERSITÀ & INFN GENOVA PER LA COLLABORAZIONE CUORE Riassunto Doppio Decadimento Beta processo contenuto scientifico
CUORE: Bolometri di grande massa per la ricerca del doppio decadimento SERGIO DI DOMIZIO UNIVERSITÀ & INFN GENOVA PER LA COLLABORAZIONE CUORE Riassunto Doppio Decadimento Beta processo contenuto scientifico
Primi risultati della ricerca del decadimento doppio beta con CUPID-0 Elisabetta Bossio per la Collaborazione CUPID-0
 Primi risultati della ricerca del decadimento doppio beta con CUPID-0 Elisabetta Bossio per la Collaborazione CUPID-0 IFAE 2018 XVII edizione degli Incontri di Fisica delle Alte Energie Milano, 4-6 Aprile
Primi risultati della ricerca del decadimento doppio beta con CUPID-0 Elisabetta Bossio per la Collaborazione CUPID-0 IFAE 2018 XVII edizione degli Incontri di Fisica delle Alte Energie Milano, 4-6 Aprile
Concezio Bozzi INFN Ferrara 5 dicembre 2012
 Concezio Bozzi INFN Ferrara 5 dicembre 2012 Il modello standard 12 particelle elementari, 6 leptoni e 6 quark, raggruppate in 3 famiglie, di massa crescente Forze tra particelle di materia trasmesse da
Concezio Bozzi INFN Ferrara 5 dicembre 2012 Il modello standard 12 particelle elementari, 6 leptoni e 6 quark, raggruppate in 3 famiglie, di massa crescente Forze tra particelle di materia trasmesse da
F. Frasconi INFN Pisa AIN Italian Nuclear Young Generation Pisa, 1 Dicembre 2017
 F. Frasconi INFN Pisa AIN Italian Nuclear Young Generation Pisa, 1 Dicembre 2017 Le Onde Gravitazionali sono increspature (perturbazioni) dello spazio-tempo che viaggiano nell Universo alla velocità della
F. Frasconi INFN Pisa AIN Italian Nuclear Young Generation Pisa, 1 Dicembre 2017 Le Onde Gravitazionali sono increspature (perturbazioni) dello spazio-tempo che viaggiano nell Universo alla velocità della
LHC e la struttura dell Universo. Luca Lista INFN
 LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
La strana storia del neutrino
 La strana storia del neutrino Antonio Ereditato Università di Berna con la collaborazione di Federico Scampoli Scuola Media Carducci-Purgotti, Perugia A.Ereditato - Perugia - 2011 1 Zoo delle particelle
La strana storia del neutrino Antonio Ereditato Università di Berna con la collaborazione di Federico Scampoli Scuola Media Carducci-Purgotti, Perugia A.Ereditato - Perugia - 2011 1 Zoo delle particelle
G.Battistoni Neutrini Atmosferici
 Neutrini Atmosferici Interazione dei cosmici in atmosfera Sciame adronico Cosmico primario Raggi cosmici secondari Sciame atmosferico Il flusso di neutrini p In un regime in cui tutti i π decadono ν µ
Neutrini Atmosferici Interazione dei cosmici in atmosfera Sciame adronico Cosmico primario Raggi cosmici secondari Sciame atmosferico Il flusso di neutrini p In un regime in cui tutti i π decadono ν µ
MONDO DEI NEUTRINI. Prima tappa: Anni 30 il neutrino entra sulla scena. Seconda tappa: Neutrini masse e oscillazioni
 UN VIAGGIO IN TRE TAPPE NEL MONDO DEI NEUTRINI Prima tappa: Anni 30 il neutrino entra sulla scena della fisica delle particelle Seconda tappa: Neutrini masse e oscillazioni Terza tappa: I neutrini come
UN VIAGGIO IN TRE TAPPE NEL MONDO DEI NEUTRINI Prima tappa: Anni 30 il neutrino entra sulla scena della fisica delle particelle Seconda tappa: Neutrini masse e oscillazioni Terza tappa: I neutrini come
Sommario. 1. I Raggi Cosmici Alcuni effetti dei RC sulla vita quotidiana. i. Generalità e prime osservazioni ii. iii.
 Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette e composizione chimica a. La nostra Galassia b. Le Supernovae originano i RC iii. Misure Indirette a. Possibili sorgenti
Sommario 1. I Raggi Cosmici i. Generalità e prime osservazioni ii. Misure dirette e composizione chimica a. La nostra Galassia b. Le Supernovae originano i RC iii. Misure Indirette a. Possibili sorgenti
Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare II. 4 giugno 2010
 Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare II 4 giugno 2010 Studente Claudia Pistone Tutor Dr. Fabio Bellini 1 sommario cos è Cuoricino cosa sappiamo dei neutrini e cosa vogliamo scoprire cos è il decadimento
Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare II 4 giugno 2010 Studente Claudia Pistone Tutor Dr. Fabio Bellini 1 sommario cos è Cuoricino cosa sappiamo dei neutrini e cosa vogliamo scoprire cos è il decadimento
ONDE GRAVITAZIONALI: COME RIVELARLE?
 ONDE GRAVITAZIONALI: COME RIVELARLE? Caratteristiche di una OG: Natura quadrupolare della deformazione dello spazio-tempo L intensità scala con la distanza al quadrato La descrizione dell effetto è diversa
ONDE GRAVITAZIONALI: COME RIVELARLE? Caratteristiche di una OG: Natura quadrupolare della deformazione dello spazio-tempo L intensità scala con la distanza al quadrato La descrizione dell effetto è diversa
Theory Italiano (Italy)
 Q3-1 Large Hadron Collider (10 punti) Prima di iniziare questo problema, leggi le istruzioni generali nella busta a parte. In questo problema è discussa la fisica dell acceleratore di particelle del CERN
Q3-1 Large Hadron Collider (10 punti) Prima di iniziare questo problema, leggi le istruzioni generali nella busta a parte. In questo problema è discussa la fisica dell acceleratore di particelle del CERN
Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF
 Fermi XENON @LNGS Auger Argentina Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF M. Bertaina CTA ARGO, Tibet KASCADE-Grande Germania JEM-EUSO Cosa sono i raggi cosmici:
Fermi XENON @LNGS Auger Argentina Attività sperimentali di fisica astroparticellare presso laboratori INFN e INAF M. Bertaina CTA ARGO, Tibet KASCADE-Grande Germania JEM-EUSO Cosa sono i raggi cosmici:
DIPARTIMENTO DI FISICA NUCLEARE E TEORICA
 DIPARTIMENTO DI FISICA NUCLEARE E TEORICA Incontro con le matricole di Fisica 6 Ottobre 2009 1 Presentazione Il Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica (DFNT) dell Università di Pavia nasce nel 1983
DIPARTIMENTO DI FISICA NUCLEARE E TEORICA Incontro con le matricole di Fisica 6 Ottobre 2009 1 Presentazione Il Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica (DFNT) dell Università di Pavia nasce nel 1983
MAGIC, una finestra sull Universo. Francesco de Sabata Liceo G. Galilei Verona, F. de I.N.F.N. Sabata, CF2010 Udine/Trieste, MAGIC collab.
 MAGIC, una finestra sull Universo Francesco de Sabata Liceo G. Galilei Verona, F. de I.N.F.N. Sabata, CF2010 Udine/Trieste, MAGIC collab. I RAGGI GAMMA I raggi γ gamma sono i piú energetici dello spettro
MAGIC, una finestra sull Universo Francesco de Sabata Liceo G. Galilei Verona, F. de I.N.F.N. Sabata, CF2010 Udine/Trieste, MAGIC collab. I RAGGI GAMMA I raggi γ gamma sono i piú energetici dello spettro
Materia oscura nell Universo
 Materia oscura nell Universo Biblioteca Civica Archimede Settimo Torinese, aprile 2013 Alessandro Bottino Università di Torino/INFN Un viaggio in tre tappe nell Universo Pi Prima tappa: Le osservazioni
Materia oscura nell Universo Biblioteca Civica Archimede Settimo Torinese, aprile 2013 Alessandro Bottino Università di Torino/INFN Un viaggio in tre tappe nell Universo Pi Prima tappa: Le osservazioni
Gravità: teoria ed esperimenti onde gravitazionali, buchi neri & stelle di neutroni
 As our island of knowledge grows, so does the shore of our ignorance. John Archibald Wheeler, 1992 Gravità: teoria ed esperimenti onde gravitazionali, buchi neri & stelle di neutroni Paolo Pani Università
As our island of knowledge grows, so does the shore of our ignorance. John Archibald Wheeler, 1992 Gravità: teoria ed esperimenti onde gravitazionali, buchi neri & stelle di neutroni Paolo Pani Università
Spettro delle onde elettromagnetiche. Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione
 Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura?
 Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura? Seminari di Fisica Dipartimento di Fisica dell Universita di Torino 26 gennaio 2016 Alessandro Bottino Evidenze osservative di presenza di materia oscura
Dove siamo con la ricerca sulla materia oscura? Seminari di Fisica Dipartimento di Fisica dell Universita di Torino 26 gennaio 2016 Alessandro Bottino Evidenze osservative di presenza di materia oscura
 Astroparticle and Neutrino Physics Group Dipartimento di Fisica Teorica dell Università di Torino Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Sezione di Torino Nicolao Fornengo Carlo Giunti Fiorenza Donato Stefano
Astroparticle and Neutrino Physics Group Dipartimento di Fisica Teorica dell Università di Torino Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Sezione di Torino Nicolao Fornengo Carlo Giunti Fiorenza Donato Stefano
Introduzione alla Fisica di EEE plus
 Introduzione alla Fisica di EEE plus Emanuele Biolcati Liceo Classico Massimo D Azeglio 28 settembre 2018 Emanuele Biolcati 1 Poniamoci alcune domande 1 Raggi cosmici Cosa sono? Perché si studiano? Come
Introduzione alla Fisica di EEE plus Emanuele Biolcati Liceo Classico Massimo D Azeglio 28 settembre 2018 Emanuele Biolcati 1 Poniamoci alcune domande 1 Raggi cosmici Cosa sono? Perché si studiano? Come
Considerazioni generali sulla proposta di attivita akwisp
 Considerazioni generali sulla proposta di attivita akwisp Per facilitare la discussione in Commissione, riassumo brevemente i punti principali delle attivita KWISP akwisp e aggiungo alcune osservazioni
Considerazioni generali sulla proposta di attivita akwisp Per facilitare la discussione in Commissione, riassumo brevemente i punti principali delle attivita KWISP akwisp e aggiungo alcune osservazioni
La Gravità come Teoria Fondamentale
 La Gravità come Teoria Fondamentale Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
La Gravità come Teoria Fondamentale Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
Il Modello Standard delle particelle
 Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
PLASMI IN ASTROFISICA E IN LABORATORIO
 PLASMI IN ASTROFISICA E IN LABORATORIO Incontro di Villa Mondragone 28 maggio 2010 I rapidi progressi della ricerca sui plasmi nei vari ambiti disciplinari possono potenziarsi a vicenda se messi a fattor
PLASMI IN ASTROFISICA E IN LABORATORIO Incontro di Villa Mondragone 28 maggio 2010 I rapidi progressi della ricerca sui plasmi nei vari ambiti disciplinari possono potenziarsi a vicenda se messi a fattor
Stages al Laboratorio di Frascati dell INFN
 Stages al Laboratorio di Frascati dell INFN L Istituto di Fisica Nucleare Le attivita del Laboratorio di Frascati Finalita degli stages Programma L INFN E l istituto che in Italia promuove la ricerca nel
Stages al Laboratorio di Frascati dell INFN L Istituto di Fisica Nucleare Le attivita del Laboratorio di Frascati Finalita degli stages Programma L INFN E l istituto che in Italia promuove la ricerca nel
Einstein aveva ragione. Adele La Rana Fondazione TERA & Università Sapienza di Roma & CERN Museo di Fisica di Napoli, 28 Gennaio 2016
 Einstein aveva ragione Adele La Rana Fondazione TERA & Università Sapienza di Roma & CERN Museo di Fisica di Napoli, 28 Gennaio 2016 2015: La Teoria della Relatività Generale compie 100 anni! 1915-2015:
Einstein aveva ragione Adele La Rana Fondazione TERA & Università Sapienza di Roma & CERN Museo di Fisica di Napoli, 28 Gennaio 2016 2015: La Teoria della Relatività Generale compie 100 anni! 1915-2015:
Le Tesi in Fisica Teorica per la Laurea Magistrale in Fisica
 Le Tesi in Fisica Teorica per la Laurea Magistrale in Fisica Facoltá di Scienze M.F.N. 24 Gennaio 2010 La tesi nel curriculum di Fisica Teorica La tesi è l attività più significativa della laurea magistrale
Le Tesi in Fisica Teorica per la Laurea Magistrale in Fisica Facoltá di Scienze M.F.N. 24 Gennaio 2010 La tesi nel curriculum di Fisica Teorica La tesi è l attività più significativa della laurea magistrale
CAPITOLO 5. Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K
 CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
CAPITOLO 5 Stima della frequenza dei segnali dovuta al 40 K 5.1 Simulazione dei segnali registrabili con i fotomoltiplicatori. Nei capitoli precedenti, dopo aver illustrato brevemente la motivazione per
Incontro sul Futuro degli esperimenti nello Spazio LNGS 5/5/2004. Per la prima volta riunita tutta la comunita INFN-spazio
 Incontro sul Futuro degli esperimenti nello Spazio LNGS 5/5/2004 Per la prima volta riunita tutta la comunita INFN-spazio 15 anni di attivita dell INFN di ricerca in Fisica nello Spazio hanno prodotto:
Incontro sul Futuro degli esperimenti nello Spazio LNGS 5/5/2004 Per la prima volta riunita tutta la comunita INFN-spazio 15 anni di attivita dell INFN di ricerca in Fisica nello Spazio hanno prodotto:
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
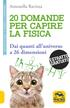 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
Raggi Cosmici. Messaggeri dallo Spazio profondo
 Raggi Cosmici Messaggeri dallo Spazio profondo Da quando siete entrati in questa Aula il vostro corpo è stato attraversato da 5,000,000 di Raggi Cosmici Benvenuti! I raggi cosmici sono particelle energetiche
Raggi Cosmici Messaggeri dallo Spazio profondo Da quando siete entrati in questa Aula il vostro corpo è stato attraversato da 5,000,000 di Raggi Cosmici Benvenuti! I raggi cosmici sono particelle energetiche
Visita Laboratori Nazionali del Gran Sasso d Italia del 16 settembre 2012
 Visita Laboratori Nazionali del Gran Sasso d Italia del 16 settembre 2012 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), uno dei quattro laboratori dell INFN, sono
Visita Laboratori Nazionali del Gran Sasso d Italia del 16 settembre 2012 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), uno dei quattro laboratori dell INFN, sono
Visita ai Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
 Visita ai Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare giovanni.mazzitelli@lnf.infn.it I Laboratori Nazionali di Frascati I LNF sono stati costruiti nel 1955 e sono il più
Visita ai Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare giovanni.mazzitelli@lnf.infn.it I Laboratori Nazionali di Frascati I LNF sono stati costruiti nel 1955 e sono il più
La Fisica Astroparticellare. Laurea Magistrale in Fisica - Curriculum Nucleare e Subnucleare
 La Fisica Astroparticellare Laurea Magistrale in Fisica - Curriculum Nucleare e Subnucleare 1 Alcune domande fondamentali Perché la materia ha vinto, tanto tempo, fa la sua battaglia sull anti-materia?
La Fisica Astroparticellare Laurea Magistrale in Fisica - Curriculum Nucleare e Subnucleare 1 Alcune domande fondamentali Perché la materia ha vinto, tanto tempo, fa la sua battaglia sull anti-materia?
Gli esperimenti sono elencati secondo le sei linee scientifiche:
 NB questo riassunto contiene informazioni selezionate rispetto alle schede originali. In alcuni casi ci sono leggere modifiche rispetto alle schede originali. Gli esperimenti sono elencati secondo le sei
NB questo riassunto contiene informazioni selezionate rispetto alle schede originali. In alcuni casi ci sono leggere modifiche rispetto alle schede originali. Gli esperimenti sono elencati secondo le sei
La Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali
 La Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali Fisica delle Interazioni Fondamentali Fisica delle Interazioni Fondamentali Interazioni Elettrodeboli Modello Standard Interazioni Forti Fisica delle Interazioni
La Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali Fisica delle Interazioni Fondamentali Fisica delle Interazioni Fondamentali Interazioni Elettrodeboli Modello Standard Interazioni Forti Fisica delle Interazioni
Fisica delle Particelle: esperimenti. Fabio Bossi (LNF INFN)
 Fisica delle Particelle: esperimenti Fabio Bossi (LNF INFN) fabio.bossi@lnf.infn.it Il processo scientifico di conoscenza Esperimento Osservazione quantitativa di fenomeni riguardanti alcune particelle
Fisica delle Particelle: esperimenti Fabio Bossi (LNF INFN) fabio.bossi@lnf.infn.it Il processo scientifico di conoscenza Esperimento Osservazione quantitativa di fenomeni riguardanti alcune particelle
Neutrini: perfetti sconosciuti
 Neutrini: perfetti sconosciuti Fabio Bellini Sapienza Università di Roma & INFN Roma Particelle Elementari ed Interazioni Fondamentali: la ricerca di frontiera Scoperti 60 anni fa! 2 Scoperti 60 anni fa!
Neutrini: perfetti sconosciuti Fabio Bellini Sapienza Università di Roma & INFN Roma Particelle Elementari ed Interazioni Fondamentali: la ricerca di frontiera Scoperti 60 anni fa! 2 Scoperti 60 anni fa!
INFN-GE - Aprile 2014
 INFN-GE - Aprile 2014 M.Battaglieri INFN-GE, Italy 1 Il GdL e gli strumenti Pagina WiKi http://wiki.ge.infn.it/wn-darkmatter/index.php/main_page Mailing List (~180 iscritti!) whatsnextdm@lists.infn.it
INFN-GE - Aprile 2014 M.Battaglieri INFN-GE, Italy 1 Il GdL e gli strumenti Pagina WiKi http://wiki.ge.infn.it/wn-darkmatter/index.php/main_page Mailing List (~180 iscritti!) whatsnextdm@lists.infn.it
Increspature dello spaziotempo
 Increspature dello spaziotempo Sebastiano Sonego Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche Belluno, 14 gennaio 2017 sebastiano.sonego@uniud.it 2015: una ricorrenza... 25 novembre 1915:
Increspature dello spaziotempo Sebastiano Sonego Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche Belluno, 14 gennaio 2017 sebastiano.sonego@uniud.it 2015: una ricorrenza... 25 novembre 1915:
Prospettive future, oltre il modello standard?
 Prospettive future, oltre il modello standard? La scoperta del bosone di Higgs chiave di volta per la consistenza del modello standard: a)generazione della massa dei mediatori e dei fermioni; b)regolarizzazione
Prospettive future, oltre il modello standard? La scoperta del bosone di Higgs chiave di volta per la consistenza del modello standard: a)generazione della massa dei mediatori e dei fermioni; b)regolarizzazione
Il curriculum magistrale in Fisica Teorica
 Il curriculum magistrale in Fisica Teorica Scopo principale: è quello di fornire basi solide e complete per una piena comprensione e capacità di sviluppo ulteriore riguardo a: - studio e modellizzazione
Il curriculum magistrale in Fisica Teorica Scopo principale: è quello di fornire basi solide e complete per una piena comprensione e capacità di sviluppo ulteriore riguardo a: - studio e modellizzazione
PROGETTO EEE: RISULTATI SCIENTIFICI. Stefano Grazzi, Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Roma Lodi, Liceo Gandini, 18/11/2016
 PROGETTO EEE: RISULTATI SCIENTIFICI Stefano Grazzi, Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Roma Lodi, Liceo Gandini, 18/11/2016 Primi Risultati scientifici ottenuti dal Progetto EEE Coincidenze tra due
PROGETTO EEE: RISULTATI SCIENTIFICI Stefano Grazzi, Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Roma Lodi, Liceo Gandini, 18/11/2016 Primi Risultati scientifici ottenuti dal Progetto EEE Coincidenze tra due
Le Onde Gravitazionali
 Le Onde Gravitazionali Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/ Le Interazioni
Le Onde Gravitazionali Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/ Le Interazioni
Violazione della Parità
 Violazione della Parità Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrosica e Particelle Elementari Motivazione Per spiegare l asimmetria nell universo tra particelle e antiparticelle bisogna trovare dei processi
Violazione della Parità Raffaele Pontrandolfi Corso di Astrosica e Particelle Elementari Motivazione Per spiegare l asimmetria nell universo tra particelle e antiparticelle bisogna trovare dei processi
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO?
 MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
MA DIO GIOCA A DADI CON IL MONDO? Le basi delle teorie della RELATIVITA e della MECCANICA QUANTISTICA A cura di Giorgio PALAZZI e Alberto RENIERI EINSTEIN E LA RELATIVITA SIAMO ALL INIZIO DEL XX SECOLO
FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA
 Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA Marta Ruspa 20.01.13 M. Ruspa 1 ONDE ELETTROMAGNETICHE
Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA Marta Ruspa 20.01.13 M. Ruspa 1 ONDE ELETTROMAGNETICHE
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
TRACCIAMENTO DI RAGGI COSMICI
 Laboratorio di Fisica delle Interazioni Fondamentali Università di Pisa TRACCIAMENTO DI RAGGI COSMICI Introduzione L esperienza consiste nella misura dell intensità e delle distribuzioni angolari dei raggi
Laboratorio di Fisica delle Interazioni Fondamentali Università di Pisa TRACCIAMENTO DI RAGGI COSMICI Introduzione L esperienza consiste nella misura dell intensità e delle distribuzioni angolari dei raggi
L Universo Invisibile. Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico
 L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
L Universo Invisibile Dr. Massimo Teodorani, Ph.D. astrofisico CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Onde elettromagnetiche e le varie frequenze 2. Fotografia nell infrarosso e nell ultravioletto 3. Intensificazione
Introduzione ai LNGS. Adriano Di Giovanni
 Introduzione ai LNGS Adriano Di Giovanni Un idea del Prof. A. Zichichi: un laboratorio nelle viscere del Gran Sasso 1979 --> proposta al Parlamento italiano del progetto di un grande laboratorio sotterraneo
Introduzione ai LNGS Adriano Di Giovanni Un idea del Prof. A. Zichichi: un laboratorio nelle viscere del Gran Sasso 1979 --> proposta al Parlamento italiano del progetto di un grande laboratorio sotterraneo
La Radiazione Cosmica e
 La Radiazione Cosmica e G. Di Sciascio Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roma Tor Vergata disciascio@roma2.infn.it Nel tempo impiegato a leggere questa frase di vario tipo che dalle profondità del
La Radiazione Cosmica e G. Di Sciascio Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roma Tor Vergata disciascio@roma2.infn.it Nel tempo impiegato a leggere questa frase di vario tipo che dalle profondità del
Il Dipartimento di Fisica Enrico Fermi dell Università di Pisa
 Il Dipartimento di Fisica Enrico Fermi dell Università di Pisa Francesco Fidecaro 23 aprile 2015 francesco.fidecaro@unipi.it 1 Storia 1564: nascita di Galileo a Pisa 450 anni fa 1749: Cattedra di Fisica
Il Dipartimento di Fisica Enrico Fermi dell Università di Pisa Francesco Fidecaro 23 aprile 2015 francesco.fidecaro@unipi.it 1 Storia 1564: nascita di Galileo a Pisa 450 anni fa 1749: Cattedra di Fisica
CACCIATORI DI MATERIA OSCURA. Art & Science Liceo Statle Democrito ( ) e Istituto Bonifacio VIII ( )
 CACCIATORI DI MATERIA OSCURA Art & Science Liceo Statle Democrito (15.2.2019) e Istituto Bonifacio VIII (22.2.2019) Cosa c è nel nostro universo? Hubble Space Telescope Ultra Deep Field - ACS Immagine
CACCIATORI DI MATERIA OSCURA Art & Science Liceo Statle Democrito (15.2.2019) e Istituto Bonifacio VIII (22.2.2019) Cosa c è nel nostro universo? Hubble Space Telescope Ultra Deep Field - ACS Immagine
M CR C O R MO M ND N O
 HIGGS DALL UNIFICAZIONE DELLA FISICA ALLA GRANDE ESPLOSIONE DELL'UNIVERSO Claudio Firmani UNAM-INAF uno sguardo al MICROMONDO Per unificazione della fisica si intende l unificazione delle quattro forze
HIGGS DALL UNIFICAZIONE DELLA FISICA ALLA GRANDE ESPLOSIONE DELL'UNIVERSO Claudio Firmani UNAM-INAF uno sguardo al MICROMONDO Per unificazione della fisica si intende l unificazione delle quattro forze
Concezio Bozzi INFN Ferrara 15 novembre 2011
 Concezio Bozzi INFN Ferrara 15 novembre 2011 Il modello standard 12 particelle elementari, 6 leptoni e 6 quark, raggruppate in 3 famiglie, di massa crescente Forze tra particelle di materia trasmesse da
Concezio Bozzi INFN Ferrara 15 novembre 2011 Il modello standard 12 particelle elementari, 6 leptoni e 6 quark, raggruppate in 3 famiglie, di massa crescente Forze tra particelle di materia trasmesse da
La Fisica, avventura della mente. P. Bernardini Dipartimento di Fisica Università di Lecce 1/29
 La Fisica, avventura della mente P. Bernardini Dipartimento di Fisica Università di Lecce 1/29 Galileo Galilei (1564-1642) e il metodo scientifico moderno 1. Osservazione e riproduzione in laboratorio
La Fisica, avventura della mente P. Bernardini Dipartimento di Fisica Università di Lecce 1/29 Galileo Galilei (1564-1642) e il metodo scientifico moderno 1. Osservazione e riproduzione in laboratorio
Raggi cosmici. Introduzione
 Raggi cosmici Introduzione Cenni storici Agli inizi del 1900 gli scienziati si trovavano di fronte a un problema che non riuscivano a spiegare: sembrava che nell ambiente ci fosse molta più radiazione
Raggi cosmici Introduzione Cenni storici Agli inizi del 1900 gli scienziati si trovavano di fronte a un problema che non riuscivano a spiegare: sembrava che nell ambiente ci fosse molta più radiazione
Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari?
 13 a edizione C. Patrignani - Bologna Masterclasses 2017 2 Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari? quali sono i costituenti elementari della materia che ci circonda? quali
13 a edizione C. Patrignani - Bologna Masterclasses 2017 2 Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari? quali sono i costituenti elementari della materia che ci circonda? quali
Istituti Paritari PIO XII
 Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Istituti Paritari PIO XII RMTD545007 Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali 00159 ROMA - via Galla Placidia, 63 RMTL395001 Costruzioni, Ambiente e territorio Tel 064381465 Fax
Il Vuoto Fisico. un invito al laboratorio. Andrea Fontana, INFN Pavia
 Il Vuoto Fisico un invito al laboratorio Andrea Fontana, INFN Pavia Il più potente acceleratore di particelle: LHC LHC ha la particolarità di non avere uno solo, ma tre sistemi di vuoto: 1. vuoto per i
Il Vuoto Fisico un invito al laboratorio Andrea Fontana, INFN Pavia Il più potente acceleratore di particelle: LHC LHC ha la particolarità di non avere uno solo, ma tre sistemi di vuoto: 1. vuoto per i
LA RIVELAZIONE DIRETTA DELLA MATERIA OSCURA
 LA RIVELAZIONE DIRETTA DELLA MATERIA OSCURA CERN ITP settembre 2016 Paola Campana Giovanni Casolari Francesca Gialanella Roberto Malesan Silvia Masi Chiara Pacini Sandra Schiavoni, Angelo Stanzione SIMULAZIONE
LA RIVELAZIONE DIRETTA DELLA MATERIA OSCURA CERN ITP settembre 2016 Paola Campana Giovanni Casolari Francesca Gialanella Roberto Malesan Silvia Masi Chiara Pacini Sandra Schiavoni, Angelo Stanzione SIMULAZIONE
Misteri nell Universo
 Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
Misteri nell Universo Quali sono le forme di materia ed energia nell universo osservabile? Quale e la ricetta (ingredienti e proporzioni) del nostro universo? 1 L eredità di Copernico Quale è la relazione
studio delle distribuzioni del numero di eventi in un intervallo di tempo fissato dei tempi di attesa di un evento
 studio delle distribuzioni del numero di eventi in un intervallo di tempo fissato dei tempi di attesa di un evento evento casuale: rivelazione di una particella carica dei raggi cosmici raggi cosmici rivelatori
studio delle distribuzioni del numero di eventi in un intervallo di tempo fissato dei tempi di attesa di un evento evento casuale: rivelazione di una particella carica dei raggi cosmici raggi cosmici rivelatori
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA
 TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
TEORIA DELLA RELATIVITA RISTRETTA EVOLUZIONE DELLE TEORIE FISICHE Meccanica Classica Principio di Relatività Galileiano Meccanica Newtoniana Gravitazione (Newton) Costante Universale G = 6,67*10^-11Nm^2/Kg^2
Liceo Classico V.Gioberti
 Liceo Classico V.Gioberti Prof.sse: P.Porta e T.Morgante Teoria della Relativita Ristretta Nel 1905 Einstein formula i postulati della Relativita Ristretta (riferita a sistemi non accelerati): 1. Le leggi
Liceo Classico V.Gioberti Prof.sse: P.Porta e T.Morgante Teoria della Relativita Ristretta Nel 1905 Einstein formula i postulati della Relativita Ristretta (riferita a sistemi non accelerati): 1. Le leggi
Matteo Sanguineti. Ricercatore a tempo determinato
 Ricercatore a tempo determinato matteo.sanguineti@unige.it +39 0103536459 Istruzione e formazione 2016 Dottorato di Ricerca in Fisica Search for GRB neutrino emission according to the photospheric model
Ricercatore a tempo determinato matteo.sanguineti@unige.it +39 0103536459 Istruzione e formazione 2016 Dottorato di Ricerca in Fisica Search for GRB neutrino emission according to the photospheric model
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
Capitolo 2. Il Suono in Acqua. Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino
 Capitolo 2 Il Suono in Acqua Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino Nel seguito presentiamo, in forma schematica, i concetti fondamentali per la descrizione della propagazione del
Capitolo 2 Il Suono in Acqua Propagazione di un segnale acustico in ambiente sottomarino Nel seguito presentiamo, in forma schematica, i concetti fondamentali per la descrizione della propagazione del
F. Guarino Curriculum Fisica Subnucleare e Astroparticellare
 Laurea Magistrale in Fisica F. Guarino fausto.guarino@unina.it Curriculum Fisica Subnucleare e Astroparticellare Cosa viene affrontato in questo curriculum? Lo studio e la ricerca sperimentale dei costituenti
Laurea Magistrale in Fisica F. Guarino fausto.guarino@unina.it Curriculum Fisica Subnucleare e Astroparticellare Cosa viene affrontato in questo curriculum? Lo studio e la ricerca sperimentale dei costituenti
NEUTRONICI CON TECNICA DEL TEMPO DI VOLO. Francesco Barilari, Alberto Edoni, Antonio Lombardi, Davide Restelli
 MISURA DI SPETTRI NEUTRONICI CON TECNICA DEL TEMPO DI VOLO GRUPPO K RELATORI: TUTORS: Francesco Barilari, Alberto Edoni, Antonio Lombardi, Davide Restelli Pierfrancesco Mastinu, Elizabeth Musacchio Carica
MISURA DI SPETTRI NEUTRONICI CON TECNICA DEL TEMPO DI VOLO GRUPPO K RELATORI: TUTORS: Francesco Barilari, Alberto Edoni, Antonio Lombardi, Davide Restelli Pierfrancesco Mastinu, Elizabeth Musacchio Carica
Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo
 Le Donne nella Scienza Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo l Ofelia Pisanti Dipartimento di Scienze Fisiche e INFN - Napoli Interazioni fondamentali e Struttura dell Universo Napoli,
Le Donne nella Scienza Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo l Ofelia Pisanti Dipartimento di Scienze Fisiche e INFN - Napoli Interazioni fondamentali e Struttura dell Universo Napoli,
Studio di sorgenti X all interno della Piccola Nube di Magellano con il satellite per astronomia X XMM-Newton
 Studio di sorgenti X all interno della Piccola Nube di Magellano con il satellite per astronomia X XMM-Newton Relatore interno: Prof. P. Pizzochero Relatore esterno: Dott. S. Mereghetti Sommario 1 2 3
Studio di sorgenti X all interno della Piccola Nube di Magellano con il satellite per astronomia X XMM-Newton Relatore interno: Prof. P. Pizzochero Relatore esterno: Dott. S. Mereghetti Sommario 1 2 3
OLAGS Optical Links for Atomic Gravity Sensors
 OLAGS Optical Links for Atomic Gravity Sensors nuova sigla CSN5 già proposta per la call CSN5 2018 (FLAGS) Coord. Naz. F. Sorrentino Gravimetri atomci Sono basati sull interferometria atomica: laser cooling
OLAGS Optical Links for Atomic Gravity Sensors nuova sigla CSN5 già proposta per la call CSN5 2018 (FLAGS) Coord. Naz. F. Sorrentino Gravimetri atomci Sono basati sull interferometria atomica: laser cooling
GW PRIMA RIVELAZIONE DI ONDE GRAVITAZIONALI CON L INTERFEROMETRO VIRGO
 GW170814 PRIMA RIVELAZIONE DI ONDE GRAVITAZIONALI CON L INTERFEROMETRO VIRGO Gruppo Virgo Padova-Trento Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Padova Padova, 27 Settembre 2017 www.virgo.lnl.infn.it
GW170814 PRIMA RIVELAZIONE DI ONDE GRAVITAZIONALI CON L INTERFEROMETRO VIRGO Gruppo Virgo Padova-Trento Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Padova Padova, 27 Settembre 2017 www.virgo.lnl.infn.it
Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo
 Le Donne nella Scienza Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo l Ofelia Pisanti Dipartimento di Scienze Fisiche e INFN - Napoli Interazioni fondamentali e Struttura dell Universo Napoli,
Le Donne nella Scienza Astroparticelle: uno strumento per indagare l universo l Ofelia Pisanti Dipartimento di Scienze Fisiche e INFN - Napoli Interazioni fondamentali e Struttura dell Universo Napoli,
I neutrini solari e da supernova (parte 1) Corso di Introduzione all astrofisica Anno accademico Alessandra Re
 I neutrini solari e da supernova (parte 1) Corso di Introduzione all astrofisica Anno accademico 018-019 Alessandra Re aaacmxicbvdlahsxfnwkzctnu6ddzinqagxtmbmmztihmyxtqbmnhnvqyneib6ddcfbipmlbvonizsswkq3/ylohc/yoia4nhmfuicvphayx3fr0pu3yyura+undxvvnz80tz6eolnadl1uplg9ndmqqkmxburofrayyiwc5zdhtx9bdyjo3/gricbyhmtxoizdflwpe4vw6lvfniyxdaetaytjfza67p0kfflgk0yift6rdk/eu7qc7bmpzatkywi/1qs4zqkqsyp34znos5ississcji1b9kr4aucjvwy5/pjxodam4ucs6gaaemgypystaafqgyk3mdpl67otlbgdgxsebrpxh3c4zlybqbyufnf5557tfia1y9xvd/wqhclguypi8alpghohr8dcqsc5swqxq0if6v8yizjgejuhbcs5ye/jkd7u0ng3zutg84ijjwytt6tlyqh38gbosynpes4+uluyw/yj/ov3uv/o38ppuvroucteylo/z35caqk
I neutrini solari e da supernova (parte 1) Corso di Introduzione all astrofisica Anno accademico 018-019 Alessandra Re aaacmxicbvdlahsxfnwkzctnu6ddzinqagxtmbmmztihmyxtqbmnhnvqyneib6ddcfbipmlbvonizsswkq3/ylohc/yoia4nhmfuicvphayx3fr0pu3yyura+undxvvnz80tz6eolnadl1uplg9ndmqqkmxburofrayyiwc5zdhtx9bdyjo3/gricbyhmtxoizdflwpe4vw6lvfniyxdaetaytjfza67p0kfflgk0yift6rdk/eu7qc7bmpzatkywi/1qs4zqkqsyp34znos5ississcji1b9kr4aucjvwy5/pjxodam4ucs6gaaemgypystaafqgyk3mdpl67otlbgdgxsebrpxh3c4zlybqbyufnf5557tfia1y9xvd/wqhclguypi8alpghohr8dcqsc5swqxq0if6v8yizjgejuhbcs5ye/jkd7u0ng3zutg84ijjwytt6tlyqh38gbosynpes4+uluyw/yj/ov3uv/o38ppuvroucteylo/z35caqk
INTRODUZIONE. ...et semina rerum...quod ex illis sunt omnia primis... e semi delle cose, che gli elementi primi son essi, onde il tutto si forma.
 INTRODUZIONE Una relazione profonda collega i fenomeni su grande scala ai costituenti fondamentali della materia; La relazione tra le cose e i i semi delle cose, di cui ci parla Lucrezio. Questo legame
INTRODUZIONE Una relazione profonda collega i fenomeni su grande scala ai costituenti fondamentali della materia; La relazione tra le cose e i i semi delle cose, di cui ci parla Lucrezio. Questo legame
Tracciamento di raggi cosmici con il telescopio EEE Esperienza 1
 Laboratorio di Fisica delle Interazioni Fondamentali Università di Pisa Tracciamento di raggi cosmici con il telescopio EEE Esperienza 1 Introduzione L esperienza consiste nella misura dell intensità e
Laboratorio di Fisica delle Interazioni Fondamentali Università di Pisa Tracciamento di raggi cosmici con il telescopio EEE Esperienza 1 Introduzione L esperienza consiste nella misura dell intensità e
Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari
 Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari Stage Residenziale 2012 Indice Caratteristiche generali sensibilità, risposta, spettro d ampiezza, risoluzione energetica, efficienza, tempo morto
Rivelatori Caratteristiche generale e concetti preliminari Stage Residenziale 2012 Indice Caratteristiche generali sensibilità, risposta, spettro d ampiezza, risoluzione energetica, efficienza, tempo morto
