Epistola XIII a Cangrande della Scala XIII
|
|
|
- Pio Grassi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Epistola XIII a Cangrande della Scala XIII Magnifico atque victorioso domino domino Cani Grandi de la Scala sacratissimi Cesarei Principatus in urbe Verona et civitate Vicentie Vicario Generali, devotissimus suus Dantes Alagherii florentinus natione non moribus, vitam orat per tempora diuturna felicem et gloriosi nominis perpetuum incrementum. [1]. Inclita vestre Magnificentie laus, quam fama vigil volitando disseminat, sic distrahit in diversa diversos, ut hos in spem sue prosperitatis attollat, hos exterminii deiciat in terrorem. Huius quidem preconium, facta modernorum exsuperans, tanquam veri existentia latius arbitrabar aliquando superfluum. Verum ne diuturna me nimis incertitudo suspenderet, velut Austri regina Ierusalem petiit, velut Pallas petiit Elicona, Veronam petii fidis oculis discursurus audita, ibique magnalia vestra vidi, vidi beneficia simul et tetigi; et quemadmodum prius dictorum ex parte suspicabar excessum, sic posterius ipsa facta excessiva cognovi. Quo factum ut ex auditu solo cum quadam animi subiectione benivolus prius exstiterim, sed ex visu postmodum devotissimus et amicus. [2]. Nec reor amici nomen assumens, ut nonnulli forsitan obiectarent, reatum presumptionis incurrere, cum non minus dispares connectantur quam pares amicitie sacramento. Nam si delectabiles et utiles amicitias inspicere libeat, illis persepius inspicienti patebit preheminentes inferioribus coniugari personas. Et si ad veram ac per se amicitiam torqueatur intuitus, nonne summorum illustriumque principum plerunque viros fortuna obscuros, honestate preclaros, amicos fuisse constabit? Quidni, cum etiam Dei et hominis amicitia nequaquam impediatur excessu? Quod si cuiquam quod asseritur nunc videretur indignum, Spiritum Sanctum audiat, amicitie sue participes quosdam homines profitentem; nam in Sapientia de sapientia legitur "quoniam infinitus thesaurus est hominibus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitie Dei". Sed habet imperitia vulgi sine discretione iudicium; et quemadmodum solem pedalis magnitudinis arbitratur, sic et circa mores vana credulitate decipitur. Nos autem quibus optimum quod est in nobis noscere datum est, gregum vestigia sectari non decet, quin ymo suis erroribus obviare tenemur. Nam intellectu ac ratione degentes, divina quadam libertate dotati, nullis consuetudinibus astringuntur; nec mirum, cum non ipsi legibus, sed ipsis leges potius dirigantur. Liquet igitur quod superius dixi, me scilicet esse devotissimum et amicum, nullatenus esse presumptum. [3]. Preferens ergo amicitiam vestram quasi thesaurum carissimum, providentia diligenti et accurata solicitudine illam servare desidero. Itaque, cum in dogmatibus moralis negotii amicitiam adequari et salvari analogo doceatur, ad retribuendum pro collatis beneficiis plus quam semel analogiam sequi mihi votivum est; et propter hoc munuscula mea sepe multum conspexi et ab invicem segregavi nec non segregata percensui, digniusque gratiusque vobis inquirens. Neque ipsi preheminentie vestre congruum comperi magis quam Comedie sublimem canticam que decoratur titulo Paradisi; et illam sub presenti epistola, tanquam sub epigrammate proprio dedicatam, vobis ascribo, vobis offero, vobis denique recommendo. [4]. Illud quoque preterire silentio simpliciter inardescens non sinit affectus, quod in hac donatione plus dono quam domino et honoris et fame conferri videri potest; quin ymo, cum eius titulo iam presagium de gloria vestri nominis amplianda satis attentis videbar expressisse; quod de proposito. Sed zelus gratie vestre, quam sitio vitam parvipendens, a primordio metam prefixam urgebit ulterius. Itaque, formula consumata epistole, ad introductionem oblati operis aliquid sub lectoris officio compendiose aggrediar. [5]. Sicut dicit Phylosophus in secundo Metaphysicorum, "sicut res se habet ad esse, sic se habet ad veritatem"; cuius ratio est, quia veritas de re, que in veritate consistit tanquam in subiecto, est similitudo perfecta rei sicut est. Eorum vero que sunt, quedam sic sunt ut habeant esse absolutum in se; quedam sunt ita ut habeant esse dependens ab alio per relationem quandam, ut eodem tempore esse et ad aliud se habere ut relativa; sicut pater et filius, dominus et servus, duplum et dimidium, totum et pars, et huiusmodi, in quantum talia. Propterea quod esse talium dependet ab alio, consequens est quod eorum veritas ab alio dependeat; ignorato enim dimidio, nunquam cognoscitur duplum, et sic de aliis. 1
2 [6]. Volentes igitur aliqualem introductionem tradere de parte operis alicuius, oportet aliquam notitiam tradere de toto cuius est pars. Quapropter et ego, volens de parte supra nominata totius Comedie aliquid tradere per modum introductionis, aliquid de toto opere premittendum existimavi, ut facilior et perfectior sit ad partem introitus. Sex igitur sunt que in principio cuiusque doctrinalis operis inquirenda sunt, videlicet subiectum, agens, forma, finis, libri titulus, et genus phylosophie. De istis tria sunt in quibus pars ista quam vobis destinare proposui variatur a toto, scilicet subiectum, forma et titulus; in aliis vero non variatur, sicut apparet inspicienti; et ideo circa considerationem de toto ista tria inquirenda seorsum sunt: quo facto, satis patebit ad introductionem partis. Deinde inquiremus alia tria non solum per respectum ad totum, sed etiam per respectum ad ipsam partem oblatam. [7]. Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non est simplex sensus, ymo dici potest polysemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus. Qui modus tractandi, ut melius pateat, potest considerari in hiis versibus: "In exitu Israel de Egipto, domus Iacob de populo barbaro, facta est Iudea sanctificatio eius, Israel potestas eius". Nam si ad litteram solam inspiciamus, significatur nobis exitus filiorum Israel de Egipto, tempore Moysis; si ad allegoriam, nobis significatur nostra redemptio facta per Christum; si ad moralem sensum, significatur nobis conversio anime de luctu et miseria peccati ad statum gratie; si ad anagogicum, significatur exitus anime sancte ab huius corruptionis servitute ad eterne glorie libertatem. Et quanquam isti sensus mystici variis appellentur nominibus, generaliter omnes dici possunt allegorici, cum sint a litterali sive historiali diversi. Nam allegoria dicitur ab 'alleon' grece, quod in latinum dicitur 'alienum', sive 'diversum'. [8.] Hiis visis, manifestum est quod duplex oportet esse subiectum, circa quod currant alterni sensus. Et ideo videndum est de subiecto huius operis, prout ad litteram accipitur; deinde de subiecto, prout allegorice sententiatur. Est ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum accepti, status animarum post mortem simpliciter sumptus; nam de illo et circa illum totius operis versatur processus. Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi et puniendi obnoxius est. [9]. Forma vero est duplex: forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus est triplex, secundum triplicem divisionem. Prima divisio est, qua totum opus dividitur in tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica dividitur in cantus. Tertia, qua quilibet cantus dividitur in rithimos. Forma sive modus tractandi est poeticus, fictivus, descriptivus, digressivus, transumptivus, et cum hoc diffinitivus, divisivus, probativus, improbativus, et exemplorum positivus. [10]. Libri titulus est: 'Incipit Comedia Dantis Alagherii, florentini natione, non moribus'. Ad cuius notitiam sciendum est quod comedia dicitur a 'comos' villa et 'oda' quod est cantus, unde comedia quasi 'villanus cantus'. Et est comedia genus quoddam poetice narrationis ab omnibus aliis differens. Differt ergo a tragedia in materia per hoc, quod tragedia in principio est admirabilis et quieta, in fine seu exitu est fetida et horribilis; et dicitur propter hoc a 'tragos' quod est hircus et 'oda' quasi 'cantus hircinus', id est fetidus ad modum hirci; ut patet per Senecam in suis tragediis. Comedia vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur, ut patet per Terentium in suis comediis. Et hinc consueverunt dictatores quidam in suis salutationibus dicere loco salutis 'tragicum principium et comicum finem'. Similiter differunt in modo loquendi: elate et sublime tragedia; comedia vero remisse et humiliter, sicut vult Oratius in sua Poetria, ubi licentiat aliquando comicos ut tragedos loqui, et sic e converso: Interdum tamen et vocem comedia tollit, iratusque Chremes tumido delitigat ore; et tragicus plerunque dolet sermone pedestri Telephus et Peleus, etc. Et per hoc patet quod Comedia dicitur presens opus. Nam si ad materiam respiciamus, a principio horribilis et fetida est, quia Infernus, in fine prospera, desiderabilis et grata, quia Paradisus; ad modum loquendi, remissus est modus et humilis, quia locutio vulgaris in qua et muliercule comunicant. 2
3 Sunt et alia genera narrationum poeticarum, scilicet carmen bucolicum, elegia, satira, et sententia votiva, ut etiam per Oratium patere potest in sua Poetria; sed de istis ad presens nihil dicendum est. [11]. Potest amodo patere quomodo assignandum sit subiectum partis oblate. Nam si totius operis litteraliter sumpti sic est subiectum, status animarum post mortem non contractus sed simpliciter acceptus, manifestum est quod hac in parte talis status est subiectum, sed contractus, scilicet status animarum beatarum post mortem. Et si totius operis allegorice sumpti subiectum est homo prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem est iustitie premiandi et puniendi obnoxius, manifestum est in hac parte hoc subiectum contrahi, et est homo prout merendo obnoxius est iustitie premiandi. [12]. Et sic patet de forma partis per formam assignatam totius; nam si forma tractatus in toto est triplex, in hac parte tantum est duplex, scilicet divisio cantuum et rithimorum. Non eius potest esse propria forma divisio prima, cum ista pars sit prime divisionis. [13]. Patet etiam de libri titulo; nam titulus totius libri est 'Incipit Comedia etc.', ut supra; titulus autem huius partis est 'Incipit cantica tertia Comedie Dantis etc. que dicitur Paradisus'. [14]. Inquisitis his tribus in quibus variatur pars a toto, videndum est de aliis tribus in quibus nulla variatio est a toto. Agens igitur totius et partis est ille qui dictus est, et totaliter videtur esse. [15]. Finis totius et partis esse posset et multiplex, scilicet propinquus et remotus; sed, omissa subtili investigatione, dicendum est breviter quod finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis. [16]. Genus vero phylosophie sub quo hic in toto et parte proceditur, est morale negotium, sive ethica; quia non ad speculandum, sed ad opus inventum est totum et pars. Nam si in aliquo loco vel passu pertractatur ad modum speculativi negotii, hoc non est gratia speculativi negotii, sed gratia operis; quia, ut ait Phylosophus in secundo Methaphysicorum, "ad aliquid et nunc speculantur practici aliquando". [17]. Hiis itaque premissis, ad expositionem littere secundum quandam prelibationem accedendum est, et illud prenuntiandum quod expositio littere nichil aliud est quam forme operis manifestatio. Dividitur ergo ista pars, seu tertia cantica que Paradisus dicitur, principaliter in duas partes, scilicet in prologum et partem executivam. Pars secunda incipit ibi: 'Surgit mortalibus per diversas fauces'. [18]. De parte prima sciendum est quod, quamvis comuni ratione dici posset exordium, proprie autem loquendo non debet dici nisi prologus; quod Phylosophus in tertio Rethoricorum videtur innuere, ubi dicit quod "proemium est principium in oratione rethorica sicut prologus in poetica et preludium in fistulatione". Est etiam prenotandum quod prenuntiatio ista, que comuniter exordium dici potest, aliter fit a poetis, aliter fit a rethoribus. Rethores enim concessere prelibare dicenda ut animum comparent auditoris; sed poete non solum hoc faciunt, quin ymo post hec invocationem quandam emittunt. Et hoc est eis conveniens, quia multa invocatione opus est eis, cum aliquid contra comunem modum hominum a superioribus substantiis petendum est, quasi divinum quoddam munus. Ergo presens prologus dividitur in partes duas, quia in prima premittitur quid dicendum sit, in secunda invocatur Apollo; et incipit secunda pars ibi: 'O bone Apollo, ad ultimum laborem'. [19]. Propter primam partem notandum quod ad bene exordiendum tria requiruntur, ut dicit Tullius in Nova Rethorica, scilicet ut benivolum et attentum et docilem reddat aliquis auditorem; et hoc maxime in admirabili genere cause, ut ipsemet Tullius dicit. Cum ergo materia circa quam versatur presens tractatus sit admirabilis, et propterea ad admirabile reducenda, ista tria intenduntur in principio exordii sive prologi. Nam dicit se dicturum ea que vidit in primo celo et retinere mente potuit. In quo dicto omnia illa tria comprehenduntur; nam in utilitate dicendorum benivolentia paratur; in admirabilitate attentio; in possibilitate docilitas. Utilitatem innuit, cum recitaturum se dicit ea que maxime allectiva sunt desiderii humani, scilicet gaudia Paradisi; admirabilitatem tangit, cum promittit se tam ardua tam sublimia dicere, scilicet conditiones regni celestis; possibilitatem ostendit, cum dicit se dicturum que mente retinere potuit; si enim ipse, et alii poterunt. Hec omnia tanguntur in verbis illis ubi dicit se fuisse in primo celo, et quod dicere vult de regno celesti quicquid in mente sua, quasi thesaurum, potuit retinere. Viso igitur de bonitate ac perfectione prime partis prologi, ad litteram accedatur. [20]. Dicit ergo quod 'gloria primi Motoris', qui Deus est, 'in omnibus partibus universi resplendet', sed ita ut 'in aliqua parte magis, et in aliqua minus'. 3
4 Quod autem ubique resplendeat, ratio et auctoritas manifestat. Ratio sic: Omne quod est, aut habet esse a se, aut ab alio: sed constat quod habere esse a se non convenit nisi uni, scilicet primo seu principio, qui Deus est, cum habere esse non arguat per se necesse esse, et per se necesse esse non competat nisi uni, scilicet primo seu principio, quod est causa omnium; ergo omnia que sunt, preter unum ipsum, habent esse ab alio. Si ergo accipiatur ultimum in universo, non quodcunque, manifestum est quod id habet esse ab aliquo; et illud a quo habet, a se vel ab aliquo habet. Si a se, sic est primum; si ab aliquo, et illud similiter vel a se vel ab aliquo. Et cum esset sic procedere in infinitum in causis agentibus, ut probatur in secundo Metaphysicorum, erit devenire ad primum, qui Deus est. Et sic, mediate vel inmediate, omne quod habet esse habet esse ab eo; quia ex eo quod causa secunda recipit a prima, influit super causatum ad modum recipientis et reddentis radium, propter quod causa prima est magis causa. Et hoc dicitur in libro De Causis quod "omnis causa primaria plus influit super suum causatum quam causa universalis secunda". Sed hoc quantum ad esse. [21]. Quantum vero ad essentiam, probo sic: Omnis essentia, preter primam, est causata, aliter essent plura que essent per se necesse esse, quod est impossibile: quod causatum, vel a natura est vel ab intellectu, et quod a natura, per consequens causatum est ab intellectu, cum natura sit opus intelligentie; omne ergo quod est causatum, est causatum ab aliquo intellectu vel mediate vel inmediate. Cum ergo virtus sequatur essentiam cuius est virtus, si essentia intellectiva, est tota et unius que causat. Et sic quemadmodum prius devenire erat ad primam causam ipsius esse, sic nunc essentie et virtutis. Propter quod patet quod omnis essentia et virtus procedat a prima, et intelligentie inferiores recipiant quasi a radiante, et reddant radios superioris ad suum inferius ad modum speculorum. Quod satis aperte tangere videtur Dionysius de Celesti Hierarchia loquens. Et propter hoc dicitur in libro De Causis quod "omnis intelligentia est plena formis". Patet ergo quomodo ratio manifestat divinum lumen, id est divinam bonitatem, sapientiam et virtutem, resplendere ubique. [22]. Similiter etiam et scientius facit auctoritas. Dicit enim Spiritus Sanctus per Hieremiam: "Celum et terram ego impleo"; et in Psalmo: "Quo ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam? Si ascendero in celum, tu illic es; si descendero in infernum, ades. Si sumpsero pennas meas etc.". Et Sapientia dicit quod "Spiritus Domini replevit orbem terrarum". Et Ecclesiasticus in quadragesimo secundo: "Gloria Domini plenum est opus eius". Quod etiam scriptura paganorum contestatur; unde Lucanus in nono: "Iuppiter est quodcunque vides, quocunque moveris". [23]. Bene ergo dictum est cum dicit quod divinus radius sive divina gloria, 'per universum penetrat et resplendet': penetrat, quantum ad essentiam; resplendet, quantum ad esse. Quod autem subicit de 'magis et minus', habet veritatem in manifesto; quoniam videmus in aliquo excellentiori gradu essentiam aliquam, aliquam vero in inferiori; ut patet de celo et elementis, quorum quidem illud incorruptibile, illa vero corruptibilia sunt. [24]. Et postquam premisit hanc veritatem, prosequitur ab ea circumloquens Paradisum; et dicit quod fuit in celo illo quod de gloria Dei, sive de luce, recipit affluentius. Propter quod sciendum quod illud celum est celum supremum, continens corpora universa et a nullo contentum, intra quod omnia corpora moventur, ipso in sempiterna quiete permanente *** et a nulla corporali substantia virtutem recipiens. Et dicitur empyreum, quod est idem quod celum igne sui ardoris flagrans; non quod in eo sit ignis vel ardor materialis, sed spiritualis, quod est amor sanctus sive caritas. [25]. Quod autem de divina luce plus recipiat, potest probari per duo: primo, per suum omnia continere et a nullo contineri; secundo, per sempiternam suam quietem sive pacem. Quantum ad primum probatur sic: Continens se habet ad contentum in naturali situ sicut formativum ad formabile, ut habetur in quarto Physicorum: sed in naturali situ totius universi primum celum est omnia continens; ergo se habet ad omnia sicut formativum ad formabile, quod est se habere per modum cause. Et cum omnis vis causandi sit radius quidam influens a prima causa que Deus est, manifestum est quod illud celum quod magis habet rationem cause, magis de luce divina recipit. [26]. Quantum ad secundum, probatur sic: Omne quod movetur, movetur propter aliquid quod non habet, quod est terminus sui motus; sicut celum lune movetur propter aliquam partem sui, que non habet illud ubi ad quod movetur; et quia sui pars quelibet non adepto quolibet ubi, quod est impossibile, movetur ad aliud, inde est quod semper movetur et nunquam quiescit, et est eius 4
5 appetitus. Et quod dico de celo lune, intelligendum est de omnibus, preter primum. Omne ergo quod movetur est in aliquo defectu, et non habet totum suum esse simul. Illud igitur celum quod a nullo movetur, in se in qualibet sui parte habet quicquid potest modo perfecto, ita quod motu non indiget ad suam perfectionem. Et cum omnis perfectio sit radius primi, quod est in summo gradu perfectionis; manifestum est quod celum primum magis recipit de luce primi, qui est Deus. Ista tamen ratio videtur arguere ad destructionem antecedentis, ita quod simpliciter et secundum formam arguendi non probat. Sed si consideremus materiam eius, bene probat, quia de quodam sempiterno, in quo potest defectus sempiternari: ita quod, si Deus non dedit sibi motum, patet quod non dedit sibi materiam in aliquo egentem. Et per hanc suppositionem tenet argumentum ratione materie; et est similis modus arguendi ac si dicerem: Si homo est, est risibile; nam in omnibus convertibilibus tenet similis ratio gratia materie. Sic ergo patet: cum dicit 'in illo celo, quod plus de luce Dei recipit', intelligit circumloqui Paradisum, sive celum empyreum. [27]. Premissis quoque rationibus consonanter dicit Phylosophus in primo De Celo quod celum "tanto habet honorabiliorem materiam istis inferioribus, quanto magis elongatum est ab hiis que hic". Ad hoc etiam posset adduci quod dicit Apostolus ad Ephesios de Christo: "Qui ascendit super omnes celos, ut adimpleret omnia". Hoc est celum delitiarum Domini; de quibus delitiis dicitur contra Luciferum per Ezechielem: "Tu signaculum similitudinis, sapientia plenus et perfectione decorus in deliciis Paradisi Dei fuisti". [28]. Et postquam dixit quod fuit in loco illo Paradisi per suam circumlocutionem, prosequitur dicens se vidisse aliqua que recitare non potest qui descendit. Et reddit causam dicens 'quod intellectus in tantum profundat se' in ipsum 'desiderium suum', quod est Deus, 'quod memoria sequi non potest'. Ad que intelligenda sciendum est quod intellectus humanus in hac vita, propter connaturalitatem et affinitatem quam habet ad substantiam intellectualem separatam, quando elevatur, in tantum elevatur, ut memoria post reditum deficiat propter transcendisse humanum modum. Et hoc insinuatur nobis per Apostolum ad Corinthios loquentem, ubi dicit: "Scio hominem, sive in corpore sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum usque ad tertium celum, et vidit arcana Dei, que non licet homini loqui". Ecce, postquam humanam rationem intellectus ascensione transierat, quid extra se ageretur non recordabatur. Et hoc est insinuatum nobis in Matheo, ubi tres discipuli ceciderunt in faciem suam, nichil postea recitantes, quasi obliti. Et in Ezechiele scribitur: "Vidi, et cecidi in faciem meam". Et ubi ista invidis non sufficiant, legant Richardum de Sancto Victore in libro De Contemplatione, legant Bernardum in libro De Consideratione, legant Augustinum in libro De Quantitate Anime, et non invidebunt. Si vero in dispositionem elevationis tante propter peccatum loquentis oblatrarent, legant Danielem, ubi et Nabuchodonosor invenient contra peccatores aliqua vidisse divinitus, oblivionique mandasse. Nam "qui oriri solem suum facit super bonos et malos, et pluit super iustos et iniustos", aliquando misericorditer ad conversionem, aliquando severe ad punitionem, plus et minus, ut vult, gloriam suam quantumcunque male viventibus manifestat. [29]. Vidit ergo, ut dicit, aliqua 'que referre nescit et nequit rediens'. Diligenter quippe notandum est quod dicit 'nescit et nequit': nescit quia oblitus, nequit quia, si recordatur et contentum tenet, sermo tamen deficit. Multa namque per intellectum videmus quibus signa vocalia desunt: quod satis Plato insinuat in suis libris per assumptionem metaphorismorum; multa enim per lumen intellectuale vidit que sermone proprio nequivit exprimere. [30]. Postea dicit se dicturum illa que de regno celesti retinere potuit, et hoc dicit esse 'materiam' sui operis; que qualia sint et quanta, in parte executiva patebit. [31]. Deinde cum dicit: 'O bone Apollo', etc., facit invocationem suam. Et dividitur ista pars in partes duas: in prima invocando petit; in secunda suadet Apollini petitionem factam, remunerationem quandam prenuntians; et incipit secunda pars ibi: 'O divina virtus'. Prima pars dividitur in partes duas: in prima petit divinum auxilium, in secunda tangit necessitatem sue petitionis, quod est iustificare ipsam, ibi: 'Hucusque alterum iugum Parnassi' etc. [32]. Hec est sententia secunde partis prologi in generali. In speciali vero non exponam ad presens; urget enim me rei familiaris angustia, ut hec et alia utilia reipublice derelinquere 5
6 oporteat. Sed spero de Magnificentia vestra ita ut alias habeatur procedendi ad utilem expositionem facultas. [33]. In parte vero executiva, que fuit divisa iuxta totum prologum, nec dividendo nec sententiando quicquam dicetur ad presens, nisi hoc, quod ubique procedetur ascendendo de celo in celum, et recitabitur de animabus beatis inventis in quolibet orbe, et quod vera illa beatitudo in sentiendo veritatis principium consistit; ut patet per Iohannem ibi: "Hec est vita eterna, ut cognoscant te Deum verum etc."; et per Boetium in tertio De Consolatione ibi: "Te cernere finis". Inde est quod ad ostendendum gloriam beatitudinis in illis animabus, ab eis tanquam videntibus omnem veritatem multa querentur que magnam habent utilitatem et delectationem. Et quia, invento principio seu primo, videlicet Deo, nichil est quod ulterius queratur, cum sit Alfa et O, idest principium et finis, ut visio Iohannis designat, in ipso Deo terminatur tractatus, qui est benedictus in secula seculorum. 6
7 Al magnifico e vittorioso signore, il signore Cangrande della Scala, Vicario generale del sacratissimo Cesareo Principato nella città di Verona e nella città di Vicenza, Dante Alighieri, fiorentino di nascita non di costumi, a lui devotissimo, augura vita felice per lunghi anni e che la gloriosa rinomanza possa accrescersi per l'eternità. [1]. L'inclita lode della Magnificenza vostra che la vigil fama svolazzando diffonde provoca effetti diversi fra gli uomini dividendoli in due parti opposte, l'una che s'esalta nella speranza del proprio successo, l'altra che s'abbatte nello sgomento della propria disfatta. Devo confessare che la voce di questa lode, più vasta di quella che si possono attendere le azioni degli uomini d'oggi, io la giudicai un tempo eccessiva, superiore alla realtà. Ma mi pesava troppo la lunga mancanza di notizie sicure, onde, come la regina del Mezzodì venne a Gerusalemme, come Pallade venne sull'elicona, io venni a Verona a verificare sulla fede dei miei occhi quel che avevo sentito dire, e qui vidi le vostre grandiosità, vidi il bene che avete fatto e lo sperimentai; e come prima avevo dubitato per quel che si diceva di voi che si fosse esagerato, così dopo riconobbi che quel che avete fatto era eccezionale. Onde avvenne che se prima al solo sentir parlare di voi avevo provato per voi un sentimento di benevolenza dettato dalla soggezione, in seguito, appena vi vidi, questo sentimento si cangiò in sensi di grande devozione e di amicizia. [2]. Né penso, arrogandomi il nome d'amico, di peccare di presunzione - e qualcuno me ne potrebbe incolpare - se è vero che il sacro vincolo dell'amicizia stringe tra loro persone sia di dissimile sia di simile stato. Ché, se esaminiamo attentamente le amicizie dilettevoli e quelle utili, apparirà che assai spesso persone eminenti si sogliono legare ad altre di stato inferiore. E se si volge lo sguardo all'amicizia perfetta e disinteressata, non risulterà forse che uomini d'oscura fortuna ma di chiara onestà furono amici di grandi e illustri principi? E perché no, quando persino l'amicizia fra Dio e l'uomo non è impedita dall'enorme distanza che li separa? Ché, se questa affermazione sembrasse a qualcuno blasfema, ascolti almeno lo Spirito Santo che testimonia che alcuni uomini hanno parte della sua amicizia; infatti si può leggere nel libro dellasapienza a proposito della sapienza: "Perocché ella è tesoro infinito per gli uomini, e coloro che la impiegano hanno parte all'amicizia di Dio". Ma l'ignoranza del volgo formula giudizi senza discernimento; e come conclude che il sole sia di larghezza nel diametro d'un piede, così per quel che riguarda i costumi è tratta in inganno dalla sciocca credulità. Ma noi a cui è stato concesso di aver coscienza del meglio ch'è in noi, non dobbiamo calcare le orme delle pecore, ché anzi siamo tenuti a correggere le loro deviazioni. Quelli infatti che sono coscienti della forza dell'intelletto razionale e del dono divino del libero arbitrio non possono essere obbligati da nessuna consuetudine; né c'è da meravigliarsene, se è vero che non essi dalle leggi, male leggi da essi prendon norma. È chiaro dunque che quel che ho detto sopra, cioè che io ho per voi "sensi di grande devozione e di amicizia" non è per nulla un peccato di presunzione. [3]. Tenendo dunque, più che a ogni altra cosa, alla vostra amicizia come al tesoro più caro, è mio desiderio di conservarla con ogni cura e premura, prevedendo la minima cosa che possa turbarla. Dunque, siccome nei dommi dell'etica s'insegna che il concetto dell'"analogo" stabilisce l'eguaglianza fra gli amici e conserva l'amicizia, per corrispondere in qualche modo ai benefici più d'una volta ricevuti, è mio voto seguire il concetto di "analogia"; e perciò molto a lungo esaminai i poveri doni che potevo farvi e ne misi qualcuno da parte e poi li riesaminai attentamente domandandomi quale fosse il più degno di voi e a voi più gradito. E non riuscii a trovare niente tanto adatto a vostra altezza quanto la suprema cantica della Comedìa che s'adorna del titolo di Paradiso. Questa, con la presente epistola che assolve perciò le funzioni di un epigramma di dedica, metto sotto il vostro nome, questa vi offro, questa vi affido. [4]. Ma il grande affetto non può far passare sotto silenzio il fatto che da questo dono che io vi faccio possa sembrare che il dono stesso più che colui che ne venga in possesso ne consegua onore e fama. Ma, al contrario, già dal titolo che vi appongo io volli esprimere, come sarà ben apparso ai lettori più attenti ed era mio proposito, un presagio dell'accrescimento della gloriosa vostra rinomanza. Ma il desiderio del vostro favore, che bramo più della vita, sarà d'incitamento a procedere più speditamente verso la mèta che mi prefissi in partenza. Pertanto esaurita la formula dell'epistola mi accingerò, in veste di lector, a esporre sommariamente alcuni punti che servano come accessus dell'opera offerta. [5]. Come dice il Filosofo nel libro secondo della Metafisica "nel modo in cui ogni cosa sta nei confronti dell'essere, così sta nei confronti della verità"; il che significa che la verità di una cosa, che consiste nella verità in quanto soggetto, sta nella perfetta simiglianza con la cosa in quanto è. 7
8 Ma fra le cose che sono soltanto alcune sono tali da avere in sé l'essere assoluto; altre sono tali da avere un essere che dipende da un altro per relazione, come essere e nel medesimo tempo stare ad altro come cosa relativa; come il padre e il figlio, il padrone e il servo, il doppio e la metà, il tutto e la parte, e così via, in quanto tali. Giacché l'essere di tali cose dipende da un altro, ne consegue che la loro verità dipende da quell'altro; se infatti s'ignorasse il concetto di metà non si potrebbe conoscere il concetto di doppio, e così via. [6]. Volendo dunque comporre un accessus che riguardi una parte di un'opera, bisogna prima dare qualche notizia del tutto di cui essa è parte. Perciò anch'io, volendo per la parte sopra nominata di tutta la Comedìa comporre qualcosa a mo' di accessus, credetti opportuno premettere qualcosa per tutta l'opera, affinché risultasse più comprensibile e più compiuto l'accessus alla parte. Orbene, sei sono gli elementi che bisogna discutere prima d'affrontare la lettura di un'opera dottrinale, cioè il soggetto, l'agente, la forma, il fine, il titolo del libro, il genere filosofico a cui appartiene. Fra questi elementi ce ne sono tre nei confronti dei quali codesta parte della Comedìa che ho deciso di dedicarvi si diversifica da tutta la Comedìa, cioè il soggetto, la forma e il titolo; nei confronti degli altri tre elementi non si diversifica come appare chiaro a chi l'esamini; perciò nell'esame di tutta la Comedìa questi tre elementi si devono discutere a parte; fatto ciò sarà più chiaro l'accessus alla parte. Poi discuteremo gli altri tre elementi non soltanto in relazione a tutta la Comedìa, ma anche in relazione alla parte offerta. [7]. Per chiarire quello che si dirà bisogna premettere che il significato di codesta opera non è uno solo, anzi può definirsi un significato polisemos, cioè di più significati. Infatti il primo significato è quello che si ha dalla lettera del testo, l'altro è quello che si ha da quel che si volle significare con la lettera del testo. Il primo si dice letterale, il secondo invece significato allegorico o morale o anagogico. Questi diversi modi di trattare un argomento si possono esemplificare, per maggior chiarezza, con i versetti: "Allorché dall'egitto uscì Israele, e la casa di Giacobbe (si partì) da un popolo barbaro; la nazione giudea venne consacrata a Dio; e dominio di Lui venne ad essere Israele". Infatti se guardiamo alla sola lettera del testo, il significato è che i figli di Israele uscirono d'egitto, al tempo di Mosè; se guardiamo all'allegoria, il significato è che noi siamo stati redenti da Cristo; se guardiamo al significato morale, il senso è che l'anima passa dalle tenebre e dalla infelicità del peccato allo stato di grazia; se guardiamo al significato anagogico, il senso è che l'anima santificata esce dalla schiavitù della presente corruzione terrena alla libertà dell'eterna gloria. E benché questi significati mistici siano definiti con diversi nomi, generalmente si possono tutti definire allegorici, in quanto si differenziano dal significato letterale ossia storico. Infatti la parola "allegoria" deriva dal greco "alleon" che è reso in latino con "alienum" ossia "diverso". [8]. Ciò premesso è chiaro che il soggetto di un'opera, sotto posto a due diversi significati, sarà duplice. E perciò si dovrà esaminare il soggetto della presente opera se esso si prende alla lettera e poi se s'interpreta allegoricamente. È dunque il soggetto di tutta l'opera, se si prende alla lettera, lo stato delle anime dopo la morte inteso in generale; su questo soggetto e intorno ad esso si svolge tutta l'opera. Ma se si considera l'opera sul piano allegorico, il soggetto è l'uomo in quanto, per i meriti e demeriti acquisiti con libero arbitrio, ha conseguito premi e punizioni da parte della giustizia divina. [9]. La forma poi è duplice: la prima riguarda la trattazione, la seconda il modo della trattazione. La forma della trattazione è triplice, secondo una divisione del testo in tre modi. Il primo consiste nella divisione per cui tutta l'opera si divide in tre cantiche. Il secondo nella divisione per cui ciascuna cantica si divide in canti. Il terzo nella divisione per cui ciascun canto si divide in ritmi. La forma o maniera del modo della trattazione è poetica, fittiva, descrittiva, digressiva, transuntiva e insieme definitiva, divisiva, probativa, improbativa ed esemplificativa. [10]. Il titolo del libro è: "Incomincia la Comedìa di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi". Per capire il titolo bisogna sapere che la parola "comedìa" deriva dalla parola "comos" che significa "villaggio" e "oda" che significa "canto", per cui "comedìa" come se fosse "canto villereccio". Ed è la comedìa un genere di narrazione poetica diverso da tutti gli altri. Si diversifica dalla tragedìa per la materia in questo che la tragedìa all'inizio è meravigliosa e placida e alla fine, cioè nella conclusione, fetida e paurosa; ed è detta tragedìa per questo da "tragos" che significa "capro" e "oda", come se fosse "canto del capro", cioè fetido come il capro; come risulta dalle tragedìe di Seneca. La comedìa invece inizia dalla narrazione di situazioni difficili, ma la sua materia finisce 8
9 bene, come risulta dalle comedìe di Terenzio. È questa la ragione per cui alcuni dettatori presero l'abitudine di adoperare, nelle formule di saluto, la frase: "Ti auguro tragico principio e comica fine". Similmente tragedìa e comedìa si diversificano per il linguaggio che è alto e sublime nella tragedìa, dimesso e umile nella comedìa, come dice Orazio nella sua Poetica quando dichiara che è permesso qualche volta agli scrittori di comedìe di esprimersi come gli scrittori di tragedìe e viceversa: Ma qualche volta anche la comedìa si alza dì tono e Cremete irato rimprovera con tumido linguaggio e nella tragedìa Telefo e Peleo si dolgono con discorso pedestre ecc. E da questo è chiaro che Comedìa si può definire la presente opera. Infatti se guardiamo alla materia, all'inizio essa è paurosa e fetida perché tratta dell'inferno, ma ha una fine buona, desiderabile e gradita, perché tratta del Paradiso. Per quel che riguarda il linguaggio questo è dimesso e umile perché si tratta della parlata volgare che usano anche le donnette. Ci sono anche altri generi di narrazioni poetiche, cioè il carme bucolico, l'elegia, la satira e la sentenza votiva (come appare dallapoetica di Orazio); ma di questi non è ora il caso di parlare. [11]. Può ora apparire chiaro come si debba definire il soggetto della parte offerta. Infatti se il soggetto di tutta l'opera presa alla lettera è la descrizione dello stato delle anime dopo la morte non limitato ma inteso in generale, è chiaro che in questa parte il soggetto è tale stato ma limitato, cioè lo stato delle anime beate dopo la morte. E se il soggetto di tutta l'opera interpretata allegoricamente è l'uomo in quanto per i meriti e demeriti acquisiti con libero arbitrio ha conseguito premi e punizioni dalla giustizia divina, è chiaro che in questa parte questo soggetto viene ad essere limitato ed è l'uomo in quanto per i meriti ha conseguito il premio della giustizia divina. [12]. E così appare per quel che riguarda la forma della parte sulla base della definizione della forma data per tutta l'opera; infatti se per quel che riguarda tutta l'opera la forma della trattazione è triplice, per quel che riguarda questa parte è soltanto duplice e consiste nella divisione in canti e nella divisione in ritmi. Non può costituire forma specifica della parte quella che abbiamo classificato come la prima divisione per tutta l'opera, dato che codesta parte è una parte di quella divisione. [13]. Appare anche per quel che riguarda il titolo del libro; infatti il titolo di tutto il libro è: "Incomincia la Comedìa, ecc.", come sopra; invece il titolo di questa parte è: "Incomincia la cantica terza della Comedìa di Dante, ecc., che s'intitola Paradiso". [24]. Esaminati questi tre elementi per cui la parte si diversifica da tutta l'opera, bisogna esaminare gli altri tre per cui non c'è nessuna variazione rispetto a tutta l'opera. L'agente dunque di tutta l'opera e della parte è colui che è nominato nel titolo, e appare chiaro che è l'agente totalmente. [15]. Il fine di tutta l'opera e della parte potrebbe essere anche molteplice, cioè vicino e lontano; ma tralasciata una ricerca così sottile, si può dire in breve che il fine di tutta l'opera e della parte consiste nell'allontanare quelli che vivono questa vita dallo stato di miseria e condurli a uno stato di felicità. [16]. Il genere poi di filosofia nel cui ambito qui si procede in tutta l'opera e nella parte è l'attività morale, cioè l'etica; perché sia tutta l'opera sia la parte sono state concepite non per la speculazione ma per l'operare. Infatti se in qualche luogo o passaggio la materia è svolta sotto la forma propria dell'attività speculativa, non lo è al fine dell'attività speculativa in sé, ma al fine dell'operare; giacché, come dice il Filosofo nel secondo libro della Metafisica: "in relazione a qualcosa e a un momento i filosofi pratici qualche volta sono indotti all'attività speculativa". [17]. Pertanto, premesse queste osservazioni, possiamo dar mano a un primo tentativo di esporre la lettera dell'opera, premettendo che l'esposizione della lettera di un'opera non è nient'altro che il chiarimento della forma dell'opera. Codesta parte, cioè la terza cantica che s'intitola Paradiso, sidivide, dunque, principalmente in due parti, cioè nel prologo e nella parte esecutiva. La seconda parte incomincia: "Surge ai mortali per diverse foci". [18]. Per quel che riguarda la prima parte bisogna notare che comunemente potrebbe essere definita esordio, ma più propriamente non deve essere definita se non prologo; su questo sembra d'accordo il Filosofo nel terzo libro della Retorica quando dice che "il proemio è l'inizio in un testo retorico come il prologo lo è in un testo poetico e il preludio in una composizione musicale". Bisogna anche premettere che questo preavviso che comunemente si può definire esordio, è svolto in modo diverso dai poeti e dai retori. 9
10 I retori infatti si limitano a premettere alcuni accenni su quel che diranno allo scopo di accattivarsi l'interesse dell'ascoltatore; ma i poeti non si limitano a questo soltanto, ché anzi dopo questi accenni pongono una invocazione. Ed è giusto che lo facciano perché hanno bisogno di una lunga invocazione, dovendo essi richiedere dalle sostanze superiori un aiuto che va oltre il limite normale dell'uomo, quasi un dono divino. II presente prologo si divide quindi in due parti, nella prima delle quali si premette quel che si dirà, nella seconda s'invoca Apollo; e comincia la seconda parte: "O buono Apollo, all'ultimo lavoro". [19]. Per quel che riguarda la prima parte del prologo bisogna osservare che per ottenere un buon esordio ci vogliono tre cose, come dice Tullio nella Retorica Nova, cioè che qualcuno renda l'auditor benevolo, attento e docile; e questo specialmente nel genere mirabile delle cause, come dice lo stesso Tullio. Poiché dunque la materia intorno a cui si svolge la presente trattazione è mirabile e perciò si deve riportare al genere mirabile, nel principio dell'esordio, ossia del prologo, si cerca di realizzare queste tre cose. Infatti il poeta dice che riferirà quel che vide nel primo cielo e che poté ricordare. In questa frase sono contenute tutte le tre cose: infatti, dichiarando l'utilità di quel che si dirà si conquista la benevolenza del lettore, dichiarandone la mirabilità se ne conquista l'attenzione, mostrandone la possibilità se ne conquista la docilità. Il poeta indica l'utilità della sua opera quando dice che narrerà cose che costituiscono il desiderio più forte dell'uomo, cioè le gioie del Paradiso; ne conferma la mirabilità quando promette di dire cose tanto ardue e sublimi, cioè le condizioni del regno celeste; ne mostra la possibilità quando dice che riferirà quel che poté ricordare; e se lo poté lui, anche gli altri lo potranno. Tutto questo è accennato in quelle parole quando il poeta dice di essere stato nel primo cielo e che vuol riferire sul regno celeste quel che poté conservare come un tesoro nel suo ricordo. Vista dunque la bontà e la perfezione della prima parte del prologo, si può passare all'esposizione della lettera. [20]. Dice dunque il poeta che "la gloria del primo Motore", cioè di Dio, "in ogni parte dell'universo risplende" ma in maniera che"in una parte più e meno in un'altra". Ora, che la gloria di Dio risplenda in ogni luogo lo dimostrano la ragione e l'autorità dei testi. La ragione procede in questo modo: Ogni cosa che è, o ha essere da sé stessa, o lo deriva da un altro; ma consta che avere essere da sé stesso non è possibile se non a un solo, vale a dire al Primo e al Principio, cioè Dio, dato che avere essere non prova essere necessariamente per sé stesso, e che essere necessariamente per sé stesso non compete che a un solo, vale a dire al Primo ovvero al Principio, che è causa di tutte le cose; dunque tutte le cose che sono, eccetto proprio quest'uno, derivano l'essere da un altro. Se dunque si considera non un qualunque essere, ma l'ultimo nell'universo, è chiaro che questo deriva il suo essere da un altro; e quello da cui lo deriva lo ha da sé o lo deriva da un altro. Se lo ha da sé, allora è lui il Primo; se lo deriva da un altro, questi allo stesso modo o lo ha da sé o lo deriva da un altro. E dato che questo sarebbe un procedere all'infinito nella ricerca delle cause agenti, come è dimostrato nel secondo libro della Metafisica, si dovrà arrivare al Primo, cioè a Dio. E così, indirettamente o direttamente, tutto quel che ha essere, deriva l'essere da Lui; giacché in conseguenza di quel che la causa seconda riceve dalla prima, essa influisce su ciò di cui è causa, alla maniera di uno specchio che riceve e riflette un raggio di luce, perché la causa prima è "causa" più che ogni altra. E questo si afferma nel libro Delle cause che "ogni causa primaria influisce su ciò di cui è causa più della causa universale seconda". Ma questo basti per quel che concerne l'essere. [21]. Per quel che concerne poi l'essenza, la dimostrazione è la seguente: Ogni essenza, eccetto la prima, è effetto di una causa, altrimenti ce ne sarebbero diverse che sarebbero per sé stesse necessariamente essere, il che è impossibile: quel che è effetto di una causa proviene o dalla natura o dall'intelletto, e quel che proviene dalla natura è per conseguenza effetto di una causa che proviene dall'intelletto, dato che la natura è opera d'intelligenza; quindi ogni effetto di una causa, è effetto di una causa che proviene da un intelletto o direttamente o indirettamente. Poiché dunque la virtù segue l'essenza di cui è virtù, se l'essenza è intellettiva, la virtù è tutta intera di quella sola essenza che la causa. E così come nella precedente dimostrazione era inevitabile arrivare alla causa prima dell'essere, così ora dovremo arrivare alla causa prima dell'essenza e della virtù. Per cui risulta che ogni essenza e virtù procede dalla prima e che le intelligenze inferiori ricevono i raggi dell'intelligenza superiore che li irraggia e li riflettono, come avviene negli specchi, alla 10
11 intelligenza che è sotto di loro. È questo che è notato assai chiaramente da Dionigi quando parla Della gerarchia celeste. E per questo si dice nel libro Delle cause che "ogni intelligenza è piena di forme". È dunque provato come la ragione dimostri che la luce divina, cioè la bontà divina, la sapienza e la virtù, risplendano in ogni luogo. [22]. La stessa cosa e con più dottrina dimostra anche l'autorità dei testi. Dice infatti lo Spirito Santo per bocca di Geremia: "Empio io il cielo e la terra"; e nel Salmo: "Dove anderò io lontan dal tuo spirito, e dove fuggirò io lontan dalla tua faccia? Se salirò al cielo, ivi se' tu; se scenderò nell'inferno, tu se' presente. Se io prenderò le ali... ecc.". E la Sapienza dice che "lo spirito del Signore riempie il mondo tutto". E l'ecclesiastico al capo quarantaduesimo: "Ogni opera del Signore è piena della sua magnificenza". Questo attestano anche gli scritti dei pagani; onde Lucano nel nono libro: Giove è dovunque guardi, dovunque movi il piè. [23]. È dunque ben detto quando il poeta dice che il divino raggio vale a dire la divina gloria "per l'universo penetra e risplende":penetra, in quanto all'essenza; risplende, in quanto all'essere. Quel che poi aggiunge a proposito del "più e meno", contiene una verità bene evidente; poiché noi possiamo constatare che una è l'essenza a un grado più elevato, altra a un grado inferiore; come appare dal cielo e dagli elementi, dei quali il cielo è incorruttibile mentre gli elementi sono corruttibili. [24.]. E dopo aver premesso questa verità il poeta, partendo da essa, prosegue, usando una circonlocuzione per nominare il Paradiso; e dice che "fu nel ciel che più riceve" della gloria di Dio, cioè "della sua luce". A proposito di questo bisogna notare che "quel cielo" è il cielo supremo che contiene tutti i corpi e che da nessun corpo è contenuto; nel quale tutti i corpi si muovono, mentre quello rimane in eterna quiete; che abbraccia tutto il suo contenuto per sua propria virtù e non riceve virtù da nessuna sostanza corporea. Ed è chiamato Empireo, cioè che brucia del fuoco del suo ardore; non perché in esso vi sia fuoco o ardore materiale, ma perché in esso v'è ardore spirituale, cioè amore santo, vale a dire la carità. [25]. Che poi "esso riceva più della divina luce", può essere dimostrato con due argomenti: prima per questa sua proprietà di contenere tutte le cose e di non essere contenuto da nessuna; poi per la sua caratteristica di rimanere in eterna quiete, vale a dire in pace. Per quel che concerne il primo argomento la dimostrazione è la seguente: il contenente sta al contenuto, per disposizione naturale, come il formativo sta al formabile, come è detto nel quarto libro della Fisica: ma per disposizione naturale di tutto l'universo il primo cielo è il contenente di tutte le cose; dunque esso sta a tutte le cose come il formativo sta al formabile, il che vale a dire che sta a tutte le cose in funzione di causa. E poiché ogni forza causativa è un raggio emanante dalla prima causa che è Dio, è chiaro che "quel cielo" che più ha forza di causa, "più della luce divina riceve". [26]. Per quel che concerne il secondo argomento la dimostrazione è la seguente: tutto quel che si muove, si muove a cagione di qualcosa che non ha, che è il termine del suo movimento; così il cielo della luna si muove a cagione di una parte di sé che non ha quel "dove" verso il quale si muove; e poiché ciascuna parte di sé, non avendo conseguito rispettivamente ciascun "dove", il che sarebbe impossibile, si muove verso un altro "dove", ne consegue che questo cielo si muove sempre e non è mai quieto, e questo è il suo appetito. E quel che ho detto del cielo della luna, è da intendersi di tutti gli altri, all'infuori del primo cielo. Tutto quel che si muove, si muove per mancanza di qualcosa e non ha in sé tutto insieme il suo essere. Dunque quel cielo che da nessuno è mosso, ha in sé, in ciascuna sua parte, ciò che è possibile che abbia, in modo così perfetto come dimostra il fatto che non ha bisogno del movimento per raggiungere una sua perfezione. E poiché ogni perfezione è raggio emanato da colui che è primo ed è al sommo grado della perfezione, è chiaro che il primo cielo "piùriceve della luce" di quel primo che è Dio. Questo ragionamento pertanto sembra che dimostri con la distruzione del termine antecedente, giacché non dimostra semplicemente e in forma d'argomentazione sillogistica. Ma se consideriamo la materia dell'argomento, la dimostrazione è valida, perché concerne l'eternità nell'ambito della quale la mancanza di qualche cosa potrebbe essere eterna: tal che se Dio non gli diede il moto è chiaro che non gli diede materia che avesse mancanza di qualcosa. E per questa supposizione l'argomento è valido in ragione della materia; ed è un modo d'argomentare come se dicessi: "Se è l'uomo, è la possibilità per lui di ridere"; infatti in ogni proposizione convertibile un ragionamento come è questo è valido in virtù della materia. Così 11
12 dunque è chiaro: quando il poeta dice "nel ciel che più della luce di Dio riceve" intende fare una circonlocuzione per nominare il Paradiso, vale a dire il Cielo Empireo. [27]. D'accordo con i ragionamenti su esposti dice il Filosofo nel primo libro Del cielo che il cielo "contiene una materia tanto più apprezzabile rispetto alle cose che son sotto di lui, quanto più è lontano dalle cose che son qui". In aggiunta a ciò si potrebbe addurre quel che dice di Cristo l'apostolo nell'epistola agli Efesini: "Che ascese sopra tutti i cieli per dar compimento a tutte le cose". Questo è il cielo delle delizie del Signore; delle qual delizie è detto per bocca di Ezechiele contro Lucifero: "Tu sigillo di somiglianza, di sapienza pieno, e ornato di perfezione. Tu vivevi fra le delizie del Paradiso di Dio". [28]. E dopo che il poeta ha detto con la sua circonlocuzione che fu in quel luogo del Paradiso, prosegue dicendo che "vide cose che ridire non può chi ne discende". E ne spiega la ragione dicendo "che l'intelletto si profonda tanto nel suo desire", cioè Dio, "che seguirlo la memoria non può". Per capire questo bisogna notare che l'umano intelletto in questa vita, a cagione dell'affinità naturale che ha con la sostanza intellettuale separata, quando s'eleva, s'eleva a tal punto, che la memoria, dopo il ritorno, vien meno per aver essa trasceso il limite concesso all'uomo: E questo ci è comunicato per bocca dell'apostolo nell'epistola ai Corinzi, dove dice: "Conosco un uomo, non so se col corpo o fuori del corpo, Dio lo sa, il quale fu rapito fino al terzo cielo, e vide gli arcani di Dio, che non è lecito ad uomo di proferire". Ecco, dopo che l'intelletto con la sua salita trascese l'umana ragione, non ricordava che cosa fosse avvenuto al di fuori di sé. E questo ci è comunicato nel Vangelo di Matteo, là dove si f dice che i tre "discepoli caddero bocconi per terra", e dopo non ridissero quel che avevano visto, come se se ne fossero dimenticati. Ed è scritto in Ezechiele: "Vidi e caddi boccone". E se queste autorità non bastano a chi vuol criticare il poeta, legga il Della contemplazione di Riccardo di San Vittore, legga il Della considerazione di Bernardo, legga il Della quantità dell'anima di Agostino, e cesserà di criticare. Ma se attaccasse violentemente il poeta perché, nonostante egli sia in peccato, ha potuto pensare che gli fosse stato riservato d'elevarsi fino a tal punto, legga il libro di Daniele, dove riscontrerà che per concessione divina anche a Nabucodonosor fu riservato di poter vedere alcune cose contro i peccatori, e le dimenticò. Infatti "Colui il quale fa che levisi il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi, e manda la pioggia pei giusti e per gl'iniqui", a volte misericordiosamente per ottenere una conversione, a volte severamente per punire una colpa, quando lo crede opportuno, o più o meno manifesta la sua gloria ai peccatori, per quanto grandi essi siano. [29]. Vide dunque il poeta "cose che riferire non sa e non può ritornando di lì". E si osservi attentamente il fatto che dice "non sa e non può": "non sa" perché se n'è dimenticato, "non può" perché, se ricorda e conserva la memoria del contenuto, "la lingua però vien meno per lo nostro sermone" Infatti attraverso il nostro intelletto vediamo molte cose per le quali mancano le espressioni verbali: il che a sufficienza dimostra Platone nelle sue opere quando si serve delle metafore; vide infatti attraverso la luce intellettuale molte cose che "nel sermone proprio" non poté esprimere. [30]. Dopo il poeta dice che dirà quelle cose "che del regnoceleste poté ritenere", e dice che questa "sarà matera del suo lavoro": e quali e quante siano queste cose, apparirà nella parte esecutiva. [31]. Quindi quando il poeta dice : "O buono Apollo" ecc. fa la sua invocazione. E questa parte si divide in due parti: nella prima richiede un aiuto con l'invocazione; nella seconda convince Apollo in favore della richiesta fatta, preannunciandogli una ricompensa; e la seconda parte comincia: "O divina virtù". La prima di queste due parti si divide in due parti: nella prima il poeta richiede l'aiuto divino, nella seconda sottolinea la necessità della sua richiesta, cioè la giustifica, quando dice: "Infino a qui l'un giogo di Parnaso" ecc. [32]. Questo è il significato della seconda parte del prologo in generale. Ma il significato in particolare non lo esporrò in questa sede; mi opprimono infatti le angustie della povertà sì che sono obbligato a tralasciare questa ed altre attività utili allo stato. Ma spero che da parte della Magnificenza vostra mi sia data la possibilità di seguitare in altra occasione questa utile esposizione. [33]. Quanto alla parte esecutiva e che fu considerata staccata dal prologo, in questa sede non se ne dirà nulla per quel che riguarda la divisione e il significato, se non che questo, che dovunque si procederà salendo di cielo in cielo e si parlerà delle anime beate incontrate in ciascuna sfera, e che la vera beatitudine consiste nel sentire il principio di verità; come appare per bocca di Giovanni, là dove dice: "La vita eterna si è, che conoscano te, vero Dio ecc."; e nel terzo libro del Della consolazione di Boezio, lì dove dice: "Il fine sta nel vedere te". È per questo che, per 12
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
5 gennaio Liturgia del giorno
 5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
5 gennaio 2014 - Liturgia del giorno Inviato da teresa Sunday 05 January 2014 Ultimo aggiornamento Sunday 05 January 2014 Parrocchia Immacolata Venosa Prima LetturaSir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO
 PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
PARROCCHIE AVESA E MONTECCHIO INCONTRO ADOLESCENTI 01 - ZAC E IL SUO ALBERO CANTO DI LODE Sono qui a lodarti Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita Resta per
Il simbolo nicenocostantinopolitano. La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione
 Il simbolo nicenocostantinopolitano La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione Credo in unum Deum Credo in un solo Dio Punti di attenzione: affermazione del monoteismo contro
Il simbolo nicenocostantinopolitano La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione Credo in unum Deum Credo in un solo Dio Punti di attenzione: affermazione del monoteismo contro
A cura di Chiesacattolica.it e LaChiesa.it. PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
 NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
NATALE DEL SIGNORE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Dal libro del profeta Isaìa 52, 7-10 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI
 PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
PARROCCHIA SACRO CUORE ADORAZIONE EUCARISTICA OPERATORI PASTORALI Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 23 Ottobre 2014 Canto d esposizione G. La domenica del comandamento
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
LITURGIA DELLA PAROLA XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) LITURGIA DELLA PAROLA PRIMA LETTURA (Ger 38,4-6.8-10) Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese (Ger 15,10). Dal libro del profeta Geremìa In quei giorni,
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) LITURGIA DELLA PAROLA PRIMA LETTURA (Ger 38,4-6.8-10) Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese (Ger 15,10). Dal libro del profeta Geremìa In quei giorni,
 DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
DIVINA COMMEDIA Opera elaborata da Dante tra il 1304 (o 1306) e il 1320-1321, la Divina Commedia appartiene al genere letterario dei poemi allegorico-didascalici che si propongono una funzione educativa
Devozione al Sacro Cuore di Gesù
 Opera Familia Christi Devozione al Sacro Cuore di Gesù Preghiera per il mese di giugno Preghiera iniziale da recitarsi insieme: Io ti saluto, o sacro Cuore di Gesù, fonte ardente della vita eterna, tesoro
Opera Familia Christi Devozione al Sacro Cuore di Gesù Preghiera per il mese di giugno Preghiera iniziale da recitarsi insieme: Io ti saluto, o sacro Cuore di Gesù, fonte ardente della vita eterna, tesoro
ALLELUIA ( Simonetta )
 ALLELUIA ( Simonetta ) Do Sol Fa Do Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (3 v.) Andate e annunciate a tutte le nazioni, così dice il Signore: Io sarò con voi tutti giorni, fino alla fine del
ALLELUIA ( Simonetta ) Do Sol Fa Do Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (3 v.) Andate e annunciate a tutte le nazioni, così dice il Signore: Io sarò con voi tutti giorni, fino alla fine del
Seduti nel cielo in Cristo Gesù
 Domenica, 10 giugno 2012 Seduti nel cielo in Cristo Gesù Efesini 2:4-6- Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati
Domenica, 10 giugno 2012 Seduti nel cielo in Cristo Gesù Efesini 2:4-6- Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati
Preghiera universale Venerdì santo
 1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
1 Preghiera universale Venerdì santo Azione Liturgica 2 Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall alto della croce ha steso le sue braccia su tutto l universo preghiamo Dio
il commento di p. Maggi al vangelo della domenica
 il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58
il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58
Litanie di Gesù. Ecco la prima Litania di Gesù all Umanità (1)- Protezione contro il Falso Profeta.
 Litanie di Gesù Ecco la prima Litania di Gesù all Umanità (1)- Protezione contro il Falso Profeta. Carissimo Gesù, salvaci dall inganno del Falso Profeta. Gesù, abbi pietà di noi. Gesù salvaci dalla persecuzione.
Litanie di Gesù Ecco la prima Litania di Gesù all Umanità (1)- Protezione contro il Falso Profeta. Carissimo Gesù, salvaci dall inganno del Falso Profeta. Gesù, abbi pietà di noi. Gesù salvaci dalla persecuzione.
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni. IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo
 Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo ISBN 978-88-250-4458-4 Copyright 2017 by P.P.F.M.C. MESSAGGERO DI SANT ANTONIO EDITRICE Basilica
Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo ISBN 978-88-250-4458-4 Copyright 2017 by P.P.F.M.C. MESSAGGERO DI SANT ANTONIO EDITRICE Basilica
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Serie: Alberi di Giustizia. L uomo nato di Nuovo-2 1
 Serie: Alberi di Giustizia L uomo nato di Nuovo-2 1 NATO DI SPIRITO 2 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico, che chi non nasce di acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:5
Serie: Alberi di Giustizia L uomo nato di Nuovo-2 1 NATO DI SPIRITO 2 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico, che chi non nasce di acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:5
Boezio e la teoria delle proporzioni. Calcidio e il commento al Timeo di Platone
 Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa. Divisione della vita in attiva e contemplativa
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
La S. MESSA (In rosso ci sono le risposte dell Assemblea)
 RITI DI INTRODUZIONE CANTO D'INGRESSO La S. MESSA (In rosso ci sono le risposte dell Assemblea) Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di
RITI DI INTRODUZIONE CANTO D'INGRESSO La S. MESSA (In rosso ci sono le risposte dell Assemblea) Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di
LITANIE MARIANE DOMENICANE. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi
 LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
LITANIE MARIANE DOMENICANE Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi Cristo, abbi pietà di noi Cristo, ascoltaci Cristo esaudiscici Padre celeste, Dio, abbi misericordia
Scala), capp. VII-VIII (lettera e allegoria)
 ITALIANO Dante, Epistole, XIII, vii vii [21] Per rendere ben comprensibili i le cose che si diranno occorre sapere che il senso di quest'opera non è unico, anzi può essere definito polisemo, ossia di più
ITALIANO Dante, Epistole, XIII, vii vii [21] Per rendere ben comprensibili i le cose che si diranno occorre sapere che il senso di quest'opera non è unico, anzi può essere definito polisemo, ossia di più
27 marzo 2016 Domenica di Pasqua
 27 marzo 2016 Domenica di Pasqua Nei cieli un grido risuonò, alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia! Morte di Croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia! Cristo ora è vivo in mezzo
27 marzo 2016 Domenica di Pasqua Nei cieli un grido risuonò, alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia! Morte di Croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia! Cristo ora è vivo in mezzo
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la
 Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
PREGHIERA EUCARISTICA III
 PREGHIERA EUCARISTICA III Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello
PREGHIERA EUCARISTICA III Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: CP Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello
BENEDETTO SPINOZA a cura di Pietro Gavagnin con il contributo degli alunni di 4AOL as
 BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
ESAME DI COSCIENZA. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore.
 ESAME DI COSCIENZA Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. V) Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. R) E rinnoverai la faccia della terra.
ESAME DI COSCIENZA Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. V) Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. R) E rinnoverai la faccia della terra.
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
LO SPIRITO E LA PAROLA
 LEZIONE 1 DELLA SCUOLA DEL SABATO LO SPIRITO E LA PAROLA 1 TRIMESTRE 2017 SABATO 7 GENNAIO 2017 Lo Spirito Santo è stato il motore e la genesi del processo di creazione della Parola scritta da Dio la Bibbia.
LEZIONE 1 DELLA SCUOLA DEL SABATO LO SPIRITO E LA PAROLA 1 TRIMESTRE 2017 SABATO 7 GENNAIO 2017 Lo Spirito Santo è stato il motore e la genesi del processo di creazione della Parola scritta da Dio la Bibbia.
LA RIFLESSIVITA' La Bibbia ci presenta spesso la persona riflessiva come saggia mentre quella che non lo è ce la presenta come stolta.
 LA RIFLESSIVITA' La riflessività è il dono che aiuta ad andare fino in fondo alle cose, a vedere oltre le apparenze. E' il dono della profondità contro la superficialità, dell'interiorità contro l'esteriorità.
LA RIFLESSIVITA' La riflessività è il dono che aiuta ad andare fino in fondo alle cose, a vedere oltre le apparenze. E' il dono della profondità contro la superficialità, dell'interiorità contro l'esteriorità.
Testo: 1 Corinzi 3:5-9 LUG 19 febbraio 2017 Tema: Ognuno di noi riceverà la ricompensa per il lavoro svolto
 Testo: 1 Corinzi 3:5-9 LUG 19 febbraio 2017 Tema: Ognuno di noi riceverà la ricompensa per il lavoro svolto 5 Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi avete creduto;
Testo: 1 Corinzi 3:5-9 LUG 19 febbraio 2017 Tema: Ognuno di noi riceverà la ricompensa per il lavoro svolto 5 Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi avete creduto;
I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
 PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 7 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Abbiamo sentito nella lettura di quel brano
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro - Mercoledì, 7 maggio 2014 I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Abbiamo sentito nella lettura di quel brano
SAN GIOVANNI XXIII, papa
 11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
11 ottobre SAN GIOVANNI XXIII, papa Dal Comune dei pastori: per un papa. COLLETTA Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il mondo l immagine viva di Cristo,
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Io sono con voi anno catechistico
 Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
Io sono con voi 7a unità Pag. 9-10 * Ti chiamo per nome Pag. 111-112 * Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Pag. 11-12 * Il Signore Dio è Padre di tutti Pag. 113-114 * Ci accoglie una grande famiglia:
La fisica. Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto)
 La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
Messaggio di Papa Francesco
 Messaggio di Papa Francesco Giobbe «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15). sapientia cordis Sapienza del cuore un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel
Messaggio di Papa Francesco Giobbe «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15). sapientia cordis Sapienza del cuore un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel
Ita per consolare essa-stessa scrisse a-lei per lettera la-sua benedizione e anche assolse essa Eng Esp Fra Por
 BENEDICTIO SANCTAE CLARAE ET EIUS SORORIBUS IN SCRIPTIS [A BEATO FRANCISCO] MISSA BENEDIZIONE A SANTA CHIARA E ALLE SUE SORELLE IN SCRITTI [DAL BEATO FRANCESCO] MESSA (Compilatio Assisiensis ) [FF1-2,
BENEDICTIO SANCTAE CLARAE ET EIUS SORORIBUS IN SCRIPTIS [A BEATO FRANCISCO] MISSA BENEDIZIONE A SANTA CHIARA E ALLE SUE SORELLE IN SCRITTI [DAL BEATO FRANCESCO] MESSA (Compilatio Assisiensis ) [FF1-2,
LITURGIA EUCARISTICA
 LITURGIA EUCARISTICA NELLA MESSA PRESENTIAMO NOI STESSI AL SIGNORE NEL SEGNO DEL PANE E DEL VINO Offertorio si portano all altare il pane e il vino che diventa il C... e il S.. di C che ci dona la sua
LITURGIA EUCARISTICA NELLA MESSA PRESENTIAMO NOI STESSI AL SIGNORE NEL SEGNO DEL PANE E DEL VINO Offertorio si portano all altare il pane e il vino che diventa il C... e il S.. di C che ci dona la sua
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa
 2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa Quando questa festa ricorre in domenica, si proclamano le tre letture qui indicate; se la festa ricorre in settimana, si sceglie come prima lettura una delle
2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Festa Quando questa festa ricorre in domenica, si proclamano le tre letture qui indicate; se la festa ricorre in settimana, si sceglie come prima lettura una delle
PER LA LITURGIA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO
 TRIDUO PASQUALE Veglia di Pasqua CANTI PER LA LITURGIA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO BRESCIA VEGLIA PASQUALE PROCESSIONE DEL CERO PRECONIO PASQUALE VEGLIA PASQUALE 3 4 PARROCCHIA DI S. SILVESTRO
TRIDUO PASQUALE Veglia di Pasqua CANTI PER LA LITURGIA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO BRESCIA VEGLIA PASQUALE PROCESSIONE DEL CERO PRECONIO PASQUALE VEGLIA PASQUALE 3 4 PARROCCHIA DI S. SILVESTRO
25 Dicembre -Natale del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. e il Verbo era Dio.
 25 Dicembre -Natale del Signore Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per
25 Dicembre -Natale del Signore Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per
Gesù è l'alfa e l'omega.
 Domenica, 29 aprile 2012 Gesù è l'alfa e l'omega. Atti 17:28- In lui viviamo, ci muoviamo, e siamo. Tutto quello che riguarda la vita, tutto quello che facciamo o che siamo, Gesù è il centro, solamente
Domenica, 29 aprile 2012 Gesù è l'alfa e l'omega. Atti 17:28- In lui viviamo, ci muoviamo, e siamo. Tutto quello che riguarda la vita, tutto quello che facciamo o che siamo, Gesù è il centro, solamente
RICEVI LO SPIRITO SANTO
 RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
RICEVI LO SPIRITO SANTO SONO DIVENTATO GRANDE... DECIDO DI ESSERE AMICO DI GESÚ FOTO PER DECIDERE DEVO CONOSCERE CONOSCO LA STORIA DI GESÚ: GESÚ E NATO E DIVENTATO GRANDE ED AIUTAVA IL PAPA GIUSEPPE E
A cura di Chiesacattolica.it e LaChiesa.it
 V DOMENICA PRIMA LETTURA Eccomi, manda me! Dal libro del profeta Isaìa 6, 1-2a.3-8 Nell anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano
V DOMENICA PRIMA LETTURA Eccomi, manda me! Dal libro del profeta Isaìa 6, 1-2a.3-8 Nell anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano
45, Nuova Serie gennaio-giugno 2015 anno LVI L ALIGHIERI. Rassegna dantesca. Direttori: Saverio Bellomo, Stefano Carrai, Giuseppe Ledda
 45, Nuova Serie gennaio-giugno 2015 anno LVI L ALIGHIERI Rassegna dantesca Direttori: Saverio Bellomo, Stefano Carrai, Giuseppe Ledda Angelo Longo Editore Ravenna «L Alighieri» Rassegna dantesca 45 - Nuova
45, Nuova Serie gennaio-giugno 2015 anno LVI L ALIGHIERI Rassegna dantesca Direttori: Saverio Bellomo, Stefano Carrai, Giuseppe Ledda Angelo Longo Editore Ravenna «L Alighieri» Rassegna dantesca 45 - Nuova
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo. Il fine ultimo dell'uomo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
QUANDO PREGATE Il Padre Nostro
 IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO QUANDO PREGATE Il Padre Nostro Domenica 13 Dicembre 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30
IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO QUANDO PREGATE Il Padre Nostro Domenica 13 Dicembre 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30
RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI
 RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI 41. Quando il penitente si presenta per fare la sua confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali. 42. Quindi
RITO PER LA RICONCILIAZIONE DEI SINGOLI PENITENTI 41. Quando il penitente si presenta per fare la sua confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali. 42. Quindi
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno
 Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva
 TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ
 Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SECONDA UNITÀ Dio Padre è sempre con noi Non siamo mai soli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Nella fatica sei con noi, Signore Leggi il catechismo
I canti del Messale Ambrosiano. Comune dei santi
 IX Giornata Diocesana per Responsabili dei Gruppi Liturgici 6/11/2010 I canti del Messale Ambrosiano. Comune dei santi All ingresso (Cantemus Domino 372) Don Cesare Pavesi Hanno fondato e amato la Chiesa
IX Giornata Diocesana per Responsabili dei Gruppi Liturgici 6/11/2010 I canti del Messale Ambrosiano. Comune dei santi All ingresso (Cantemus Domino 372) Don Cesare Pavesi Hanno fondato e amato la Chiesa
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
AVE, GRATIA PLENA! CONOSCERE E FAR CONOSCERE. Ave, gratia plena! Salve, o Regina!
 TESTI DEI CANTI AVE, GRATIA PLENA! Ave, gratia plena! Salve, o Regina! Freddi come il ghiaccio sono per te i cuori di noi, miseri figli di Adamo. Non c è trono umano che possa esser degno di te, tanto
TESTI DEI CANTI AVE, GRATIA PLENA! Ave, gratia plena! Salve, o Regina! Freddi come il ghiaccio sono per te i cuori di noi, miseri figli di Adamo. Non c è trono umano che possa esser degno di te, tanto
La Bibbia. "Ogni Scrittura è ispirata da Dio" (2 Lettera di Paolo a Timoteo 3:16)
 La Bibbia cos'è, come legger/a "Ogni Scrittura è ispirata da Dio" (2 Lettera di Paolo a Timoteo 3:16) Se tu possiedi una Bibbia, possiedi un tesoro inestimabile. E' la Parola di Dio. Una Parola scritta
La Bibbia cos'è, come legger/a "Ogni Scrittura è ispirata da Dio" (2 Lettera di Paolo a Timoteo 3:16) Se tu possiedi una Bibbia, possiedi un tesoro inestimabile. E' la Parola di Dio. Una Parola scritta
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
E.G.W. (Historia de la Redención, cap. 3, p 26)
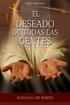 LEZIONE 2 DELLA SCUOLA DEL SABATO CRISI COSMICA: LA FRANTUMAZIONE DELL ORDINE PER SABATO 11 OTTOBRE 2008 Fu un essere creato Era il sigillo della perfezione Pieno di saggezza Pieno di bellezza Vestito
LEZIONE 2 DELLA SCUOLA DEL SABATO CRISI COSMICA: LA FRANTUMAZIONE DELL ORDINE PER SABATO 11 OTTOBRE 2008 Fu un essere creato Era il sigillo della perfezione Pieno di saggezza Pieno di bellezza Vestito
Prima settimana di Quaresima
 Prima settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù disse loro: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra,
Prima settimana di Quaresima Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù disse loro: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra,
Le nostre preghiere. Questa Corona è formata da 33 grani divisi in tre gruppi di undici.
 Le nostre preghiere CORONA DEL DISCEPOLO Questa Corona è formata da 33 grani divisi in tre gruppi di undici. Dopo la crociera ci sono ancora tre grani e termina con un a Medaglia di tre Cuori. Iniziando
Le nostre preghiere CORONA DEL DISCEPOLO Questa Corona è formata da 33 grani divisi in tre gruppi di undici. Dopo la crociera ci sono ancora tre grani e termina con un a Medaglia di tre Cuori. Iniziando
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana
 9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
9 novembre 2014 Cristo Re Giornata Caritas ambrosiana 18.00 10.00 (Messa vigiliare del sabato: la voce guida prima che inizia la processione all altare) Chiamati anche oggi da Gesù per celebrare il suo
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae
 Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
PREGHIERA DEL MATTINO
 PREGHIERA DEL MATTINO Segno della Croce Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Ti adoro 1 / 7 Ti adoro o mio Dio, Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
PREGHIERA DEL MATTINO Segno della Croce Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Ti adoro 1 / 7 Ti adoro o mio Dio, Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
Etimologia della parola ANTROPOLOGIA
 Etimologia della parola ANTROPOLOGIA Deriva dal greco Ανθρωπολογία, composto da άνθρωπος, ànthropos = "uomo" e λόγος, lògos = nel senso di "studio") è la scienza che studia l'uomo dal punto di vista sociale,
Etimologia della parola ANTROPOLOGIA Deriva dal greco Ανθρωπολογία, composto da άνθρωπος, ànthropos = "uomo" e λόγος, lògos = nel senso di "studio") è la scienza che studia l'uomo dal punto di vista sociale,
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora
 CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELLA PASQUA lezionario festivo anno C Sabato 16 febbraio 2013,
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELLA PASQUA lezionario festivo anno C Sabato 16 febbraio 2013,
il commento al vangelo
 il commento al vangelo SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO commento al Vangelo della quinta domenica di quaresima (22 marzo 2015) di p. Alberto Maggi: Gv 12,20-33 In quel
il commento al vangelo SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO commento al Vangelo della quinta domenica di quaresima (22 marzo 2015) di p. Alberto Maggi: Gv 12,20-33 In quel
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
AGGETTIVI PER DESCRIVERE DIO?
 AGGETTIVI PER DESCRIVERE DIO? AGGETTIVI PER DESCRIVERE DIO Amorevole Giusto Paziente Misericordioso Geloso Egoista Santo Fedele Buono Saggio UN DIO EGOISTA DEFINIZIONE DI EGOISMO Atteggiamento di chi si
AGGETTIVI PER DESCRIVERE DIO? AGGETTIVI PER DESCRIVERE DIO Amorevole Giusto Paziente Misericordioso Geloso Egoista Santo Fedele Buono Saggio UN DIO EGOISTA DEFINIZIONE DI EGOISMO Atteggiamento di chi si
ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione,
 ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, io dirigo il traffico da qui; non sapete quanto è meraviglioso saper aiutare da qui. Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione, dove vivo
ha tanto da fare qui come ha avuto tanto da fare là, io dirigo il traffico da qui; non sapete quanto è meraviglioso saper aiutare da qui. Perché voi lo state facendo nella vostra dimensione, dove vivo
Cavarzere 28 Ottobre Mistero: La Risurrezione di Gesù
 Cavarzere 28 Ottobre 2012 1 Mistero: La Risurrezione di Gesù O Gesù, la tua morte in croce è sembrata a tanti un fallimento. Ed invece questa apparente sconfitta è stata l inizio della tua vittoria che
Cavarzere 28 Ottobre 2012 1 Mistero: La Risurrezione di Gesù O Gesù, la tua morte in croce è sembrata a tanti un fallimento. Ed invece questa apparente sconfitta è stata l inizio della tua vittoria che
Parrocchia San Marcello, Bari - Servizio della Parola. 27 marzo 2011
 27 marzo 2011 III DOMENICA DI QUARESIMA PRIMA LETTURA Dacci acqua da bere. Dal libro dell Èsodo 17, 3-7 In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e
27 marzo 2011 III DOMENICA DI QUARESIMA PRIMA LETTURA Dacci acqua da bere. Dal libro dell Èsodo 17, 3-7 In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e
Leonardo Messinese. L apparire di Dio. Per una metafisica teologica. Edizioni ETS
 Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
PRESUNZIONE DELL UOMO
 CHIEDI A DIO PRESUNZIONE DELL UOMO 1 SAMUELE 16:7 Ma il SIGNORE disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato; infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce
CHIEDI A DIO PRESUNZIONE DELL UOMO 1 SAMUELE 16:7 Ma il SIGNORE disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato; infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
Scongiurare un pericolo
 http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
http://italianosemplicemente.com/ Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente Scongiurare un pericolo Buongiorno amici. Buona giornata a tutti gli amici di Italiano Semplicemente. Oggi per la sezione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi
 avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di Voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra (At 1,8) Furono queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della Sua Ascensione
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
 OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
OMELIA SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI Nel Vangelo di Matteo Gesù agli inizi della sua attività pubblica vuole far conoscere a coloro che lo ascoltano che cosa vuole donare all umanità. Quello che abbiamo
DOMENICA DI PENTECOSTE Alla Messa del giorno
 DOMENICA DI PENTECOSTE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all
DOMENICA DI PENTECOSTE Alla Messa del giorno PRIMA LETTURA Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all
Ordinario della Messa
 www.cantoeprego.it Canti per la Liturgia Ordinario della Messa Domenica 31 Luglio 2011 id_2012 v01.02 ord Indice 0401.11 Alleluia (Taize')... 1 0071.11 Gloria (Frisina) 1... 2 0400.11 Gloria (Lecot)...
www.cantoeprego.it Canti per la Liturgia Ordinario della Messa Domenica 31 Luglio 2011 id_2012 v01.02 ord Indice 0401.11 Alleluia (Taize')... 1 0071.11 Gloria (Frisina) 1... 2 0400.11 Gloria (Lecot)...
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora
 CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELL INCARNAZIONE E DELLA PASQUA lezionario festivo anno A Domenica
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELL INCARNAZIONE E DELLA PASQUA lezionario festivo anno A Domenica
DELLA SCUOLA DEL SABATO
 LEZIONE 14 DELLA SCUOLA DEL SABATO VANTARSI NELLA CROCE 3 TRIMESTRE 2017 SABATO 30 SETTEMBRE 2017 L addio finale di Paolo, in realtà è l ultimo appello ai galati. Paolo, come un pastore preoccupato del
LEZIONE 14 DELLA SCUOLA DEL SABATO VANTARSI NELLA CROCE 3 TRIMESTRE 2017 SABATO 30 SETTEMBRE 2017 L addio finale di Paolo, in realtà è l ultimo appello ai galati. Paolo, come un pastore preoccupato del
Veniva nel mondo la luce vera
 IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO Veniva nel mondo la luce vera Domenica 14 Dicembre 2014 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30
IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO Veniva nel mondo la luce vera Domenica 14 Dicembre 2014 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30
CONSIGLIO. consigliare ed ascoltare col cuore
 CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. nel giorno in cui lo invocavo.
 SALMO 116 (CEI 2008) 1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 2 Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 3 Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli
SALMO 116 (CEI 2008) 1 Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 2 Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 3 Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli
Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia. Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto
 Amen. Maranathà! Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia a cura di: Franco Gomiero Paola Talamini 2008 - by Casa Musicale Edizioni
Amen. Maranathà! Patriarcato di Venezia Ufficio Liturgico Sezione Musica e Canto Amen. Maranathà! Repertorio di Canti per la Liturgia a cura di: Franco Gomiero Paola Talamini 2008 - by Casa Musicale Edizioni
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora
 CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELLA PASQUA lezionario festivo anno B Sabato 21 febbraio 2015,
CANTI PROPOSTI SU CELEBRIAMO LA DOMENICA, foglietto ad uso delle comunità ambrosiane per le celebrazioni festive editrice Ancora MISTERO DELLA PASQUA lezionario festivo anno B Sabato 21 febbraio 2015,
ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio
 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito
 INCONTRO UNITARIO NELLA FEDE Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito Domenica 14 giugno 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA - ZONA MILANO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 17.00 Introduzione
INCONTRO UNITARIO NELLA FEDE Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito Domenica 14 giugno 2015 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA - ZONA MILANO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 17.00 Introduzione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio. L'amore di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica
 Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE.
 PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
