LE VORE DI BARBARANO: NOTE DESCRITTIVE E SPELEOGENESI
|
|
|
- Antonella Costanzo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LEONARDO BECCARISI, GIANNI CACCIATORE, LEONARDO CHIRIACÒ, MARCO DELLE ROSE, FRANCESCO GIURI, VITTORIO MARRAS, GIANFRANCO QUARTA, FERNANDO RESTA, PAOLO SOLOMBRINO Gruppo Speleologico Neretino, p.zza Mercato 13, Nardò (Lecce). LE VORE DI BARBARANO: NOTE DESCRITTIVE E SPELEOGENESI RIASSUNTO Le Vore di Barbarano sono due delle più ampie cavità carsiche, a prevalente sviluppo verticale, del Salento. Esse risultano morfologicamente più complesse di altre cavità analoghe, quali le Vore di Spedicaturo e le Grotte della Poesia. Le osservazioni speleologiche, geomorfologiche, stratigrafiche, idrogeologiche e biologiche, permettono di individuare i meccanismi speleogenetici all'origine delle vore. Sono state così individuate le fasi evolutive dalla formazione delle protogrotte sino alle aperture degli accessi. SUMMARY In the Salento peninsula several karst systems of mainly vertical cave are present. These caves are locally called "Vore" and can be described like collapse dolines (with the depth usually higher than the base diameter) or solution chimney due to developments of drain system in closed depressions. The Vore di Barbarano ( Vora Piccola and Vora Grande ) are two of the biggest vertical caves of the Salento peninsula, about 35 and 25 m deep. Although they show some similarities with other dolines of the Salento, they are morphologically more complex, being formed by two superimposed chambers. The entries are sub-elliptical, irregular due to rockfalls and anthropic activity of quarry. The spelaelogical, geomorphological, stratigraphic, hydrogeological and biological observations carried out in the studied area may give us information about the spelaegenetic mechanism causing karst systems evolution. This survey suggests a evolutionary hypothesis which may be described through the following steps: identification of the basal karst level; formation of the early caves; evolution of the bottom chambers towards the tension dome shape; formation of the upper chambers caused by vault collapses of the lower chambers; evolution of the upper chambers; opening of the sinkholes. INTRODUZIONE Le vore di Barbarano (Morciano di Leuca, LE) costituiscono due delle maggiori cavità carsiche a prevalente sviluppo verticale del Salento. Esse sono inserite nel Catasto Regionale delle Grotte (GIULIANI, 2000) come Pu 114 (Vora Grande) e Pu 115 (Vora Piccola). Con il termine locale vora vengono indicate numerose cavità carsiche sia di origine ipogea con accesso principale verticale (doline di crollo) che inghiottitoi generati da infiltrazioni nel sottosuolo di acque superficiali; in qualche raro caso il termine è usato anche per grotte marine, come per Grotta delle Vore (Pu 136) nel territorio di Gagliano del Capo. Le vore sono, talvolta, raggruppate in sistemi come quelle di Spedicaturo (Pu 192, Pu 1557, Pu 1558 e Pu 1559), delle Grotte della Poesia di Roca Vecchia (Pu 127 e Pu 128), di
2 Supersano ( La Ora, Pu 188 e Lu Fau ) e degli inghiottitoi di Salice Salentino. Le vore di Barbarano si aprono a poche centinaia di metri dal Santuario di Leuca Piccola, storico luogo di ristoro per i pellegrini diretti a Madonna di Leuca. Nelle cronache dei pellegrinaggi, piuttosto scarse, non vi sarebbe alcun riferimento agli ipogei. La più antica citazione bibliografica delle Vore è del frate Luigi Tasselli (1693), che le descrive come un luogo caratteristico e le classifica come fenomeno carsico. Giacomo Arditi (1878) ne fa solo menzione. Moscardino (1957) riporta le presenza di meati sul fondo e segnala ritrovamenti di manufatti silicei e di resti di Bos primigenius e Cervus elaphus. Il primo rilevamento topografico è del 1967, a cura del Gruppo Speleologico Modenese. Il Gruppo Speleologico Neretino ha esplorato e rilevato a più riprese le vore di Barbarano a partire dal 1974, utilizzando inizialmente scalette in acciaio e in seguito le attuali tecniche di progressione su corda. Fig. 1 - Carta geologica e sezione stratigrafica misurata nelle vore
3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL AREA Barbarano è ubicato nel pianoro compreso tra i rilievi delle serre di Morciano (Serre Falitte) e di Montesardo (Fig. 1). La morfologia del territorio rispecchia lo stile tettonico del substrato geologico del Salento ad alti e bassi strutturali separati da faglie ad alto angolo (MART I N I S, 1970; DELLE ROSE, 2001). Il basso strutturale in cui è ubicato Barbarano prosegue verso N, sin oltre Taurisano e, verso S, sino a Leuca, per una estensione complessiva in pianta di oltre 20 km. In esso si aprono anche altre cavità carsiche, quali la Vora nel fondo Lame ad A c q u a r i c a del Capo (Pu 181), utilizzata per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque di pioggia insistenti sull abitato (DELLE ROSE, 1992) e la Vora di Serra Pozzo Mauro a Presicce (Pu 182). Il paesaggio naturale e l idrografia superficiale sono, in massima parte, modificate dalle attività agricole; le vaschette di corrosione rappresentano le forme di superficie più frequenti. Le vore risultano ubicate in corrispondenza dell impluvio del pianoro. Le rocce carbonatiche affioranti nel pianoro sono riferite nel foglio 223 della Carta Geologica d Italia, a scala 1: , alle Calcareniti del Salento e indicate come Fig. 2 - Sezioni topografico-geologiche e planimetrie delle Vore di Barbarano
4 direttamente sovrapposte ai Calcari di Melissano del Cretaceo. In realtà, la situazione stratigrafica è più complessa benché non ricostruibile mancando adeguati studi. E opportuno ricordare che nell adiacente e più meridionale zona di Castrignano-Leuca, BOSSIO et al. (1987) hanno dimostrato la presenza di varie unità stratigrafiche del Pliocene e del Miocene, mentre verso N, a Presicce e Acquarica, è accertata la presenza di un unità prevalentemente pelitica riconducibile alle Argille Subappennine (MARTINIS, 1970). L interposizione di tali unità tra le Calcareniti del Salento e i Calcari del Cretaceo, in ispecie quelle di età miocenica anche in considerazioni con la vicinanza con il depocentro di Leuca (DELLE ROSE, 2001), si può ritenere quantomeno probabile anche nella zona di Barbarano. Peraltro non si può escludere neanche la presenza di unità riferibili al Paleogene, unità cronostratigrafica la cui estensione e presenza nel Salento è stata recentemente rivista da vari Autori con non poche novità rispetto al regresso stato delle conoscenze (BOSSIO et al., 1998). Sulla base di osservazioni dirette eseguite lungo le pareti delle vore, è stata ricostruita la colonna stratigrafica per uno spessore di circa 35 m. Gli strati, costituiti prevalentemente da frammenti di fossili, possono essere raggruppati in quattro livelli in base al differente grado di cementazione (Fig. 1). Il livello superiore, spesso 4,5 m, è intensamente sfruttato per estrazione di pietra da costruzione come testimoniano le numerose antiche cave della zona, utilizzate sino all inizio del XX secolo. I livelli intermedi di sabbie parzialmente litificate coincidono con le camere superiori delle vore, mentre il più profondo livello calcarenitico con le camere inferiori (Fig. 2). Le calcareniti risultano interessate da un moderato stato di fratturazione; le fratture tettoniche osservate hanno andamento subverticale e spaziature di alcuni metri. Le sabbie parzialmente litificate contengono una falda superficiale sostenuta dal livello di calcareniti ben cementate, la profondità della superficie freatica della quale, come rilevato nei pozzi circostanti, è di circa 20 m con cadente piezometrica verso i quadranti meridionali. Analisi chimiche e microbiologiche su alcuni campioni di acqua prelevati nel febbraio 2001 da pozzi superficiali circostanti, non hanno evidenziato forme di inquinamento di tipo organico. A Barbarano, una seconda falda si rinviene a circa 110 m dal piano campagna (CALÒ et al., 1990) e costituisce un livello idrico distinto dalla falda carsica profonda di estensione regionale, la cui superficie piezometrica è ubicata, in base al principio di DuCommon- Ghyben-Herberg, a circa 130 m di profondità. DESCRIZIONE NATURALISTICADELLE CAVITA Attualmente la Vora Grande è profonda circa 35 m, mentre la Vora Piccola circa 25 m (Fig. 2). Entrambe hanno ampi accessi subellittici (diametri di 20 e 15 m circa), resi irregolari da crolli perimetrali e dall attività estrattiva di pietre da costruzione, e sono formate da due camere sovrapposte. Le camere superiori, profonde circa 20 m, hanno forma cilindrica; quelle inferiori hanno forma conica rovesciata irregolare, raggiungendo sviluppi delle superfici di base di quasi 1000 (Vora Grande) e 250 (Vora Piccola) m 2. Lungo le pareti delle camere superiori sono presenti varie condotte e cavità di interstrato incise sino a circa 5 m, alcune delle quali formano ampie cengie. Due di queste, una per ciascuna vora, sono raggiungibili per mezzo di passaggi artificiali scavati nella roccia. Sul lato N della camera superiore della Vora Grande sono ben evidenti cupole di corrosione per condensa. In corrispondenza del passaggio tra le camere superiori e quelle inferiori si osservano, specie all interno della Vora Grande, concrezioni stalattidiche, oltre che una fitta vegetazione igrofila e un intenso stillicio perenne, effetto del drenaggio della falda
5 superficiale. Il fondo delle cavità è formato da coni detritici di notevole potenza, in parte naturali e in parte di origine antropica, su cui si osservano sottili e discontinui depositi calcitici. MARTINIS (1970) indica profondità di circa 35 m per Vora Piccola e di 45 m per Vora Grande, segnalando la presenza di un cunicolo nella parete S di quest ultima. Tuttavia, le pareti delle camere inferiori delle vore sono quasi del tutto prive di irregolarità e, nonostante assidue ricerche, non sono stati individuati cunicoli praticabili. Occorre segnalare la mancanza di significative differenze metriche e morfologiche rispetto ai rilevamenti eseguiti dal Gruppo Spleleologico Modenese nel Sulla base di misurazioni occasionali svolte nel biennio è stato effettuato un preliminare inquadramento microclimatico-ambientale delle due vore. Nella Vora Grande, lungo la sua perpendicolare, sono evidenti tre gradienti ambientali relativi a luce, temperatura ed umidità. L irraggiamento diretto sul fondo della voragine avviene solo nel settore settentrionale durante la fase di azimut solare; la zona restante interna della cavità rimane perennemente nelle condizioni di ombra. Il gradiente termico dall esterno all interno varia stagionalmente in relazione alle variazioni climatiche esterne, dato che la temperatura ipogea oscilla di poco e con maggiore inerzia rispetto a quella esterna, intorno a valori di C. Anche l umidità relativa è pressoché costante nella zona profonda della cavità, essendo stati qui registrati valori compresi tra 65 e 75%. Il cono detritico è estesamente colonizzato da una flora sciafila ed igrofila che annovera la lingua di cervo (Asplenium scolopendrium) e una briofita del genere Mnium, entrambi elementi aventi il loro massimo di diffusione nel piano montano e submontano (GIACOMINI, 1943) e che nel Salento sono confinati esclusivamente negli ambienti di grotta (BECCARISI et al., 2001). Tra le altre crittogame sono stati individuati un ascomicete del gen. Scutellinia ed alcuni basidiomiceti (Agaricales s. l.). Le pareti della voragine sono colonizzate da Adiantum capillus-veneris, Anogramma leptophylla, Hedera helix e Ficus carica, tra cui si inseriscono, in misura maggiore procedendo verso l esterno, elementi sempre più xerofili sino a costituire la gariga di macchia mediterranea che circoscrive strettamente l ingresso della cavità (MEDAGLI, 1989). Il territorio circostante è adibito a colture, soprattutto oliveti, o è incolto. Le osservazioni zoologiche si limitano ad alcuni esemplari di rospo (Bufo bufo), ed al passero (Passer domesticus) che colonizza gli anfratti lungo le pareti. La Vora Piccola ha caratteristiche biologiche e ecologiche pressoché analoghe a quelle della Vora Grande ma, data la minore profondità, le variazioni ambientali e vegetazionali tra il piano campagna e la zona sub-liminare della cavità sono di minore entità. Attualmente, le camere superiori e il bordo degli accessi sono piuttosto instabili e, non di rado, si manifestano eventi di crollo. Particolarmente instabili risultano gli ammassi posti al di sopra delle cavità di interstrato più ampie. L ultimo importante fenomeno gravitativo, verificatosi tra aprile e maggio 2000, ha comportato il distacco di un blocco di alcune decine di metri cubi dalla parete orientale della camera superiore di Vora Grande. IPOTESI SPELEOGENETICA I sistemi di vore del Salento hanno differenti origini ed evoluzioni. Ad esempio, mentre quello di Spedicaturo si è sviluppato da un livello carsico di base coincidente con una falda superficiale (BECCARISI et al., 1999), quello di Supersano presenta caratteristiche di sistemi drenanti acque superficiali che fanno supporre un origine epigea. Inoltre è variabile anche il rapporto tra i sistemi di vore e le strutture tettoniche. Così, mentre i sistemi di Spedicaturo e di Supersano appaiono intimamente legati a importanti sistemi di faglie, quelli di Roca Vecchia e di Salice, sembrano non avere relazioni dirette con
6 Fig. 3 - Sezione topografico-geologica e planimetria della Vora nel fondo Lame di Acquarica del Capo. strutture tettoniche principali. A questa seconda tipologia sembrano appartenere anche le vore di Barbarano, distando centinaia di m dai bordi del basso strutturale. Analoga posizione occupa la Vora nel fondo Lame di Acquarica, che si apre in una successione stratigrafica simile a quella di Barbarano, mentre differente è il tipo di accesso o collegamento con l esterno (Fig. 3). Di essa si conosce il substrato al di sotto del conoide di detrito, costituito da depositi limoso-sabbiosi che sorreggono una falda idrica a cui può essere riferita la speleogenesi della vora stessa (origine ipogea). Anche per le vore di Barbarano, benché ubicate lungo l asse di impluvio del pianoro e drenanti significative quantità d acqua in occasione dei principali eventi meteorici, l origine ipogea appare più probabile di quella epigea che in ogni caso potrebbe spiegare, al più, solo la formazione delle camere superiori. Infatti la forma cilindrica di queste ultime, simile a quella di alcuni condotti o pozzi carsici verticali ( vertical shaft ) può far pensare una genesi dovuta a infiltrazione di lame d acqua in rapido movimento (POHL, 1955; WHITE, 1988). Con questa ipotesi, le camere superiori avrebbero poi intersecato quelle inferiori, evolutesi indipendentemente. Tale coincidenza richiederebbe, comunque, elementi tettonici di controllo sia della circolazione superficiale che di quella sotterranea non presenti a Barbarano. Le vore di Barbarano si differenziano, comunque, dagli altri sistemi di vore proprio perché formate da più camere sovrapposte, a testimonianza di condizioni speleogenetiche complesse e articolate. L ipotesi ipogea richiede un livello carsico di base che può coincidere con un livello impermeabile o poco permeabile della serie stratigrafica ( controllo stratigrafico ) oppure
7 con una falda d acqua sostenuta da acqua di mare di invasione continentale ( controllo idrogeologico di acquifero costiero). Nel primo caso, essendo, come già ricordato, poco conosciuta la stratigrafia del sito, l individuazione del livello carsico di base relativo alle vore permane un incognita. Esso potrebbe essere rappresentato da livelli poco permeabili di età pliocenica, miocenica o oligocenica, a profondità compresa tra 35 e 110 m. Nel caso di controllo idrogeologico di acquifero costiero, il livello carsico di base sarebbe stato determinato dagli stazionamenti del mare durante la regressione pleistocenica, a cui è riconducibile anche l evoluzione di alcuni sistemi carsici a prevalente sviluppo orizzontale delle Serre Salentine (DELLE ROSE et al., 1998). Sulla base delle caratteristiche delle vore di Barbarano e delle precedenti considerazioni è possibile tracciare un ipotesi evolutiva articolata in differenti fasi. Nello stadio iniziale, precedente alla formazione delle cavità, si ha l individuazione del livello carsico di base ad una profondità presumibilmente compresa tra 10 e 20 m dall attuale fondo. Nel caso di controllo stratigrafico, è supponibile la presenza, in analogia con la Vora di Acquarica, di un livello poco permeabile. In questa fase, nella falda, la circolazione doveva avvenire ancora in modo diffuso ( diffuse flow aquifer di WHITE, 1988). Successivamente, in accordo con la watertable cave theory (FORD, 1977), in corrispondenza di un livello di base si allargavano progressivamente vari cunicoli (Fig. 4A). La presenza di fratture nella roccia favoriva parziali crolli di alcuni tratti dei cunicoli stessi, Fig. 4 - Ipotesi speleogenetica delle Vore di Barbarano
8 che permettevano l individuazione delle protogrotte (sensu FORD, 1988). A questo punto il sistema carsico in via di formazione doveva avere caratteristiche tali da modificare la circolazione idrica verso il tipo conduit aquifer (WHITE, 1988), ossia verso prevalenza di circolazione nelle condotte carsiche. Nello stadio successivo, l ampliamento della base delle protogrotte per processi chimici ed erosivi, determinava ulteriori crolli delle pareti, con il risultato di aumentare l altezza degli ipogei (Fig. 4B). Nel complesso le cavità tendevano ad assumere profili sempre più prossimi alla zona di massimo stress per taglio ( tension dome di WHITE, 1988), con geometrie imposte dalle caratteristiche geomeccaniche della roccia e dal tipo di circolazione idrica. Quest ultima, in ogni caso, doveva essere tale da garantire l evacuazione dei detriti di crollo. Dalle volte, probabilmente, si iniziava a manifestarsi uno stillicidio d acqua con formazione di concrezioni stalattitiche. Un ulteriore evoluzione delle cavità determinò, quindi, l intersezione della tension dome delle camere inferiori con la base del livello meno coerente di sabbie parzialmente litificate. Questi eventi critici modificarono sostanzialmente le condizioni di equilibrio degli ipogei. Le scadenti qualità geomeccaniche degli strati dovettero causare, infatti, accentuati crolli nelle zone apicali delle volte. La falda superficiale venne così drenata copiosamente dalle cavità e il flusso idrico intensificò l entità dei crolli. Il concrezionamento fu maggiore che in precedenza, ed interessò la zona di passaggio tra le preesistenti camere inferiori e quelle superiori in via di formazione. L ampliamento delle camere superiori fu dovuto principalmente a crolli e, subordinatamente, a corrosione inversa delle volte per dissoluzione operata dalla condensazione di vapori (Fig. 4C). Man mano che le camere superiori evolvevano verso la configurazione di tension dome, i crolli si attenuavano in dimensioni e frequenza. L intersezione della zona di massimo sforzo di taglio delle camere superiori con il livello stratigrafico superiore di calcareniti ben cementate, comportò nuove condizioni di equilibrio. Infatti le calcareniti ben cementate, compatte e sufficientemente spesse, costituivano volte piuttosto stabili (Fig. 4D). Una prova diretta di ciò è dagli ipogei artificiali di Leuca Piccola, posti a poche centinaia di m dalle vore e ricavati nelle calcareniti ben cementate, il più ampio dei quali, di forma ellittica, ha un altezza di 2,5 m e asse maggiore di circa 15 m. Inoltre le tracce dell intensa attività estrattiva a ridosso delle vore e, in particolare, la presenza di un fronte di cava di circa 5 m lungo il perimetro dell accesso di Vora Grande (Fig. 2) fanno ipotizzare che, al tempo dell attività di cava, gli accessi alle vore dovevano mancare o, al più, avere dimensioni ridotte. E opportuno inoltre precisare che è possibile formulare anche una differente ipotesi ipogea, più conforme all usuale concetto di approfondimento del livello carsico di base, che implicherebbe, quindi, un evoluzione della camera superiore precedente a quella della camera inferiore. Tali ipotesi richiede, tuttavia, il sostegno di morfologie vadose, tipiche dell approfondimento dei livelli varsici, che a Barbarano non sono presenti. CONCLUSIONI L evoluzione speleogenetica delle Vore di Barbarano può essere schematicamente descritta attraverso le seguenti fasi: individuazione del livello carsico di base e formazione delle protogrotte delle camere inferiori; ampliamento di queste ultime secondo profili sempre più prossimi alla zona di massimo stress per taglio ( tension dome ); formazione delle camere superiori, innescate da crolli delle volte delle camere inferiori, e loro evoluzione; apertura degli accessi. Coerentemente con tale ipotesi, quest ultima fase appare legata all attività di estrazione di
9 pietra da costruzione. La datazione di questa attività permetterebbe, quindi, di individuare cronologicamente sia l inizio della colonizzazione vegetale che quello della fruizione antropica delle vore. RINGRAZIAMENTI Antonio Renzo, presidente della Pro Loco di Morciano di Leuca, per la sua costante opera di valorizzazione ambientale e culturale delle Vore e per l amicizia dimostrataci. Antonio Alfarano, geologo, per le informazioni sulla stratigrafia e la forma della Vora nel fondo Lame di Acquarica del Capo. Infine tutti i soci e i corsisti del G.S.N. che hanno partecipato alle esplorazioni. BIBLIOGRAFIA ARDITI G., Corografia fisica e storica della provincia della provincia di Lecce (ristampa anastatica, 1994), Quotidiano di Lecce ed., pp BECCARISI L., CHIRIACÒ L., DELLE ROSE M., Il sistema carsico Vore Spedicaturo. Itinerari speleologici, 8, BECCARISI L., CHIRIACÒ L., MARCHIORI S., MEDAGLI P., 2001 Felci (Filicopsida) spontanee del Salento. Informatore Botanico Italiano, 33(2), BOSSIO A., MAZZEI R., MONTEFORTI B., SALVATORINI G., 1987 Studi sul Neogene e Quaternario della Penisola Salentina: II Evoluzione paleogeografica dell area di Leuca nel contesto della dinamica mediterranea. Quad. Ric. Cent. Studi Geot. Ing., 11, BO S S I O A., ES U D., FO R E S I L.M., GI R O T T I O., IA N N O N E A., LU P E RTO E., MA R G I O T TA S., MA Z Z E I R., MO N T E F O RT I B., RI C C H E T T I G., SA LVATO R I N I G., Formazione di Galatone, nuovo nome per un unità litostratigrafica del Salento (Puglia, Italia meridionale). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, 105, CALÒ G., GNONI R. E STANI M., 1990 Caratteri idrogeologici delle falde superficiali della Penisola Salentina e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. Amministrazione provinciale di Lecce, 31 pp. DELLE ROSE M., 1992 Il rischio geologico nel Salento: 3) Acquarica del Capo, un esempio di interazione uomo-natura. Il Leccio, 9-12, DELLE ROSE M., Salento Miocene: a preliminary paleoenvironmental reconstruction. Thalassia Salentina, 25, DELLE ROSE M., FEDERICO A., S IMEONE V., Carsismo e salvaguardia del territorio nell area delle Serre Salentine. Atti 79 Congr. Società Geologica Italiana, FORD D.C., Genetic classification of solutional cave system. Proc. 7th Int. Congr. Spel., Sheffield, FORD D.C., Characteristics of dissolutional cave system in carbonate rocks. in James N.P. & Choquette P.W., ed. Paleokarst, Sprong-Verlag, GIACOMINI V., 1943 Saggio fitogeografico sulle pteridofite d Italia. in Fiori A., Flora Italica Cryptogama, Società Botanica Italiana, GIULIANI P., 2000 Elenco delle grotte pugliesi catastate fino al 31 ottobre Itinerari speleologici, 9, MARTINI S B., 1970 Note illustrative della C.G.I., Foglio 223 Capo S. Maria di Leuca, Napoli, 69 pp. MEDAGLI P., 1989 Le vore di Barbarano: aspetti floristici. Obiettivo Ambiente, Rivista di ecologia e gestione del territorio, 2, 5 pp. MOSCARDINO M., 1957 Paleontologia e Speleologia in Terra d Otranto. Pajano ed., Galatina
10 TASSELLI L., Antichità di Leuca. Lecce. POHL E.R., 1955 Vertical shafts in limestones caves. Natl. Speleol. Soc. Occ. Paper, 2. WHITE W. B., 1988 Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. Oxford Univ. press, New Yok, 464 pp
Capitolo 12 Le acque sotterranee
 Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
ORDINE DEI GEOLOGI DELL ORDINE DEI GEOL A TOSCANA
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Reggio Emilia, Parco Nazionale dell Appennino Tosco-Emiliano Via Comunale, Sassalbo di Fivizzano (MS)
 GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
GRUPPO SPELEOLOGICO PALETNOLOGICO GAETANO CHIERICI,, MEMBRO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA * AFFILIATO ALLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Reggio Emilia, 27.3.2017 Parco Nazionale
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE. N Catasto. Nome della Grotta:
 REGIONE PGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Città di Nardò Provincia di Lecce
 Città di Nardò Provincia di Lecce Settore Ambiente Ufficio Parco prot. n. Nardò, 02/12/2015 Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista via Cognetti, 36 70121 BARI OGGETTO : D.G.R. n. 995 del
Città di Nardò Provincia di Lecce Settore Ambiente Ufficio Parco prot. n. Nardò, 02/12/2015 Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista via Cognetti, 36 70121 BARI OGGETTO : D.G.R. n. 995 del
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
Grotta Fetida Di S. Cesarea Terme
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
A scala del mezzo poroso
 C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
Grotta Bagno Marino di S. Cesarea Terme
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
LEONARDO BECCARISI*, LEONARDO CHIRIACO*, SILVANO MARCHIORI**, PIER0 MEDAGLI** RINVENIMENTI FLORISTIC1 ALL'INTERNO DI ALCUNE VORAGINI SALENTINE
 LEONARDO BECCARISI*, LEONARDO CHIRIACO*, SILVANO MARCHIORI**, PIER0 MEDAGLI** * Gruppo Speleologico Neretino, Piazza Mercato 13, Nardb (Le) ** Dipartimento di Biologia Universita di Lecce Ecotekne, 73100
LEONARDO BECCARISI*, LEONARDO CHIRIACO*, SILVANO MARCHIORI**, PIER0 MEDAGLI** * Gruppo Speleologico Neretino, Piazza Mercato 13, Nardb (Le) ** Dipartimento di Biologia Universita di Lecce Ecotekne, 73100
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Grotta La Rotondella. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Caverna Di Porto Rosso. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Grotta Cripta Di Riggio 1. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
 IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Corso di Aggiornamento Professionale Viterbo, 24 maggio 2010 - Palazzo della Provincia Prima Sessione Le componenti geologiche nello SIA: ambiente
Cunicolo dei Diavoli PU_101 PORTO BADISCO L'ACCESSO E' IMPEDITO DA CANCELLATA IN FERRO. Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al :23:53
 Lecce PORTO BADISCO 66 45 X X L'ACCESSO E' IMPEDITO DA CANCELLATA IN FERRO Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al 0-06-17 05:3:53 7/05/01 40-4 - 5 X 18-8 - 59.4 1 da otranto raggiungere porto badisco e scendere
Lecce PORTO BADISCO 66 45 X X L'ACCESSO E' IMPEDITO DA CANCELLATA IN FERRO Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al 0-06-17 05:3:53 7/05/01 40-4 - 5 X 18-8 - 59.4 1 da otranto raggiungere porto badisco e scendere
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
POLO N. 2 - ARGENTA, PONTE BASTIA
 TIPOLOGIA DI POLO LITOLOGIA DEL GIACIMENTO Argilla COMUNE INTERESSATO Argenta INQUADRAMENTO DELL AREA L area è ubicata nei pressi di Ponte Bastia, nel Comune di Argenta. E delimitata a sud dalla Strada
TIPOLOGIA DI POLO LITOLOGIA DEL GIACIMENTO Argilla COMUNE INTERESSATO Argenta INQUADRAMENTO DELL AREA L area è ubicata nei pressi di Ponte Bastia, nel Comune di Argenta. E delimitata a sud dalla Strada
Capitolo 6 Rilevamento geologico
 Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1
 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA AREA ESTRATTIVA "S. MARTINO" AMBITO 1 1. INQUADRAMENTO Comune di: Civitella di Romagna. Località: S. Martino in Varolo. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav.
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni 1. Premessa In Italia la progettazione geotecnica è regolata dal N.T.C. 2008 ed è redatta ai sensi del p.to 6.2.2. La presente Relazione è relativa all Analisi sulle
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni 1. Premessa In Italia la progettazione geotecnica è regolata dal N.T.C. 2008 ed è redatta ai sensi del p.to 6.2.2. La presente Relazione è relativa all Analisi sulle
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
Pozzo Naturale presso la Voragine Il Cavone
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
FULVIO ZEZZA 1. La grotta di Lamalunga: evoluzione e conservazione del sistema carsico sotterraneo
 FULVIO ZEZZA 1 La grotta di Lamalunga: evoluzione e conservazione del sistema carsico sotterraneo Introduzione La Grotta di Lamalunga appartiene ad una delle aree geografiche pugliesi, quella delle Murge,
FULVIO ZEZZA 1 La grotta di Lamalunga: evoluzione e conservazione del sistema carsico sotterraneo Introduzione La Grotta di Lamalunga appartiene ad una delle aree geografiche pugliesi, quella delle Murge,
PU_1571. Condotte sommerse della Palude del Capitano. Porto Selvaggio Palude del Capitano GRUPPO SPELEOLOGICO NERETINO
 PU_57 Lecce Porto Selvaggio Palude del Capitano 58 0 X X Pagina di Scheda aggiornata al 28-02-7 :57:20 25/03/203 -X -- si giunge attraverso sentieri e percorsi naturalistici facenti parte del parco naturale
PU_57 Lecce Porto Selvaggio Palude del Capitano 58 0 X X Pagina di Scheda aggiornata al 28-02-7 :57:20 25/03/203 -X -- si giunge attraverso sentieri e percorsi naturalistici facenti parte del parco naturale
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Vora Di Vitigliano. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
Grotta della Poesia Piccola
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
ALLEGATO C (Classi di Rischio Geologico e indagini di tipo geologico, geofisico e geotecnico minime da eseguire)
 ALLEGATO C (Classi di Geologico e indagini di tipo geologico, geofisico e geotecnico minime da eseguire) Il testo del presente allegato è stato redatto in collaborazione tra la Direzione Regionale Infrastrutture
ALLEGATO C (Classi di Geologico e indagini di tipo geologico, geofisico e geotecnico minime da eseguire) Il testo del presente allegato è stato redatto in collaborazione tra la Direzione Regionale Infrastrutture
Lezione Circolazione idrica sotterranea
 Lezione Circolazione idrica sotterranea Obiettivi La lezione pone l attenzione sulle modalità di circolazione idrica sotterranea, partendo dalla scala dei pori fino a giungere alla scala di bacino, attraverso
Lezione Circolazione idrica sotterranea Obiettivi La lezione pone l attenzione sulle modalità di circolazione idrica sotterranea, partendo dalla scala dei pori fino a giungere alla scala di bacino, attraverso
GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE COMMISSIONE CATASTO REQUISITI DELLE CAVITA PER L INSERIMENTO IN CATASTO
 1) DIMENSIONI FEDERZIONE SPELEOLOGIC PUGLIESE COMMISSIONE CTSTO REQUISITI DELLE CVIT PER L INSERIMENTO IN CTSTO Per poter accatastare una cavità, lo sviluppo spaziale deve superare i 5 metri, la sua larghezza
1) DIMENSIONI FEDERZIONE SPELEOLOGIC PUGLIESE COMMISSIONE CTSTO REQUISITI DELLE CVIT PER L INSERIMENTO IN CTSTO Per poter accatastare una cavità, lo sviluppo spaziale deve superare i 5 metri, la sua larghezza
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE. N Catasto. Grave Rotolo. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL AMBIENTE FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE AREA ESTRATTIVA "CAVIGNANO DI SOTTO" - POLO 11 B
 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE AREA ESTRATTIVA "CAVIGNANO DI SOTTO" - POLO 11 B 1. INQUADRAMENTO Comune di: Sogliano al Rubicone. Località: Cavignano di Sotto. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000):
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE AREA ESTRATTIVA "CAVIGNANO DI SOTTO" - POLO 11 B 1. INQUADRAMENTO Comune di: Sogliano al Rubicone. Località: Cavignano di Sotto. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000):
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
 AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Grotta del Lume. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
COMUNE DI AGRA. Provincia di Varese
 COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
Inghiottitoio Le Gravinelle PU_15. Le Gravinelle CASTELLANA GROTTE. Gravinelle. Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al :11:18
 Le Gravinelle Bari Castellana Grotte p.zza Caduti castellanesi Gravinelle 21 O 15 X X G. Mancini 11/11/1938 Vianello - Tommasini 26/12/1956 F. Orofino 11/3/1968 Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al 21-7-17
Le Gravinelle Bari Castellana Grotte p.zza Caduti castellanesi Gravinelle 21 O 15 X X G. Mancini 11/11/1938 Vianello - Tommasini 26/12/1956 F. Orofino 11/3/1968 Pagina 1 di 14 Scheda aggiornata al 21-7-17
MARCO DELLE ROSE 1. Influenza dell ipercarsismo sull evoluzione delle coste rocciose basse del Salento
 MARCO DELLE ROSE 1 Influenza dell ipercarsismo sull evoluzione delle coste rocciose basse del Salento Introduzione Ipercarsismo è usato sia in senso morfologico, per indicare marcate evidenze di dissoluzione
MARCO DELLE ROSE 1 Influenza dell ipercarsismo sull evoluzione delle coste rocciose basse del Salento Introduzione Ipercarsismo è usato sia in senso morfologico, per indicare marcate evidenze di dissoluzione
GEOMORFOLOGIA. Modellamento dei versanti
 GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
Spélaion 2010 Atti del XV Incontro Regionale di Speleologia Pugliese
 Finito di editare nel 2013 A cura del Gruppo Speleologico Vespertilio con una tiratura limitata del CD\DVD con file originali 1\200 Copia digitale scaricabile dai siti del Gruppo Speleologico Vespertilio
Finito di editare nel 2013 A cura del Gruppo Speleologico Vespertilio con una tiratura limitata del CD\DVD con file originali 1\200 Copia digitale scaricabile dai siti del Gruppo Speleologico Vespertilio
Un processo morfogenetico è un particolare meccanismo attraverso il quale un agente morfogenetico riesce a creare o modificare forme e depositi.
 Un agente morfogenetico è un fenomeno fisico e/o chimico che, attraverso l attivazione di meccanismi caratteristici, può generare o modificare le forme del rilevo e/o le caratteristiche dei depositi (morfogenesi).
Un agente morfogenetico è un fenomeno fisico e/o chimico che, attraverso l attivazione di meccanismi caratteristici, può generare o modificare le forme del rilevo e/o le caratteristiche dei depositi (morfogenesi).
Grava presso le antenne RAI TV
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
COMUNE DI FORLI AREA ESTRATTIVA "CASTIGLIONE" POLO 14
 COMUNE DI FORLI AREA ESTRATTIVA "CASTIGLIONE" POLO 14 1. INQUADRAMENTO Comune di: Forlì. Località: Castiglione Monte Vescovado. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav. 239 SE Faenza. Tipo di
COMUNE DI FORLI AREA ESTRATTIVA "CASTIGLIONE" POLO 14 1. INQUADRAMENTO Comune di: Forlì. Località: Castiglione Monte Vescovado. Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav. 239 SE Faenza. Tipo di
Ambito estrattivo 3S - Scalello
 Ambito estrattivo 3S - Scalello Comune di: Sarsina Località: Scalello Area inserita nel PAE Comunale con sigla: Ii10 Stato di fatto: Area con attività estrattiva in corso L Area è inserita nel PIAE vigente?:
Ambito estrattivo 3S - Scalello Comune di: Sarsina Località: Scalello Area inserita nel PAE Comunale con sigla: Ii10 Stato di fatto: Area con attività estrattiva in corso L Area è inserita nel PIAE vigente?:
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
GESTIONE delle RISORSE IDRICHE
 Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
GLI IDROCARBURI. Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO
 GLI IDROCARBURI Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Idrogeno Carbonio Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO molecola del metano GLI IDROCARBURI: FORMAZIONE
GLI IDROCARBURI Gli idrocarburi sono sostanze organiche formate da molecole di idrogeno e carbonio. Idrogeno Carbonio Sono idrocarburi il PETROLIO e il METANO molecola del metano GLI IDROCARBURI: FORMAZIONE
PU_113. Grotta Grande di Ciolo. Rutta Rane - Bocca del Pozzo - Ucca U'Puzzu GAGLIANO DEL CAPO CIOLO BOCCA DEL POZZO - UCCA U'PUZZU - RUTTA RANE
 Rutta Rane - Bocca del Pozzo - Ucca U'Puzzu Lecce CIOLO BOCCA DEL POZZO - UCCA U'PUZZU - RUTTA RANE 11 224 X X L'ACCESSO E' DA MARE O CON PROGRESSIONE SU CORDA Nicolardi M. 1/1/194 GG Milano CAI SEM 1/1/1972
Rutta Rane - Bocca del Pozzo - Ucca U'Puzzu Lecce CIOLO BOCCA DEL POZZO - UCCA U'PUZZU - RUTTA RANE 11 224 X X L'ACCESSO E' DA MARE O CON PROGRESSIONE SU CORDA Nicolardi M. 1/1/194 GG Milano CAI SEM 1/1/1972
Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua. Gianluigi Giannella
 Corso di Aggiornamento Professionale PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI POZZI ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVO-AMMINISTRATIVI Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua Gianluigi Giannella 17 Dicembre 2010
Corso di Aggiornamento Professionale PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI POZZI ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVO-AMMINISTRATIVI Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua Gianluigi Giannella 17 Dicembre 2010
TERREMOTO CENTRO ITALIA Di.Coma.C Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione. Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016
 Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Grassano (Matera - italy)
 Grassano (Matera - italy) www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS Pozzi Strutturali e cloujet ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS GRASSANO (MATERA - ITALIA) PROGETTO: Consolidamento dell
Grassano (Matera - italy) www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS Pozzi Strutturali e cloujet ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS GRASSANO (MATERA - ITALIA) PROGETTO: Consolidamento dell
Esame di Stato per Geologo. Sede Urbino 2 sessione Prima prova scritta. risanamento che possono riguardare la professione del geologo.
 Esame di Stato per Geologo Sede Urbino 2 sessione 2013 Prima prova scritta 1) La Geologia e l'inquinamento ambientale: vari tipi di inquinamento, tecniche di indagine e di risanamento che possono riguardare
Esame di Stato per Geologo Sede Urbino 2 sessione 2013 Prima prova scritta 1) La Geologia e l'inquinamento ambientale: vari tipi di inquinamento, tecniche di indagine e di risanamento che possono riguardare
LE ACQUE SOTTERRANEE ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA E CASI DI STUDIO
 GIOVANNI PRANZINI LE ACQUE SOTTERRANEE ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA E CASI DI STUDIO PRESENTAZIONE Questo volume contiene i fondamenti dell'idrogeologia. Gli argomenti trattati coprono praticamente tutti gli
GIOVANNI PRANZINI LE ACQUE SOTTERRANEE ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA E CASI DI STUDIO PRESENTAZIONE Questo volume contiene i fondamenti dell'idrogeologia. Gli argomenti trattati coprono praticamente tutti gli
CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna)
 www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna) CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (SPAGNA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS PROGETTO: realizzazione di uno
www.pacchiosi.com ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (Spagna) CIUDAD DE LA JUSTICIA VALENCIA (SPAGNA) ROCK-SOIL TECHNOLOGY AND EQUIPMENTS PROGETTO: realizzazione di uno
Geomorfologia Eolica
 Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
POLO N. 5 BONDENO, SETTEPOLESINI
 TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Grotta di Gemmabella. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
Caso II: Modellazione della generazione di fessurazioni e riattivazione delle faglie dovuta all estrazione di fluidi dal sottosuolo (Wuxi, China)
 Analisi modellistica del rischio idrogeologico connesso alla geomeccanica della produzione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo Omar Tosatto, Carlo Janna, Massimiliano Ferronato, Pietro Teatini www.m3eweb.it
Analisi modellistica del rischio idrogeologico connesso alla geomeccanica della produzione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo Omar Tosatto, Carlo Janna, Massimiliano Ferronato, Pietro Teatini www.m3eweb.it
Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse
 Report attività ISPRA del 03 Settembre 2016 Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse 1. Anagrafica sopralluogo Denominazione sito: Comune
Report attività ISPRA del 03 Settembre 2016 Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse 1. Anagrafica sopralluogo Denominazione sito: Comune
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
Capitolo 7 Sezioni geologiche e problemi di stratimetria
 Capitolo 7 Sezioni geologiche e problemi di stratimetria Sezione geologica: finalizzata a ricostruire e rappresentare l andamento dei corpi e delle strutture geologiche in profondità Passaggio dalla rappresentazione
Capitolo 7 Sezioni geologiche e problemi di stratimetria Sezione geologica: finalizzata a ricostruire e rappresentare l andamento dei corpi e delle strutture geologiche in profondità Passaggio dalla rappresentazione
ACQUAVIVA DELLE FONTI. GSV-Gruppo Speleologico Vespertilio CENTRO ALTAMURANO RICERCHE SPELEOLOGICHE
 Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
Grotta di Curtomartino Bari Curtomartino curtomartino 72 63 X X X grotta chiusa con cancello Privato. Vito abbrusci www.grottacurtomartino.it 500 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli 11/11/1960 Alessandrelli
COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "CA BIANCHI" POLO 28
 COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "CA BIANCHI" POLO 28 1. INQUADRAMENTO Comune di: Cesena. Località: Borgo Paglia. Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 NE - Cesena. Tipo di materiale di cui
COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "CA BIANCHI" POLO 28 1. INQUADRAMENTO Comune di: Cesena. Località: Borgo Paglia. Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 NE - Cesena. Tipo di materiale di cui
Riccardo Petrini Università di Pisa Dipartimento di Scienze della Terra. Franco Cucchi Luca Zini Francesca F. Slejko. DMG-Università di Trieste
 Gli isotopi dello stronzio nello studio della interazione acquaroccia e nella caratterizzazione di corpi idrici in aquiferi carbonatici. Introduzione ed esempi Riccardo Petrini Università di Pisa Dipartimento
Gli isotopi dello stronzio nello studio della interazione acquaroccia e nella caratterizzazione di corpi idrici in aquiferi carbonatici. Introduzione ed esempi Riccardo Petrini Università di Pisa Dipartimento
COMUNE DI CASTROCARO e TERRA DEL SOLE AREA ESTRATTIVA "CASE DI SOTTO" - POLO 18
 COMUNE DI CASTROCARO e TERRA DEL SOLE AREA ESTRATTIVA "CASE DI SOTTO" - POLO 18 1. INQUADRAMENTO Comune di: Castrocaro Terme - Terra del Sole. Località: Case di sotto. Elaborato cartografico di riferimento:
COMUNE DI CASTROCARO e TERRA DEL SOLE AREA ESTRATTIVA "CASE DI SOTTO" - POLO 18 1. INQUADRAMENTO Comune di: Castrocaro Terme - Terra del Sole. Località: Case di sotto. Elaborato cartografico di riferimento:
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA
 RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA PREMESSA - OGGETTO DEI LAVORI I lavori hanno per oggetto l'esecuzione delle infrastrutture di supporto al Piano per gli Insediamenti Produttivi
RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA PREMESSA - OGGETTO DEI LAVORI I lavori hanno per oggetto l'esecuzione delle infrastrutture di supporto al Piano per gli Insediamenti Produttivi
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Pulo di Altamura. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005)
 SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:
 Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: 1. Corsi d acqua appartenenti all Elenco Principale delle Acque Pubbliche D.Luog. 23.5.1918:
Cartografia geologica e microzonazione sismica
 Sala A conferenze, Terza Torre - 19 aprile 12 MICROZONAZIONE SISMICA UNO STRUMENTO CONSOLIDATO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO L esperienza della Regione Emilia-Romagna Cartografia geologica e microzonazione
Sala A conferenze, Terza Torre - 19 aprile 12 MICROZONAZIONE SISMICA UNO STRUMENTO CONSOLIDATO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO L esperienza della Regione Emilia-Romagna Cartografia geologica e microzonazione
Il carsismo è un processo di erosione chimica che si sviluppa :
 Il carsismo è un processo di erosione chimica che si sviluppa : in presenza di rocce solubili: - rocce evaporitiche (gesso, salgemma); - rocce carbonatiche (calcari, dolomie, marmi ). in presenza di acqua:
Il carsismo è un processo di erosione chimica che si sviluppa : in presenza di rocce solubili: - rocce evaporitiche (gesso, salgemma); - rocce carbonatiche (calcari, dolomie, marmi ). in presenza di acqua:
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA. N Catasto. Buca del Vento. Nome della Grotta:
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
 La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque
 Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Dott. Alberto Cisotto Autorità di bacino dell Alto Adriatico L articolo 14 della direttiva
Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Dott. Alberto Cisotto Autorità di bacino dell Alto Adriatico L articolo 14 della direttiva
Aosta. 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone
 Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
IL CLIMA MEDITERRANEO MEDITERRANEA
 IL CLIMA MEDITERRANEO E LA MACCHIA MEDITERRANEA Il clima mediterraneo, secondo la classificazione climatica è il meno esteso dei climi temperati. È caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva
IL CLIMA MEDITERRANEO E LA MACCHIA MEDITERRANEA Il clima mediterraneo, secondo la classificazione climatica è il meno esteso dei climi temperati. È caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva
Grotta presso Masseria Pacelli
 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL ECOLOGIA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA Scheda Catastale redatta ai sensi dell art.3 - L.R. 32/86 e relativo regolamento CATASTO DELLE GROTTE
Spesso la pianura è attraversata da corsi d'acqua e per questo è un ambiente favorevole a molte attività umane e soprattutto all'agricoltura.
 LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
LA PIANURA La pianura ha un'altitudine inferiore a 200 metri. In pianura non ci sono i rilievi. Le strade sono comode, molto trafficate, poco tortuose e prive ripide salite e discese. Ci sono autostrade,
Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale
 ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
ESPLORAZIONI 223 Grotta del Falco (Cp 448) - ramo laterale Rilievo 1988: U. Del Vecchio, I. Giulivo 268 UMBERTO DEL VECCHIO GROTTA DEL FALCO (CP 448) La Grotta del Falco si apre nel settore settentrionale
IDROGEOLOGIA COME SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI VIABILITÀ E GALLERIE
 Giornata di Studio PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE IDROGEOLOGIA DELL ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA FIRENZE, 9 DICEMBRE 2008 AUDITORIUM DELLA REGIONE TOSCANA IDROGEOLOGIA COME SUPPORTO
Giornata di Studio PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE IDROGEOLOGIA DELL ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA FIRENZE, 9 DICEMBRE 2008 AUDITORIUM DELLA REGIONE TOSCANA IDROGEOLOGIA COME SUPPORTO
COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "IL MOLINO" POLO 25
 COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "IL MOLINO" POLO 25 1. INQUADRAMENTO Comune di: Cesena. Località: Borello. Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 SE - Borello. Tipo di materiale di cui è prevista
COMUNE DI CESENA AREA ESTRATTIVA "IL MOLINO" POLO 25 1. INQUADRAMENTO Comune di: Cesena. Località: Borello. Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 SE - Borello. Tipo di materiale di cui è prevista
Fondazioni dirette: Plinti
 Fondazioni Fondazioni La fondazione è quella parte del manufatto a diretto contatto con il terreno, al quale vincola stabilmente il manufatto stesso. La geometria della fondazione deve essere tale da trasferire
Fondazioni Fondazioni La fondazione è quella parte del manufatto a diretto contatto con il terreno, al quale vincola stabilmente il manufatto stesso. La geometria della fondazione deve essere tale da trasferire
Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna
 Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna lmartelli@regione.emilia-romagna.it fmolinari@regione.emilia-romagna.it fsciuto@regione.emilia-romagna.it Esempio di riserve geotermiche
Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna lmartelli@regione.emilia-romagna.it fmolinari@regione.emilia-romagna.it fsciuto@regione.emilia-romagna.it Esempio di riserve geotermiche
CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
 Regione Autonoma Valle D aosta Région Autonome Vallée d Aoste Comune di Verrayes Commune de Verrayes Committente : Menegoni S.r.l. Via Arberaz n 5 11023 Chambave (Ao) CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
Regione Autonoma Valle D aosta Région Autonome Vallée d Aoste Comune di Verrayes Commune de Verrayes Committente : Menegoni S.r.l. Via Arberaz n 5 11023 Chambave (Ao) CAVA DI SCAGLIAME DI MARMO OFICALCE
INTRODUZIONE 2 1. METODI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA 2 2. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELL ACQUIFERO
 SOMMARIO INTRODUZIONE 2 1. METODI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA 2 2. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELL ACQUIFERO SUPERFICIALE MEDIANTE IL METODO GOD (1987) 3 2.1 - Descrizione del metodo
SOMMARIO INTRODUZIONE 2 1. METODI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA 2 2. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELL ACQUIFERO SUPERFICIALE MEDIANTE IL METODO GOD (1987) 3 2.1 - Descrizione del metodo
LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE
 Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Date: 13 e 27 ottobre 2015 Docente: Claudio Lancini LEZIONE N. 4 SCIENZE MISURA DELLA CIRCONFERENZA TERRESTRE Già al tempo degli antichi Egizi, molti scienziati avevano capito che la Terra non era piatta
Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici
 Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici a cura di Michele Aleffi Dipartimento di Scienze Ambientali Sezione di Botanica ed Ecologia Università di Camerino L opera d arte d o un qualsiasi reperto
Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici a cura di Michele Aleffi Dipartimento di Scienze Ambientali Sezione di Botanica ed Ecologia Università di Camerino L opera d arte d o un qualsiasi reperto
A2.1 - Tabelle per il calcolo dei coefficienti di amplificazione sismica (secondo livello di approfondimento)
 ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA
 INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DEI MARI ITALIANI ALLA SCALA 1: 250.000. Annamaria Correggiari
 LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DEI MARI ITALIANI ALLA SCALA 1: 250.000 Annamaria Correggiari Progetto a cura di F. Trincardi, A. Argnani, A. Correggiari con contributi di Informatizzazione: F. Foglini Carta
LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DEI MARI ITALIANI ALLA SCALA 1: 250.000 Annamaria Correggiari Progetto a cura di F. Trincardi, A. Argnani, A. Correggiari con contributi di Informatizzazione: F. Foglini Carta
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale. Variazioni relative del livello marino
 Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA
 Università del Salento IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA Vincenzo Orofino Gruppo di Astrofisica Marte osservato dall Hubble Space Telescope La superficie di Marte ripresa dal MER03 Spirit
Università del Salento IL PIANETA MARTE E LA SUA EVOLUZIONE CLIMATICA Vincenzo Orofino Gruppo di Astrofisica Marte osservato dall Hubble Space Telescope La superficie di Marte ripresa dal MER03 Spirit
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO
 REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
Geo Tecnologie s.r.l.
 INDICE 1. PREMESSA 2 2. DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008 7 2.1 Parametri sismici locali 9 1 1. PREMESSA L Appennino meridionale presenta una storia sismica tra le più severe dell Italia, sia in termini
INDICE 1. PREMESSA 2 2. DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008 7 2.1 Parametri sismici locali 9 1 1. PREMESSA L Appennino meridionale presenta una storia sismica tra le più severe dell Italia, sia in termini
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche. a) Relazione b) Norme di attuazione
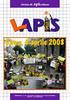 Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
Provincia Autonoma di Trento Assessorato all Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3 Approvazione della Carta delle risorse idriche a) Relazione
