UN CONFRONTO TRA DUE APPROCCI PER LA MODELLAZIONE DELL INTERAZIONE TERRENO-ATMOSFERA IN TERRENI PIROCLASTICI
|
|
|
- Gianpaolo Paoli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 UN CONFRONTO TRA DUE APPROCCI PER LA MODELLAZIONE DELL INTERAZIONE TERRENO-ATMOSFERA IN TERRENI PIROCLASTICI Alfredo Reder Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università degli Studi di Napoli Federico II Regional Models and geo Hydrological Impacts (REMHI) Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) via Maiorise, Capua (CE) alfredo.reder@unina.it Guido Rianna Regional Models and geo Hydrological Impacts (REMHI) Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) via Maiorise, Capua (CE) guido.rianna@cmcc.it Luca Pagano Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università degli Studi di Napoli Federico II lupagano@unina.it Sommario Il flusso di vapore attraverso la superficie del terreno è un processo fisico indotto da una transizione di fase che può avvenire direttamente in superficie o nelle zone più superficiali del suolo. Il lavoro presentato evidenzia le approssimazioni connesse nel considerare il fenomeno solo come fenomeno di superficie. Allo scopo confronta due approcci di letteratura e giudica l accuratezza delle previsioni attraverso il confronto con le osservazioni consegnate da un modello fisico. 1. Introduzione Nei problemi geotecnici e, in particolare, di stabilità dei versanti, il bilancio idrologico nel dominio di interesse è spesso stimato trascurando la componente evapotraspirativa, o perché ritenuta di minore entità rispetto, ad esempio, all infiltrazione e al drenaggio profondo, o, semplicemente, in quanto un adeguata stima di tale componente rappresenta usualmente un elemento di elevata complessità. Gli approcci maggiormente adottati nella disciplina geotecnica qualora l analisi dell interazione terreno-atmosfera preveda la modellazione dei flussi evaporativi sono due. In entrambi il comportamento dello scheletro solido è assunto rigido, il che consente di eliminare il problema meccanico. Nel primo approccio (Wilson, 1990; Wilson et al, 1994; Wilson et al, 1997), l interazione terrenoatmosfera è modellata in modo, per così dire, completo, associando alle equazioni che descrivono il flusso dell acqua allo stato liquido e di vapore quelle che descrivono il flusso di calore (Figura 1a). Il flusso evaporativo è ricavato da un bilancio energetico imposto all interfaccia terreno-atmosfera. La temperatura superficiale del dominio, condizione al contorno del problema termico, viene ipotizzata
2 coincidente con quella atmosferica o ricavata anch essa da un bilancio energetico in superficie. In tale approccio il flusso evaporativo che attraversa l interfaccia può avvenire anche per effetto di cambi di stato che si verificano all interno del dominio stesso. Nel secondo approccio (Figura 1b), per così dire semplificato, si modella solo il flusso della fase liquida nel mezzo parzialmente saturo (equazione di Richards, 1931). I flussi evaporativi applicati al contorno sono quantificati come nel caso precedente, tramite un bilancio energetico all interfaccia. La differenza sostanziale tra i due approcci è che mentre nel primo l evaporazione è un fenomeno che si approfondisce non appena le zone più superficiali si desaturano, nel secondo è un fenomeno solo di superficie. Il cambio di stato avviene in una zona di transizione di fase delimitata inferiormente dalla superficie del cambio di stato dell acqua (S.C.S.). La seguente nota pone a confronto i due approcci, completo e semplificato, in un tentativo di validazione di ciascuno di essi. Al fine di esprimere un giudizio circa l accuratezza della previsioni, si assumono come riferimento le osservazioni raccolte nel corso di una sperimentazione con modello fisico nel corso di circa 4 anni. Preliminarmente, i due approcci sono confrontati teoricamente ipotizzando condizioni atmosferiche costanti nel tempo. Fig 1. Schemi concettuali degli approcci adottati: modello completo (Wilson) (a); modello semplificato (Richards) (b) 2. Un semplice confronto numerico tra i due approcci I due approcci sono implementati nel codice FEM Vadose 2007/W. Essi sono stati confrontati nell ipotesi che l interazione terreno atmosfera sia governata da un evaporazione potenziale che agisce con intensità costante su di un dominio monodimensionale (flussi di acqua e calore unidirezionali) per un intervallo di 60 giorni. Parimenti, le variabili atmosferiche che regolano la domanda evaporativa sono assunte costanti (Tabella 1); l effetto integrale atteso, in assenza di eventi di imbibizione, è la progressiva desaturazione del mezzo a partire dalla superficie superiore. Tabella 1. Forzanti atmosferiche
3 T media [ C] RH media [%] U wind [m/s] R n [MJ/m2] ,35 T media = temperatura atmosferica medio RH media = umidità relativa media U wind = velocità del vento R n = radiazione netta In entrambi i casi si è assunta come condizione iniziale una distribuzione idrostatica di pressione della fase liquida, caratterizzata da valore nullo alla base del dominio (e, ovviamente, valore minimo negativo in corrispondenza del contorno superiore). Nel modello completo la temperatura è stata assunta costante nello spazio e nel tempo e con valore corrispondente al valore atmosferico. I parametri idraulici e termici sono stati quantificati assumendo i valori derivati attraverso una sperimentazione su modello fisico (Rianna et al, 2014a,b; Pagano et al, 2014a,b) per una piroclastite limosa non plastica con contenuto di fine pari a circa il 10%. La Figura 2 riporta l evoluzione di evaporazione reale ottenuta applicando nelle condizioni appena menzionate i due approcci. La stessa figura riporta anche l evoluzione di evaporazione potenziale. Fig 2. Evoluzione dell evaporazione simulata in condizioni semplificate attraverso la risoluzione dell equazione di Richards (in rosso) e la risoluzione del sistema di equazioni di Wilson (in nero); evoluzione dell evaporazione potenziale (in verde) Nella prima fase, i due approcci restituiscono risultati coincidenti: entrambi stimano che il suolo possa sostenere la domanda atmosferica per oltre 35 giorni. Ciò avviene fintantoché i valori di conducibilità idraulica superficiali sono sufficientemente elevati da garantire il soddisfacimento della domanda esterna attraverso apporti idrici dal basso. In questa fase l evaporazione deriva esclusivamente da un cambio di stato della acqua in superficie. La successiva desaturazione della zona superficiale e la conseguente riduzione della conducibilità idraulica determinano un rapido discostamento di entrambi i flussi evaporativi dal valore potenziale. Il discostamento è rapidissimo nella previsione fornita dall approccio semplificato: nel giro di pochi giorni il flusso evaporativo passa dal valore potenziale a un valore pressoché nullo. Nel modello com-
4 pleto, invece, la riduzione del flusso è più graduale. Nel modello completo il cambio di stato dell acqua segue, come detto, l approfondimento della S.C.S. e interessa pertanto volumi di acqua decisamente maggiori rispetto a quelli presenti solo in superficie. Peraltro, la formazione di vapore in profondità attiva un flusso diretto verso l alto, reso efficiente da valori del coefficiente di permeabilità al vapore accresciuti dalla desaturazione della zona di transizione di fase. Nel modello semplificato, al contrario, il cambio di stato interessa i modestissimi volumi di acqua presenti in superficie, laddove il contenuto d acqua è oramai prossimo al valore residuo. L apporto idrico dal basso è peraltro reso inefficiente dall abbattimento del coefficiente di conducibilità idraulica causato dalla desaturazione del mezzo. Nell approccio semplificato il flusso di vapore che attraversa la superficie superiore del dominio è dunque controllato dalla permeabilità della fase liquida, che progressivamente si riduce, mentre nell approccio completo il flusso è controllato dalla permeabilità della fase di vapore, che progressivamente s incrementa. 3. Previsioni e osservazioni Le differenze di previsione fornite dai due diversi approcci sono ora confrontate in relazione ad un evoluzione reale di variabili atmosferiche. Tale evoluzione coincide con quella che determina variazioni di peso, dovute ad infiltrazione ed evaporazione di acqua, del campione posto in opera nel modello fisico sopra introdotto (altezza campione=0,75m; base=(1,15x1,15)m 2 ). Fig 3. Evoluzione del volume d acqua immagazzinato misurato nel modello fisico (in grigio), modellato attraverso la risoluzione dell equazione di Richards (in rosso) e modellato attraverso la risoluzione del sistema di equazioni di Wilson (in nero) In Figura 3 si riportano le evoluzioni di peso computate con i due diversi approcci, confrontate con le evoluzioni di peso osservate. Si evidenzia innanzitutto che, attraverso entrambi gli approcci, è possibile riprodurre in modo abbastanza soddisfacente il comportamento sperimentale. Coerentemente con quanto illustrato nel paragrafo precedente, si osserva che i due approcci forniscono risultati coincidenti per valori del contenuto d acqua superficiale elevati e, dunque, per valori del peso prossimi a quelli
5 massimi, in virtù del fatto che in tali condizioni l evaporazione reale, coincidente con il valore potenziale, è un fenomeno solo di superficie. I risultati divergono invece quando il peso si riduce e la zona superficiale si desatura. In questa fase, nelle previsioni fornite dall approccio completo i volumi maggiori di acqua coinvolti nel cambio di stato producono riduzioni di peso più significative e maggiormente coerenti con il dato sperimentale. Previsioni e colate rapide di fango I due approcci sono infine confrontati, sempre in termini di peso di acqua immagazzinata, assumendo uno spessore maggiore (2m) e le variabili meteo registrate in località di Nocera Inferiore durante un lasso di tempo più lungo (circa 10 anni) a poche centinaia di metri dall ubicazione di un fenomeno di colata rapida, verificatosi il 4 marzo Indagini condotte nell area hanno permesso di stabilire come la granulometria e la porosità del mezzo coinvolto nel fenomeno siano del tutto consistenti con quelle del terreno impiegato nel modello; per tale motivo, i parametri adottati nell analisi sono coincidenti con quelli utilizzati in precedenza mentre il valore utilizzato per lo spessore della coltre è coerente con quello restituito dalle indagini geologiche sull area. Si può osservare che le previsioni convergono ogni qualvolta il peso si avvicina al valore massimo e tendono a divergere negli altri casi. Una non trascurabile divergenza si verifica spesso anche durante la fase tardo autunnale, tipicamente suscettibile all innesco dei fenomeni di colata rapida. In corrispondenza del fenomeno d instabilità le previsioni convergono, in virtù del fatto che il per un periodo pregresso di alcuni mesi l evaporazione reale si era attestata al valore potenziale. Fig 4. Evoluzione del volume d acqua immagazzinato per la previsione della frana occorsa a Nocera Inferiore, modellato attraverso la risoluzione dell equazione di Richards (in rosso) e attraverso la risoluzione del sistema di equazioni di Wilson (in nero) 4. Conclusioni Il confronto tra due approcci spesso utilizzati per prevedere il bilancio idrologico di un sottosuolo consente di concludere quanto segue: -i due approcci forniscono previsioni confrontabili se il contenuto d acqua superficiale è sufficientemente elevato da comportare valori di evaporazione reale prossimi al valore potenziale
6 -l approccio completo fornisce previsioni accurate nell arco dell intero anno idrologico; quello semplificato solo nel periodo invernale e all inizio della stagione primaverile -in relazione all utilizzo dei due modelli in sistemi di allarme per la previsione di fenomeni di colata rapida di fango, il modello semplificato risulta più (forse eccessivamente) cautelativo rispetto a quello completo Bibliografia Pagano L., Reder A., Rianna G. (2014a). Processi di infiltrazione ed evaporazione nei terreni piroclastici illustrati attraverso la selezione di alcuni eventi rappresentativi. Rivista Italiana Geotecnica (RIG), 1, Pagano L., Reder A., Rianna G. (2014b). Experiments to Investigate the Hydrological Behaviour of Volcanic Covers. Procedia Earth and Planetary Science 01/2014, 9, Rianna G., Pagano L., Urciuoli G. (2014a). Investigation of soil-atmosphere interaction in pyroclastic soils. Journal of hydrology, 510, Rianna G., Pagano L., Urciuoli G. (2014b). Rainfall patterns triggering flowslides in pyroclastic soils. Engineering Geology, 174, Richards L A. (1931). Capillary conduction of liquids through porous mediums. Physics, 1, Wilson G.W. (1990). Evaporation from Bare Soil Surfaces. PhD Thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. Wilson G.W., Fredlund D.G., Barbour S.L. (1994). Coupled soil-atmosphere modelling for soil evaporation. Canadian Geotechnical Journal, 31(2), Wilson G.W., Fredlund D.G., Barbour S.L. (1997). The effect of soil suction on evaporative fluxes from soil surfaces. Canadian Geotechnical Journal, 34(4),
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Caratterizzazione idraulica di una piroclastite campana
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Caratterizzazione idraulica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Caratterizzazione idraulica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE Corso di laurea triennale in INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE Corso di laurea triennale in INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN TESI DI LAUREA
 SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA Calibrazione di sensori per
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA Calibrazione di sensori per
Isteresi idraulica di una piroclastite non satura
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Isteresi idraulica di una piroclastite
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO TESI DI LAUREA TRIENNALE Isteresi idraulica di una piroclastite
Scuola politecnica e delle scienze di Base
 Scuola politecnica e delle scienze di Base UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E
Scuola politecnica e delle scienze di Base UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE ABSTRACT Modellazione di aste
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE ABSTRACT Modellazione di aste
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
SPERIMENTAZIONE SULLA RISPOSTA IDRAULICA DI TERRENI PIROCLASTICI RADICATI CON GRAMINACEE
 SPERIMENTAZIONE SULLA RISPOSTA IDRAULICA DI TERRENI PIROCLASTICI RADICATI CON GRAMINACEE Vittoria Capobianco vcapobianco@unisa.it Leonardo Cascini l.cascini@unisa.it Sabatino Cuomo scuomo@unisa.it Vito
SPERIMENTAZIONE SULLA RISPOSTA IDRAULICA DI TERRENI PIROCLASTICI RADICATI CON GRAMINACEE Vittoria Capobianco vcapobianco@unisa.it Leonardo Cascini l.cascini@unisa.it Sabatino Cuomo scuomo@unisa.it Vito
BILANCIO IDROLOGICO DI PIENA STIMA PIOGGIA NETTA. Dati bacino Chisone a S. Martino. Ilaria Brignone Aimonetto. Stima pioggia netta
 BILANCIO IDROLOGICO DI PIENA STIMA PIOGGIA NETTA Dati bacino Chisone a S. Martino 1 Introduzione L elaborato che segue intende sviluppare considerazioni in merito al riesame dei risultati ottenuti con
BILANCIO IDROLOGICO DI PIENA STIMA PIOGGIA NETTA Dati bacino Chisone a S. Martino 1 Introduzione L elaborato che segue intende sviluppare considerazioni in merito al riesame dei risultati ottenuti con
UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
I pendii di piroclastiti in Campania sono stati spesso soggetti a fenomeni di colate rapide
 I pendii di piroclastiti in Campania sono stati spesso soggetti a fenomeni di colate rapide In concomitanza di eventi meteorici di particolare intensità Principali eventi franosi nelle aree oggetto dello
I pendii di piroclastiti in Campania sono stati spesso soggetti a fenomeni di colate rapide In concomitanza di eventi meteorici di particolare intensità Principali eventi franosi nelle aree oggetto dello
INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SUL REGIME IDRICO DI UN PENDIO DI TERRENI PARZIALMENTE SATURI
 INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SUL REGIME IDRICO DI UN PENDIO DI TERRENI PARZIALMENTE SATURI M. Pirone, M. V. Nicotera, R. Papa, G. Urciuoli Dipartimento di Ingegneria Idraulica Geotecnica ed
INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SUL REGIME IDRICO DI UN PENDIO DI TERRENI PARZIALMENTE SATURI M. Pirone, M. V. Nicotera, R. Papa, G. Urciuoli Dipartimento di Ingegneria Idraulica Geotecnica ed
Università degli Studi di Napoli Federico II UN METODO DI ANALISI PER LA MODELLAZIONE DEL FENOMENO DI ROTTURA PROGRESSIVA NEI PENDII
 Università degli Studi di Napoli Federico II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria
Università degli Studi di Napoli Federico II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE Corso di Laurea in INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
Guido Rianna Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici(CMCC)
 CENTRO EURO--MEDI ITERRANEO PER I CAMBIAMENTII CLIMATIICI I ISC Divisione Impatti sul Suolo e sulle Coste Technical Reports Installazione della versione stand alone del soil module TERRA-LM Guido Rianna
CENTRO EURO--MEDI ITERRANEO PER I CAMBIAMENTII CLIMATIICI I ISC Divisione Impatti sul Suolo e sulle Coste Technical Reports Installazione della versione stand alone del soil module TERRA-LM Guido Rianna
Metodi numerici per l'analisi della ventilazione e delle sollecitazioni strutturali in caso di incendi in galleria.
 Metodi numerici per l'analisi della ventilazione e delle sollecitazioni strutturali in caso di incendi in galleria. V max = 46.5 m/s V min = -6.0 m/s T max = 1000 C T min = 20.0 C Campo di velocità indotto
Metodi numerici per l'analisi della ventilazione e delle sollecitazioni strutturali in caso di incendi in galleria. V max = 46.5 m/s V min = -6.0 m/s T max = 1000 C T min = 20.0 C Campo di velocità indotto
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Abstract
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE Abstract MISURA DI GRANDEZZE IDRICHE NEL SOTTOSUOLO IN PENDII
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE Abstract MISURA DI GRANDEZZE IDRICHE NEL SOTTOSUOLO IN PENDII
INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
LA PORTATA DI PICCO DI UNA COLATA: ERRORI NEL MODELLO DI TAKAHASHI E PROPOSTA DI CORREZIONE. C. Gregoretti 1
 Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. LA PORTATA DI PICCO DI UNA COLATA: ERRORI NEL MODELLO DI TAKAHASHI E PROPOSTA DI CORREZIONE
Convegno di Medio Termine dell Associazione Italiana di Ingegneria Agraria Belgirate, 22-24 settembre 2011 memoria n. LA PORTATA DI PICCO DI UNA COLATA: ERRORI NEL MODELLO DI TAKAHASHI E PROPOSTA DI CORREZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
obiettivo Fase I: Misure acquisite suzione tensiometri Jet Fill
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI ELABORATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI ELABORATO
4 STIMA DELL'EVAPOTRASPIRAZIONE NEI MODELLI CONCETTUALI
 4 STIMA DELL'EVAPOTRASPIRAZIONE NEI MODELLI CONCETTUALI 4.1 Premesse (Rif.: [3]) Con il termine di evapotraspirazione si intende l acqua che complessivamente si trasferisce dal bacino idrografico all atmosfera
4 STIMA DELL'EVAPOTRASPIRAZIONE NEI MODELLI CONCETTUALI 4.1 Premesse (Rif.: [3]) Con il termine di evapotraspirazione si intende l acqua che complessivamente si trasferisce dal bacino idrografico all atmosfera
Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo
 Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Torino, 9-10 Ottobre 2013 Stefano LO RUSSO DIATI Dipartimento di Ingegneria dell Ambiente, del Territorio
Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Torino, 9-10 Ottobre 2013 Stefano LO RUSSO DIATI Dipartimento di Ingegneria dell Ambiente, del Territorio
PROVE D INFILTRAZIONE IN TERRENI PIROCLASTICI FINALIZZATE ALLO STUDIO DELLA CONDIZIONE AL CONTORNO INFERIORE
 PROVE D INFILTRAZIONE IN TERRENI PIROCLASTICI FINALIZZATE ALLO STUDIO DELLA CONDIZIONE AL CONTORNO INFERIORE Alfredo Reder Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) Università di Napoli
PROVE D INFILTRAZIONE IN TERRENI PIROCLASTICI FINALIZZATE ALLO STUDIO DELLA CONDIZIONE AL CONTORNO INFERIORE Alfredo Reder Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) Università di Napoli
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
AGGIORNAMENTO DATI DI QUALITÀ DELL ARIA
 RETE EDISON DI ALTOMONTE AGGIORNAMENTO DATI DI QUALITÀ DELL ARIA ANNO 2016 ARIA Redatto dalla dr.ssa Claudia Tuoto e dalla dr.ssa Maria Anna Caravita ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell
RETE EDISON DI ALTOMONTE AGGIORNAMENTO DATI DI QUALITÀ DELL ARIA ANNO 2016 ARIA Redatto dalla dr.ssa Claudia Tuoto e dalla dr.ssa Maria Anna Caravita ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Tesi di laurea triennale in Ingegneria per l Ambiente e il
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Tesi di laurea triennale in Ingegneria per l Ambiente e il
I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica
 I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica Con i sistemi geotermici a bassa temperatura, l utilizzo del terreno come sorgente termica, tramite una moderna pompa di calore,
I sistemi geotermici a bassa temperatura: il terreno come sorgente termica Con i sistemi geotermici a bassa temperatura, l utilizzo del terreno come sorgente termica, tramite una moderna pompa di calore,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE ABSTRACT RESISTENZA DI TERRENI PIROCLASTICI IN CONDIZIONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE ABSTRACT RESISTENZA DI TERRENI PIROCLASTICI IN CONDIZIONI
AUTUNNO ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto.
 AUTUNNO 2010 ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto. Nella mappa riportata in Figura 1 sono indicati i corpi idrici di transizione
AUTUNNO 2010 ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto. Nella mappa riportata in Figura 1 sono indicati i corpi idrici di transizione
VALIDAZIONE DEGLI ABACHI PER LA STIMA DELL AMPLIFICAZIONE LITO-STRATIGRAFICA PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO II DELLA REGIONE
 VALIDAZIONE DEGLI ABACHI PER LA STIMA DELL AMPLIFICAZIONE LITO-STRATIGRAFICA PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO II DELLA ABACHI Procedure semplificate volte alla stima dell amplificazione
VALIDAZIONE DEGLI ABACHI PER LA STIMA DELL AMPLIFICAZIONE LITO-STRATIGRAFICA PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO II DELLA ABACHI Procedure semplificate volte alla stima dell amplificazione
4 - L'ACQUA NEL TERRENO
 4 - L'ACQUA NEL TERRENO 4.1 - GENERALITA' I terreni sono costituiti da una parte solida e da uno o più fluidi (acqua e/o aria). L'acqua contenuta nei vuoti del terreno può trovarsi in stato di quiete (condizioni
4 - L'ACQUA NEL TERRENO 4.1 - GENERALITA' I terreni sono costituiti da una parte solida e da uno o più fluidi (acqua e/o aria). L'acqua contenuta nei vuoti del terreno può trovarsi in stato di quiete (condizioni
TERMODINAMICA. Studia le trasformazioni dei sistemi in relazione agli scambi di calore e lavoro. GENERALITÀ SUI SISTEMI TERMODINAMICI
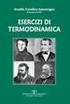 TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
TERMODINAMICA Termodinamica: scienza che studia le proprietà e il comportamento dei sistemi, la loro evoluzione e interazione con l'ambiente esterno che li circonda. Studia le trasformazioni dei sistemi
Compressibilità edometrica di terreni parzialmente saturi
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE SOMMARIO DELL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE SOMMARIO DELL
Guido Rianna Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici(CMCC)
 CENTRO EURO--MEDI ITERRANEO PER I CAMBIAMENTII CLIMATIICI I ISC Divisione Impatti sul Suolo e sulle Coste Technical Reports Modellazione dei processi di filtrazione nel suolo tramite codici di calcolo
CENTRO EURO--MEDI ITERRANEO PER I CAMBIAMENTII CLIMATIICI I ISC Divisione Impatti sul Suolo e sulle Coste Technical Reports Modellazione dei processi di filtrazione nel suolo tramite codici di calcolo
EFFETTO DELL ATTRITO LATERALE NELLA PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
 EFFETTO DELL ATTRITO LATERALE NELLA PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA luigi.mongiovi.ing@gmail.com Sommario Nella prova di compressione edometrica la principale causa di errore sperimentale è l attrito
EFFETTO DELL ATTRITO LATERALE NELLA PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA luigi.mongiovi.ing@gmail.com Sommario Nella prova di compressione edometrica la principale causa di errore sperimentale è l attrito
Capacità di infiltrazione dell AFI di Tezze
 Capacità di infiltrazione dell AFI di Tezze M. Mastrocicco 1, N. Colombani 2 1 DISTABIF, Seconda Università di Napoli 1 Dip. Di ScienzedellaTerra, Sapienza Università di Roma RICARICA ARTIFICIALE: PERCHE?
Capacità di infiltrazione dell AFI di Tezze M. Mastrocicco 1, N. Colombani 2 1 DISTABIF, Seconda Università di Napoli 1 Dip. Di ScienzedellaTerra, Sapienza Università di Roma RICARICA ARTIFICIALE: PERCHE?
Assetto strutturale e movimento dei fluidi nel sistema idrotermale di Acquasanta Terme : dati e modelli numerici
 Assetto strutturale e movimento dei fluidi nel sistema idrotermale di Acquasanta Terme : dati e modelli numerici Convegno Nazionale Acquasanta Terme (AP) 25 gennaio 2014 Assetto strutturale e movimento
Assetto strutturale e movimento dei fluidi nel sistema idrotermale di Acquasanta Terme : dati e modelli numerici Convegno Nazionale Acquasanta Terme (AP) 25 gennaio 2014 Assetto strutturale e movimento
UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERISITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
RETE EDISON DI ALTOMONTE
 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Aria RETE EDISON DI ALTOMONTE Aggiornamento dati di Qualità dell Aria Anno 2018 ARIA Report
Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Aria RETE EDISON DI ALTOMONTE Aggiornamento dati di Qualità dell Aria Anno 2018 ARIA Report
RETE EDISON DI ALTOMONTE
 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Aria RETE EDISON DI ALTOMONTE Aggiornamento dati di Qualità dell Aria Anno 2017 ARIA Report
Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Aria RETE EDISON DI ALTOMONTE Aggiornamento dati di Qualità dell Aria Anno 2017 ARIA Report
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
STRATEGIE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER LA GESTIONE DEI RISCHI NATURALI STRADA STATO DI AVANZAMENTO AZIONE 2.2
 STRATEGIE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER LA GESTIONE DEI RISCHI NATURALI STRADA STATO DI AVANZAMENTO AZIONE 2.2 Ing. Secondo BARBERO Arpa Piemonte Dipartimento Sistemi Previsionali Comitato
STRATEGIE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER LA GESTIONE DEI RISCHI NATURALI STRADA STATO DI AVANZAMENTO AZIONE 2.2 Ing. Secondo BARBERO Arpa Piemonte Dipartimento Sistemi Previsionali Comitato
INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE SINTESI DELL
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE SINTESI DELL
Regione Calabria ARPACAL. Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria
 Regione Calabria ARPACAL Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELLA CALABRIA (Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Legge n. 100
Regione Calabria ARPACAL Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Calabria CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELLA CALABRIA (Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Legge n. 100
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ D INGEGNERIA INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ D INGEGNERIA INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale ABSTRACT Definizione di una correlazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ D INGEGNERIA INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale ABSTRACT Definizione di una correlazione
Alfredo Reder. Libero professionista. Curriculum Vitae Alfredo Reder INFORMAZIONI PERSONALI
 INFORMAZIONI PERSONALI Alfredo Reder Via Manzoni 216, 80123 Napoli (NA) (Italia) alfredo.reder@unina.it ; alfredo.reder@cmcc.it PEC alfredo.reder@ordingna.it Sesso Maschile Data di nascita 27/08/1987 Nazionalità
INFORMAZIONI PERSONALI Alfredo Reder Via Manzoni 216, 80123 Napoli (NA) (Italia) alfredo.reder@unina.it ; alfredo.reder@cmcc.it PEC alfredo.reder@ordingna.it Sesso Maschile Data di nascita 27/08/1987 Nazionalità
Facoltà di Ingegneria. Presentazione delle attività svolte nel settore Difesa del Suolo:
 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Foto della torre di piazzale Tecchio Presentazione delle attività svolte nel settore Difesa del Suolo: Prof. Ing. Gianfranco Urciuoli,
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Foto della torre di piazzale Tecchio Presentazione delle attività svolte nel settore Difesa del Suolo: Prof. Ing. Gianfranco Urciuoli,
Idraulica e Idrologia: Lezione 5
 Idraulica e Idrologia: Lezione 5 Agenda del giorno - Modello CN-SCS: ESERCIZI 1 MODELLO CN - SCS MODELLAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL DEFLUSSO: METODO CN-SCS I modelli di piena sono formati da due moduli
Idraulica e Idrologia: Lezione 5 Agenda del giorno - Modello CN-SCS: ESERCIZI 1 MODELLO CN - SCS MODELLAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL DEFLUSSO: METODO CN-SCS I modelli di piena sono formati da due moduli
SISMICITÀ NATURALE E INDOTTA A THE GEYSERS, CALIFORNIA: PROPRIETÀ DELLA FRATTURAZIONE E PERICOLOSITÀ SISMICA
 SISMICITÀ NATURALE E INDOTTA A THE GEYSERS, CALIFORNIA: PROPRIETÀ DELLA FRATTURAZIONE E PERICOLOSITÀ SISMICA Aldo Zollo (1), Nitin Sharma(1), Vincenzo Convertito(2), Antonio Emolo(1) (1) Dipartimento di
SISMICITÀ NATURALE E INDOTTA A THE GEYSERS, CALIFORNIA: PROPRIETÀ DELLA FRATTURAZIONE E PERICOLOSITÀ SISMICA Aldo Zollo (1), Nitin Sharma(1), Vincenzo Convertito(2), Antonio Emolo(1) (1) Dipartimento di
GESTIONE delle RISORSE IDRICHE
 Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 3-4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale - DIAM IL TRASPORTO
Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 3-4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale - DIAM IL TRASPORTO
Lezione 4 GEOTECNICA. Docente: Ing. Giusy Mitaritonna
 Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
Lezione 4 GEOTECNICA Docente: Ing. Giusy Mitaritonna e-mail: g.mitaritonna@poliba.it - Lezione 4 A. Cenni sul moto di filtrazione nelle terre B. Tensioni efficaci in presenza di forze di filtrazione C.
Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Alghero
 Alghero, 25 giugno 2018 Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Alghero Guido Rianna, Paola Mercogliano Fondazione CMCC-REMHI Il cambiamento climatico è un fenomeno
Alghero, 25 giugno 2018 Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Alghero Guido Rianna, Paola Mercogliano Fondazione CMCC-REMHI Il cambiamento climatico è un fenomeno
INVOLUCRO: progettazione, simulazione e monitoraggio di due edifici test
 INVOLUCRO: progettazione, simulazione e monitoraggio di due edifici test Prof. Massimo Garai CIRI EC Arena Regione Europa spazi di cambiamento SAIE 2018 19 ottobre 2018 INTRODUZIONE PROGETTO INVOLUCRO
INVOLUCRO: progettazione, simulazione e monitoraggio di due edifici test Prof. Massimo Garai CIRI EC Arena Regione Europa spazi di cambiamento SAIE 2018 19 ottobre 2018 INTRODUZIONE PROGETTO INVOLUCRO
DI IDROLOGIA TECNICA PARTE III
 FACOLTA DI INGEGNERIA Laurea Specialistica in Ingegneria Civile N.O. Giuseppe T. Aronica CORSO DI IDROLOGIA TECNICA PARTE III Idrologia delle piene Lezione XI: Generalità Generalità Piena: significativo
FACOLTA DI INGEGNERIA Laurea Specialistica in Ingegneria Civile N.O. Giuseppe T. Aronica CORSO DI IDROLOGIA TECNICA PARTE III Idrologia delle piene Lezione XI: Generalità Generalità Piena: significativo
Meccanica delle Terre Geotecnica Prova scritta di esame
 # 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
# 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
Figura 1: ubicazione del laboratorio mobile all interno dell area di competenza dell istituto; cerchiata l area di posizionamento.
 Andamento della qualità dell aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile presso la Scuola Capasso ubicata in via Alcide De Gasperi, Acerra (NA) Il monitoraggio della qualità dell aria
Andamento della qualità dell aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile presso la Scuola Capasso ubicata in via Alcide De Gasperi, Acerra (NA) Il monitoraggio della qualità dell aria
simulazioni fluidodinamiche di scambiatori a pacco alettato
 u efficienza energetica u simulazioni fluidodinamiche di scambiatori a pacco alettato Matteo Totaro, Luca Cogo Ufficio tecnico Aermec, Bevilacqua (VR) Gli scambiatori a pacco alettato rivestono un ruolo
u efficienza energetica u simulazioni fluidodinamiche di scambiatori a pacco alettato Matteo Totaro, Luca Cogo Ufficio tecnico Aermec, Bevilacqua (VR) Gli scambiatori a pacco alettato rivestono un ruolo
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE
 POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Original Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Original Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo
Situazione meteorologica
 Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
Situazione meteorologica Ad integrazione della presentazione dei dati rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell aria, si riportano in maniera sintetica i dati relativi ai parametri meteorologici
SVILUPPO DI PIATTAFORMA MODELLISTICA DI PREVISIONE DELLE PIENE IN TEMPO REALE NEL FIUME ARNO
 SVILUPPO DI PIATTAFORMA MODELLISTICA DI PREVISIONE DELLE PIENE IN TEMPO REALE NEL FIUME ARNO Ing. ENZO DI CARLO REGIONE TOSCANA CFR Ing. DARIO TRICOLI RUWA SRL STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SICCITA
SVILUPPO DI PIATTAFORMA MODELLISTICA DI PREVISIONE DELLE PIENE IN TEMPO REALE NEL FIUME ARNO Ing. ENZO DI CARLO REGIONE TOSCANA CFR Ing. DARIO TRICOLI RUWA SRL STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SICCITA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI DELL ELABORATO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI DELL ELABORATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7)
Richiesta di energia elettrica
 GWh Luglio, 2015 Lo scenario energetico 2014 ed il primo semestre 2015 1 Il quadro dell energia elettrica in Italia si è chiuso nel 2014 con due elementi caratteristici: l ulteriore riduzione della domanda
GWh Luglio, 2015 Lo scenario energetico 2014 ed il primo semestre 2015 1 Il quadro dell energia elettrica in Italia si è chiuso nel 2014 con due elementi caratteristici: l ulteriore riduzione della domanda
VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA
 Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
Associazione Italiana di Acustica 38 Convegno Nazionale Rimini, 08-10 giugno 2011 VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO PER INCIDENZA DIFFUSA UTILIZZANDO UNA SORGENTE SONORA DI POTENZA NOTA Paolo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E
Federico Spanna. Regione Piemonte Settore Fitosanitario Sezione di Agrometeorologia
 Federico Spanna Regione Piemonte Settore Fitosanitario Sezione di Agrometeorologia Obiettivi Bilancio Idrico del Nocciolo Verifica di attendibilità del metodo Regolazione dell apporto idrico per irrigazione
Federico Spanna Regione Piemonte Settore Fitosanitario Sezione di Agrometeorologia Obiettivi Bilancio Idrico del Nocciolo Verifica di attendibilità del metodo Regolazione dell apporto idrico per irrigazione
Scenari del cambiamento climatico in Italia: esiti delle ricerche più recenti
 Scenari del cambiamento climatico in Italia: esiti delle ricerche più recenti Bologna, 18 Novembre 2017 Paola Mercogliano CMCC Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Divisione REMHI
Scenari del cambiamento climatico in Italia: esiti delle ricerche più recenti Bologna, 18 Novembre 2017 Paola Mercogliano CMCC Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Divisione REMHI
In realtà la T(x) è differente non essendo il flusso monodimensionale (figura 4.3).
 Richiami sui ponti termici (cap. 4) Autore: prof. ing. Francesco Minichiello, Università degli Studi di Napoli Federico II Anno di compilazione: 2005 Nota: si ringrazia vivamente il prof. ing. Pietro Mazzei,
Richiami sui ponti termici (cap. 4) Autore: prof. ing. Francesco Minichiello, Università degli Studi di Napoli Federico II Anno di compilazione: 2005 Nota: si ringrazia vivamente il prof. ing. Pietro Mazzei,
ANALISI DELL ANDAMENTO METEOROLOGICO DEL MESE DI OTTOBRE 2018 NELLA REGIONE ABRUZZO
 SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO Ufficio direttiva nitrati e qualità dei suoli, coordinamento servizi vivaistici e agrometeo (Cepagatti - Scerni) ANALISI DELL ANDAMENTO METEOROLOGICO
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO Ufficio direttiva nitrati e qualità dei suoli, coordinamento servizi vivaistici e agrometeo (Cepagatti - Scerni) ANALISI DELL ANDAMENTO METEOROLOGICO
ANPE - 2a Conferenza Nazionale
 Temperature di esercizio delle coperture Francesca Cappelletti Piercarlo Romagnoni OUTLINE - Premessa - Obiettivi e metodo - Indagini sperimentali - Indagini numeriche - Discussione dei risultati 2 Cosa
Temperature di esercizio delle coperture Francesca Cappelletti Piercarlo Romagnoni OUTLINE - Premessa - Obiettivi e metodo - Indagini sperimentali - Indagini numeriche - Discussione dei risultati 2 Cosa
Tabella riassuntiva Fabbisogno finanziario 2002
 Tabella riassuntiva Fabbisogno finanziario 2002 N Scheda Progetto Linee Obiettivi Periodo Fabbisogno 2002 1 Piattaforma Miglioramento della fruibilità 2002 130000 Web-GIS per dell informazione contenuta
Tabella riassuntiva Fabbisogno finanziario 2002 N Scheda Progetto Linee Obiettivi Periodo Fabbisogno 2002 1 Piattaforma Miglioramento della fruibilità 2002 130000 Web-GIS per dell informazione contenuta
questi elementi strutturali, affrancando il progettista dalla determinazione del campo termico indotto dall incendio all interno delle colonne stesse.
 ABSTRACT La verifica di sicurezza delle strutture in condizioni di incendio è necessaria quando il rischio di incendio non è trascurabile ed il danneggiamento strutturale può avere conseguenze inaccettabili
ABSTRACT La verifica di sicurezza delle strutture in condizioni di incendio è necessaria quando il rischio di incendio non è trascurabile ed il danneggiamento strutturale può avere conseguenze inaccettabili
La turbolenza e il suo ruolo nello Strato Limite Atmosferico
 Copertina Corso di Fisica dello Strato Limite Atmosferico La turbolenza e il suo ruolo nello Strato Limite Atmosferico Giaiotti Dario & Stel Fulvio 1 Sommario della lezione Che cos'è la turbolenza nei
Copertina Corso di Fisica dello Strato Limite Atmosferico La turbolenza e il suo ruolo nello Strato Limite Atmosferico Giaiotti Dario & Stel Fulvio 1 Sommario della lezione Che cos'è la turbolenza nei
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura
 Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura AUTORI: Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura AUTORI: Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura
 Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università Telematica
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura Antonio Formisano, Ricercatore Università di Napoli Federico II Francesco Fabbrocino, Ricercatore Università Telematica
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI Con riferimento alla allegata relazione geologica e geotecnica redatta dal dott. Geol Samuel Sangiorgi per la nuova scuola elementare di Renazzo posta ad una distanza di circa
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI Con riferimento alla allegata relazione geologica e geotecnica redatta dal dott. Geol Samuel Sangiorgi per la nuova scuola elementare di Renazzo posta ad una distanza di circa
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO ABSTRACT SIMULAZIONE NUMERICA DEL MOTO ATTRAVERSO L INTERFACCIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO ABSTRACT SIMULAZIONE NUMERICA DEL MOTO ATTRAVERSO L INTERFACCIA
Misure idrologiche. Ing. Antonino Cancelliere. Variabili idrologiche
 Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Corso di Costruzioni Idrauliche A.A. 2004-05 www.dica.unict.it/users/costruzioni Misure idrologiche Ing. Antonino Cancelliere Dipartimento
Corso di Laurea in Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio Corso di Costruzioni Idrauliche A.A. 2004-05 www.dica.unict.it/users/costruzioni Misure idrologiche Ing. Antonino Cancelliere Dipartimento
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica Dipartimento di Ingegneria Geotecnica Tesi di laurea Fondazioni miste platee su
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica Dipartimento di Ingegneria Geotecnica Tesi di laurea Fondazioni miste platee su
Elenco delle figure. Elenco delle tabelle
 Indice Elenco delle figure Elenco delle tabelle Prefazione ix xv xvii 1 Introduzione 1 1.1 Vento globale... 1 1.2 Vento locale... 2 1.3 Risposta aerodinamica della struttura... 2 1.4 Risposta meccanica
Indice Elenco delle figure Elenco delle tabelle Prefazione ix xv xvii 1 Introduzione 1 1.1 Vento globale... 1 1.2 Vento locale... 2 1.3 Risposta aerodinamica della struttura... 2 1.4 Risposta meccanica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA E AMBIENTALE
Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Sassari
 Sassari, 26 giugno 2018 Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Sassari Guido Rianna, Paola Mercogliano Fondazione CMCC Il cambiamento climatico è un fenomeno in
Sassari, 26 giugno 2018 Scenari di cambiamento climatico in ambiente urbano con un focus sulla città di Sassari Guido Rianna, Paola Mercogliano Fondazione CMCC Il cambiamento climatico è un fenomeno in
La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio del CNR-ISAFOM
 Associazione Italiana Pedologi CORSO BREVE PER L AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO IN FISICA E IDROLOGIA DEL SUOLO 4 5 Giugno 2009 - Ercolano La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio
Associazione Italiana Pedologi CORSO BREVE PER L AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO IN FISICA E IDROLOGIA DEL SUOLO 4 5 Giugno 2009 - Ercolano La misura delle proprietà idrauliche dei suoli nel laboratorio
Forme di energia energia accumulata energia interna, energia esterna energia in transito calore, lavoro
 Forme di energia energia accumulata energia interna, energia esterna energia in transito calore, lavoro alore definizione operativa, capacità termica, calori specifici Lavoro lavoro di configurazione,
Forme di energia energia accumulata energia interna, energia esterna energia in transito calore, lavoro alore definizione operativa, capacità termica, calori specifici Lavoro lavoro di configurazione,
ANALISI DEGLI EFFETTI DELLE PIOGGE SULLE PRESSIONI NEUTRE IN PENDII ARGILLOSI
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica TESI DI LAUREA IN STABILITA DEI PENDII E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANALISI DEGLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica TESI DI LAUREA IN STABILITA DEI PENDII E SICUREZZA DEL TERRITORIO ANALISI DEGLI
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Integrazione di misure idrometriche in alveo per il monitoraggio delle portate e dei parametri di resistenza idraulica di un corso d'acqua
 La ricerca scientifica italiana nel campo dell idraulica: presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 Ferrara, 24-25 gennaio 2013 Integrazione di misure idrometriche in alveo per il monitoraggio
La ricerca scientifica italiana nel campo dell idraulica: presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 Ferrara, 24-25 gennaio 2013 Integrazione di misure idrometriche in alveo per il monitoraggio
ANALISI DELL EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI NELL AREA DI TARANTO
 GEOLOGI e TERRITORIO Periodico dell Ordine dei Geologi della Puglia n. 3-4/2007, pp. 109-115 109 ANALISI DELL EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI NELL AREA DI TARANTO Claudio Cherubini
GEOLOGI e TERRITORIO Periodico dell Ordine dei Geologi della Puglia n. 3-4/2007, pp. 109-115 109 ANALISI DELL EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI NELL AREA DI TARANTO Claudio Cherubini
eseguito in Comune di... Località.. Via... n.. CAP... Comune Catastale.. Foglio n. Mappale o Particella. DICHIARA
 MODULO 9 DICHIARAZIONE / ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO DI CONGRUITA' DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI REQUISITI RICHIESTI DAL PUNTO 6.2.1 DELLE N.T.C. DM 14/01/08 e/o DALLA D.G.R. IX 2616/2011 Il
MODULO 9 DICHIARAZIONE / ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO DI CONGRUITA' DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI REQUISITI RICHIESTI DAL PUNTO 6.2.1 DELLE N.T.C. DM 14/01/08 e/o DALLA D.G.R. IX 2616/2011 Il
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA GEOTECNICA ED AMBIENTALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA GEOTECNICA ED AMBIENTALE
SETTORE ACQUE OSSERVATORIO ALTO ADRIATICO
 SETTORE ACQUE Copertura: regionale Frequenza: trimestrale OSSERVATORIO ALTO ADRIATICO www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
SETTORE ACQUE Copertura: regionale Frequenza: trimestrale OSSERVATORIO ALTO ADRIATICO www. arpa.veneto.it Rapporto di sintesi sugli andamenti dei principali parametri oceanografici e meteo-marini delle
NTC 2018 e MS3. Un incontro possibile?
 NTC 2018 e MS3 Un incontro possibile? Ing. Roberto Di Girolamo Via G. di Giovanni 10B 62032 Camerino (MC) mail: rdigirolamo@tin.it port.: +393356394081 Skype: roberto.di.girolamo 1 MS3 Dall Ordinanza 24
NTC 2018 e MS3 Un incontro possibile? Ing. Roberto Di Girolamo Via G. di Giovanni 10B 62032 Camerino (MC) mail: rdigirolamo@tin.it port.: +393356394081 Skype: roberto.di.girolamo 1 MS3 Dall Ordinanza 24
CONFRONTO FRA L'AZIONE DI TRINCEE E PALI DRENANTI
 CONFRONTO FRA L'AZIONE DI TRINCEE E PALI DRENANTI F. Aloi Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università degli Studi di Napoli Federico II ferdinando.aloi@unina.it M. Pirone Dipartimento
CONFRONTO FRA L'AZIONE DI TRINCEE E PALI DRENANTI F. Aloi Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università degli Studi di Napoli Federico II ferdinando.aloi@unina.it M. Pirone Dipartimento
Indice RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA INDAGINI GEOGNOSTICHE MODELLO GEOTECNICO VALORI CARATTERISTICI... 5
 Indice RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA... 2 Introduzione... 2 1. INDAGINI GEOGNOSTICHE... 3 2. MODELLO GEOTECNICO... 3 3. VALORI CARATTERISTICI... 5 4. ANALISI SISMICA... 7 Parametri sismici... 7 Combinazioni
Indice RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA... 2 Introduzione... 2 1. INDAGINI GEOGNOSTICHE... 3 2. MODELLO GEOTECNICO... 3 3. VALORI CARATTERISTICI... 5 4. ANALISI SISMICA... 7 Parametri sismici... 7 Combinazioni
A2.1 - Tabelle per il calcolo dei fattori di amplificazione sismica (secondo livello di approfondimento)
 TABELLE E FORMULE PER LA STIMA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) DI CUI ALL OCDPC 532/2018. A2.1 - Tabelle per il calcolo dei
TABELLE E FORMULE PER LA STIMA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) DI CUI ALL OCDPC 532/2018. A2.1 - Tabelle per il calcolo dei
