ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
|
|
|
- Michela Rossetti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia Patria per la Puglia SAN SEVERO 1997 Stampa: Centro Grafi co S.r.l. - Tel cofoggia.it
2 41 S. M. CASSANO* G. EYGUN**, I. MUNTONI* La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale *Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche ed Antropologiche dell'antichità - Università degli Studi di Roma La Sapienza ** Department d Ethnologie et Préhistorie - Université Paris - X Le comunità di villaggio del Tavoliere Nella presente nota 1 si illustrano i risultati delle prove sperimentali di riproduzione di alcune ceramiche neolitiche prodotte dalle numerose comunità di villaggio del Tavoliere di Puglia. In questa area, che costituisce la più grande pianura dell Italia meridionale, insediamenti neolitici sembrano comparire intorno alla fine del VII millennio a.c. già in possesso di tutte le caratteristiche di una economia produttiva, quali le specie domestiche animali e vegetali ed una vita presumibilmente sedentaria (BRADFORD 1957; JONES 1987; TINÈ, SIMONE 1984). La ceramica sembra avere fin dall inizio un ruolo importante sia per la sua frequenza nei singoli contesti, sia per l avanzato livello tecnologico già nelle forme più antiche, sia infine per il rapido processo di diversificazione in una tipologia molto varia entro un breve arco di tempo. Al contrario un pari sviluppo tecnologico non si avverte in 1 Il programma di sperimentazione ha avuto inizio nel 1992 presso l UREA - Laboratoire d Ethnologie de l Université de Nice) sotto la guida preziosa di Y. Garidel. I risultati sono stati oggetto di una precedente nota al European Meeting on Ancient Ceramics, tenutosi a Barcellona (Spagna) nel Novembre 1993 (CASSANO ET ALII 1995a) e sono qui riproposti in quanto sede più appropriata per temi di ricerca sul Tavoliere e in quanto la sperimentazione si è poi ampliata portando a risultati più puntuali (CASSANO ET ALII 1995c), anche integrandosi con i risultati di analisi archeometriche delle argille e degli impasti (CASSANO ET ALII 1995b; CASSANO ET ALII in stampa).
3 42 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni altri ambiti quali l industria litica, le tecniche di coltivazione e di allevamento, il modello insediamentale. Nell ambito degli scavi più ampi e sistematici condotti in alcuni dei numerosissimi insediamenti neolitici, quali Lagnano da Piede (MALLORY ), Masseria Candelaro (CASSANO, MANFREDINI 1983; CASSANO, MANFREDINI 1987), Passo di Corvo (TINÈ 1983) e Ripa Tetta (TOZZI, VEROLA 1990), le ceramiche hanno costituito il cardine per un primo fondamentale inquadramento della eccezionale moltitudine di siti entro fasi (Neolitico antico, medio e recente) rapportabili alla cronologia italiana e mediterranea, la cui durata datazioni assolute hanno poi contribuito a convalidare e precisare (WHITEHOUSE 1987). Alcuni parziali sfasamenti o apparenti sovrapposizioni lasciano sussistere dubbi nell ambito di microsequenze, probabilmente di significato soltanto locale. Nel presente programma di ricerca, si è ritenuto che la grande varietà di stili della produzione ceramica del Tavoliere racchiudesse anche potenziali informazioni sugli aspetti sociali e organizzativi delle comunità neolitiche. Questa ipotesi ha indotto ad avviare una serie di ricerche in una prospettiva soprattutto tecnologica con analisi archeometriche degli impasti, ma anche con prove sperimentali di riproduzione di alcuni tipi 2 supportate anche da dati etnoarcheologici tratti da situazioni confrontabili, e infine con analisi tecnologiche degli aspetti più strettamente connessi alla ricostruzione della catena operativa di fabbricazione di alcune tipologie formali 3. Tali ricerche naturalmente non dovrebbero essere limitate alle realtà di singoli villaggi, mentre risposte significative potranno ottenersi da campionature sistematiche tratte da insediamenti diversi e da aree anche distanti del Tavoliere. È realizzabile una nuova prospettiva? Sulla base di queste considerazioni si è avviato il lavoro sperimentale, integrandolo con analisi tecnologiche e con ricerche che possano chiarire il contesto sociale delle tecniche di fabbricazione e distinguendo i seguenti livelli di analisi: 2 Una prima serie di analisi archeometriche su 57 campioni di ceramiche neolitiche del Tavoliere è stata condotta sugli insediamenti di Amendola, Guadone, Passo di Corvo e Scaloria (MANNONI 1980; MANNONI 1983), così come riproduzioni sperimentali sono state effettuate su ceramiche tipo Passo di Corvo e Scaloria rivolte soprattutto a ricostruire alcune particolari tecniche decorative dipinte (NOVELLI 1980; SIMONE, NOVELLI 1983). 3 EYGUN in stampa; MUNTONI 1995a.
4 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 43 l analisi geologica volta a definire le potenzialità dell ambiente della ceramica evidenziando l entità ed i limiti dello sfruttamento delle risorse durante il Neolitico. la ricostruzione della catena operativa seguita nella fabbricazione della ceramica che dovrebbe avvicinare alla comprensione sia del livello tecnologico, sia del ruolo del ceramista come figura attiva e determinante nei singoli processi di fabbricazione del vaso. la ricerca sugli aspetti economici della produzione e sugli adattamenti socio-organizzativi coinvolti nell attività del vasaio, nell uso e nella distribuzione delle ceramiche. le analisi archeometriche degli impasti e delle argille effettuate su una campionatura sufficientemente ampia e spazialmente organizzata si integreranno a vari livelli con i precedenti punti 4. La sperimentazione come punto di partenza L archeologia sperimentale intesa come metodo diretto a realizzare nel presente processi che pensiamo siano avvenuti nel passato (VAN DER LEEUW 1991) è la via più efficace per affrontare lo studio tecnologico cui sopra si è accennato. Repliche sperimentali sono anche utilizzate come fonti di analogia utili alla comprensione del record archeologico (SCHIFFER, SKIBO 1987). Tuttavia dal punto di vista adottato in questa ricerca, l archeologia sperimentale non implica automaticamente che esista un solo processo per raggiungere il risultato noto, né che questo processo possa essere interamente ricostruito, ma piuttosto che: a) possono esserci stati diversi modi consapevoli e sperimentati per raggiungere un dato risultato; b) ogni vaso rappresenta l esito di un processo creativo che riflette il livello tecnologico ed i modelli culturali del gruppo, oltre alle scelte individuali; c) non tutte le conoscenze tecnologiche sono così esplicite da poter essere colte ed interpretate da chiunque pratichi la sperimentazione (SCHIFFER, SKIBO 1987); d) è ineliminabile inoltre la componente della soggettività del ricercatore nel tentare di riprodurre oggetti del passato, anche quando la metodologia adottata aspiri al massimo livello di obiettività. 4 Durante la fase iniziale del progetto le prime analisi archeometriche erano ancora in corso per cui la relazione presentata nel 1993 furono illustrati soprattutto i risultati relativi al secondo punto.
5 44 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni A causa di questa inevitabile soggettività, si potrebbe considerare l archeologia sperimentale come il metodo più adatto a cogliere le variabili che possano essersi presentate nel processo di fabbricazione. Data la notevole importanza che si attribuisce in questa sede alle scelte individuali o ai valori e comportamenti della comunità nel lavoro del vasaio, si considera la sperimentazione molto utile non solo quando tali varianti possano essere esattamente riprodotte, ma soprattutto quando più variabili, legate alle scelte del vasaio, possano essere messe in evidenza: Esplorare tutte le scelte che si presentino al singolo vasaio, costituisce la maggiore possibilità di capire il perché di singole scelte (LONGACRE 1991a). Nell ambito degli studi sulla ceramica neolitica, e più in generale in quelli sulla produzione vascolare in società non complesse, è possibile cogliere le interrelazioni esistenti tra quattro ambiti distinti: 1) La sfera materiale che comprende l insieme dei fattori deterministici, quali il tipo di materie prime disponibili, le possibilità ed i limiti climatici ed ambientali, ecc. 2) La sfera tecnologica, che comprende tutte le azioni e decisioni, che si allineano in una sequenza ordinata, ma flessibile, di operazioni: ricerca delle materie prime, loro preparazione, montaggio del vaso, trattamento di superficie, cottura e raffreddamento. 3) La sfera funzionale che coinvolge tutte le norme ed esigenze legate all utilizzo di un singolo o di una categoria di vasi. 4) La sfera cognitiva in cui la ceramica è connessa a scelte individuali o di gruppo a loro volta riconducibili a più ampie motivazioni socio-ideologiche. Dal punto di vista qui adottato, l archeologia sperimentale dovrebbe facilitare la definizione delle prime due sfere, le quali a loro volta dovrebbero aprire prospettive di interpretazione per quanto riguarda le altre due. Ogni sfera è comunque da ritenersi una fonte paritetica ed interattiva di variabilità. La produzione ceramica Alla luce delle conoscenze fino ad ora acquisite sui processi di manifattura ceramica delle comunità neolitiche del Tavoliere (MUNTONI 1995b), il programma di sperimentazione (Fig. 1) è stato sviluppato con due assunti di base. In primo luogo è stato ipotizzato che ciascun villaggio producesse la propria ceramica, probabilmente a livello di singole unità familiari, e che i vasi potessero essere oggetto di scambio tra comunità diverse. In secondo luogo si è supposto che i ceramisti usassero argille affioranti nei pressi dei rispettivi villaggi o almeno le più accessibili dal luogo di manifattura.
6 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 45 TAB. 1 - ELENCO DEI CAMPIONI DI ARGILLA UTILIZZATI E LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI. N. Località Carta Coordinate Sigla descrizione della formazione I.G.M. 1 Posta Ferrara 164 I SO 33TWG Q 2 M Sabbie argillose con concrezioni calcaree e molluschi marini, di facies litorale. Pleistocene. 2 Mass. Coppa Nevigata 164 I SE 33TWG Q Argille alluvionali recenti. Olocene. 3 Mass. Santa Tecchia 164 I SO 33TWF Q Argille alluvionali recenti. Olocene. 4 Mass. Santa Tecchia 164 I SO 33TWF Q Argille alluvionali recenti. Olocene. 5 Monte Ripa Tetta 163 II SE 33TWF PQa Argille scistose e marnose giallastre. Pliocene. 6 Monte Ripa Tetta 163 II SE 33TWF PQa Argille scistose e marnose grigio-azzurre. Pliocene. Le argille utilizzate (Tab. 1) sono state campionate nelle zone pedemontana e costiera del Tavoliere nelle quali sono rispettivamente localizzati i villaggi di Ripa Tetta e quelli di Masseria Candelaro e Coppa Nevigata (Fig. 2), oggetto di scavi estensivi e di specifiche ricerche archeometriche sulle produzioni ceramiche. Nella prima area sono stati prelevati due campioni (nn. 5-6) dai depositi argillosi pliocenici affioranti immediatamente a ridosso del sito e per molti anni oggetto di coltivazione per la realizzazione di laterizi: il primo di colore giallastro, nella parte superiore dell affioramento, ed il secondo di colore grigio azzurro, dalla parte inferiore. Dalla seconda area, quella costiera, provengono invece quattro campioni, due dei quali (nn. 1-2) da sedimenti clastici pleistocenici ed olocenici sul margine dell antica laguna litoranea lungo la quale si distribuiscono i villaggi neolitici, e gli altri due (nn. 4-5) dai depositi alluvionali attuali nell area della laguna ora bonificata. Come materiali coloranti, infine, sono stati utilizzati due campioni di terre, molto ricche in ossidi di ferro, di colore rosso e giallastro, prelevati sulle pendici del promontorio del Gargano. I campioni utilizzati possono essere considerati sufficientemente indicativi, almeno da un punto di vista tecnologico, dei diversi tipi di argille affioranti nell area del Tavoliere (DELL ANNA ET ALII 1974) le quali possono
7 46 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni essere raggruppate in due tipi principali (LAVIANO 1995). Lungo la fascia pedemontana dell Appennino, così come lungo la depressione bradanica, affiorano le argille subappennine di età plio-pleistocenica. Si tratta di argille siltose e marnose di origine sedimentaria, che presentano una composizione mineralogica piuttosto uniforme, mentre maggiormente variabile, anche all interno di uno stesso affioramento, appare il rapporto tra frazione argillosa e siltosa; decisamente subordinata appare quella sabbiosa (BALENZANO ET ALII 1977; DONDI ET ALII 1992). I depositi affioranti invece nell area costiera sono piuttosto diversificati, di formazione marina ed alluvionale, complessivamente risalenti al pleistocene-olocene. I depositi prettamente argillosi sono costituiti da silt argillosi, con una maggiore presenza di sabbia, a composizione maggiormente variabile, in rapporto alla differente natura delle formazioni argillose e arenaceo - marnose incise dai numerosi corsi d acqua che ancora attualmente percorrono il Tavoliere in direzione O-E. La maggior parte delle argille campionate presentava una buona lavorabilità, sicché è stato deciso di testarle tal quali senza l aggiunta di smagranti intenzionali. I dati disponibili relativi alla preparazione degli impasti sono ancora piuttosto scarsi, anche se sono state individuate procedure differenziate sia in termini di diversa depurazione della materia prima (DELL ANNA 1986), sia in termini di aggiunta intenzionale di smagrante minerale (EYGUN in stampa). In attesa di più puntuali dati petrografici (CASSANO ET ALII 1994), relativi soprattutto ai campioni di ceramica dai siti oggetto di studio 5, è stato deciso in una prima fase della sperimentazione di non esplorare questo elemento di variabilità. Successivi test 6 sono stati effettuati sia con l aggiunta di sgrassanti sabbiosi in diverse percentuali, sia con miscele di argille diverse per ovviare all eccessiva o scarsa plasticità di alcune. La preparazione del corpo ceramico è stata effettuata con argilla umida, provvedendo ad eliminare le maggiori impurità sia minerali sia vegetali, e 5 Successivamente alla presentazione della comunicazione (Novembre 1993) e prima della redazione definitiva del testo (Dicembre 1996) si sono resi disponibili i risultati completi di analisi archeometriche su 79 campioni provenienti dai siti di Masseria Candelaro e Coppa Nevigata (Cassano et alii 1995b; Cassano et alii in stampa). 6 Nell inverno del 1995 venne organizzato, nell ambito delle attività seminariali del corso di Ecologia Preistorica ed Archeologia del Paleolitico ed in preparazione della mostra Dall argilla al vaso realizzata nel Museo delle Origini (CASSANO et alii 1995c), un secondo ciclo di sperimentazione con la guida della prof.ssa Karen D. Vitelli dell Indiana University (Usa).
8 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 47 amalgamando a mano il corpo argilloso, per renderlo più omogeneo. Solo il campione n. 1 proveniente dell area costiera e i due campioni di terre garganiche, contenendo una elevata percentuale di sabbia, sono stati fatti decantare in acqua per ottenerne una buona lavorabilità. Per la realizzazione del vaso sono state utilizzate le tecniche di montaggio a pressione e al colombino. Con la prima in particolare è stata ottenuta la base del vaso, opportunamente manipolando con un pugno o con le dita un grumo di pasta, mentre la seconda è stata utilizzata per la realizzazione delle pareti, sovrapponendo una serie di colombini, successivamente fusi tra loro con la pressione delle dita o con l utilizzo di una stecca. Durante tutto il montaggio il vaso è stato appoggiato su un anello in fibra vegetale o in tessuto (è la tecnica del puki attestata etnograficamente tra i Pueblo), oppure su una superficie concava, quale quella di un altro vaso o di un frammento. Associate alle tecniche primarie di montaggio, sono state adottate una serie di tecniche secondarie, sulle pareti già parzialmente essiccate, al fine di perfezionare la forma del vaso. Per regolarizzarne il profilo è stata utilizzata sia la tecnica della battitura con una spatola in legno, in alcuni casi utilizzando un ciottolo come incudine, sia quella della raschiatura della pasta in eccesso con uno strumento a margine tagliente, quale una lama in selce o una costola di caprovino. Quest ultima tecnica in particolare è stata utilizzata preferenzialmente per la realizzazione di contenitori con spessori ridotti: sebbene le argille fossero dotate di sufficiente plasticità e nerbo per montare direttamente pareti di pochi mm di spessore, si è preferito utilizzare questo metodo alternativo, che è sembrato consentisse meglio di replicare soprattutto vasi in ceramica figulina. In relazione invece ai trattamenti superficiali, tutti i vasi sono stati levigati per regolarizzarne la superficie, eliminando le asperità macroscopiche e riducendo la porosità, sia con le dita bagnate, sia con un pezzo di cuoio anch esso inumidito. In rapporto quindi alla tipologia del trattamento di superficie scelto, alcuni vasi sono stati fatti parzialmente essiccare fino a raggiungere una consistenza cuoio e quindi bruniti, con uno strumento rigido e liscio come un ciottolo, fino a raggiungere l effetto di lucentezza delle superfici. Per la brunitura di parti molto delicate come quelle dipinte, il margine del ciottolo è stato in alcuni casi coperto con grasso animale. La qualità della brunitura ottenuta è stata determinata sia dal grado di umidità del vaso, sia dalla durata dell essiccazione: quando questa era troppo rapida la lucentezza tendeva a scomparire. La decorazione impressa è stata eseguita su superfici ancora plastiche, utilizzando diversi strumenti quali conchiglie, canne, punte in osso, o le
9 48 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni semplici dita. È da notare che la tipica decorazione a rock pattern, ottenuta ruotando alternativamente il margine di un cardium, si può effettuare solo su pasta parzialmente essiccata. La decorazione incisa invece è stata ottenuta facendo scorrere sulla superficie umida o già parzialmente secca, uno strumento appuntito in osso o in fibra vegetale. La decorazione dipinta è stata realizzata utilizzando le due terre gialla e rossa, ricche in ossidi di ferro, e successivamente anche ossidi di manganese per il colore bruno, applicate su superfici levigate o brunite, utilizzando come pennello l estremità di una piuma o ciuffi di pelo o una sottile fibra vegetale. Per l ingobbiatura, per altro piuttosto rara, intendendo con essa l applicazione di un rivestimento diverso nella sua composizione dal corpo ceramico, le superfici ancora parzialmente umide sono state interamente ricoperte con una miscela di ocra rossa e argilla piuttosto fluida. Se complessivamente è risultato piuttosto facile replicare vasi in ceramica grossolana, confrontabili con i materiali archeologici nella generale asimmetria della forma ed irregolarità dello spessore e del grado di finitura superficiale, indubbiamente più complesso è stato ottenere vasi confrontabili in ceramica fine sia per la simmetria delle forme e delle pareti sia per la qualità dei trattamenti di superficie. Durante la fase dell essiccazione e di conseguente riduzione di volume dei vasi, alcuni di essi hanno sviluppato diversi tipi di fratture, in rapporto soprattutto a difetti di preparazione della materia prima e di montaggio, quali un insufficiente lavorazione dell argilla o una disomogeneità nello spessore delle pareti. Un importante fattore che ha interagito con il ritmo di essiccazione, è stato quello climatico, inteso sia in rapporto a fattori stagionali, sia a microclimi locali. Nel caso delle repliche sperimentali, effettuate in laboratorio, i fattori stagionali hanno influito in maniera piuttosto limitata, mentre una serie di dati sono stati raccolti in relazione al diverso comportamento delle argille. In particolare quelle provenienti dall area costiera, più plastiche in fase di montaggio, tendevano a subire maggiori fratturazioni, al contrario di quelle dai depositi argillosi pliocenici, meno plastiche, ma meno soggette ad alterazioni. Le cotture dei vasi, almeno in una prima fase della sperimentazione, sono state effettuate a fuoco diretto, sia pur con una diversità di accorgimenti tecnici. Nella seconda fase della sperimentazione 7 è stata realizzata una riproduzione in scala 1: 3 di un forno, sulla base dei dati strutturali 7 Si veda nota 6.
10 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 49 disponibili per quelli individuati nei siti neolitici di Trasano (GRIFONI CREMONESI 1995) e dell Olivento (CIPOLLONI SAMPÒ 1995). Nell area del Tavoliere invece non sono state fino ad ora identificate strutture di combustione, ad eccezione del forno di Ripa Tetta (TOZZI 1995). In quest ultimo caso, per le dimensioni piuttosto ridotte che avrebbero consentito la cottura solo di vasi molto piccoli, è stato ipotizzato che potesse essere destinato alla preparazione di risorse alimentari, quali la tostatura dei cereali o la cottura di focacce. Dopo una breve fase di preriscaldamento, i vasi sono stati collocati su un piano di frammenti ceramici per isolarli dal contatto diretto con il terreno e con un primo strato di combustibile, già parzialmente carbonizzato durante la fase di preriscaldamento. È stato utilizzato legname di piante arboree e arbustive localmente disponibile senza una selezione specifica, pur considerando quanto il diverso tipo di materiale vegetale possa influenzare la velocità di combustione ed il gradiente della temperatura. Per misurare le temperature raggiunte sono stati utilizzati sia una serie di coni pirometrici (sensibili a temperature comprese fra 600 e 730 C), sia una termocoppia Ch-Al e un pirometro digitale. Al fine di ottenere le due colorazioni maggiormente osservate sulle ceramiche neolitiche, quella chiara tipica delle ceramiche impresse e dipinte, e quella invece piuttosto scura delle brunite, si è tentato di creare nel fuoco un atmosfera ossidante ed una riducente con diversi metodi, ricorrendo alla disposizione diversificata del combustibile. Per creare condizioni di cottura ossidante in un primo test il combustibile è stato posto intorno ai vasi, senza coprirli, verificando se si potessero cuocere per irradiazione di calore. In un secondo test invece i vasi sono stati coperti completamente da combustibile, consumatosi completamente il quale, la cottura è stata ultimata lasciando i vasi su un livello di brace. Durante l intero processo si è cercato di limitare il contatto diretto tra le superfici dei vasi ed il carbone, al fine di impedire la formazione delle cosiddette nuvole di cottura, chiazze più scure di solito nerastre, in punti dove il vaso si raffredda a contatto con il carbone o con un altro vaso che impedisce l afflusso di ossigeno. Il primo metodo non ha fornito i risultati sperati, sia in termini di colorazione dei vasi, apparsi piuttosto affumicati, sia in termini di cottura, in quanto sono state raggiunte temperature insufficienti a determinare la trasformazione irreversibile del materiale argilloso. La temperatura massima raggiunta, per un periodo molto limitato, è stata di 600 C, mentre per il resto della cottura durata circa 1,5 h oscillava fra 400 e 500 C. Nel secondo caso invece i vasi sono risultati ben cotti e con una colorazione chiara piuttosto omogenea: la massima temperatura di 800 C è stata re-
11 50 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni gistrata, per circa 30 minuti, tra la brace, mentre intorno ai vasi non ha superato i 730 C. I due diversi tipi di materiali coloranti utilizzati, hanno dato dei risultati simili, variabili dal rosso al bruno in relazione al tipo di atmosfera ottenuta e confrontabili con quelli riscontrati sui materiali archeologici. Si sottolinea, infatti, che per i vasi dipinti si è cercato di evitare il formarsi di condizioni di cottura riducente. Per ottenere invece condizioni di cottura riducente, sono state analogamente testate due metodiche. Nel primo caso i vasi sono stati coperti dal combustibile, che è stato poi aggiunto durante tutta la durata della cottura, mentre nel secondo sono stati coperti da un altro vaso precedentemente cotto, sul quale è stato poi posto il combustibile. In ambedue i test i vasi sono stati ben cotti, mentre riguardo alla colorazione delle superfici solo nel secondo, dove è stata raggiunta una temperatura massima di 700 C per circa 30 minuti, è stata ottenuta una colorazione scura uniforme, priva di chiazze chiare. Le prove sperimentali di cottura sono state eseguite per ragioni logistiche indipendenti dal protocollo di sperimentazione, ambedue nel mese di Novembre, in condizioni climatiche non ottimali, in quanto in ambedue i casi la stagione si presentava particolarmente umida e piovosa. Questo ha posto alcuni problemi in relazione alla non ottimale essiccazione dei vasi ed al grado di umidità del suolo e del combustibile: è stato, infatti, difficoltoso mantenere una temperatura costante e soprattutto controllare le emissioni di fumo. Durante la cottura inoltre sono stati osservati diversi tipi di fratturazioni, causate da un riscaldamento non graduale e/o uniforme, che ha determinato la trasformazione dell acqua contenuta nell argilla in vapore e la sua rapida fuoriuscita con la conseguente rottura o l esplosione del vaso stesso. Tra i tipi di fratture ne sono state osservate sia di verticali a partire dall orlo verso il basso, sia di lenticolari con il conseguente distacco di scaglie dalle superfici, probabilmente per la presenza all interno della parete di una sacca d aria; fratture simili sono state talora riscontrate sui materiali archeologici. Considerazioni conclusive Nonostante i limiti personali ed obiettivi precedentemente ricordati, si è stati in grado di replicare la maggior parte dei tipi vascolari del Neolitico del Tavoliere, utilizzando argille locali, prelevate da depositi alluvionali e marini, sia pur con differenti risultati. La maggior parte degli impasti è stata preparata senza far ricorso a lunghe e complesse tecniche di prepa-
12 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 51 razione. I vasi sono stati montati con le tecniche più semplici (a colombino o a pressione). Fino a questo punto sembra dunque supportata l ipotesi di partenza di una produzione locale essenzialmente a carattere domestico. Un eccezione riguarda la ceramica figulina della quale non sono state riprodotte le caratteristiche di tessitura molto fine e compatta del corpo ceramico, né quelle di una cottura controllata e ad alte temperature, caratteristiche di questo tipo di ceramica. Come indiziato dai risultati delle analisi archeometriche 8, ad eccezione della figulina sembra che le diverse classi ceramiche siano state ottenute con materie prime e tecniche piuttosto simili, mentre i maggiori elementi di variabilità risiedono nelle forme e nei trattamenti di superficie. Questo sembra contraddire alcune classificazioni che interpretano come cambiamenti culturali alcune minimali trasformazioni stilistiche o di gusto, anche quando una trasformazione tecnologica non sia stata osservata. A livello sincronico si possono, infatti, ipotizzare differenti scelte individuali o di gruppo in risposta a esigenze funzionali o stimoli sociali. Da un punto di vista diacronico, invece, si può riconoscere l esistenza di un limitato sviluppo tecnologico all interno di una ben definita tradizione ceramica. Un importante salto tecnologico potrebbe essere rappresentato dall introduzione degli impasti figulini che non a caso caratterizzano il Neolitico medio. In relazione inoltre alle tecniche di cottura, una importante differenza risiede tra la ceramica nero lucida e quella figulina, frequentemente associate nei contesti archeologici. L attività di sperimentazione ha evidenziato come le differenze tra le due classi risiedano non solo nei trattamenti di superficie, quanto soprattutto nelle tecniche di cottura: sarebbe dunque lecito domandarsi se tutti i vasi di quel periodo fossero prodotti ancora a livello di singole unità residenziali o se ceramiche diverse fossero scambiate tra famiglie o tra comunità distinte. Un aspetto non marginale del lavoro di sperimentazione è stato il riscontrare l esistenza di diversi possibili livelli di competenza/esperienza che possono essere connessi con la produzione ceramica in generale o di specifiche classi e/o tipi vascolari. Di questi livelli non è facile la lettura attraverso i dati archeologici, mentre ne è stata percepita la rilevanza nell attività pratica di sperimentazione. La conoscenza tecnologica è apparsa immediatamente quale fattore più rilevante in termini socio-economici. Poteva esistere, infatti, una conoscenza tradizionale facilmente acquisibile probabilmente sin dall età giovanile, 8 Si veda nota 5.
13 52 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni attraverso la semplice osservazione delle operazioni eseguite dagli adulti (madre?) nella fabbricazione della ceramica. A questo livello di apprendimento, si ascrive in genere il più basso livello di variabilità nello stile (LONGRACRE 1991b), in opera d altra parte nell ambito di società non strutturate. La tradizione ceramica neolitica tuttavia può far supporre anche un livello di conoscenza acquisita che poteva essere necessaria al vasaio per produrre le ceramiche fini. Questo livello potrebbe indurre ad ipotizzare l esistenza di una figura autonoma di vasaio e quindi di un suo ruolo in una società più complessa. Si può ipotizzare che questa esperienza fosse acquisita durante tutto l arco della vita o piuttosto attraverso forme di apprendistato, sia pur non formale. La pratica si configura come una componente diversa parallela all apprendistato, ma essenziale al raggiungimento del successo sistematico. La pratica ripetuta nel produrre un determinato tipo (a qualsiasi livello di difficoltà) è determinante per il successo sistematico dell operazione (ROUX 1990). Nell ambito del record archeologico questo livello di competenza può essere identificato nel grado di uniformità tecnologica caratteristica di alcune classi ceramiche neolitiche. L abilità personale, infine, che era un importante livello di qualificazione all interno della famiglia o del gruppo, rimane il più difficile da identificare nel record archeologico; la sperimentazione tuttavia ha permesso di apprezzare la sua rilevanza quale minore, ma non meno significativo, elemento di variabilità all interno di una tradizione ceramica. A livello di confronti etnografici questo livello trova riscontro nel frequente riconoscimento del buon vasaio da parte di singole comunità. BIBLIOGRAFIA BALENZANO F., DELL ANNA L., DI PIERRO M Ricerche mineralogiche, chimiche e granulometriche su argille subappennine della Daunia, Geologia Applicata e Idrogeologia, XII (II): BRADFORD J.S.P Ancient Landscapes, G. Bell & Sons: London. CASSANO S.M., MANFREDINI A Studi sul Neolitico del Tavoliere della Puglia, British Archaeological Reports Int. S. 160: Oxford. CASSANO S.M., MANFREDINI A Neolitico. La ricerca archeologica, in Cassano S.M., Cazzella A., Manfredini A., Moscoloni M., Coppa Nevigata e il suo territorio. Testimonianze archeologiche dal VII al II millennio a.c., 29-93, Ed. Quasar: Roma.
14 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 53 CASSANO S.M., CURCI A., GRATZIU C., MEUCCI C., MUNTONI I Programma di analisi tecnologiche delle ceramiche neolitiche del Tavoliere di Puglia, in 1st European Workshop on Archaeological Ceramics (eds Burragato F., Grubessi O., Lazzarini L.), , Università La Sapienza: Roma. CASSANO S.M., EYGUN G., GARIDEL Y., MUNTONI I. 1995a - Pottery making in Southern Italy: an experimental study, in Estudios sobre ceràmica antiga, Actes del simposi sobre ceràmica antiga (eds Vendrell-Saz M., Pradell T., Molera J., Garcia M.), 11-16, Universitat de Barcelona: Barcelona. CASSANO S.M., LAVIANO R., MUNTONI I. 1995b - Pottery technology of Early Neolithic communities of Coppa Nevigata and Masseria Candelaro (Foggia, Southern Italy), in The Cultural Ceramic Heritage, European Ceramic Society Fourth Conference, vol. 14, (ed Fabbri B.), , Gruppo Editoriale Faenza Editrice: Faenza. CASSANO S.M., MUNTONI I., CONATI BARBARO C. (eds) 1995c - Dall argilla al vaso. Sistemi di fabbricazione in una comunità neolitica di anni fa, Àrgos: Roma. CASSANO S.M., GRATZIU C., MARINI S., MEUCCI C., MUNTONI I. in stampa - Analisi tecnologiche di impasti ceramici dal villaggio Neolitico di Masseria Candelaro, Scienze dell Antichità, 6. CIPOLLONI SAMPÒ M Olivento (Lavello), in Dall argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni fa (eds. Cassano S.M., Muntoni I., Conati Barbaro C.), 49-50, Àrgos: Roma. DELL ANNA A Applicazione dell analisi mineralogica allo studio della ceramica impressa di C.no San Matteo - Chiantinelle (FG), Taras, VI (1-2): DELL ANNA L., DI PIERRO M., NUOVO G., CIARANFI N., RICCHETTI G Puglie, in Giacimenti di argille ceramiche in Italia (eds. Veniale F., Palmonari C.), , Gruppo Italiano A.I.P.E.A.: Roma. DONDI M., FABBRI B., LAVIANO R Characteristics of the clays utilized in the brick industry in Apulia and Basilicata (Southern Italy), Miner. Petrogr. Acta, XXXV (A): EYGUN G. in stampa - Interprétations culturelles d analyses céramiques?, in Actes du 63 Congrés de IACFAS (Chicoutimi, Maggio 1995). GRIFONI CREMONESI G Trasano (Matera), in Dall argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni fa (eds. Cassano S.M., Muntoni I., Conati Barbaro C.), 40,49, Àrgos, Roma. JONES G.D.B Apulia. Neolithic Settlement in the Tavoliere, The Society of Antiquaries: London. LAVIANO R La ecologia della ceramica. Il territorio di Manfredonia (FG), in Dall argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni fa (eds. Cassano S.M., Muntoni I., Conati Barbaro C.), 21-24, Àrgos, Roma. LONGACRE W.A. 1991a - Ceramic Ethnoarchaeology: An Introduction, in Ceramic Ethnoarchaeology (ed Longacre W.A.), 1-10, The University of Arizona Press: Tucson. LONGACRE W.A. 1991b - Sources of Ceramic Variability Among the Kalinga of Norhern Luzon, in Ceramic Ethnoarchaeology (ed Longacre W.A.), , The University of Arizona Press: Tucson.
15 54 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni MALLORY J.P. (a cura di) Lagnano da Piede I. An Early Neolthic Village in the Tavoliere, Origini, XIII: MANNONI T Analisi minero-petrografiche in sezione sottile delle ceramiche del Guadone, Rivista di Scienze Preistoriche, XXXV: MANNONI T Caratterizzazioni mineralogico-petrografiche e tecniche di alcune ceramiche del Tavoliere, in Tinè S., Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, 94-97, Sagep: Genova. MUNTONI I. 1995a - A technological approach to the Neolithic pottery production at Masseria Candelaro (FG-Italy), in The Ceramics Cultural Heritage (ed Vincenzini P.), , Techna: Faenza. MUNTONI I. 1995b - Le analisi mineralogiche e chimiche. le applicazioni alle ceramiche neolitiche del Tavoliere, in Dall argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni fa (eds Cassano S.M., Muntoni I., Conati Barbaro C.), 51-52, Àrgos: Roma. NOVELLI G Nota sulle tecniche di esecuzione delle decorazioni tipo Scaloria bassa, in Civiltà e Culture Antiche tra Gargano e Tavoliere, Lacaita: Manduria. ROUX V The Psychological Analysis of Technical Activities: a Contribution to the Study of Craft Specialization, Archaeological Review from Cambridge, 9 (1): SCHIFFER M.B., SKIBO J.M Theory and Experiment in the Study of Technological Change, Current Anthropology, 28 (5): SIMONE L., NOVELLI G Considerazioni sull aspetto tecnologico di alcune classi ceramiche, in Tinè S., Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, 93-94, Sagep: Genova. TINÈ S Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, Sagep: Genova. TINÈ S., SIMONE L Il Neolitico, in La Daunia Antica (ed Mazzei M.), , Electa: Milano. TOZZI C., Ripa Tetta (Lucera), in Dall argilla al vaso. Fabbricazione della ceramica in una comunità neolitica di 7000 anni fa (eds. Cassano S.M., Muntoni I., Conati Barbaro C.), 40, Àrgos, Roma. TOZZI C., VEROLA M.L La campagna di scavo 1990 a Ripatetta (Lucera, Foggia), in Atti del 12 Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, 37-45, Archeoclub d Italia: San Severo. VAN DER LEEUW S.E Variation, Variability, and Explanation in Pottery Studies, in Ceramic Ethnoarchaeology (ed Longacre W.A.), 11-39, The University of Arizona Press: Tucson. WHITEHOUSE R Il Neolitico Antico: Cronologia Assoluta, in CASSANO S.M., CAZZELLA A., MANFREDINI A., MOSCOLONI M., Coppa Nevigata e il suo territorio. Testimonianze archeologiche dal VII al II millennio a.c., 95-97, Ed. Quasar: Roma.
16 La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale 55 Fig. 1 - La sequenza operativa seguita nel programma di sperimentazione
17 56 S. M. Cassano, G. Eygun, I. Muntoni Fig. 2 - Localizzazione dei villaggi neolitici di Masseria Candelaro (A) e Ripa Tetta (B) e dei campioni (1-6) di argille utilizzate (da JONES 1987, modificata)
18 INDICE Introduzione pag. 3 ARTURO PALMA DI CESNOLA I lavori a Grotta Paglicci negli anni » 5 MAURO CALATTINI Il Neolitico di Pozzo del Corriere (Fg): I la componente a bifacciali campignani » 9 S. PIRO, G. BOSCHIAN, C. TOZZI Prospezione geofisiche nel sito neolitico di Ripa Tetta (Lucera-Foggia) » 23 S. M. CASSANO, G. EYGUN, I. MUNTONI La produzione ceramica nel Neolitico del Tavoliere: spunti da uno studio sperimentale » 41 MARIA TERESA CUDA, PAOLO GIUNTI La stazione eneolitica di Colicchio (Vieste) » 57 MARIO LANGELLA Radogna (Bovino - Fg): l industria litica » 69 ARMANDO GRAVINA Il complesso preistorico della Valle dell Inferno presso S. Giovanni Rotondo » 75
19 246 ALBERO CAZZELLA, MAURIZIO MOSCOLONI Gli scavi nell insediamento dell età del bronzo di Coppa Nevigata: nuovi risultati » 103 PAOLO BOCCUCCIA Nuovi dati sulla frequentazione protostorica di Coppa Nevigata.» 117 MARISA CORRENTE Monili a Minervino Murge tra V e IV secolo a.c......» 145 M. A. CANNAROZZI, M. MAZZEI, G. VOLPE I materiali delle ville romane di S. Maria di Merino e Fioravanti (Vieste) » 179 FRANCESCO PAOLO MAULUCCI VIVOLA Il quadrato magico o crittrogramma del Pater Noster....» 229
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO
 3.6 - REGIONE PUGLIA Ing. Alfredo Ferrandino Tutor regionale 3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.6.1.1 - Scelta del campione Sulla base dei concetti generali formatori
3.6 - REGIONE PUGLIA Ing. Alfredo Ferrandino Tutor regionale 3.6.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.6.1.1 - Scelta del campione Sulla base dei concetti generali formatori
Anno scolastico 2012-2013
 Museo delle Scienze di Trento Corso di aggiornamento per docenti Anno scolastico 2012-2013 Mercoledì 28 novembre 2012 Laboratorio di archeologia imitativa Le mani in pasta corso per imparare a lavorare
Museo delle Scienze di Trento Corso di aggiornamento per docenti Anno scolastico 2012-2013 Mercoledì 28 novembre 2012 Laboratorio di archeologia imitativa Le mani in pasta corso per imparare a lavorare
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
SETAC S.r.l. Servizi & Engineering: Trasporti Ambiente Costruzioni Via Don Guanella 15/B Bari Tel/Fax (2 linee) : mandante
 COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA REGIONE PUGLIA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEL
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA REGIONE PUGLIA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEL
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA =============== Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II TRAVERSA VIA ELENA 1. PREMESSA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA =============== Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II TRAVERSA VIA ELENA 1. PREMESSA
1: Dalla pietra ai ceramici avanzati. - Materiali Ceramici Introduzione Materie prime Lavorazione Cottura Prodotti
 1: Dalla pietra ai ceramici avanzati - Materiali Introduzione Materie prime Lavorazione Cottura Prodotti Introduzione Industria dei prodotti litici e lapidei: - foggiatura-formatura-taglio per rimozione
1: Dalla pietra ai ceramici avanzati - Materiali Introduzione Materie prime Lavorazione Cottura Prodotti Introduzione Industria dei prodotti litici e lapidei: - foggiatura-formatura-taglio per rimozione
UTILIZZO CERAMICO DI SCARTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI. Studio di fattibilità
 UTILIZZO CERAMICO DI SCARTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI Studio di fattibilità Correggio, 15 Settembre 2008 STUDIO MM s.r.l. - via Pedemontana 40/s - 43029 Mamiano (PR) - Tel. 0521.844092 - info@studio-mm.it
UTILIZZO CERAMICO DI SCARTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI Studio di fattibilità Correggio, 15 Settembre 2008 STUDIO MM s.r.l. - via Pedemontana 40/s - 43029 Mamiano (PR) - Tel. 0521.844092 - info@studio-mm.it
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 1998 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Mineralogia, ambiente e salute (polveri atmosferiche, silicosi, amianto)
 Si aggiungono brevi argomenti di: Mineralogia, ambiente e salute (polveri atmosferiche, silicosi, amianto) Mineralogia e beni culturali (nella preistoria, nella storia della cultura materiale, nell'archeologia,
Si aggiungono brevi argomenti di: Mineralogia, ambiente e salute (polveri atmosferiche, silicosi, amianto) Mineralogia e beni culturali (nella preistoria, nella storia della cultura materiale, nell'archeologia,
IL TERRENO E I SUOI PICCOLI MINERALI
 IL TERRENO E I SUOI PICCOLI MINERALI Alunni: Alessia De Maria; Pasquale Falvo; Miriam Ferraiuolo; Manual Gualtieri; Lorenza Marchio; Giuseppe Martire; Giuseppe Palermo; Antonio Pantano; Martina Pizzonia;
IL TERRENO E I SUOI PICCOLI MINERALI Alunni: Alessia De Maria; Pasquale Falvo; Miriam Ferraiuolo; Manual Gualtieri; Lorenza Marchio; Giuseppe Martire; Giuseppe Palermo; Antonio Pantano; Martina Pizzonia;
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive
 Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
Stato della ricerca preistorica e protostorica in Sardegna: innovazione e prospettive L attività di ricerca archeologica nelle due Università sarde, nel settore della Preistoria e della Protostoria, si
MICHELA DANESI. Pubblicazioni:
 MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
MICHELA DANESI Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica presso l Università di Roma Sapienza, XXIII ciclo, con un progetto dal titolo La produzione ceramica del periodo dei Templi (3600-2300 a.c.)
CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ
 CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZA 1 RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO E BIOLOGICO - I cinque sensi - Alcuni esseri
CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZA 1 RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO E BIOLOGICO - I cinque sensi - Alcuni esseri
Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali Allegato 2.E al Piano Triennale dell Offerta Formativa 2016/19 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA
 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
CURRICOLO SCIENZE SCUOLA PRIMARIA
 CURRICOLO SCIENZE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. Osservare la realtà circostante per cogliere
CURRICOLO SCIENZE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. Osservare la realtà circostante per cogliere
SCUOLA PRIMARIA - SCIENZE
 SCUOLA PRIMARIA - SCIENZE CLASSE PRIMA COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie risolutrici.
SCUOLA PRIMARIA - SCIENZE CLASSE PRIMA COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie risolutrici.
CURRICOLO DI SCIENZE
 ISTITUTO COMPRENSIVO Lorenzo Lotto CURRICOLO DI SCIENZE elaborato dai docenti di scuola primaria F. Conti e Mestica a.s. 2013/14 coordinatore Ins.te Galli Anna Maria Traguardi per lo sviluppo delle competenze
ISTITUTO COMPRENSIVO Lorenzo Lotto CURRICOLO DI SCIENZE elaborato dai docenti di scuola primaria F. Conti e Mestica a.s. 2013/14 coordinatore Ins.te Galli Anna Maria Traguardi per lo sviluppo delle competenze
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
Materie prime e scambi nella produzione ceramica del Neolitico apulo: il contributo delle analisi archeometriche
 ROCCO LAVIANO * - ITALO MARIA MUNTONI ** Materie prime e scambi nella produzione ceramica del Neolitico apulo: il contributo delle analisi archeometriche LE RICERCHE ARCHEOMETRICHE IN PUGLIA 1 A livello
ROCCO LAVIANO * - ITALO MARIA MUNTONI ** Materie prime e scambi nella produzione ceramica del Neolitico apulo: il contributo delle analisi archeometriche LE RICERCHE ARCHEOMETRICHE IN PUGLIA 1 A livello
Capitolato d Oneri Prescrizioni per la redazione elaborati
 Affidamento dei servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS per le attività di studio e di indagini archeologiche nell ambito del Progetto Definitivo di Adeguamento e messa in sicurezza della SS
Affidamento dei servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS per le attività di studio e di indagini archeologiche nell ambito del Progetto Definitivo di Adeguamento e messa in sicurezza della SS
RAPPORTO DI PROVA R
 RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO Claudio Negrelli
 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO 2014-2015 Claudio Negrelli La ceramologia: una disciplina a sé stante? Lo studio del materiale ceramico medievale e post-medievale La ceramologia in generale come studio tipologico,
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE CORSO 2014-2015 Claudio Negrelli La ceramologia: una disciplina a sé stante? Lo studio del materiale ceramico medievale e post-medievale La ceramologia in generale come studio tipologico,
COMUNE DI REGGIO EMILIA RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 1 LETTERA b DELLA L.R. 24/2017 PER L AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE SEDE
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 1 LETTERA b DELLA L.R. 24/2017 PER L AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE SEDE
LA PRODUZIONE DEI LATERIZI
 Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara Corso di PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI Prof. Ing. Maurizio Biolcati Rinaldi LA PRODUZIONE DEI LATERIZI Sintesi degli argomenti trattati
Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Ferrara Corso di PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI Prof. Ing. Maurizio Biolcati Rinaldi LA PRODUZIONE DEI LATERIZI Sintesi degli argomenti trattati
IL NUOVO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
 IL NUOVO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Itis Galilei di Roma - 9 novembre 2009 - SI ARTICOLA NELLE TRE AREE OPZIONALI DI APPROFONDIMENTO: CHIMICA E MATERIALI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
IL NUOVO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Itis Galilei di Roma - 9 novembre 2009 - SI ARTICOLA NELLE TRE AREE OPZIONALI DI APPROFONDIMENTO: CHIMICA E MATERIALI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Orlo di vaso a bocca quadrata
 Orlo di vaso a bocca quadrata Cultura del Vaso a Bocca Quadrata Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede/sm020-00043/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/sm020-00043/
Orlo di vaso a bocca quadrata Cultura del Vaso a Bocca Quadrata Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede/sm020-00043/ Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/sm020-00043/
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 1998 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 19 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 27-29 novembre 1998 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Scienze - Triennio Scuola Primaria. cl. II - La materia - L acqua - Le stagioni
 Scienze - Triennio Scuola Primaria Indicatori Osservazione, analisi e descrizione 1. Osservare, descrivere, classificare elementi della realtà circostante. 2. Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema
Scienze - Triennio Scuola Primaria Indicatori Osservazione, analisi e descrizione 1. Osservare, descrivere, classificare elementi della realtà circostante. 2. Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema
CAMPIONAMENTO fondamentale analisi campionamento omogenei stessa composizione variazione l abilità persona variabilità metodo analitico realtà
 CAMPIONAMENTO Un momento fondamentale di una analisi è rappresentato dal campionamento, generalmente si pensa che i campioni da analizzare siano omogenei e che abbiano in ogni punto la stessa composizione,
CAMPIONAMENTO Un momento fondamentale di una analisi è rappresentato dal campionamento, generalmente si pensa che i campioni da analizzare siano omogenei e che abbiano in ogni punto la stessa composizione,
15 luglio - 15 settembre 2018
 Grazie alla cortese concessione della Presidente del Sistema Museale di Ateneo dell Università di Pisa, dott.ssa Chiara Bodei, sarà esposta la mostra 15 luglio - 15 settembre 2018 Museo Didattico Via Piana
Grazie alla cortese concessione della Presidente del Sistema Museale di Ateneo dell Università di Pisa, dott.ssa Chiara Bodei, sarà esposta la mostra 15 luglio - 15 settembre 2018 Museo Didattico Via Piana
Sistema Museale di Ateno Università degli Studi di Bari Museo di Scienze della Terra settore Geopaleontologico
 Sistema Museale di Ateno Università degli Studi di Bari Museo di Scienze della Terra settore Geopaleontologico AREE DISCIPL. 3c La misura del tempo Laboratorio: Misura del tempo in geologia: la Cronologia
Sistema Museale di Ateno Università degli Studi di Bari Museo di Scienze della Terra settore Geopaleontologico AREE DISCIPL. 3c La misura del tempo Laboratorio: Misura del tempo in geologia: la Cronologia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
Profili laminati di alta qualità
 L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare le caratteristiche meccaniche
L'acciaio antiusura Profili laminati di alta qualità ESTRONG è un acciaio legato a basso contenuto di Carbonio e con elevati tenori di Boro, Molibdeno e Nichel, tali da ottimizzare le caratteristiche meccaniche
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 SCUOLA PRIMARIA SEZIONE A: Traguardi formativi COMPETENZA CHIAVE EUROPEA OSSERVA E DESCRIVE L AMBIENTE CHE LO CIRCONDA CLASSE PRIMA- SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE Sviluppare
SCUOLA PRIMARIA SEZIONE A: Traguardi formativi COMPETENZA CHIAVE EUROPEA OSSERVA E DESCRIVE L AMBIENTE CHE LO CIRCONDA CLASSE PRIMA- SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE Sviluppare
UNITA DI APPRENDIMENTO 1. E in grado di individuare le caratteristiche di una alimentazione sana ed equilibrata.
 DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSI SECONDE UNITA DI APPRENDIMENTO 1 TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA: E in grado di individuare le caratteristiche dei principi alimentari. E in grado di individuare le caratteristiche
DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSI SECONDE UNITA DI APPRENDIMENTO 1 TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA: E in grado di individuare le caratteristiche dei principi alimentari. E in grado di individuare le caratteristiche
SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013
 SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA IN LETTERE- BENi CULTURALI Insegnamento PALETNOLOGIA Docente GIULIA RECCHIA S.S.D. dell insegnamento L/ANT-01 Anno di Corso 2012/2013 Crediti
SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA IN LETTERE- BENi CULTURALI Insegnamento PALETNOLOGIA Docente GIULIA RECCHIA S.S.D. dell insegnamento L/ANT-01 Anno di Corso 2012/2013 Crediti
LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Faenza, 30/01/2015 NORMATIVA APPLICATA: ETAG 004:2011 DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 17/12/2014
 CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO SCIENZE DELIBERATO ANNO SCOL. 2015/2016
 SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DELIBERATO ANNO SCOL. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA COMPETENZA DI Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni,
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DELIBERATO ANNO SCOL. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA COMPETENZA DI Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni,
CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ
 CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZA 1 RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO E BIOLOGICO - I cinque sensi - Alcuni esseri
CURRICOLO DI SCIENZE Scuola Primaria CLASSI 1^ e 2^ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZA 1 RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO E BIOLOGICO - I cinque sensi - Alcuni esseri
Progetto UNDERGROUND
 Comune di Ferrara Città patrimonio dell umanità Progetto UNDERGROUND Proposta didattica per lo studio della geologia strutturale e stratigrafica del sottosuolo padano-emiliano e ferrarese in particolare,
Comune di Ferrara Città patrimonio dell umanità Progetto UNDERGROUND Proposta didattica per lo studio della geologia strutturale e stratigrafica del sottosuolo padano-emiliano e ferrarese in particolare,
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 1994 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 15 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 1994 A T T I a cura di Armando Gravina con gli auspici della Società di Storia
FACCIATA DELL IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE M. MODERNI
 Ministero dell Università e della Ricerca Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da CSICERT Iscrizione all Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del
Ministero dell Università e della Ricerca Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da CSICERT Iscrizione all Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del
Parco Archeologico del Forcello Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
 Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
Strada Statale Romana (SS 413) Via Valle, San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Recapiti Pro Loco Bagnolo tel 348 0394636, fax 0376 415446 Comune di Bagnolo San Vito tel. 0376.413317, fax 0376.415387 info@parcoarcheologicoforcello.it
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA
 RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
Destinatari: classi III - IV e V della Scuola Primaria adattabile anche alla scuola secondaria di I grado
 l osservazione diretta e l analisi dell ambiente e della flora presente oggi al Lavagnone. A questo punto si lascia il sito archeologico. 2) Attività presso il Museo Rambotti. I ragazzi effettuano l attività
l osservazione diretta e l analisi dell ambiente e della flora presente oggi al Lavagnone. A questo punto si lascia il sito archeologico. 2) Attività presso il Museo Rambotti. I ragazzi effettuano l attività
GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
IL GIARDINO ROCCIOSO. Dott. ssa geol. Annalisa Antonelli
 IL GIARDINO ROCCIOSO QUANDO È NATO? Origini che risalgono al Rinascimento (1350-1550); ricchi Signori collezionavano pietre, spugne, conchiglie, ossa di animali acquatici, ecc Periodo del paesaggismo inglese
IL GIARDINO ROCCIOSO QUANDO È NATO? Origini che risalgono al Rinascimento (1350-1550); ricchi Signori collezionavano pietre, spugne, conchiglie, ossa di animali acquatici, ecc Periodo del paesaggismo inglese
ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO AMABILE GUASTELLA CHIARAMONTE GULFI SCIENZE OTTOBRE
 SCIENZE OTTOBRE - Individuare, attraverso l interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne le qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
SCIENZE OTTOBRE - Individuare, attraverso l interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne le qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
Classe quinta Scuola Primaria scienze - COMPETENZE EUROPEE CONTENUTI E ATTIVITA APPRENDIMENTO
 COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA Comunicazione nella madrelingua (CAPACITA DI ESPRIMERE E INTERPERTARE IN FORMA ORALE E SCRITTA) 1. Espone in forma chiara ciò
COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA Comunicazione nella madrelingua (CAPACITA DI ESPRIMERE E INTERPERTARE IN FORMA ORALE E SCRITTA) 1. Espone in forma chiara ciò
CURRICOLO DI SCIENZE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 CURRICOLO DI SCIENZE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità Riconoscere
CURRICOLO DI SCIENZE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità Riconoscere
LA COTTURA VARI METODI PER LA COTTURA DELLA CERAMICA
 LA COTTURA VARI METODI PER LA COTTURA DELLA CERAMICA PRINCIPI Nel processo di cottura avviene la trasformazione di alcuni materiali in altri, detti di neoformazione, che impartiscono le proprietà al manufatto
LA COTTURA VARI METODI PER LA COTTURA DELLA CERAMICA PRINCIPI Nel processo di cottura avviene la trasformazione di alcuni materiali in altri, detti di neoformazione, che impartiscono le proprietà al manufatto
Come nasce un presepe p in terracotta. Si ringraziano i maestri artigiani dei gruppi di CIAP, Manos Amigas e Minka
 Come nasce un presepe p in terracotta Si ringraziano i maestri artigiani dei gruppi di CIAP, Manos Amigas e Minka per la gentilezza ae disponibilità dimostrate La tradizione artigianale della ceramica
Come nasce un presepe p in terracotta Si ringraziano i maestri artigiani dei gruppi di CIAP, Manos Amigas e Minka per la gentilezza ae disponibilità dimostrate La tradizione artigianale della ceramica
SCUOLA x PRIMARIA. SECONDARIA SCUOLA x PRIMARIA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SECONDARIA. : Area linguistico-artisticoespressiva CURRICOLARE
 SCUOLA x PRIMARIA SECONDARIA SCUOLA x PRIMARIA PROGRAMMAZIONE SECONDARIA DISCIPLINA PROGRAMMAZIONE : Area linguistico-artisticoespressiva DISCIPLINA INSEGNANTE: : area antropologica CLASSI: CLASSE: III
SCUOLA x PRIMARIA SECONDARIA SCUOLA x PRIMARIA PROGRAMMAZIONE SECONDARIA DISCIPLINA PROGRAMMAZIONE : Area linguistico-artisticoespressiva DISCIPLINA INSEGNANTE: : area antropologica CLASSI: CLASSE: III
VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Francesca CHIECHI)
 Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado Palmieri - San Giovanni Bosco Viale II Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) Tel. 0882/222110 Fax 0882/222157 Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it
Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado Palmieri - San Giovanni Bosco Viale II Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) Tel. 0882/222110 Fax 0882/222157 Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it
$ #% &'( & ) # * ++ ' )# ' ( & -./0
 !" #$#%&'(& )#*++')# ),('(& -./0 Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
!" #$#%&'(& )#*++')# ),('(& -./0 Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto (Bo): Corso Italia 163 presso Porta Garibaldi Sede espositiva di Sant Agata Bolognese (Bo): via Terragli a Ponente presso ex
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO
 CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
CASTELFRANCO MUSEI UN MUSEO PER LA SCUOLA PROPOSTE DIDATTICHE PER L ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Per l anno scolastico 2015-2016 i musei del Comune di Castelfranco di Sotto propongono una serie diversificata
Diossine, furani e PCB diossina-simili in provincia di Treviso Presentazione del report
 Diossine, furani e PCB diossina-simili in provincia di Treviso Presentazione del report 2014 ARPAV Direttore Generale Carlo Emanuele Pepe Dipartimento Provinciale di Treviso Loris Tomiato Progetto e realizzazione
Diossine, furani e PCB diossina-simili in provincia di Treviso Presentazione del report 2014 ARPAV Direttore Generale Carlo Emanuele Pepe Dipartimento Provinciale di Treviso Loris Tomiato Progetto e realizzazione
S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI
 S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 ter, della L.R. Sicilia n. 09/2010 5. ANALISI E PROIEZIONE DELL ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DELLA PRODUZIONE
S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 ter, della L.R. Sicilia n. 09/2010 5. ANALISI E PROIEZIONE DELL ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DELLA PRODUZIONE
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE)
 Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
Indagini archeologiche nella chiesa arcipretale di Bondeno (FE) Committenza Associazione Bondeno Cultura Direzione scientifica Dott.ssa Chiara Guarnieri 1 Premessa Premessa Le indagini sono state condotte
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA. INDICATORI COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA Riconosce le principali caratteristiche di organismi 3. L uomo, i viventi e l ambiente Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo nei suoi diversi
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA Riconosce le principali caratteristiche di organismi 3. L uomo, i viventi e l ambiente Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo nei suoi diversi
CURRICOLO SCIENZE E TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO SCIENZE E TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nuclei tematici Fisica e chimica Traguardi per lo sviluppo della competenza Esplorare e sperimentare in laboratorio e all aperto, lo svolgersi
CURRICOLO SCIENZE E TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nuclei tematici Fisica e chimica Traguardi per lo sviluppo della competenza Esplorare e sperimentare in laboratorio e all aperto, lo svolgersi
RAPPORTO DI PROVA R
 CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
CertiMaC soc.cons. a r.l. Via Granarolo, 62 48018 Faenza RA Italy tel. +39 0546 670363 fax +39 0546 670399 www.certimac.it info@certimac.it R.I. RA, partita iva e codice fiscale 02200460398 R.E.A. RA 180280
Solo il 10% è suolo!
 Il suolo è l epidermide della Terra, come la buccia di una mela ma: Solo il 25% di questa mela non è sommerso dalle acque Di cui il 15% è deserto, ghiaccio o roccia affiorante Solo il 10% è suolo! Il suolo
Il suolo è l epidermide della Terra, come la buccia di una mela ma: Solo il 25% di questa mela non è sommerso dalle acque Di cui il 15% è deserto, ghiaccio o roccia affiorante Solo il 10% è suolo! Il suolo
POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI
 REV 0 1 di 7 POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 20/06/2011 REV 0 2 di 7 SOMMARIO 1 RIFERIMENTI 3 2 DEFINIZIONI 3 3 SCOPO E CAMPO
REV 0 1 di 7 POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 20/06/2011 REV 0 2 di 7 SOMMARIO 1 RIFERIMENTI 3 2 DEFINIZIONI 3 3 SCOPO E CAMPO
SCUOLA PRIMARIA SCIENZE classi prima, seconda, terza
 NUCLEI TEMATICI ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO SCUOLA PRIMARIA SCIENZE classi prima, seconda, terza COMPETENZE SA INDIVIDUARE ASPETTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
NUCLEI TEMATICI ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO SCUOLA PRIMARIA SCIENZE classi prima, seconda, terza COMPETENZE SA INDIVIDUARE ASPETTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2009 A T T I
 ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
ARCHEOCLUB D ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 30 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 21-22 novembre 2009 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2010 Stampa:
Composizione dei vetri dei prodotti eruttati durante la sequenza esplosiva avvenuta a Stromboli giorno 30 giugno 2010
 Prot. int. n UFVG2010/25 Composizione dei vetri dei prodotti eruttati durante la sequenza esplosiva avvenuta a Stromboli giorno 30 giugno 2010 Rosa Anna Corsaro e Lucia Miraglia Nel presente rapporto sono
Prot. int. n UFVG2010/25 Composizione dei vetri dei prodotti eruttati durante la sequenza esplosiva avvenuta a Stromboli giorno 30 giugno 2010 Rosa Anna Corsaro e Lucia Miraglia Nel presente rapporto sono
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA NOVEMBRE Con il patrocinio:
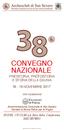 CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
CONVEGNO NAZIONALE PREISTORIA, PROTOSTORIA E STORIA DELLA DAUNIA 18-19 NOVEMBRE 2017 Con il patrocinio: Amministrazione Comunale di San Severo Società di Storia Patria per la Puglia HOTEL CICOLELLA Sala
L essiccazione delle erbe officinali: apparati per le piccole aziende. Fabrizio Scartezzini CRA - MPF
 L essiccazione delle erbe officinali: apparati per le piccole aziende Fabrizio Scartezzini CRA - MPF Caratteristiche salienti dell azienda a cui si fa riferimento: superficie investita a colture officinali
L essiccazione delle erbe officinali: apparati per le piccole aziende Fabrizio Scartezzini CRA - MPF Caratteristiche salienti dell azienda a cui si fa riferimento: superficie investita a colture officinali
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DOVUTO ALLO SCORRIMENTO ED ALLA PERCOLAZIONE NEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE.
 18016 Supplemento ordinario n. 9 alla GZZETT UFFICILE Serie generale n. 90 LLEGTO VII PREVENZIONE DELL'INQUINMENTO DELLE CQUE DOVUTO LLO SCORRIMENTO ED LL PERCOLZIONE NEI SISTEMI DI IRRIGZIONE Principi
18016 Supplemento ordinario n. 9 alla GZZETT UFFICILE Serie generale n. 90 LLEGTO VII PREVENZIONE DELL'INQUINMENTO DELLE CQUE DOVUTO LLO SCORRIMENTO ED LL PERCOLZIONE NEI SISTEMI DI IRRIGZIONE Principi
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
AUTUNNO ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto.
 AUTUNNO 2010 ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto. Nella mappa riportata in Figura 1 sono indicati i corpi idrici di transizione
AUTUNNO 2010 ARPAV, attraverso il Settore Acque, è competente per il monitoraggio delle acque di transizione della regione Veneto. Nella mappa riportata in Figura 1 sono indicati i corpi idrici di transizione
RICOSTRUIAMO IL DIORAMA SUOLO
 RICOSTRUIAMO IL DIORAMA SUOLO INFEA - MATERIALE DIDATTICO Ricostruiamo il diorama suolo Il suolo è una risorsa limitata, composto da particelle minerali, sostanza organica, acqua aria ed organismi viventi,
RICOSTRUIAMO IL DIORAMA SUOLO INFEA - MATERIALE DIDATTICO Ricostruiamo il diorama suolo Il suolo è una risorsa limitata, composto da particelle minerali, sostanza organica, acqua aria ed organismi viventi,
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI. Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze. Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella
 SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA MASCAGNI Anno scolastico 2014 2015 - Classi terze Insegnanti: Chiti Manola Galluzzo Ornella I bambini delle classi terze della Scuola Primaria Mascagni hanno svolto durante l anno scolastico
CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI IN ITALIA:
 CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI IN ITALIA: IL CASO DI STUDIO DEL SIN DELLA BASSA VALLE DEL FIUME CHIENTI (MC) Marco Petitta & Eva Pacioni Dipartimento di Scienze della Terra, Università
CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI IN ITALIA: IL CASO DI STUDIO DEL SIN DELLA BASSA VALLE DEL FIUME CHIENTI (MC) Marco Petitta & Eva Pacioni Dipartimento di Scienze della Terra, Università
4.2 Sintesi delle emissioni
 PROVINCIA DI 4.2 Sintesi delle emissioni Nelle figure che seguono sono riportate alcune elaborazioni di sintesi ricavate dall inventario delle emissioni in atmosfera costruito per la provincia di Ferrara
PROVINCIA DI 4.2 Sintesi delle emissioni Nelle figure che seguono sono riportate alcune elaborazioni di sintesi ricavate dall inventario delle emissioni in atmosfera costruito per la provincia di Ferrara
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
- Raccogliere informazioni, distinguere e analizzare fenomeni attraverso i cinque sensi con la consapevolezza della loro funzione e utilità.
 SCIENZE monoennio Competenza 1- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici
SCIENZE monoennio Competenza 1- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici
ALLEGATO A lettera g
 ALLEGATO A lettera g Il presente documento è l Allegato A lettera g all istanza per ottenere il permesso di ricerca di acque minerali naturali in località Piancornello nel comune di Montalcino (SI), denominato
ALLEGATO A lettera g Il presente documento è l Allegato A lettera g all istanza per ottenere il permesso di ricerca di acque minerali naturali in località Piancornello nel comune di Montalcino (SI), denominato
Ciao, mi chiamo Mezzettino!
 Ciao, mi chiamo Mezzettino! Sono un boccale in maiolica. Oggi ti racconterò la mia storia, con quali materiali e in che modo sono stato realizzato e ti parlerò dei miei antenati. Dopo il nostro viaggio
Ciao, mi chiamo Mezzettino! Sono un boccale in maiolica. Oggi ti racconterò la mia storia, con quali materiali e in che modo sono stato realizzato e ti parlerò dei miei antenati. Dopo il nostro viaggio
Determinazioni analitiche preliminari ad una variazione di materie prime argillose in impasto
 Determinazioni analitiche preliminari ad una variazione di materie prime argillose in impasto Paolo Zannini - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Determinazioni analitiche preliminari ad una variazione di materie prime argillose in impasto Paolo Zannini - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
CMR - Centro di Medicina Riabilitativa. Relazione tecnico-diagnostica
 CMR - Centro di Medicina Riabilitativa Telefono: 0942.794510 - Fax: 0942.797103 - E-mail: info@cmr-marchese.it Prove in situ per il monitoraggio periodico dell umidità a seguito dell installazione di tecnologia
CMR - Centro di Medicina Riabilitativa Telefono: 0942.794510 - Fax: 0942.797103 - E-mail: info@cmr-marchese.it Prove in situ per il monitoraggio periodico dell umidità a seguito dell installazione di tecnologia
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo dicembre 2005 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 26 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 10-11 dicembre 2005 A T T I TOMO PRIMO a cura di Armando Gravina SAN SEVERO
Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica
 Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica Il Comune di Solarolo propone alle scuole un offerta didattica da svolgere all aperto presso il sito archeologico di via Ordiere, un villaggio di 3500
Un viaggio nell età del Bronzo. Proposta didattica Il Comune di Solarolo propone alle scuole un offerta didattica da svolgere all aperto presso il sito archeologico di via Ordiere, un villaggio di 3500
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell Emilia-Romagna Via Belle Arti n. 52-40126 BOLOGNA 051.223773-220675 - 224402 fax 051.227170 sba-ero.stampa@beniculturali.it
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO NAZIONALE. sulla. Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo novembre 2002 A T T I
 ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI SAN SEVERO 23 CONVEGNO NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 23-24 novembre 2002 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2003 Stampa:
Istituto Comprensivo di Pralboino Curricolo Verticale
 FISICA e CHIMICA E consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché della ineguaglianza dell accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
FISICA e CHIMICA E consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché della ineguaglianza dell accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
CARATTERIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO E DELLE SUE SORGENTI NELL AREA DI LECCE
 WORKSHOP REPORT SALUTE E AMBIENTE in Provincia di Lecce CARATTERIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO E DELLE SUE SORGENTI NELL AREA DI LECCE Daniele Contini Istituto di Scienze dell
WORKSHOP REPORT SALUTE E AMBIENTE in Provincia di Lecce CARATTERIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO E DELLE SUE SORGENTI NELL AREA DI LECCE Daniele Contini Istituto di Scienze dell
MATERIALI PER IL COMPITO AUTENTICO...
 MATERIALI PER IL COMPITO AUTENTICO... Deposito Archeologico Noale Museo della Centuriazione Borgoricco PD fig.1 Pozzo di età romana rinvenuto a Borgoricco fig.1 Pozzo fig.2 Pozzale,...per pozzi fig.3...
MATERIALI PER IL COMPITO AUTENTICO... Deposito Archeologico Noale Museo della Centuriazione Borgoricco PD fig.1 Pozzo di età romana rinvenuto a Borgoricco fig.1 Pozzo fig.2 Pozzale,...per pozzi fig.3...
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA
 DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
DALLO SCAVO AL MUSEO 2009: PRIMA DELLA CITTA Proposta dell organizzazione del progetto degli ARCHEOCLUB di Parma e S. Secondo (PR) Coordinamento progetto: Dr Roberta Conversi Progetto e tutor : Dr Paola
IPPC-NET: il progetto Workshop per il settore IPPC 3.5 Vercelli, 28 giugno 2011
 MED-IPPC IPPC-NET: il progetto Workshop per il settore IPPC 3.5 Vercelli, 28 giugno 2011 Presentazione dei dati ottenuti dall Analisi Regionale Dott. F. Sandri Dott.ssa T. Saracino Arpa Piemonte Analisi
MED-IPPC IPPC-NET: il progetto Workshop per il settore IPPC 3.5 Vercelli, 28 giugno 2011 Presentazione dei dati ottenuti dall Analisi Regionale Dott. F. Sandri Dott.ssa T. Saracino Arpa Piemonte Analisi
Introduzione. Obiettivi
 Tecniche di studio RM per la quantificazione di flusso intracerebrale e sue applicazioni. Dr TSRM Giorgi Riccardo Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano Introduzione Una delle
Tecniche di studio RM per la quantificazione di flusso intracerebrale e sue applicazioni. Dr TSRM Giorgi Riccardo Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano Introduzione Una delle
Mauro Maffizzoli. I prodotti da costruzione da materiali riciclati di demolizione e di risulta
 Mauro Maffizzoli I prodotti da costruzione da materiali riciclati di demolizione e di risulta Chi siamo Biopietra produce rivestimenti in pietra ricomposta ecologici certificati per la bioedilizia. Ha
Mauro Maffizzoli I prodotti da costruzione da materiali riciclati di demolizione e di risulta Chi siamo Biopietra produce rivestimenti in pietra ricomposta ecologici certificati per la bioedilizia. Ha
Condizioni di imposta delle dighe dell Italia centro-meridionale in relazione alla stabilità dei versanti ed al rischio sismico
 Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II Tesi di laurea triennale in Ingegneria per l ambiente e il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II Tesi di laurea triennale in Ingegneria per l ambiente e il
REGIONE SICILIANA SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO
 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO INDUSTRIA CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI NARO DEL GIORNO 04/02/2005 Dr. Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Ambrogio Alfieri - Dr. Geol.
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO INDUSTRIA CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI NARO DEL GIORNO 04/02/2005 Dr. Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Ambrogio Alfieri - Dr. Geol.
