Reti Ottiche: dalla trasmissione su fibra alla commutazione fotonica
|
|
|
- Silvestro Nardi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Reti Ottiche: dalla trasmissione su fibra alla commutazione fotonica Parte VI: Reti a instradamento di lunghezza d onda (wavelength routing) Fabio Neri e Marco Mellia Gruppo Reti Dipartimento di Elettronica nome.cognome@polito.it fabio.neri@polito.it - tel Programma di massima Introduzione e motivazioni Cenni alla propagazione in fibra ottica Componenti per sistemi ottici Cenni a reti ottiche di prima generazione Reti ottiche WDM di tipo broadcast-and-select Reti ottiche WDM di tipo multi-hop Reti wavelength routing Reti d'accesso Architetture di protocolli nelle reti ottiche Cenni a gestione e affidabilità Cenni a commutazione ottica di pacchetti
2 Reti wavelength routing (WR) Sono architetture di rete WDM che instradano e commutano informazione nel dominio ottico sulla base delle lunghezze d onda Vengono creati circuiti ottici trasparenti o opachi detti lightpath (cammini di luce) tra nodi della rete ottica. I lighpath sono circuiti ottici, che possono essere single-hop nella topologia fisica, o multi-hop, cioè attraversare punti di commutazione nella rete ottica Il traffico veicolato sui lightpath può essere a pacchetto, per esempio per interconnessione tra router IP, ma la rete ottica non ha nozione dei pacchetti Dispositivi in reti WR I dispositivi delle reti wavelength routing sono Optical Line Terminal (OLT): terminatore di linea, con funzioni di adattamento di lunghezza d onda, amplificazione, multiplexing/demultiplexing Optical Add-Drop Multiplexers (OADM): consente di derivare/inserire il traffico trasportato da una o più lunghezze d onda su un collegamento WDM Optical Cross Connect (OXC): commutatore di lunghezza d onda tra più ingressi e uscite Questi dispositivi sono equivalenti ad analoghi dispositivi di prima generazione delle reti SONET/SDH
3 Architettura reti WR OLT OLT OXC OXC router IP OADM OADM OADM OADM SONET terminal Esempio di rete WR Per motivare l utilizzo delle reti WR, consideriamo un esempio, modificando progressivamente una rete di tipo telefonica di prima generazione (con trasmissioni punto-punto su fibra ottica) Queste comprendono sovente anelli in tecnologia SONET/SDH operanti tipicamente a 2.5 Gb/s (OC48-STM16) I dispositivi di interconnessione per reti SONET/SDH sono adddrop multiplexer (ADM) e digital cross-connect (DCS)
4 Esempio di rete WR ADM=Add-Drop Multiplexer DCS=Digital Cross-Connect Esempio di rete WR La matrice di traffico normalizzata è la seguente: A B C D A B C D Se il traffico aumenta: A B C D A B C D possiamo passare a WDM
5 Esempio di rete WR L instradamento diventa: Esempio di rete WR flusso lungh. d onda # di OC-48 AB 1 BD 1 AD 1 AC 2 BC 1 BD 1 CD 1 con 3 lunghezze d onda
6 Esempio di rete WR Abbiamo costruito una topologia logica su una topologia fisica, costruendo dei lighpath ottici Esempio di rete WR Per gestire cambi di traffico e per offrire protezione, possono utilizzare commutatore ottici
7 Secondo esempio A B C Topologia fisica Tre router IP A, B e C, con interfacce a 10 Gb/s 50 Gb/s tra ogni coppia di router router router router progetto senza OADM router router OADM router progetto con OADM Secondo esempio Servono 10 lunghezze d onda su entrambe le fibre Senza OADM, la topologia logica (o topologia dei lightpath) è a bus (coincide con la topologia fisica); il router B ha bisogno di 20 porte Con OADM, la topologia logica è ad anello; il router B ha bisogno di 10 porte La convenienza tra le due alternative dipende dal costo relativo tra OADM e porte di router 5 B 5 A B C A C 5
8 Terzo esempio Topologia fisica Soluzione con 3 λ Topologia logica Quarto esempio: : anello bidir. Confrontiamo tre topologie logiche ottenute su anelli bidirezionali in termini di numero di porte dei router, numero di lunghezze d onda e distanza percorsa (in termini di hop). Il traffico è uniforme: ogni router invia t% della banda di un canale WDM a tutti gli altri N router (t/n-1 da router a router) WDM punto-punto (PWDM) hub (single hub) full-mesh (fully optical) hub si aggiunge un router di hub
9 Quarto esempio: anello bidir. Numero porte per router (Q) PWDM Q = 2W Hub Q = t Full-mesh Q = (N-1) t/(n-1) Numero lunghezze d onda (W) W = t/8 (N+1+1/(N-1)) W = t N/2 W = t / N-1 (N 2 /8+N/4) Diagrammiamo queste curve nel caso N=8 per diversi valori di t Quarto esempio: # di porte (traffico totale per distanza media diviso numero link)
10 Quarto esempio: # di l t Grooming Con il termine grooming si intende l impaccamento in una lnghezza d onda di circuiti (o flussi di informazione) a velocità inferiore. Questa funzione è svolta tipicamente dagli OXC Un solo canale può portare quindi più circuiti, multiplati con una tecnica opportuna Le commutazioni elettro ottiche consentono di effettuare grooming a livello elettronico. Nell esempio precedente la soluzione tutto ottica soffre di un basso livello di grooming (per bassi valori di t i lightpath sono sottoutilizzati); le curve di prestazioni risultano essere quantizzate in modo più grossolano
11 Reti wavelength routing Si usano cross-connect ottici (Optical Cross-Connect - OXC o Wavelength Cross-Connect - WXC) con collegamenti in fibra La rete fornisce lightpath (bandwidth pipe) tra coppie di nodi. Con la tecnologia attuale, sono possibili fino a un centinaio di lightpath per fibra B lightpath A E D λ1 C WDM cross-connect Bisogna decidere accuratamente l allocazione delle frequenze in modo da massimizzare il riuso spaziale Strato ottico Una rete wavelength routing costituisce uno strato ottico (con capacità di commutazione) che offre lightpath agli strati superiori Possiamo avere reti statiche o riconfigurabili Caratteristiche/potenzialità: Riutilizzo spaziale delle frequenze Possibilità di conversione di lunghezza d onda Trasparenza Commutazione di circuito Affidabilità (riconfigurazione in caso di guasto)
12 Conversione di l Possiamo utilizzare convertitori di lunghezza d onda, che consentono di utilizzare meglio le risorse di rete e agevolare l interconnessione di reti diverse B E C A D Wavelength converter Ragioni per utilizzare convertitori di lunghezza d onda: cambiare λ aggiunge flessibilità alle strutture WDM di tipo wavelength routing i dati possono essere generati ad una λ non compatibile con la rete interconnettendo reti diverse possono essere necessarie conversioni Quattro tipologie: Input λ variabile fissa fissa variabile Output λ fissa fissa variabile variabile
13 Conversione di l Convertitori opto-elettronici (OEO): Wavelength converter RX rigeneratore TX Svolgono naturalmente anche funzione di rigeneratore Permettono l inserimento di ritardi (anche variabili) per risincronizzare Non implicano commutazione nel dominio elettronico Comunque i singoli canali sono attestati nel dominio elettronico Si perde in trasparenza del lightpath
14 Diversità spaziale Sovente abbiamo diverse fibre nello stesso cavo. Questa diversità spaziale è equivalente a diversità di lunghezza d onda, scambiando commutatori con convertitori di lunghezza d onda fibra 1 fibra 1 fibra 1 fibra 1 λ 4 λ 5 λ 6 λ 4 λ 5 λ 6 fibra 2 fibra 2 switch λ-converter Wavelength Cross-Connect Connect network element manager porte di dorsale WDM cross-connect porte di dorsale porte locali I cross-connect ottici possono offrire diversi livelli di trasparenza (= rigenerazione): 1R: solo ricezione e ritrasmissione dei segnali ottici 2R: con risagomatura dei segnali 3R: con ritemporizzazione e risagomatura dei segnali
15 Wavelength Cross-Connect Connect wavelength demux wavelength mux... λ W 1... λ W 1... λ W 2 electronic cross connect... λ W 2... λ W M... λ W M receivers transmitters... λ W 1 wavelength demux Wavelength Cross-Connect Connect wavelength mux... λ W 1... λ W 2 optical switch... λ W 2... λ W M... λ W M wavelength converters (var fixed)
16 Wavelength Cross-Connect Connect... λ W 1... λ W 1... λ W 2... λ W 2... λ W M λ W... λ W M demux switch mux (no wavelength conversion) Wavelength Cross-Connect Connect Tecnologia realizzativa Ottica Elettronica Trasparenza sì difficile Conversione di λ difficile più facile Bit rate > 10 Gb/s 10 Gb/s Dimensione crossconnect piccola grande Potenza di alimentazione piccola grande Progetto strato fisico difficile più facile Monitoraggio limitato completo Componenti richiesti: mux/demux sì sì commutatori ottici sì no commutatori elettronici no sì trasmettitori/ricevitori no sì convertitori di λ forse no Le realizzazioni ottiche sono in prima istanza insensibili al bit rate, ma richiedono 3R nel dominio fotonico Le realizzazioni elettroniche costano meno (per ora)
17 Riconfigurabilità Le reti wavelength routing possono essere: statiche (senza OXC): minori costi, minor flessibilità, minor affidabilità riconfigurabili (con OXC): maggiori costi, maggior flessibilità, maggiore affidabilità Una rete statica è descrivibile con una matrice di connettività o con un (multi)grafo bipartito Reti WR statiche mux coupler coupler demux OXC statico grafo bipartito
18 Reti WR riconfigurabili Esistono equivalenze tra agilità in frequenza e commutazione spaziale (cioè tra numero di lunghezze d onda e numero di stadi di commutazione) Riconfigurabilità in tempi brevi trasformano un problema off-line (la matrice di traffico è completamente nota) in un problema on-line (variazione continue dei lightpath) Si possono affrontare due problemi: Logical (Virtual) TopologyDesign (LTD) Routing and Wavelength Assignment (RWA) Problemi di progetto in reti WR Problema di Routing and Wavelength Assignment (RWA): Data una topologia di rete e un insieme di richieste di lightpath (end-to-end), trovare l instradamento e la/e lunghezza/e d onda per ogni lightpath minimizzando il numero di lunghezze d onda utilizzate Problema di Logical Topology Design (LTD): Data una matrice di richieste di traffico tra nodi di una rete, trovare un insieme di lightpath ottimale (in termini di costi e/o prestazioni)
19 RWA: esempio Sorgente Destinazioni RWA: esempio l 3 Fibre occupate 13
20 RWA: altro esempio t 1 r 1 t 2 r 2 t 3 r 3 t 4 r 4 t 5 r 5 Abbiamo un lightpath da i a n-i+1 (n=5 nell esempio) Senza conversione occorrono comunque n lunghezza d onda Con conversione e routing opportuno possiamo avere due lightpath per canale; quindi due lunghezze d onda sono sufficienti Wavelength Assignment Il problema di Wavelength Assignment è simile al problema RWA, ma gli instradamenti sono definiti Dato un insieme di richieste di lightpath e di instradamenti, se l i è il numero di lightpath sul canale i della topologia, il carico (load) della rete è definito come L=max i l i Il problema WA diventa banale in presenza di conversione di lunghezza d onda: L lunghezza d onda sono sufficienti. Altrimenti ne occorrono in generale di più
21 WA e colorazione di grafi Grafo della rete Grafo dei lightpath Grafo dei lightpath: ogni nodo è un lightpath e gli archi specificano condivisione di canali nella rete Obiettivi del problema RWA Obiettivi del problema RWA possono essere la minimizzazione del carico L, o la minimizzazione della probabilità di bloccare una futura richiesta di lightpath Si può dimostrare che l instradamento di un insieme di lightpath con carico L in una rete G con M archi, se il numero massimo di hop per i lightpath è D, richiede al più un numero di lunghezze d onda pari a: min [(L-1)D + 1, (2L-1) M L + 2]
22 Colorazione di grafi Grafo dei lightpath: ogni nodo è un lightpath e gli archi specificano condivisione di canali nella rete Problema della colorazione del grafo: ogni nodo deve avere un colore diverso dai suoi vicini. Il minimo numero di colori si chiama numero cromatico del grafo Il problema della colorazione dei grafi è NP-completo anche se esistono buoni algoritmi ottimi in casi particolari e diverse euristiche RWA su anelli Gli anelli sono le più semplici topologie biconnesse e sono stati adottati da diversi standard, quali FDDI e SONET/SDH Ci sono solo due instradamenti possibili (orario e antiorario) per ogni lightpath. E possibile ottenere minimo carico L con un instradamento non a distanza minima e carico 2 L con un instradamento a distanza minima E facile trovare soluzioni al problema WA in un anello con carico L utilizzando non più di 2L-1 lunghezze d onda
23 WA su anelli taglio taglio su un nodo con numero minimo di lightpath in transito insieme dei lighpath assegnazione greedy delle λ più una λ per ogni lightpath tagliato (garantisce non più di 2L-1 λ) WA su diverse topologie Topologia Tipo di conversione nessuna fissa piena limitata arbitraria min[(l-1)d+1, L L (2L-1) M-L+2] anello 2L-1 L+1 L L stella 3L/2 L L albero 3L/2 L
24 RWA e conversione di l Abbiamo visto che la disponibilità anche limitata di conversione di lunghezza d onda può ridurre di molto il numero di lunghezze d onda se vogliamo servire off-line un insieme di richieste senza perdite Nel caso di richieste on-line che variano statisticamente, accettando una certa probabilità di blocco delle richieste, il guadagno portato dalla conversione di lunghezza d onda appare invece limitato nella maggior parte dei casi studiati (principalmente con simulazione) in letteratura RWA su topologie a maglia Si usano euristiche risolutive Esempio: Strategia First Fit Dato un lightpath da s a d Instradalo sul percorso fisico più breve Coloralo con la prima lunghezza d onda disponibile su tutte le fibre del percorso Strategia Max Fill Data una lunghezza d onda λ Dato un lightpath da s a d Instradalo sul percorso più breve usando λ, se possibile
25 Logical Topology Design Gli strati superiori dell architettura (per esempio IP o SONET/SDH) vedono un lightpath come un collegamento fisico tra i loro nodi Chiamamo fisica la topologia vista dallo strato ottico e logica la topologia vista dagli strati (elettronici) superiori topologia fisica lightpath canale in fibra WXC ottico switch SDH lightpath topologia logica Progetto della topologia I problemi di progetto della topologia logica e di progetto della topologia fisica sono tra di loro accoppiati Nella pratica di norma si risolve prima il problema del progetto della topologia logica (LTD), poi si progetta la topologia fisica (se non data) e infine si risolve il problema RWA Sovente si è nella situazione in cui l infrastruttura di rete (topologia fisica) è posseduta e controllata da un fornitore di servizi (che affronta il problema RWA), che vende connessioni ATM o SONET/SDH ai propri clienti (che affrontano il problema LTD)
26 Logical Topology Design Obbiettivo nel progetto della topologia logica è la minimizzazione del costo, trovando il miglior compromesso tra costo dei lightpath (includendo il costo della loro commutazione) e costo di commutatori a livello SONET/SDH o ATM, sovente con vincoli sull affidabilità della rete E possibile dare una formulazione in termini di problemi di programmazione lineare mista del problema LTD Vista la complessità della soluzione, sono state proposte e vengono utilizzate tecniche euristiche Vincoli e obiettivi del LTD Vincoli: Numero limitato di trasmettitori/ricevitori per nodo Numero limitato di lunghezze d onda per fibra Numero di hop fisici limitato da problemi trasmissivi Obiettivi: Minimizzare la lunghezza dei percorsi multihop Minimizzare il ritardo endto-end Minimizzare la massima congestione su un lightpath Altro Problema NP-HARD
27 Formulazione del problema Data: Una rete WDM fisica dove ogni nodo i è dotato di δ i O trasmettitori e δ i I ricevitori Una matrice di traffico T sd =[t sd ]; Σ d t sd = t s Dato un algoritmo di routing per traffico multi-hop Trovare L insieme di lightpath che soddisfa la richesta di traffico e che minimizza il massimo livello di congestione sui canali logici f max, dato dalla somma del traffico che attraversa ogni lightpath Formulazione del problema Obiettivo: min f max f ij f i, j max Conservazione di flusso ad ogni nodo j s s s t if s = i fij f ji = s, i si j t if s i s f ij = fij i, j s s s fij bijt i, j, s Vincoli di connettività i bij O i j j bij I j i b ij { 0,1} i, j b ij = 1 se esiste un arco (lightpath) tra il nodo i e il nodo j f s ij = quantità di informazione generata da s e instradata sul collegamento (i,j)
28 Instradamento traffico multi-hop La formulazione precedente permette un instradamento ottimo del traffico sulla topologia, ovvero di poter spezzare i flussi di traffico offerto t s attraverso tutti percorsi della rete senza vincoli aggiuntivi Purtroppo nelle reti IP esistono vincoli tecnologici che impediscono questo: il problema ottimo di instradamento è un classico problema multicommodity, anch esso in generale NP-Hard Occorre includere il vincolo di instradamento nella formulazione di cui sopra: i flussi saranno instradati sui percorsi a costo minimo Approcci di ottimizzazione Euristiche greedy Considerando i dati di ingresso, si costruisce una soluzione ad hoc per il problema Topologia casuale (BR): genera N topologie casuali e considera la migliore Massimizzare traffico single hop (Scom):aggiungi lightpath corrispondenti alle più grosse relazioni t sd Considera il traffico multihop (R&R): rimuovi gli archi meno usati, e reinstrada il traffico Uso di topologie logiche regolari: occorre ottimizzare la disposizione dei nodi
29 Metaeuristiche Approcci di ottimizzazione Espora più soluzioni in modo intelligente Simulated annealing Data una topologia, costruiscine una alterazione. Se f max è minore, tieni la nuova topologia. Se è peggiore, tienila con una probabilità non nulla (che si modifica col tempo) Tabu search Data una topologia, considera tutte quelle che ottieni applicando una alterazione, e scegli la migliore. Evita cicli con lista di mosse proibite Ricerca locale Partenza da una soluzione iniziale X Aggiornamento di soluzione corrente, e miglior soluzione ottenuta Esplorazione di soluzioni vicine (A,B,C,D) Spostamento verso La miglior soluzione del vicinato (steepest descent ) B x A F... Opt Il primo vicino migliorante (first improvement ) C D E Termine dopo un numero di iterazioni PROBLEMA: possibile intrappolamenti in minimi locali
30 Tabu e Simulated Annealing Per evitare intrappolamenti in minimi locali Uso di memoria per ricordare il percorso fatto: Tabu search Uso di casualità per interrompere il determinismo nella scelta: Simulated Annealing Tabu Search Memorizza lista di mosse vietate (non le soluzioni, ma le mosse) Esclude dal calcolo dei vicini quelli ottenuti tramite l applicazione di mosse vietate Nel nostro caso Mossa: scambio di due archi (per mantenere il vincolo di connettività) Vicinato: tutte le topologie che differiscono dalla corrente per lo scambio di due archi Scelta del vicino di tipo steepest descent
31 Simulated Annealing Data la soluzione corrente, genera un vicino a caso (tramite lo scambio di due archi a caso) Se migliore accetta soluzione con probabilità 1 Se non migliore accetta soluzione con probabilità p = e -(distanza)/kt T rappresenta la temperatura T diminuisce con il numero di soluzioni visitate Algoritmo che alla fine diviene una ricerca locale tipo first improvement Esempio su una rete 24 nodi
32 Esempi di evoluzione soluzione
Classificazione dei sistemi in fibra ottica
 Classificazione dei sistemi in fibra ottica Reti ottiche Le fibre ottiche sono oggi il mezzo trasmissivo più utilizzato per distanze superiori a qualche chilometro e velocità di trasmissione superiori
Classificazione dei sistemi in fibra ottica Reti ottiche Le fibre ottiche sono oggi il mezzo trasmissivo più utilizzato per distanze superiori a qualche chilometro e velocità di trasmissione superiori
Corso di Reti di Telecomunicazione. Elementi delle reti WDM
 Corso di Reti di Telecomunicazione Elementi delle reti WDM Elementi delle reti WDM CWDM vs. DWDM Elementi delle reti WDM Optical Line Terminals (OLT) Optical Line Amplifiers Optical Add/Drop Multiplexer
Corso di Reti di Telecomunicazione Elementi delle reti WDM Elementi delle reti WDM CWDM vs. DWDM Elementi delle reti WDM Optical Line Terminals (OLT) Optical Line Amplifiers Optical Add/Drop Multiplexer
Introduzione. Il routing permette la comunicazione tra due nodi differenti anche se non sono collegati direttamente
 Routing Introduzione Il livello 3 della pila ethernet ha il compito di muovere i pacchetti dalla sorgente attraversando più sistemi Il livello di network deve quindi: Scegliere di volta in volta il cammino
Routing Introduzione Il livello 3 della pila ethernet ha il compito di muovere i pacchetti dalla sorgente attraversando più sistemi Il livello di network deve quindi: Scegliere di volta in volta il cammino
Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE
 Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato su Datagram Algoritmi
Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato su Datagram Algoritmi
RETI OTTICHE: APPARATI
 RETI OTTICHE: APPARATI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Introduzione Reti ottiche WDM forniscono canali ottici end-to-end
RETI OTTICHE: APPARATI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Introduzione Reti ottiche WDM forniscono canali ottici end-to-end
Topologie delle reti di telecomunicazione
 Topologie delle reti di telecomunicazione Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ INTRODUZIONE ALLE RETI TELEMATICHE - 1 Rete di telecomunicazione Definizione: un insieme
Topologie delle reti di telecomunicazione Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ INTRODUZIONE ALLE RETI TELEMATICHE - 1 Rete di telecomunicazione Definizione: un insieme
Reti Ottiche: dalla trasmissione su fibra alla commutazione fotonica
 Reti Ottiche: dalla trasmissione su fibra alla commutazione fotonica Parte IX: Cenni a gestione e affidabilità Fabio Neri e Marco Mellia Gruppo Reti Dipartimento di Elettronica e-mail: nome.cognome@polito.it
Reti Ottiche: dalla trasmissione su fibra alla commutazione fotonica Parte IX: Cenni a gestione e affidabilità Fabio Neri e Marco Mellia Gruppo Reti Dipartimento di Elettronica e-mail: nome.cognome@polito.it
Introduzione alle reti ottiche
 Corso di Sistemi di Telecomunicazione Ottici Introduzione alle reti ottiche Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni A.A. 2009/2010 Introduzione alle reti ottiche Introduzione
Corso di Sistemi di Telecomunicazione Ottici Introduzione alle reti ottiche Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni A.A. 2009/2010 Introduzione alle reti ottiche Introduzione
Programma del corso. Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori
 Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
Proposte di tesi in Telecom Italia Lab, Aprile (sede in Torino, Via Reiss Romoli)
 Proposte di tesi in Telecom Italia Lab, Aprile 2015 (sede in Torino, Via Reiss Romoli) Le proposte di tesi presenti alla pagine successive sono state proposte direttamente da Telecom Italia Lab, e prevedono
Proposte di tesi in Telecom Italia Lab, Aprile 2015 (sede in Torino, Via Reiss Romoli) Le proposte di tesi presenti alla pagine successive sono state proposte direttamente da Telecom Italia Lab, e prevedono
Reti di Calcolatori:
 Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
Flusso a Costo Minimo
 Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Flusso a Costo Minimo Docente: Renato Bruni bruni@dis.uniroma.it Corso di: Ottimizzazione Combinatoria Dal
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Flusso a Costo Minimo Docente: Renato Bruni bruni@dis.uniroma.it Corso di: Ottimizzazione Combinatoria Dal
RETI DI CALCOLATORI II
 RETI DI CALCOLATORI II Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine Ing. DANIELE DE CANEVA a.a. 2009/2010 ARGOMENTI DELLA LEZIONE TEORIA DEL ROUTING ROUTING STATICO ROUTING DINAMICO o PROTOCOLLI
RETI DI CALCOLATORI II Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine Ing. DANIELE DE CANEVA a.a. 2009/2010 ARGOMENTI DELLA LEZIONE TEORIA DEL ROUTING ROUTING STATICO ROUTING DINAMICO o PROTOCOLLI
Reti locali. Protocolli di accesso per reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
In questa sezione si affronteranno i seguenti argomenti: Introduzione agli amplificatoriottici. Amplificatori ottici ad Erbio (EDFA)
 Reti in fibra ottica 1/64 Cosa c è nella lezione In questa sezione si affronteranno i seguenti argomenti: Introduzione agli amplificatoriottici Amplificatori ottici ad Erbio (EDFA) Caratteristiche EDFA
Reti in fibra ottica 1/64 Cosa c è nella lezione In questa sezione si affronteranno i seguenti argomenti: Introduzione agli amplificatoriottici Amplificatori ottici ad Erbio (EDFA) Caratteristiche EDFA
Corso di Reti di Telecomunicazione. Reti di trasporto
 Corso di Reti di Telecomunicazione Reti di trasporto Reti di trasporto (1) Reti di trasporto Evoluzione delle reti di TLC Progetto dello strato di trasmissione Sistemi WDM unidirezionali e bidirezionali
Corso di Reti di Telecomunicazione Reti di trasporto Reti di trasporto (1) Reti di trasporto Evoluzione delle reti di TLC Progetto dello strato di trasmissione Sistemi WDM unidirezionali e bidirezionali
MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI
 MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia METODI DI MULTIPLAZIONE TDM
MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia METODI DI MULTIPLAZIONE TDM
Fondamenti di Internet e Reti 097246
 sul livello di Rete Instradamento. o Si consideri la rete in figura.. Si rappresenti, mediante un grafo, la rete per il calcolo dei cammini minimi (solo i nodi e gli archi no reti). Si calcoli il cammino
sul livello di Rete Instradamento. o Si consideri la rete in figura.. Si rappresenti, mediante un grafo, la rete per il calcolo dei cammini minimi (solo i nodi e gli archi no reti). Si calcoli il cammino
2.2 Alberi di supporto di costo ottimo
 . Alberi di supporto di costo ottimo Problemi relativi ad alberi hanno numerose applicazioni: progettazione di reti (comunicazione, teleriscaldamento,...) memorizzazione compatta di sequenze (DNA) diffusione
. Alberi di supporto di costo ottimo Problemi relativi ad alberi hanno numerose applicazioni: progettazione di reti (comunicazione, teleriscaldamento,...) memorizzazione compatta di sequenze (DNA) diffusione
Interconnessione di reti IP
 Interconnessione di reti IP Mario Baldi mario.baldi@polito.it staff.polito.it/mario.baldi Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slide) è protetto dalle leggi sul copyright
Interconnessione di reti IP Mario Baldi mario.baldi@polito.it staff.polito.it/mario.baldi Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slide) è protetto dalle leggi sul copyright
1: Generalità sulle reti di trasmissione numeriche
 1 1 1: Generalità sulle reti di trasmissione numeriche Reti e sistemi distribuiti 2 Una rete di computer è un insieme di calcolatori interconnesso L accesso ad una risorsa remota presuppone la connessione
1 1 1: Generalità sulle reti di trasmissione numeriche Reti e sistemi distribuiti 2 Una rete di computer è un insieme di calcolatori interconnesso L accesso ad una risorsa remota presuppone la connessione
Appello Esempio d esame. Es1 (6 pt) Es2 (6 pt) Es3 (6 pt) Ques (9 pt) Lab (6pt)
 Fondamenti di Internet e Reti Proff. A. Capone, M. Cesana, I. Filippini, G. Maier Cognome Nome Matricola Appello Esempio d esame Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 2h15m Usare lo spazio
Fondamenti di Internet e Reti Proff. A. Capone, M. Cesana, I. Filippini, G. Maier Cognome Nome Matricola Appello Esempio d esame Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 2h15m Usare lo spazio
RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO. Caratteristiche e principi di funzionamento
 RETI A COMMUTAZIOE DI PACCETTO Caratteristiche e principi di funzionamento VARIABILITA DEL BIT RATE DI U SEGALE R (Bit-Rate) VALORE DI PICCO DEL BIT-RATE S VALORE MEDIO DEL BIT-RATE E tempo CARATTERISTICE
RETI A COMMUTAZIOE DI PACCETTO Caratteristiche e principi di funzionamento VARIABILITA DEL BIT RATE DI U SEGALE R (Bit-Rate) VALORE DI PICCO DEL BIT-RATE S VALORE MEDIO DEL BIT-RATE E tempo CARATTERISTICE
Il protocollo RS Introduzione. 1.2 Lo Standard RS-232
 1 Il protocollo RS232 1.1 Introduzione Come noto un dispositivo di interfaccia permette la comunicazione tra la struttura hardware di un calcolatore e uno o più dispositivi esterni. Uno degli obiettivi
1 Il protocollo RS232 1.1 Introduzione Come noto un dispositivo di interfaccia permette la comunicazione tra la struttura hardware di un calcolatore e uno o più dispositivi esterni. Uno degli obiettivi
Reti. insieme di computer (host) interconnessi. Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile
 Reti Rete insieme di computer (host) interconnessi Tipologie interconnessioni Ad anello (token ring). Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile i pacchetti di dati possono girare
Reti Rete insieme di computer (host) interconnessi Tipologie interconnessioni Ad anello (token ring). Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile i pacchetti di dati possono girare
Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti. PARTE I Introduzione e modelli 1. Capitolo 1 Introduzione 3
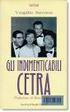 Prefazione Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti XIII XVII XIX PARTE I Introduzione e modelli 1 Capitolo 1 Introduzione 3 1.1 Comunicazione dati 3 1.2 Reti 6 1.3 Internet 12 1.4 Protocolli
Prefazione Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti XIII XVII XIX PARTE I Introduzione e modelli 1 Capitolo 1 Introduzione 3 1.1 Comunicazione dati 3 1.2 Reti 6 1.3 Internet 12 1.4 Protocolli
RETE DI TRASPORTO OTTICA
 RETE DI TRASPORTO OTTICA I sistemi di trasmissione WDM furono introdotti inizialmente per aumentare la capacità dei collegamenti punto-punto; con l introduzione di altri dispositivi come l Optical Add
RETE DI TRASPORTO OTTICA I sistemi di trasmissione WDM furono introdotti inizialmente per aumentare la capacità dei collegamenti punto-punto; con l introduzione di altri dispositivi come l Optical Add
4c. Esercizi sul livello di Rete Instradamento in Internet
 c. sul livello di Rete Instradamento in Internet c- o Si consideri la rete in figura. Si rappresenti, mediante un grafo, la rete per il calcolo dei cammini minimi (solo i nodi e gli archi no reti). Si
c. sul livello di Rete Instradamento in Internet c- o Si consideri la rete in figura. Si rappresenti, mediante un grafo, la rete per il calcolo dei cammini minimi (solo i nodi e gli archi no reti). Si
Networking e Reti IP Multiservizio
 Networking e Reti IP Multiservizio Modulo : Introduzione alle reti per dati Livello (routing su IP) Gabriele i Stefano: gabriele@ing.univaq.it 4: Network Layer 4a- Livello : Network (Rete) Questa lezione:
Networking e Reti IP Multiservizio Modulo : Introduzione alle reti per dati Livello (routing su IP) Gabriele i Stefano: gabriele@ing.univaq.it 4: Network Layer 4a- Livello : Network (Rete) Questa lezione:
Introduzione alle Reti di Calcolatori. Prof. Ing. Mario Catalano
 Introduzione alle Reti di Calcolatori Prof. Ing. Mario Catalano Computing centralizzato Caratteristiche del computing centralizzato: sistemi fortemente centralizzati grandi capacità di calcolo rete complessa
Introduzione alle Reti di Calcolatori Prof. Ing. Mario Catalano Computing centralizzato Caratteristiche del computing centralizzato: sistemi fortemente centralizzati grandi capacità di calcolo rete complessa
Parte I. Ibrido MPLS. Figura 1.1
 Parte I 1. INTRODUZIONE ALLE RETI MPLS Instradamento a pacchetto datagram Ibrido Commutazione di circuito virtuale IP MPLS ATM Figura 1.1 L MPLS (Multiprotocol label switching, commutazione di etichetta
Parte I 1. INTRODUZIONE ALLE RETI MPLS Instradamento a pacchetto datagram Ibrido Commutazione di circuito virtuale IP MPLS ATM Figura 1.1 L MPLS (Multiprotocol label switching, commutazione di etichetta
Lezione n.8 LPR- Informatica Applicata
 Lezione n.8 LPR- Informatica Applicata 3/4/2006 Laura Ricci Laura Ricci 1 RIASSUNTO DELLA LEZIONE Classfull IP Addressing Subnetting CIDR: Classless Adddressing Laura Ricci 2 INTERCONNESSIONE DI RETI:
Lezione n.8 LPR- Informatica Applicata 3/4/2006 Laura Ricci Laura Ricci 1 RIASSUNTO DELLA LEZIONE Classfull IP Addressing Subnetting CIDR: Classless Adddressing Laura Ricci 2 INTERCONNESSIONE DI RETI:
Fondamenti di Reti di Telecomunicazioni Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010
 Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda 1 1 (svolgere su questo foglio e sul retro) (7 punti) Si consideri la rete a commutazione
Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda 1 1 (svolgere su questo foglio e sul retro) (7 punti) Si consideri la rete a commutazione
1. Introduzione alle Reti di TLC
 Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 1 1. Introduzione alle Reti di TL Prof. Raffaele olla ompito della rete è: INTERONNETTERE più apparati o utenti per permettere
Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 1 1. Introduzione alle Reti di TL Prof. Raffaele olla ompito della rete è: INTERONNETTERE più apparati o utenti per permettere
Reti di calcolatori. Rete di calcolatori
 Operatore informatico giuridico Informatica Giuridica A.A 2006/2007 II Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi hardware
Operatore informatico giuridico Informatica Giuridica A.A 2006/2007 II Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi hardware
AMPL Problemi su Reti
 Dipartimento di Matematica Università di Padova Corso di Laurea Informatica Outline Problemi su Reti Cammino Minimo Molti problemi di ottimizzazione combinatoria possono essere modellati ricorrendo ai
Dipartimento di Matematica Università di Padova Corso di Laurea Informatica Outline Problemi su Reti Cammino Minimo Molti problemi di ottimizzazione combinatoria possono essere modellati ricorrendo ai
RETI DI CALCOLATORI. Domande di riepilogo Quarta Esercitazione. Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway?
 RETI DI CALCOLATORI Domande di riepilogo Quarta Esercitazione Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway? Bridge, Router e Gateway servono ad interconnettere reti diverse (internetworking).
RETI DI CALCOLATORI Domande di riepilogo Quarta Esercitazione Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway? Bridge, Router e Gateway servono ad interconnettere reti diverse (internetworking).
Tipi di comunicazione
 Tipi di comunicazione - 1 - COMMUTAZIONE: DI CIRCUITO E DI PACCHETTO La commutazione è quell operazione che predispone il percorso che le informazioni emesse dal mittente devono seguire per raggiungere
Tipi di comunicazione - 1 - COMMUTAZIONE: DI CIRCUITO E DI PACCHETTO La commutazione è quell operazione che predispone il percorso che le informazioni emesse dal mittente devono seguire per raggiungere
Fondamenti di Internet e Reti. Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier
 Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier 4 - Livello Rete (parte ) Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier Strato di rete e strato di trasporto Lo strato di trasporto
Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier 4 - Livello Rete (parte ) Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier Strato di rete e strato di trasporto Lo strato di trasporto
- 5 - Controllo a finestra
 Politecnico di Milano Dipartimento di Elettronica e Informazione - 5 - Controllo a finestra Laboratorio di Reti di Telecomunicazione 1 Controllo della velocità di trasmissione della sorgente di traffico
Politecnico di Milano Dipartimento di Elettronica e Informazione - 5 - Controllo a finestra Laboratorio di Reti di Telecomunicazione 1 Controllo della velocità di trasmissione della sorgente di traffico
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
 Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack StarTech ID: IES101002SFP Lo switch Ethernet a 10 porte IES101002SFP offre flessibilità
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack StarTech ID: IES101002SFP Lo switch Ethernet a 10 porte IES101002SFP offre flessibilità
SDH Synchronous Digital Hierarchy
 SDH Synchronous Digital Hierarchy Principi della gerarchia SDH Si basa sulla rete SONET (Synchronous Optical Network) L elemento base si chiama STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1) Durata 125µs
SDH Synchronous Digital Hierarchy Principi della gerarchia SDH Si basa sulla rete SONET (Synchronous Optical Network) L elemento base si chiama STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1) Durata 125µs
Ricerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili
 Ricerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili Modelli per la Logistica Distributiva: Single Commodity Minimum Cost Flow Problem Multi Commodity Minimum Cost Flow Problem Fixed Charge
Ricerca Operativa e Logistica Dott. F.Carrabs e Dott.ssa M.Gentili Modelli per la Logistica Distributiva: Single Commodity Minimum Cost Flow Problem Multi Commodity Minimum Cost Flow Problem Fixed Charge
Reti a Commutazione. Commutazione di Circuito. Esempio di Rete a Commutazione. Elementi di una Rete a Commutazione
 I semestre 03/04 Reti a Commutazione Commutazione di Circuito Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
I semestre 03/04 Reti a Commutazione Commutazione di Circuito Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione. Modelli Funzionali
 Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione Modelli Funzionali 2 Il servizio di comunicazione o Date due o più entità remote o Possiamo descrivere il servizio di comunicazione
Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione Modelli Funzionali 2 Il servizio di comunicazione o Date due o più entità remote o Possiamo descrivere il servizio di comunicazione
Una rete di computer e': Una rete di computer permette:
 Reti di calcolatori Le reti La nozione di rete e' un concetto molto diffuso. Una rete e' topologicamente senza gerarchia e senza centro. Si parla di rete stradale, rete elettrica, rete da pesca, rete del
Reti di calcolatori Le reti La nozione di rete e' un concetto molto diffuso. Una rete e' topologicamente senza gerarchia e senza centro. Si parla di rete stradale, rete elettrica, rete da pesca, rete del
Introduzione ai grafi. Introduzione ai grafi p. 1/2
 Introduzione ai grafi Introduzione ai grafi p. 1/2 Grafi Un grafo G é costituito da una coppia di insiemi (V,A) dove V é detto insieme dei nodi e A é detto insieme di archi ed é un sottinsieme di tutte
Introduzione ai grafi Introduzione ai grafi p. 1/2 Grafi Un grafo G é costituito da una coppia di insiemi (V,A) dove V é detto insieme dei nodi e A é detto insieme di archi ed é un sottinsieme di tutte
LE RETI DI COMPUTER. Il modello ISO/OSI Prima parte
 LE RETI DI COMPUTER Il modello ISO/OSI Prima parte I MODELLI PER LE RETI All i izio dell era i for ati a, la gestio e delle comunicazioni tra sistemi si era rilevata uno dei problemi più grandi, soprattutto
LE RETI DI COMPUTER Il modello ISO/OSI Prima parte I MODELLI PER LE RETI All i izio dell era i for ati a, la gestio e delle comunicazioni tra sistemi si era rilevata uno dei problemi più grandi, soprattutto
Intelligenza Artificiale. Ricerca euristica Algoritmo A*
 Intelligenza Artificiale Ricerca euristica Algoritmo A* Marco Piastra Metodi di ricerca - Ricerca non informata Ricerca nello spazio degli stati Definizione di un grafo come spazio degli stati I nodi rappresentano
Intelligenza Artificiale Ricerca euristica Algoritmo A* Marco Piastra Metodi di ricerca - Ricerca non informata Ricerca nello spazio degli stati Definizione di un grafo come spazio degli stati I nodi rappresentano
Routing IP. IP routing
 Routing IP IP routing IP routing (inoltro IP): meccanismo per la scelta del percorso in Internet attraverso il quale inviare i datagram IP routing effettuato dai router (scelgono il percorso) Routing diretto
Routing IP IP routing IP routing (inoltro IP): meccanismo per la scelta del percorso in Internet attraverso il quale inviare i datagram IP routing effettuato dai router (scelgono il percorso) Routing diretto
Progetto di Reti di Telecomunicazione Modelli in Programmazione Lineare Problemi di Network design
 Progetto di Reti di Telecomunicazione Modelli in Programmazione Lineare Problemi di Network design Network Design È data una rete rappresentata su da un grafo G = (V, A) e un insieme di domande K, ciascuna
Progetto di Reti di Telecomunicazione Modelli in Programmazione Lineare Problemi di Network design Network Design È data una rete rappresentata su da un grafo G = (V, A) e un insieme di domande K, ciascuna
Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione
 Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione Sorgenti di informazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche
Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione Sorgenti di informazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE Prof. Giovanni Schembra 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO
 E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
Le reti rete La telematica telematica tele matica Aspetti evolutivi delle reti Modello con mainframe terminali Definizione di rete di computer rete
 Reti e comunicazione Le reti Con il termine rete si fa riferimento, in generale ai servizi che si ottengono dall integrazione tra tecnologie delle telecomunicazioni e le tecnologie dell informatica. La
Reti e comunicazione Le reti Con il termine rete si fa riferimento, in generale ai servizi che si ottengono dall integrazione tra tecnologie delle telecomunicazioni e le tecnologie dell informatica. La
Reti a commutazione di pacchetto
 Prof. Roberto De Prisco TEORIA Lezione Reti a commutazione di pacchetto Università degli studi di Salerno Laurea e Diploma in Informatica Svantaggi commutazione circuito Risorse riservate al circuito Se
Prof. Roberto De Prisco TEORIA Lezione Reti a commutazione di pacchetto Università degli studi di Salerno Laurea e Diploma in Informatica Svantaggi commutazione circuito Risorse riservate al circuito Se
Routing statico. Routing statico. Tolleranza ai guasti. Routing statico. Fase di progetto. 09CDUdc Reti di Calcolatori.
 Fixed directory routing Regole di instradamento impostate una tantum dall amministratore di sistema 09Udc Reti di alcolatori Orizzonte di visibilità limitato allo stato dei link adiacenti Semplice da realizzare
Fixed directory routing Regole di instradamento impostate una tantum dall amministratore di sistema 09Udc Reti di alcolatori Orizzonte di visibilità limitato allo stato dei link adiacenti Semplice da realizzare
Reti Locali LAN. Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni
 Reti Locali LAN Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Caratteristiche delle reti LAN Nelle reti locali tutte le stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo, generalmente
Reti Locali LAN Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Caratteristiche delle reti LAN Nelle reti locali tutte le stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo, generalmente
Amplificatori Ottici
 Amplificatori Ottici Amplificazione ottica (1/2) Per controbilanciare l attenuazione della fibra, sono utili gli amplificatori ottici E () t = GE () t + n() t out in Rumore ottico generato dall amplificatore
Amplificatori Ottici Amplificazione ottica (1/2) Per controbilanciare l attenuazione della fibra, sono utili gli amplificatori ottici E () t = GE () t + n() t out in Rumore ottico generato dall amplificatore
Sintesi Sequenziale Sincrona Sintesi Comportamentale di reti Sequenziali Sincrone
 Sintesi Sequenziale Sincrona Sintesi Comportamentale di reti Sequenziali Sincrone Il problema dell assegnamento degli stati versione del 9/1/03 Sintesi: Assegnamento degli stati La riduzione del numero
Sintesi Sequenziale Sincrona Sintesi Comportamentale di reti Sequenziali Sincrone Il problema dell assegnamento degli stati versione del 9/1/03 Sintesi: Assegnamento degli stati La riduzione del numero
Internet (- working). Le basi.
 Internet (- working). Le basi. 1 GABRIELLA PAOLINI (GARR) 18 OTTOBRE 2011 Capire come funziona Internet 2 FACCIAMO UN PASSO INDIETRO Internet È un insieme di reti interconnesse fra di loro su tutto il
Internet (- working). Le basi. 1 GABRIELLA PAOLINI (GARR) 18 OTTOBRE 2011 Capire come funziona Internet 2 FACCIAMO UN PASSO INDIETRO Internet È un insieme di reti interconnesse fra di loro su tutto il
GLI APPARATI PER L INTERCONNESSIONE DI RETI LOCALI 1
 GLI APPARATI PER L INTERCONNESSIONE DI RETI LOCALI 1 Il Repeater 2 L Hub 3 Il Bridge 11 Lo Switch 11 Router 19 Gli apparati per l interconnessione di reti locali Distinguiamo i seguenti tipi di apparati:
GLI APPARATI PER L INTERCONNESSIONE DI RETI LOCALI 1 Il Repeater 2 L Hub 3 Il Bridge 11 Lo Switch 11 Router 19 Gli apparati per l interconnessione di reti locali Distinguiamo i seguenti tipi di apparati:
Call Admission Controll (CAC)
 CAC: Connection Admission Control Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ TECNICHE DI ACCETTAZIONE DELLE CHIAMATE - 1 Call Admission Controll (CAC) Tecnica di controllo
CAC: Connection Admission Control Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ TECNICHE DI ACCETTAZIONE DELLE CHIAMATE - 1 Call Admission Controll (CAC) Tecnica di controllo
Programmazione Lineare Intera: Piani di Taglio
 Programmazione Lineare Intera: Piani di Taglio Andrea Scozzari a.a. 2014-2015 April 22, 2015 Andrea Scozzari (a.a. 2014-2015) Programmazione Lineare Intera: Piani di Taglio April 22, 2015 1 / 23 Programmazione
Programmazione Lineare Intera: Piani di Taglio Andrea Scozzari a.a. 2014-2015 April 22, 2015 Andrea Scozzari (a.a. 2014-2015) Programmazione Lineare Intera: Piani di Taglio April 22, 2015 1 / 23 Programmazione
INTERNET e RETI di CALCOLATORI A.A. 2015/2016 Capitolo 4 Instradamento e Algoritmi di instradamento Fausto Marcantoni
 Laurea in INFORMATICA INTERNET e RETI di CALCOLATORI A.A. 2015/2016 Capitolo 4 Instradamento e Algoritmi di instradamento fausto.marcantoni@unicam.it Che cosa fa il livello di rete? Il ruolo dello strato
Laurea in INFORMATICA INTERNET e RETI di CALCOLATORI A.A. 2015/2016 Capitolo 4 Instradamento e Algoritmi di instradamento fausto.marcantoni@unicam.it Che cosa fa il livello di rete? Il ruolo dello strato
RETI DI CALCOLATORI - Reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Ethernet è una suite di protocolli originariamente sviluppati per realizzare LAN (Local Area Networks):
 Reti in fibra ottica Il protocollo Ethernet Ethernet è una suite di protocolli originariamente sviluppati per realizzare LAN (Local Area Networks): Ethernet ha avuto molto successo ed è uno dei protocolli
Reti in fibra ottica Il protocollo Ethernet Ethernet è una suite di protocolli originariamente sviluppati per realizzare LAN (Local Area Networks): Ethernet ha avuto molto successo ed è uno dei protocolli
Routing. Forwarding e routing
 Routing E necessario stabilire un percorso quando host sorgente e destinazione non appartengono alla stessa rete Router di default si occupa di instradare il traffico all esterno della rete Router sorgente:
Routing E necessario stabilire un percorso quando host sorgente e destinazione non appartengono alla stessa rete Router di default si occupa di instradare il traffico all esterno della rete Router sorgente:
Sistemi di Telecomunicazione
 Sistemi di Telecomunicazione Parte 6: Sistemi Ottici Parte 6.4: Esempi di dimensionamento di sistemi ottici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2013-2014 A.A. 2013-2014 Sistemi di Telecomunicazione
Sistemi di Telecomunicazione Parte 6: Sistemi Ottici Parte 6.4: Esempi di dimensionamento di sistemi ottici Universita Politecnica delle Marche A.A. 2013-2014 A.A. 2013-2014 Sistemi di Telecomunicazione
Figura 1: 1) Si scriva la formulazione del problema come problema di PLI (con un numero minimo di vincoli) e la matrice dei vincoli.
 ESERCIZIO 1 Sia dato il grafo orientato in Figura 1. Si consideri il problema di flusso a 1 2 4 Figura 1: costo minimo su tale grafo con b 1 = 4 b 2 = 2 b = b 4 = e c 12 = 2 c 1 = 4 c 14 = 1 c 2 = 1 c
ESERCIZIO 1 Sia dato il grafo orientato in Figura 1. Si consideri il problema di flusso a 1 2 4 Figura 1: costo minimo su tale grafo con b 1 = 4 b 2 = 2 b = b 4 = e c 12 = 2 c 1 = 4 c 14 = 1 c 2 = 1 c
Cosa c è nella lezione. In questa sezione si affronteranno: Reti in fibra ottica. La struttura complessiva. Il trasmettitore ottico
 Reti in fibra ottica 1/30 Cosa c è nella lezione In questa sezione si affronteranno: La struttura complessiva Il trasmettitore ottico Il ricevitore ottico. 2/30 Reti in fibra ottica 3/30 Schema a blocchi
Reti in fibra ottica 1/30 Cosa c è nella lezione In questa sezione si affronteranno: La struttura complessiva Il trasmettitore ottico Il ricevitore ottico. 2/30 Reti in fibra ottica 3/30 Schema a blocchi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa 1 Seconda prova intermedia 17 giugno 2013
 A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Seconda prova intermedia 7 giugno 0 Nome: Cognome: Matricola: Orale /06/0 ore aula N Orale 0/07/0 ore aula N
A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE Corso di Studi in Ingegneria Informatica Ricerca Operativa Seconda prova intermedia 7 giugno 0 Nome: Cognome: Matricola: Orale /06/0 ore aula N Orale 0/07/0 ore aula N
A cura di Valeria Valecchi
 A cura di Valeria Valecchi Libro di testo di riferimento: Cloud di Gallo e Sirsi Blocco tematico C: L azienda e le reti Unità di apprendimento 1 CHE COS E UNA RETE DI COMPUTER TELEMATICA= TELEcomunicazione+inforMATICA
A cura di Valeria Valecchi Libro di testo di riferimento: Cloud di Gallo e Sirsi Blocco tematico C: L azienda e le reti Unità di apprendimento 1 CHE COS E UNA RETE DI COMPUTER TELEMATICA= TELEcomunicazione+inforMATICA
Gestione della produzione e della supply chain Logistica distributiva
 Gestione della produzione e della supply chain Logistica distributiva Paolo Detti Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Scienze Matematiche Università di Siena Convergenza dell algoritmo Se non
Gestione della produzione e della supply chain Logistica distributiva Paolo Detti Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Scienze Matematiche Università di Siena Convergenza dell algoritmo Se non
Minimizzazione di Reti Logiche Combinatorie Multi-livello. livello
 Minimizzazione di Reti Logiche Combinatorie Multi-livello livello Maurizio Palesi Maurizio Palesi 1 Introduzione I circuiti logici combinatori sono molto spesso realizzati come reti multi-livello di porte
Minimizzazione di Reti Logiche Combinatorie Multi-livello livello Maurizio Palesi Maurizio Palesi 1 Introduzione I circuiti logici combinatori sono molto spesso realizzati come reti multi-livello di porte
Reti logiche: analisi, sintesi e minimizzazione Esercitazione. Venerdì 9 ottobre 2015
 Reti logiche: analisi, sintesi e minimizzazione Esercitazione Venerdì 9 ottobre 05 Punto della situazione Stiamo studiando le reti logiche costruite a partire dalle porte logiche AND, OR, NOT per progettare
Reti logiche: analisi, sintesi e minimizzazione Esercitazione Venerdì 9 ottobre 05 Punto della situazione Stiamo studiando le reti logiche costruite a partire dalle porte logiche AND, OR, NOT per progettare
Esame di Ricerca Operativa del 07/09/2016
 Esame di Ricerca Operativa del 0/09/201 (Cognome) (Nome) (Matricola) Esercizio 1. Un industria chimica produce due tipi di fertilizzanti (A e B) la cui lavorazione è affidata ai reparti di produzione e
Esame di Ricerca Operativa del 0/09/201 (Cognome) (Nome) (Matricola) Esercizio 1. Un industria chimica produce due tipi di fertilizzanti (A e B) la cui lavorazione è affidata ai reparti di produzione e
CORSO DI RETI DI CALCOLATORI II (Docente Luca Becchetti) Esercizi su instradamento e tabelle di routing 1
 CORSO DI RETI DI CALCOLATORI II (Docente Luca Becchetti) Esercizi su instradamento e tabelle di routing 1 1. Si proponga una topologia di rete corrispondente alla seguente porzione della tabella di instradamento
CORSO DI RETI DI CALCOLATORI II (Docente Luca Becchetti) Esercizi su instradamento e tabelle di routing 1 1. Si proponga una topologia di rete corrispondente alla seguente porzione della tabella di instradamento
Ottimizzazione Combinatoria e Reti (a.a. 2007/08)
 o Appello 6/07/008 Ottimizzazione Combinatoria e Reti (a.a. 007/08) Nome Cognome: Matricola: ) Dopo avere finalmente superato l esame di Ricerca Operativa, Tommaso è pronto per partire in vacanza. Tommaso
o Appello 6/07/008 Ottimizzazione Combinatoria e Reti (a.a. 007/08) Nome Cognome: Matricola: ) Dopo avere finalmente superato l esame di Ricerca Operativa, Tommaso è pronto per partire in vacanza. Tommaso
Minimizzazione a più livelli di reti combinatorie Cristina Silvano
 Minimizzazione a più livelli di reti combinatorie Cristina Silvano Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze dell Informazione Milano (Italy) Sommario Modello booleano e modello algebrico
Minimizzazione a più livelli di reti combinatorie Cristina Silvano Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze dell Informazione Milano (Italy) Sommario Modello booleano e modello algebrico
Progetto 1: rete con dorsale in cavo coassiale
 Progetto 1: rete con dorsale in cavo coassiale La figura 1 illustra il progetto relativo alla realizzazione di una rete in una piccola scuola in cui si vogliano collegare due laboratori ed alcuni uffici
Progetto 1: rete con dorsale in cavo coassiale La figura 1 illustra il progetto relativo alla realizzazione di una rete in una piccola scuola in cui si vogliano collegare due laboratori ed alcuni uffici
Ricerca Operativa. G. Liuzzi. Lunedí 20 Aprile 2015
 1 Lunedí 20 Aprile 2015 1 Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica IASI - CNR Rilassamento di un problema Rilassare un problema di Programmazione Matematica vuol dire trascurare alcuni (tutti i)
1 Lunedí 20 Aprile 2015 1 Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica IASI - CNR Rilassamento di un problema Rilassare un problema di Programmazione Matematica vuol dire trascurare alcuni (tutti i)
RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE
 RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE Prof. PIER LUCA MONTESSORO Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine 1999 Pier Luca Montessoro (si veda la nota a pagina 2) 1 Nota di Copyright
RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE Prof. PIER LUCA MONTESSORO Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine 1999 Pier Luca Montessoro (si veda la nota a pagina 2) 1 Nota di Copyright
Esame di Ricerca Operativa del 16/06/2015
 Esame di Ricerca Operativa del 1/0/01 (Cognome) (Nome) (Matricola) Esercizio 1. Una ditta produce vernici in tre diversi stabilimenti (Pisa, Cascina, Empoli) e le vende a tre imprese edili (A, B, C). Il
Esame di Ricerca Operativa del 1/0/01 (Cognome) (Nome) (Matricola) Esercizio 1. Una ditta produce vernici in tre diversi stabilimenti (Pisa, Cascina, Empoli) e le vende a tre imprese edili (A, B, C). Il
Un semplice commutatore a pacchetto
 Realizzazione di commutatori a pacchetto: cosa c e dentro un router IP? Prof. Ing. Carla Raffaelli Un semplice commutatore a pacchetto Una workstation con schede di rete e software per ricevere pacchetti
Realizzazione di commutatori a pacchetto: cosa c e dentro un router IP? Prof. Ing. Carla Raffaelli Un semplice commutatore a pacchetto Una workstation con schede di rete e software per ricevere pacchetti
Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A Pietro Frasca. Parte II Lezione 2
 Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A. 2013-14 Pietro Frasca Parte II Lezione 2 Giovedì 6-03-2014 1 Multiplazione (multiplexing) nelle reti
Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A. 2013-14 Pietro Frasca Parte II Lezione 2 Giovedì 6-03-2014 1 Multiplazione (multiplexing) nelle reti
Sistemi distribuiti e reti di calcolatori
 Sistemi distribuiti e reti di calcolatori 1 Indice Modulazione e trasmissione dei dati Reti di calcolatori Topologia Messaggi e protocolli ISO/OSI Ethernet Architettura client/server Telefonia mobile 2
Sistemi distribuiti e reti di calcolatori 1 Indice Modulazione e trasmissione dei dati Reti di calcolatori Topologia Messaggi e protocolli ISO/OSI Ethernet Architettura client/server Telefonia mobile 2
2.3 Cammini ottimi. E. Amaldi Fondamenti di R.O. Politecnico di Milano 1
 . Cammini ottimi E. Amaldi Fondamenti di R.O. Politecnico di Milano .. Cammini minimi e algoritmo di Dijkstra Dato un grafo orientato G = (N, A) con una funzione di costo c : A c ij R e due nodi s e t,
. Cammini ottimi E. Amaldi Fondamenti di R.O. Politecnico di Milano .. Cammini minimi e algoritmo di Dijkstra Dato un grafo orientato G = (N, A) con una funzione di costo c : A c ij R e due nodi s e t,
Architettura degli Elaboratori I Esercitazione 5 - Progettazione di Reti di Interconnessione fra Registri Roberto Navigli
 Architettura degli Elaboratori I Esercitazione 5 - Progettazione di Reti di Interconnessione fra Registri Roberto Navigli 1 Reti di Interconnessione fra Registri In questa esercitazione vedremo i quattro
Architettura degli Elaboratori I Esercitazione 5 - Progettazione di Reti di Interconnessione fra Registri Roberto Navigli 1 Reti di Interconnessione fra Registri In questa esercitazione vedremo i quattro
Problemi di localizzazione
 Problemi di localizzazione Claudio Arbib Università di L Aquila Prima Parte (marzo 200): problemi con singolo decisore . Introduzione Un problema di localizzazione consiste in generale nel decidere dove
Problemi di localizzazione Claudio Arbib Università di L Aquila Prima Parte (marzo 200): problemi con singolo decisore . Introduzione Un problema di localizzazione consiste in generale nel decidere dove
Il problema del commesso viaggiatore
 Il problema del commesso viaggiatore Mauro Passacantando Dipartimento di Informatica Largo B. Pontecorvo 3, Pisa mpassacantando@di.unipi.it M. Passacantando TFA 2012/13 - Corso di Ricerca Operativa Università
Il problema del commesso viaggiatore Mauro Passacantando Dipartimento di Informatica Largo B. Pontecorvo 3, Pisa mpassacantando@di.unipi.it M. Passacantando TFA 2012/13 - Corso di Ricerca Operativa Università
IL LIVELLO RETE. Il Livello RETE. Reti di Calcolatori
 Reti di Calcolatori IL LIVELLO RETE D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato
Reti di Calcolatori IL LIVELLO RETE D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato
Reti di calcolatori. Riferimenti: Curtin cap. 9
 Reti di calcolatori Riferimenti: Curtin cap. 9 Reti di calcolatori Una rete di calcolatori è costituita da due o più elaboratori collegati mediante un mezzo che permette di farli colloquiare il mezzo è
Reti di calcolatori Riferimenti: Curtin cap. 9 Reti di calcolatori Una rete di calcolatori è costituita da due o più elaboratori collegati mediante un mezzo che permette di farli colloquiare il mezzo è
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE
 Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni 1 - INTRODUZIONE 1 Argomenti della lezione Definizioni: Sorgente di informazione Sistema di comunicazione Segnali trasmissivi determinati e aleatori Architettura
Laboratorio di Informatica
 per chimica industriale e chimica applicata e ambientale LEZIONE 7 Le reti telematiche 1 Le reti telematiche Tra le tecnologie del XX secolo dominano l elaborazione e la distribuzione delle informazioni
per chimica industriale e chimica applicata e ambientale LEZIONE 7 Le reti telematiche 1 Le reti telematiche Tra le tecnologie del XX secolo dominano l elaborazione e la distribuzione delle informazioni
Università di Genova Facoltà di Ingegneria
 Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 5. Internetworking L/L3 Prof. Raffaele Bolla! a l esistenza (almeno nella fase iniziale) di tecnologie diverse, la limitatezza
Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 5. Internetworking L/L3 Prof. Raffaele Bolla! a l esistenza (almeno nella fase iniziale) di tecnologie diverse, la limitatezza
Marco Listanti. Esercitazione 7 DIET
 Marco Listanti Esercitazione 7 Protocolli MAC DIET Esercizio 1(1) Con riferimento a una LAN operante con protocollo CSMA/CD Calcolare la minima lunghezza L min della PDU di strato MAC in una LAN di lunghezza
Marco Listanti Esercitazione 7 Protocolli MAC DIET Esercizio 1(1) Con riferimento a una LAN operante con protocollo CSMA/CD Calcolare la minima lunghezza L min della PDU di strato MAC in una LAN di lunghezza
Standard per reti locali
 Standard per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ STANDARD PER RETI LOCALI - 1 Standard IEEE 802 802.1 ARCHITECTURE 802.1 INTERNETWORKING 802.2 LOGICAL LINK
Standard per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ STANDARD PER RETI LOCALI - 1 Standard IEEE 802 802.1 ARCHITECTURE 802.1 INTERNETWORKING 802.2 LOGICAL LINK
Cercare il percorso minimo Ant Colony Optimization
 Cercare il percorso minimo Ant Colony Optimization Author: Luca Albergante 1 Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Milano 4 Aprile 2011 L. Albergante (Univ. of Milan) PSO 4 Aprile 2011
Cercare il percorso minimo Ant Colony Optimization Author: Luca Albergante 1 Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Milano 4 Aprile 2011 L. Albergante (Univ. of Milan) PSO 4 Aprile 2011
