A. Luca de Martini. STORIA DELLA LINGUA SARDA CAMPIDANESE DAL SECOLO XVII AL XXI con testi inediti in appendice
|
|
|
- Graziano Sorrentino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A. Luca de Martini STORIA DELLA LINGUA SARDA CAMPIDANESE DAL SECOLO XVII AL XXI con testi inediti in appendice SOMMARIO: Introduzione pag Antonio María da Esterzili 8 2. Salvador Vidal e Juan Francisco Carmona: le prime attestazioni del campidanese Sa dotrina Christiana a sa lingua sardisca Juan María Contu La Vida de Santu Potitu I Goccius de Santa Barbara Il catechismo del Corongiu Antonio Purqueddu Giuseppe Cossu Efisio Pintor Sirigu Le Constituzionis po sa Cunfraria de Sant Efis La parafrasi del Salmo cinquantesimo Il Vangelo di Matteo tradotto da Federigo Abis Sa scomuniga de predi Antiogu Gli scrittori del Novecento La suddivisione del campidanese in varietà diatopiche Opere lessicografiche e grammaticali Il campidanese nel ventunesimo secolo Ipotesi di unificazione linguistica. Nazionalismo ed etnofilassi 81 Tabella comparativa 101 Bibliografia 102 Appendice I: Giuda nel Libro de comedias di Antonio María da Esterzili 107 Appendice II: Il contrasto in campidanese di J.F. Carmona 119 1
2 Appendice III: Due poesie dal Novenariu di J.M. Contu 135 Appendice IV: La Vida de Santu Potitu 146 Appendice V: I Goccius de Santa Barbara 157 Appendice VI: Un inno al Cuore di Gesú 167 Appendice VII: Una disposizione del Segretario Cossu 175 Appendice VIII: Una parafrasi ottocentesca del Salmo cinquantesimo 182 Appendice IX: Fastiju e S Arruga dereta 198 Appendice X: Il perfetto nella storia della lingua sarda campidanese 211 Appendice XI L uso dei modi indefiniti in sardo campidanese 215 Appendice XII Dedicata a Romagnino e Beccaria 223 2
3 INTRODUZIONE Il sardo medievale è il primo idioma neolatino onde siano stati redatti documenti ufficiali di uno stato: fra il 1070 ed il 1080 d.c. il Giudice Torchitorio di Cagliari promulgò una Carta in volgare, per mezzo di cui si donavano all arcivescovado di Cagliari alcune terre con numerosi privilegi, compresi quelli sulla servitú; è il primo di una lunga serie di documenti, oggi conservati nell Archivio Arcivescovile del capoluogo isolano, di alcuni dei quali, compreso il succitato, esistono copie risalenti ai secoli successivi. Talune carte del Giudicato di Cagliari possiedono anche l originalità d essere scritte in caratteri greci: la piú famosa di esse conservasi a Marsiglia. Il sardo medievale è conosciuto attraverso tre tipi fondamentali di testi, tutti di carattere giuridicoamministrativo: le Carte, in prevalenza atti di concessione ad ordini religiosi da parte dei sovrani sardi; gli Statuti, opere legislative dei giudicati o dei singoli comuni, qual è la famosa Carta de Logu del Giudicato d Arborea; i Condaghi (dal greco medievale κοντάκιον, bastone su cui s avvolgevano le pergamene e che prese poi la significazione di tomo ), ovverosia registri di enti monastici. La lingua di tali testi è paratattica, cancelleresca e imperniata su formule fisse, e si contraddistingue per una grafia etimologica che non consente di leggerle facilmente né, tantomeno, di ricostruirne il sistema fonologico. Il volgare di questo genere di documenti, che furono redatti sino al XVI secolo, risulta suddiiviso latitudinalmente in tre varietà: quella settentrionale, usata nei Giudicati di Torres e Gallura; quella meridionale, adoperata nel Giudicato di Cagliari; quella mediana, detta arborense dal nome del Giudicato d Arborea, impiegata nella zona che, soprattutto a occidente, faceva da trapasso fra le due suddette varietà. La prima è l antenata della favella chiamata oggi logudorese, quella meridionale lascia intravedere le tendenze che saranno proprie del campidanese 1, mentre la mediana prefigura una zona mista che presenta ancor oggi caratteri compositi logudoresi e campidanesi. Nella parte settentrionale dell isola si svilupparono poi due parlate che non rientrano nel sistema linguistico del sardo neolatino, del quale esse non condividono i caratteri tipici, sí da dover essere inserite in un altro gruppo romanzo: si tratta del gallurese e del sassarese 2. In Sardegna si hanno inoltre alcuni centri in cui sono parlati alcuni idiomi allogeni: Carloforte e Calasetta, isole linguistiche liguri; Carbonia e Arborea, fondate nel XX secolo e popolate in alta percentuale da Italiani (in esse però il campidanese è penetrato); Alghero, città in cui accanto al logudorese è 1 Le due varietà, sino al Novecento, erano di solito definite rispettivamente volgare del Capo di Sopra e volgare del Capo di Sotto. 2 Poiché esso non è presente nella sola città di Sassari, d ora in avanti lo chiamerò turritano. 3
4 ancora vivo il catalano, testimonianza dell antica cacciata degli indigeni da parte dei conquistatori iberici. La prima opera letteraria in sardo che si conosca, Sa vitta et sa morte et passione de sanctu Gavinu, Prothu e Januariu del sacerdote e poi arcivescovo di Sassari Antonio Cano ( circa), è in logudorese, e mostra peculiarità alquanto lontane da quelle dei documenti giuridici contemporanei. È rilevante il fatto che tutti gli scrittori i quali hanno adoperato il logudorese, da Cano nel XV secolo fino ad Antioco Casula detto Montanaru ( ) nel XX secolo inoltrato, si sono avvalsi di una lingua indiscutibilmente unitaria: essa deriva dal dialetto 3 logudorese nordoccidentale, che ha Bosa e Bonorva come centri principali e possiede un appendice nell area del Monte Acuto e del Limbara (Pattada, Monti ed anche Luras e Olbia città), e sul piano fonetico è identificabile, in estrema sintesi, dalla locuzione mi piaghet mi piace, pronunziata /mi βjaɣɛðɛ/, con lenizione di tutte e tre le consonanti occlusive sorde intervocaliche e palatalizzazione del gruppo latino PL- (in maniera parallela a CL- e FL-) 4. Tale idioma, assurto a lingua letteraria, fu codificato dal canonico Giovanni Spano ( ) nella sua Ortografia sarda nazionale, ossia grammatica della lingua logudorese (1840). La prima opera letteraria in campidanese invece è il Libro de comedias (1688) di frate Antonio María da Esterzili (1644 o ), nel quale si riscontra una lingua considerevolmente diversa da quella dei testi medievali d area meridionale. Ancor piú evidente è la distanza dal logudorese coevo, logudorese che lo stesso frate Antonio usa nella sua opera, in particolare nella prima sacra rappresentazione, quando entrano in scena i pastori, che giungono ad adorare il Bambin Gesú e s esprimono cosí, proprio per rimarcare la distanza dalla lingua degli spettatori 5. Noi esamineremo innanzitutto il Libro de comedias sotto i suoi varî aspetti grammaticali, perciocché esso è la prima testimonianza letteraria di un sistema linguistico come il campidanese moderno, autonomo dal sardo antico e dal logudorese, il quale ultimo era ed è rimasto piú vicino alla lingua della Sardegna medievale; seguiremo quindi l evoluzione del campidanese attraverso i tre secoli successivi, dapprima con l analisi delle opere letterarie antiche, poi, dalla nascita della linguistica sarda per merito di Max Leopold Wagner, anche col sussidio di lavori glottologici e 3 Attribuiamo qui a dialetto, sempre in senso glottologico e mai sociolinguistico, il senso di varietà diatopica e ne diamo la definizione seguente: parlata che rientra nell ambito di una certa lingua, poiché ne condivide la struttura grammaticale, ma se ne discosta in qualche punto, foss anche un solo esito fonetico ; è dunque un tipo interno ad una lingua, una sua suddivisione, e il termine ben s adopera ad indicare la parlata di un singolo villaggio, considerata in relazione con quelli vicini. Poiché la parola dialetto ha assunto nel parlar comune un senso alquanto spregiativo, non me n avvarrò piú in questo libro se non per discuterne la significazione. 4 Nel Legendariu de santas virgines et martires de Jesu Christu (Roma, 1627) di Gian Matteo Garipa la liquida è conservata (plus ecc.) : ciò può essere comunque un esempio di scrittura etimologica. 5 La Barbagia e il Logudoro, regioni... la cui caratteristica economica era... la pastorizia, si identificano, per sovrapposizione, con le campagne di Betlem; e i pastori non saranno più della Giudea, ma della Barbagia (S. BULLEGAS, La Spagna. Il teatro. La Sardegna, CUEC, Cagliari, 1996, pag. 46). 4
5 lessicografici. Si allega una tabella, nella quale sono schematicamente rappresentati alcuni dei principali fatti grammaticali che caratterizzano i primi autori, da frate Antonio María a Pintor Sirigu, e sono infine presentati in appendice, oltre a passi significativi di autori citati, in taluni casi da me riveduti e ripubblicati, anche i testi inediti da me scoperti e presentati per la prima volta sulla rivista NAE: si tratta della Vida de Santu Potitu, dei Goccius de Santa Barbara, dei Goccius de su sacratissimu e dulcissimu coru de Gesú Redentori nostru, della Parafrasi de su Salmu Cinquantesimu. Il primo scopo di questo libro è espresso nel titolo, e consiste nel fare conoscere la storia del campidanese mostrando le fasi principali della sua evoluzione dal secolo decimo settimo al vigesimo primo; allo stesso tempo si cerca di stimolare lo studio delle opere letterarie prodotte in quest area della Sardegna, e infine si vogliono confutare alcune ipotesi di codificazione linguistica basate su presupposti secondo me errati. Abdullah Luca de Martini, 1432 E d.c. Avvertenza sulla grafia Le citazioni di ogni opera sono fatte secondo la grafia presente nel testo, e dove è stato possibile ricostruire la natura di un fonema, si è adoperato l Alfabeto Fonetico Internazionale (AFI). Come modello di scrittura, noi abbiamo adottato il seguente, del quale si giustifica la scelta nel capitolo 18. L alfabeto a caratteri latini che qui si è adottato per la scrittura del campidanese si compone di ventiquattro grafemi: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, x, y, z. Si hanno sei digrammi: ch, dh, gh, sc, sç, tz. Ecco i ventinove simboli (h da sé solo non esprime fonemi) ed i loro valori fonetici: a = /a/ b a inizio di parola, dopo consonante diversa da r, e raddoppiato = /b/; intervocalico, tra vocale e r, e dopo r = /β/ c davanti a a/o/u e consonante = /k/; davanti a e/i = /ʧ/ ch = /k/ (è usato solo davanti a e/i) ç = /ʧ/ (è usato solo davanti a a/o/u) d a inizio di parola, dopo consonante, e raddoppiato = /d/; intervocalico, e tra vocale e r = /ð/ 5
6 dh = /ɖ/ e: è = /ɛ/ (quando non è accentato, è scritto semplicemente e); é = /e/ (quando non è accentato, è scritto semplicemente e) f = /f/ g davanti a a/o/u (ma non intervocalico), davanti a consonante, e raddoppiato /g/; davanti a e/i = /ʤ/; intervocalico (sempre davanti a a/o/u), e tra vocale e r = /ɣ/ gh non intervocalico = /g/; intervocalico /ɣ/ (è usato solo davanti a e/i) i = /i/; tra consonante e vocale ha l allofono /j/ j = /ʤ/ (è usato solo davanti a a/o/u) l = /l/ m = /m/ n = /n/, con due allofoni: davanti a consonante diversa da n = /ŋ/; se è seguito da d = /ɳɖ/ o: ò = /ɔ/ (quando non è accentato, è scritto semplicemente o); ó = /o/ (quando non è accentato, è scritto semplicemente o) p = /p/ r = /r/ s iniziale e davanti a consonante (ma mai davanti a b/d/g/m/v), e raddoppiato = /s/; intervocalico, e davanti a b/d/g/l/m/n/v = /z/ sc davanti a e/i = /ʃ/ (davanti a a/o/u o consonante = /sk/) sç = /ʃ/ (è usato solo davanti a a/o/u) t = /t/ tz = /ʦ/ u = /u/; tra consonante e vocale ha l allofono /w/ v = /v/ x = /ʒ/ y = /j/ 6
7 z = /ʣ/ Il sistema fonologico si compone pertanto di trentadue fonemi. Le vocali sono sette: a, è, é, i, ó, ò, u; un fonema è approssimante: y; gli altri sono consonanti. Non è stato assegnato un posto nel sistema fonologico campidanese alla laterale palatale sonora /ʎ/ e alla nasale palatale sonora /ɲ/, in quanto allofoni dei gruppi /l:j/ (/lj/ a inizio di parola) e /n:j/ (/nj/ a inizio di parola): quando però si sono dovuti esprimere, tali fonemi sono stati resi rispettivamente con lh (per esempio caramelha in luogo di caramèllia) e nh (è il caso di banha in luogo di bànnia). La lettera h è priva di suono e, fuorché in alcune esclamazioni, è scritta solo unita alle lettere c/d/g, con cui compone digrammi: non è un grafema essa sola. Le lettere l/n/r/s quando sono raddoppiate indicano fonema intenso (in questo caso s è sempre sorda), in contrapposizione alla corrispondenti lettere scempie, che indicano fonema debole: filu e fillu (/l/ e /l:/), manu e mannu (/n/ e /n:/), caru e carru (/r/ e /r:/), casu e cassu (a contrapporre /z/ e /s/ intenso). Le lettere b/d/g sono scritte raddoppiate soltanto per indicare che il relativo fonema è occlusivo, affinché si distinguano dalle corrispondenti fricative, scritte scempie. L'accento tonico si segna in tutte le parole tronche e sdrucciole, mentre nelle parole piane si segna soltanto su quelle vocali e ed o che apparentemente contraddicono la norma della metafonesi vigente sia in logudorese sia in campidanese. Precisamente: sulle è ed ò toniche le quali, pur essendo seguite da i ed u in sillaba finale, presentano suono aperto. Si scriverà quindi: totu/totus, inginneri/inginneris; tempus/tèmpus, procu/pròcus; mèri/mèris, mònti/mòntis. In tutti i suddetti casi, in cui si hanno vocali aperte segnate con accento, la sillaba finale presentava in origine e ed o, poi chiusesi rispettivamente in i ed u, ma si mantenne il suono aperto nella penultima sillaba, che aveva sviluppato la vocale aperta in virtú della metafonesi stessa; sulle é ed ó le quali, pur essendo seguite da a, presentano suono chiuso. Si scriverà quindi crésça cresciuta (< créscida), arrésça impigliata, attaccata (< arréscida) e cóya matrimonio (< cóyuva, qui anche a causa della semiconsonante palatale). 7
8 1. ANTONIO MARÍA DA ESTERZILI Il primo scrittore in lingua campidanese a noi noto è frate Antonio María da Esterzili (1644/ ) 6. Della sua vita non si sa molto, anche perché fu coinvolto in uno scandalo sessuale che gli costò una sorta di damnatio memoriae: nemmeno il suo cognome ci è noto. Sappiamo che visse nel convento di Sanluri: può darsi che la composizione del Libro de Comedias (1688) sia nata grazie al desiderio del frate di riabilitarsi presso la Chiesa. Il manoscritto, conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, risulta essere la trascrizione di opere composte in periodi diversi, come dimostrano alcune differenze grafiche e linguistiche: la prima sacra rappresentazione risale al 1674, sulla base dell indicazione presente nel testo. L ampiezza del Libro de comedias permette una soddisfacente ricostruzione sincronica del campidanese del Seicento. Grafia e fonologia Saranno considerati i varî grafemi e i fonemi 7, e poi i tratti fonetici peculiari della lingua di frate Antonio María; a partire dalle lettere scelte per esprimere i diversi suoni 8, si delinea il primo alfabeto campidanese moderno. Esaminiamo prima le vocali. Le sette vocali del sistema fonetico campidanese sono rese con cinque lettere: a è aperta (/a/, anteriore aperta non arrotondata), i è chiusa (/i/, anteriore chiusa non arrotondata), u è chiusa (/u/, posteriore chiusa arrotondata); e ed o rappresentano entrambe due fonemi diversi, /e/ (anteriore semichiusa non arrotondata) e /ɛ/ (anteriore semiaperta non arrotondata) la prima, /o/ (posteriore semichiusa arrotondata) e /ɔ/ (posteriore semiaperta arrotondata) la seconda. I fonemi e ed o aperti e chiusi non trovano quindi nessuna espressione nella scrittura. Per ragioni etimologiche la lettera e, quando deriva dal latino ae od oe, può presentarsi come ę (hębreu, pęna). I simboli ij e y sovente stanno al posto di i in fine di parola (dij, soly), specialmente in fine di verso, mentre talvolta j designa /i/ secondo elemento di dittongo (cujdadu). L apostrofo che segue certe vocali è dovuto ad etimologia o a semplice preferenza grafica: a (< ad), e (< et), o (< aut, e pure come esclamazione). Consonanti: 6 L odierno nome campidanese di questo paese, collocato fra la Barbagia di Seulo e l Ogliastra, è Stertzili, quello locale Stressili: la vocale prostetica E- spagnoleggiante non è presente. 7 Sugli allofoni si possono proporre solo ipotesi molto difficilmente dimostrabili. 8 Tutto questo, s intende, in base allo sviluppo storico della lingua e alle conoscenze che oggi possediamo: è un operazione di ricostruzione, e l effettiva pronunzia della lingua di frate Antonio Maria ci è sconosciuta. 8
9 - b indica occlusiva bilabiale sonora /b/ (beni), talvolta intensa 9 (pubblicamenti), e fricativa bilabiale sonora /β/ (suba) 10 ; - c davanti a a/o/u indica occlusiva velare sorda /k/ (castigari, confusioni, custu), mentre davanti a e/i indica o affricata dentale sorda /ʦ/ (cia, preciosu, negociu), o affricata prepalatale sorda /ʧ/ (dulci, innocenti), o fors anche fricativa dentale sorda /s/ (concillu, acuncentu: in questi gruppi consonantici, però, la tendenza articolatoria produceva presumibilmente un suono già affricato); - ç è semplice variante grafica di c davanti a e/i ma si usa anche davanti a a/o/u, e designa i medesimi fonemi (ançilla; isperança; conçolu); - ch indica affricata prepalatale sorda /ʧ/ (inchi ci, isfachadu); - d indica occlusiva dentale sonora /d/ (dari), anche intensa (adolorada), e fricativa dentale sonora /ð/ (nadu, idi ti ); - dd indica occlusiva cacuminale sonora /ɖ/ (ddu), anche intensa (cuddu) 11 ; - f indica fricativa labiodentale sorda /f/ (fairi, cunffessu), anche intensa (boffitus); - g davanti a a/o/u indica occlusiva velare sonora /g/ (ingannari, gosari, ingui), mentre davanti a e/i indica affricata prepalatale sonora /ʤ/ (regia, giganti, genti). In posizione intervocalica 12 (solo davanti a a, o, u) indica invece fricativa velare sonora /ɣ/ (pagu, ligadu); - gu davanti a e/i indica occlusiva velare sonora /g/ (guerra, guia), ma in posizione intervocalica indica fricativa velare sonora /ɣ/ (siguiri). Di rado si trova davanti ad a, e in questa posizione indica il gruppo labiovelare sonoro /gw/ (guardada sorvegliata, guarnecida fortificata ); - gn indica nasale palatale sonora /ɲ/ (malignu, intragnas viscere ); - j indica affricata prepalatale sonora /ʤ/ (tenju, sujeta); - l indica laterale dentale sonora /l/ (luna), anche intensa (fillu); - ll indica laterale palatale sonora /ʎ/ (llamadu chiamato, istrellas stelle, vellacu); 9 Tutte le consonanti intervocaliche sono rafforzate nella pronunzia, cosicché si è sempre avuta oscillazione nella scrittura: fanno eccezione /l/, /n/, /r/, che oppongono un fonema debole ad uno forte (caru rispetto a carru, pala rispetto a palla ecc.). 10 Tale fonema fricativo è debole, tanto che taluni autori lo considerano approssimante: ciò vale parimenti per /ɣ/ e /ð/. 11 Raramente la cacuminale è scritta con d- a inizio di parola: danti = ddu anti. 12 Le liquide l e r in tale posizione si comportano come vocali: sagradu in fonetica è reso con /sa'ɣraδu/. 9
10 - m indica nasale bilabiale sonora /m/ (mama), anche intensa (immaculadu); - n indica nasale dentale sonora /n/ (negari), anche intensa (donnia, linna), e l allofono nasale velare sonoro davanti a consonante /ŋ/; talvolta nasale palatale sonora /ɲ/ (senora) 13 ; - ñ indica nasale palatale sonora /ɲ/ (señori); - p indica occlusiva bilabiale sorda /p/ (podiri), anche intensa (appu); - qu è usato generalmente davanti a e/i e indica occlusiva velare sorda (que come, qui che ), mentre davanti ad a designa il gruppo labiovelare sordo /kw/ (aqua, isquadroni); - r indica vibrante dentale sonora /r/ (rica), anche intensa (currenti); - s indica fricativa dentale sorda /s/ (serbidu), anche intensa (passesti), e fricativa dentale sonora /z/ in posizione intervocalica (nosu) o davanti a consonante sonora (isbandonadu abbandonato ). La s scempia intervocalica raramente è sorda 14 ; - sc costituisce digramma quando precede e/i, 15 e indica fricativa prepalatale sorda /ʃ/, benché talvolta non si possa escludere una fricativa dentale sorda /s/ intensa (resuscitadu, descendentis); - sç è variante grafica di sc (disçipulus); - t indica occlusiva dentale sorda /t/ (tui), anche intensa (fattu); - tz indica affricata dentale sorda /ʦ/ intensa (potzat); - v indica fricativa labiodentale sonora /v/ (vida, bivendu); - x indica fricativa prepalatale sorda /ʃ/ (ixiri sapere, quexosu lamentoso ), fricativa prepalatale sonora /ʒ/ (boxis), affricata prepalatale sonora /ʤ/ (arxentu); - y indica approssimante palatale sonora /j/ (ayastis avevate, apoyadiosi appoggiatevi ), ma è soprattutto usata ad indicare /i/ quando questa è secondo elemento di dittongo (ay, imoy); - z indica affricata dentale sorda /ʦ/ (zugu collo, senza), affricata dentale sonora /ʣ/ (mazineri fattucchiere, iscandalizadus), e raramente fricativa dentale sonora /z/ (belleza, gozendu godendo ). 13 Si può pensare però che in questo caso la tilde sopra n sia stata dimenticata. 14 Si veda il caso di esisti (nota n.38). Con la scrittura della consonante scempia potrebbe esservi confusione laddove il fonema intenso è distintivo, per esempio fra i verbi pasari riposare e passari passare. 15 Infatti davanti a a/o/u si hanno i due distinti fonemi /s/ e /k/. 10
11 I simboli usati (lettere e gruppi di lettere) per vocali e consonanti sono dunque 32, ai quali si aggiunge h. Si nota che alcuni fonemi sono espressi con piú di un simbolo: /ʧ/ è reso con ch, ç, ci, ce; /ʤ/ è reso con j, x, gi, ge; /ʦ/ è reso con ç, ci, ce, z, tz. /z/ è reso con s, z. Oltre a tutto ciò, va ribadita l importanza che la grafia etimologica ha nel Libro de comedias: si trovano lettere o gruppi di lettere, che possono coincidere con quelli succitati ma sono scritti alla maniera latina, e dunque si leggono diversamente dal modo in cui sono scritti: h è muta (hora, homini); ct e pt si leggono t(t) (nocti, iscriptus); ti seguito da vocale talvolta si legge z sorda (presentia); qu davanti a vocale talvolta si legge c velare (quali, quasi); mn si legge nn (omnipotenti); mpt si legge nt (Redemptori); ch può leggersi c velare (Christu, charidadi); ph si legge f (sphera); th si legge t (theologus); ps si legge ss (eclipsari); bs si legge s (obscura, obstinadu); bd si legge d (subditu); dv si legge v (advertidu). Uno degli aspetti piú caratteristici del manoscritto è la difficoltà, da parte dello scrivente, a esprimere in forma scritta una lingua di cui non si possedevano opere letterarie: sia l autore, sia colui che ricopiò le commedie se non lo fece lo stesso frate paiono sentirsi davvero pionieri, ma tale condizione non giustifica da sé sola le numerosissime incertezze grafiche rintracciabili in ogni foglio del Libro de comedias. Quando lo scrivente si trova davanti a problemi di fonetica sintattica, allora ma non sempre possono aversi grafie fonetiche che paiono oggi veramente stravaganti 16 : a sora (= a s ora), so hortu (= s ortu), sa alirgat (= si alirgat), a sessi fillu (= as essi fillu) sarai figlio, non cha pat (= no nchi apat) non ci sia, ma avisari (= mi avisari) avvisarmi. Talvolta alcune parole, come le forme dei verbi ausiliari, sono incorporate da altri elementi della frase: idda firmada (= idda at firmada) l ha firmata ; in altri casi il genere del sostantivo può essere arduo da stabilire: cudda arburi vedadu (= cuddu arburi vedadu) quell albero vietato. I fatti specificamente fonetici piú importanti sono: presenza frequente di i- prostetica davanti ai gruppi con s + consonante: l autore usa forme come ispantas, istari, isconsolada in libera alternanza con stas, speranza. La i- è obbligatoria solo dopo l articolo determinativo plurale: is iscribbas; 16 Tanto stravaganti che in questo articolo riportiamo i passi del Libro de comedias già corretti in quelle forme che lo scrivente stesso mostra di conoscere, giacché talvolta se ne serve. 11
12 prostesi vocalica di a- davanti a r- iniziale (la quale poi è rafforzata) 17 : arrestari restare, arreposari, arregordu; casi di epitesi: cun > cuni davanti a consonante (cuni sa solitudi); chiusura della vocale o in u nei gruppi com/con + consonante: compatiri s alterna con cumpatiri, congregari con cungregari ecc. svariati fenomeni di fonetica sintattica, riguardanti vocali e consonanti: spirantizzazione in posizione intervocalica in su xelu (= su chelu), assimilazione di grado in cum bosu (= cun bosu), caduta di occlusive intervocaliche in sa ucca (= sa bucca), sa enida (= sa benida) e de sa ida (= de sa bida della vedova ), passaggio e > i in presenza di iato in di andari (= de andari), e, di rado, caduta della consonante d- della preposizione de in po amori e Deus 18, parziale assimilazione vocalica in erriri < arriri ridere ; sviluppo di consonante labiale iniziale (dall avverbio di luogo bi < lat. ibi) davanti a verbi in vocale 19 : betari (= *bi etari gettare ), bandat (= *bi andat) 20, bessiri (= * bi essiri) che s alterna con essiri di pronunzia piana, mentre mochiri uccidere presenta m- per influsso di mòrriri (la forma bociri è attestata in campidanese molto piú tardi, sicché non si può parlare di passaggio b- > m-); infisso nasale in voci quali grancia grazia (che ha una sola occorrenza rispetto al regolare gracia) e vimbrari vibrare (unica forma usata); affricata prepalatale sonora in getari gettare 21, usato in alternanza con betari; passaggio da labiovelare, che di regola è sempre conservata, a labiale in bardamenti solamente ma non in guardari 22 ; sanguini s alterna con sanguni, in cui si ha vocalizzazione della labiale; passaggio da liquida a vibrante nei gruppi con cons. + l: fruminis < lat. flumen; l abituale mantenimento di fl- dev essere visto come scrittrua etimologica; passaggio di r mediana a n: mencedi mercede ; passaggio di ns a nz: tranziri con /ʦ/ accanto a transiri; casi di metatesi: Perdu è adoperato come variante di Pedru (ciò consente una figura etimologica: su petus miu, Perdu, qui fudi de perda), arbili è variante di abrili, borqueri 17 Si può presumere che il fenomeno sia molto piú esteso di quanto la grafia mostri: probabilmente r- iniziale è conservata per ragioni etimologiche. 18 Il fenomeno si riscontra in uno dei passi dove il tono della conversazione è molto concitato. 19 Evidentemente anche questo, in origine, è un fatto di fonetica sintattica. 20 Qui però b- iniziale può essere anche un eredità del lat. vaděre. 21 Questa è la forma di regolare derivazione dal lat. *iectare < iactare; la gutturale del campidanese moderno ghetai non ha ancora trovato una spiegazione plausibile. 22 Dal tosc. altramente altrimenti, in caso contrario, incrociato con *bardari guardare, custodire < tosc. guardare: il verbo è presente nel manoscritto sotto la forma regolare guardari. 12
13 scudo viene dal cat. broquer (da sillaba aperta a sillaba chiusa); cruxanta corrano deriva da curxanta (congiuntivo pres.) e abrexanta da *aberjanta, con passaggio da affricata a fricativa, e da sillaba chiusa a sillaba aperta; casi di dissimilazione vocalica: maladita è variante di maledicta, come aguetari trovare rispetto a agatari, e besari baciare rispetto a basari; casi di assimilazione vocalica: ameleçari dallo sp. amenazar (vi è anche il passaggio della consonante nasale a liquida); casi di epentesi: inestabili instabile. L accento è segnato soltanto su alcune parole tronche, ma graficamente non si distingue dall apostrofo: nel caso dei pronomi enclitici uniti agli imperativi, per esempio, spesso per motivi metrici l accento cade certamente sulla vocale pronominale, ma resta il dubbio se tali parole fossero sempre tronche. Morfologia Articolo Articolo determinativo: al singolare si ha su per il genere maschile, sa per il femminile; al plurale la forma comune è is. Queste voci sono usate anche come pronomi dimostrativi. Se l articolo determinativo è preceduto da preposizione, può fondersi con essa dando luogo alla cosiddetta preposizione articolata: assu (a + su), ays (a + is). 23 La presenza della preposizione può fare ripristinare la forma originaria dell articolo 24 : de issu lillu del giglio, que issa folla come la foglia. Articolo indeterminativo: maschile unu, femminile una. Quando è preceduto da alcune preposizioni, sorge d- eufonica: cun dunu, in duna. Né l articolo determinativo né quello indeterminativo, sono mai apostrofati: su intentu, unu unguentu. Sostantivo I sostantivi della cosiddetta prima declinazione 25, che normalmente sono di genere maschile, hanno la desinenza del singolare in -u, del plurale in -us. Esistono anche pochi nomi, come petus e tempus, che al singolare hanno terminazione in -us: derivano da sostantivi neutri latini. 23 Anche in altri casi, come po + su, in + sa e in + is, quando nel manoscritto la preposizione è vicinissima all articolo, si può supporre che l autore pensasse a una preposizione articolata. Sporadicamente si trova comunque anche possu, scritto indiscutibilmente come preposizione articolata. 24 Le forme di partenza sono *issu, -a, -us (< -os), -as: gli articoli su e sa sono ottenuti per aferesi, is per apocope. 25 Non è necessario insistere sul fatto che non vi è niente di scientifico nel definire un raggruppamento di nomi prima declinazione o seconda : lo si fa solo per comodità scolastica, secondo le suddivisioni grammaticali tradizionali. 13
14 La seconda declinazione, prevalentemente costituita da sostantivi di genere femminile, ha uscita del singolare in -a, del plurale in -as. La terza declinazione è formata da sostantivi maschili e femminili con singolare in -i e plurale in -is. I sostantivi che hanno s iniziale seguita da una o due consonanti prendono di norma i- prostetica al plurale: is istellas, is iscribbas. Al singolare la i- prostetica invece non è sempre usata. Un diminutivo-vezzeggiativo molto impiegato è quello in -eddu. Aggettivo Gli aggettivi di prima classe 26 escono in -u, -us (maschile); -a, -as (femminile). Gli aggettivi di seconda classe hanno singolare in -i e plurale in -is. L aggettivo segue il sostantivo, ma per ragioni poetiche può anche essere preposto. In quest ultima posizione si trovano aggettivi femminili con forma maschile: sa grandu Galilea. Nel manoscritto si trovano numerosi superlativi assoluti in -issimu, che sono da ritenere cultismi. Numerali Compaiono nel manoscritto i cardinali unu (femm. una), dus o duus (femm. duas), tres, quaturu o quateru 27, ses sei, noi nove, trinta, sessanta, sexentus (composto di chentu, con formazione di plurale), milla e mili (sia tonico, sia proclitico). La locuzione totu a is dus significa entrambi. Come apposizione, il numerale può essere preceduto dall articolo determinativo: concedimi qui andeus is duus impari concedimi che andiamo insieme in due. I numerali ordinali, fra i quali troviamo primu, segundu, terzu e quartu, 28 hanno la particolarità che l aggettivo femminile preposto al nome può mantenere la forma maschile o assumere la desinenza sua propria: sa prima cosa ma sa primu desobediençia, sa segunda perçoni. Pronomi personali Soggetto Complem. tonico Complem. atono I deu, eu mei, mimi mi II tui tei, ti ti III issu e issa issu e issa (i)ddu e (i)dda; (i)ddi (indir.) IV nosu, nosaterus nosu nos(i) V bosu, bosaterus, osu bosu bos(i), os(i), si (raro) VI issus e issas issus e issas (i)ddus e (i)ddas; (i)ddis 26 Per il termine classe vale lo stesso discorso che si fa per declinazione : si veda la nota precedente. 27 La vocale mediana è epentetica. 28 Codesti terzu e quartu sono cultismi: nella lingua viva si dice su de tres e su de cuàturu, e cosí via per tutti gli altri numerali ordinali; c è alternanza fra segundu e su de duus/sa de duas. 14
15 Rifl. - sei si Il clitico (i)ndi significa ne, e davanti a ddu/dda assume la forma etimologica (i)nde: o puru inde ddu abaxeis oppure lo calate da là. I pronomi ddi e ddis non sono mai usati con la funzione di complemento oggetto. Alla III e alla VI persona c è distinzione fra maschile e femminile. Il pronome complemento di I e II persona dopo la preposizione cun piglia la forma megu e tegu: cun megu(s), cun tegus (-s è avverbiale). Ciò vale anche per il pronome riflessivo: cun segu. I pronomi atoni, che hanno funzione di complemento e possono tanto essere preposti quanto posposti alle forme verbali, spesso assumono i- prostetica al singolare e riflessivo: imi, idi, isi; solo in un caso, al plurale, si hanno inosi (IV) e isos (V), che forse è analogico e la cui prima s non è etimologica 29 ; è frequente ios (V), sovente scritto y os (per confusione con l omografa congiunzione) e in un caso hios. Tutte codeste forme sono modellate sul pronome personale di III persona, che infatti tende a mantenere la vocale etimologica iniziale 30, e la mantiene sempre dopo congiuntivo esortativo: fatzantiddu lo facciano. Nelle forme osu e osi di V persona b- iniziale è caduta per fonetica sintattica. Un uso pleonastico si ha con l accostamento delle due forme pronominali, tonica e atona: a ti ti at bogadu te t ha tolto ; talvolta l impiego del pronome è di per sé ridondante: itta ddu apu guadanjadu in negari su provadu che cosa ho guadagnato nel negare ciò che è provato?. Come pronome di rispetto, oltre a bosu, che frequentemente è sottinteso grazie al verbo di V persona, è impiegata anche la III persona, espressa da ddi complemento: su qui ddi ollu declarari ciò che le voglio dire ; se il pronome di rispetto di tale persona è soggetto, rimane sottinteso: at airi intesu (ella) avrà sentito. Possessivi Dalla I alla VI persona abbiamo in ordine: miu, tuu (tu forma contratta), suu (su contratto), nostu, bostu/ostu, insoru. Il femminile esce ovviamente in -a: si ha dunque tua, sua eccetera. È usato anche allenu/alienu altrui. 29 La forma isos, a meno che non sia un errore di scrittura, potrebbe essere spiegata come fenomeno di duplicazione: un si di V persona con i- prostetica e apocope (si > isi > is), accostato all abituale os. 30 Ricordiamo che iddu proviene infatti dal lat. ĭllu(m). 15
16 Dimostrativi Si ha custu questo, cussu codesto 31, cuddu quello. Nei nessi preposizionali si recupera la vocale etimologica iniziale 32 : ai gustu (< a i-custu), in gustu (per sincope: < *in igustu < in i-custu), cuni cuddus (< cun i-cuddus); talvolta anche dopo congiunzione: ca igussu. Relativi È innanzitutto adoperato qui 33, polivalente e indeclinabile; vi è poi il relativo-dimostrativo cantu: esso muta per numero ma non per genere. È un cultismo su quali, frequentemente usato col significato di la qual cosa. Interrogativi Nel manoscritto si trovano quini, usato solo come pronome; cali, impiegato da aggettivo; it(t)a e it(t)e (meno frequente), e cantu, che possono essere sia pronomi sia aggettivi: cantu pena, cun itta crudeli pena con quale crudele pena. Indefiniti Fungono da pronomi e aggettivi indefiniti le seguenti parole: ateru altro, donnia (che compare anche, etimologicamente, come de omnia) ogni, unu alcuno, donniunu ognuno, calencunu qualcuno, meda, tanti e tantu, pagu, prus, totu, calisiollat qualsivoglia, algunu alcuno, qualche, nexunu, nigunu, perunu e nemus, i quali quattro significano nessuno. Ha declinazione completa, per genere e per numero, soltanto ateru e unu: pagu, donnia, prus, calisiollat sono indeclinabili, nexunu e perunu variano per genere ma non per numero, mentre i restanti variano per numero (a totus, totu sa memoria, tanti traiçioni, meda gosu, meda annus ma anche medas annus); totu quale aggettivo di solito rimane invariato al plurale prima dell articolo, ma può anche prendere -s (totus is rexonis); tanti di rado può essere preceduto da articolo (sa tanti desventura). Sono usati esclusivamente come pronomi, al singolare maschile, calincunu, donniunu e nemus. Sono usati in correlazione unus e aterus gli uni... gli altri. Si segnala anche un particolare uso di totu: esso può posporsi al pronome interrogativo, divenendo rafforzativo con una sfumatura di sorpresa (itte totu mi naras? ma che cosa mi dici mai? ). Gli aggettivi nexunu e perunu sono posposti al nome: falta nixuna nessuna colpa. 31 Cussu ha un uso piú largo dell italiano codesto, il quale nella lingua parlata è divenuto raro: cussu svolge infatti anche la funzione di generico pronome di riferimento, ovverosia serve come ripresa di ciò che è già stato detto nella frase. 32 I pronomi hanno origine dal lat. eccu(m) ĭstu(m) > (e)cústu (sincope di -i-), con successivo passaggio e > i. In logudorese, invece, la i- iniziale è conservata solo dopo preposizioni terminanti in consonante. 33 Ricordiamo che la pronunzia è /ki/. 16
17 Avverbî Secondo la classificazione tradizionale, si hanno avverbî: di modo, come beni, aichi cosí, solus, de badas invano ecc., oltre a quella formati in -menti, alla maniera italiana e spagnola, con l aggettivo in -i che può uscire in -a (cortesamenti); di luogo, come innoxi qui, ingui (trisillabo) costí, lí, iní lí, me dentro, foras, suba, innanti(s), eccu, (i)ndi ne, (i)nchi ci, ddu ci. Hanno funzione relativa undi e aundi, inui dove, inca e ainca dove ; di tempo: imoi e imò adesso, hoi 34 oggi, insaras e insara allora, mai, sempiri, subitu, (de) pustis poi, jai, primu prima ; di giudizio: e totu proprio, no e non, forsis, quissa forse ; di quantità: meda, pagu, tropu, nienti, prus, tanti e tantu; d interrogatizione, come candu, poitta, cantu, comenti, undi, ainui. Ha valore di cortesia la locuzione in bona hora (intrinti puru in bona hora entrino pure, prego ). Preposizioni Le preposizioni piú impiegate sono a (normalmente scritta a ) de, in, cun (anche cu o cum), po. Fra le particolarità si segnalano: il passaggio de > di davanti a vocale in iato (di andari); il recupero della vocale etimologica iniziale dei dimostrativi preceduti da preposizione (si veda il paragrafo specifico); la formazione di preposizioni articolate in presenza d articolo (si veda sopra). Variante di po è por, voce castigliana usata soprattutto nella locuzione por vida mia. Altre preposizioni sono per/peri, sinò eccetto, suba sopra, suta sotto, intre tra (da interpretare come intra de > intra e), finza/finsa e fina fino, sena e senza/sensa (anche seguite da de), acanta, innantis de, ananti de davanti a (per gli ultimi esempî è piú corretto parlare di locuzioni preposizionali). Congiunzioni Fra le congiunzioni coordinative abbiamo e (scritta e e presente nelle varianti et, y) 35, ancu, puru, ne, ni, nimancu (copulative); o (disgiuntiva); ma, totu via tuttavia (avversative); aduncas, però perciò (conclusiva). Congiunzioni e locuzioni congiuntive subordinative, che richiedono un modo verbale finito nella proposizione dipendente, sono invece a e qui, che possono assumere diverse funzioni, in primo luogo quella dichiarativa; ca (dichiarativa); jai qui, essendu qui, ca, pues e pues qui poiché, e soprattutto po qui (causali); si, qui (ipotetiche); ancu qui, ancora qui, si benis sebbene 34 Scritto pure hoy. 35 La scrittura y, con passaggio e > i in iato, è dovuta ad influsso spagnolo. 17
18 (concessive); candu, luegu qui, finsa qui, fina qui, apenas (temporali); que come, comenti, segundu qui (modali e comparative); ultra qui (eccettuativa); sino ca (esclusiva); a tali qui, de modu qui (consecutive). La congiunzione po seguita dall infinito caratterizza le frasi finali; comenti richiede la preposizione a nelle comparazioni semplici (comenti a magu). Esclamazioni È frequentemente usata o con valore vocativo; mancari magari introduce una frase ottativa, mentre bastu basta è seguita da un sostantivo (bastu prantu) o da un infinito (bastu charlari). Interiezioni autentiche sono ea, aiosa e l italiano orsu orsú, hay/ay ohi, olà ehilà. Verbo Il sistema verbale del campidanese di frate Antonio María può essere ricostruito in maniera soddisfacente. Diamo dapprima le desinenze regolari delle sei persone verbali, distinguendo una prima coniugazione, con infinito presente in ari, da una seconda coniugazione in -iri. Bisogna precisare che, sotto la seconda coniugazione indicata, rientrano due gruppi di verbi, divisi in base all accento dell infinito: gli uni sono piani, gli altri sdruccioli; la scrittura però non evidenzia tale opposizione, la quale, peraltro, nel corpo dell intera coniugazione è limitata al solo infinito e al participio passato (con uscita rispettivamente in -idu e -ídu). Le vocali paragogiche, quando sono diverse dall ultima vocale della sillaba precedente, sono separate dall ultima consonante della desinenza mediante un trattino. Indicativo presente I con. -u -u -as -is -at -it -aus -eus -ais -eis -ant -int II con. Indicativo imperfetto -à (< -àa) -ia -àst -ias -aiat, -àt -iat 18
19 estis -aiant, -ànt -iant La forma -aíat è un incrocio di -àt e -iat, ed anche la III persona plurale -aíant è incrocio (fra -ànt e -iant). Anche le altre desinenze della coniugazione in -iri hanno l accento sulla i. La forma -estis è testimoniata dal solo tenestis. Indicativo perfetto -ei -isi -esti -isisti, -isti -et-i, -esit (raro) -isit... -isistus -estis -istis -ent-i -isint La desinenza -esit ha una sola attestazione: guadangesit (accanto al normale guadangedi). Congiuntivo presente -i -a -is -as -it -at -eus -aus -eis -ais -int -ant Il congiuntivo imperfetto regolare vede attestata una IV persona di II coniugazione in -ireus (bolireus volessimo ), ed è testimoniato a sufficienza solo per gli ausiliari àiri ed èssiri; c è poi un pensas (I p. di pensari, nella proposizione concessiva si benis mi pensas essiri atesu sebbene io (mi) pensassi che fosse lontano ), che pare forma derivata dall italiano. Il modo imperativo ha forma propria per le persone II e V: -a, -adi (I con.); -i, -edi (II con.). Le altre persone, e cosí pure spesso le stesse II e V, sono espresse per mezzo del congiuntivo presente, il quale è impiegato sempre per l imperativo negativo. 19
20 Gli altri tempi dei modi verbali finiti sono analitici: fra questi, indicativo passato prossimo, indicativo trapassato prossimo, congiuntivo passato e trapassato richiedono la presenza di uno dei due verbi ausiliari, seguito dal participio passato del verbo da coniugare (per esempio apu fatu ho fatto ); l indicativo futuro semplice è costruito coll indicativo presente di airi, la congiunzione a e l infinito del verbo (at a mostari mostrerà ), mentre il futuro anteriore ha l infinito di airi e il participio passato del verbo (at airi intesu avrà sentito ). La forma analitica conserva il valore originario di necessità in un passo quale è il seguente: fuedda poyta rexoni apu a fari su qui bolis di per quale ragione dovrei fare ciò che vuoi. Il condizionale è il modo verbale di piú varia complessa costruzione. Esistono diversi tipi di formazione analitica che elenchiamo di seguito: 1. il perfetto di airi seguito dal participio: merexia veramenti qui si ait fatu meritavo veramente che si facesse (letteralmente si sarebbe fatto ), quey cussu cumbertidu... qui in eternu no ddu ai bidu come quel convertito, che in eterno non avrei visto, beni podiada issu si chircari unu babu de medas arriquesas qui ddu ait potzidu a cumplimentu regalari lett. avrebbe potuto trattarlo ossia egli avrebbe potuto ben cercarsi un padre di molte ricchezze, il quale potesse mantenerlo agiatamente. In questo maniera si esprime il condizionale passato, con verbi e transitivi e intransitivi. Le frasi del suddetto tipo sono o ipotetiche o dichiarative che esprimono posteriorità temporale. In un caso si ha l inserimento dell infinito fra il perfetto di airi e il participio: custa ddy per certu non hay estari bidu lett. questo giorno per certo non avrei visto. Quest ultimo è un condizionale passato, in cui l infinito di stari sostituisce essiri (la qual cosa avviene di norma al perfetto e al participio). 2. l imperfetto di airi seguito dalla congiunzione a e l infinito: mi declaret... qui ayasta a beni cun gloria lett. verresti ossia mi dichiarò che saresti venuta con gloria, o si no essiri arruta in sa maldadi comenti aya andari advertida lett. andrei ossia oh, se non fossi caduta nel peccato, come sarei stata attenta (qui a è assorbita dalla vocale successiva). In questa maniera si esprime il condizionale presente, corrispondente a quel condizionale passato italiano usato nel periodo ipotetico dell irrealtà. L uso di questo tipo è diffuso sia in proposizioni condizionali, sia in proposizioni dichiarative esprimenti posteriorità: itte isperança... si podiat tenniri... sino ca aya a negari su fillu de deu quale speranza si poteva avere, se non che avrei negato il figlio di Dio ; mi ayastis nadu... qui os aya a negari mi avevate detto che v avrei rinnegato. In quest ultimo caso l uso del condizionale presente e non passato separa il sardo, alla pari delle altre lingue romanze, dall italiano letterario, che richiede invece il condizionale passato. Questo secondo è il costrutto rimasto 20
21 vivo nella lingua moderna (èmu a nai), nella quale il condizionale passato è cosí composto: imperfetto di ài + èssi + participio del verbo (em èssi nau). 3. il perfetto di airi con a e l infinito: iddi naredi... qui dd ait a biri in cumpangia gli disse che l avrebbe visto in compagnia. Questo tipo compare solo una volta, ed è da intendere come variante del tipo 1). 4. il perfetto di airi seguito dalla particella modale mo e l infinito (condizionale presente), o da mo con l infinito di airi e il participio del verbo coniugato (condizionale passato): s enti mo apoderari si impadronirebbero, mai edi mo bastari mai finirebbe (presente); issu idd edi m airi reedificadu egli l avrebbe ricostruito, non dd enti m airi consignadu non l avrebbero consegnato. In quissa no essi mestiri tentada forse non saresti stata tentata si ha metatesi sillabica: la costruzione è infatti mo esti (perf. di àiri) essiri tentada. Le frasi possono essere sia ipotetiche (e della possibilità e dell irrealtà), sia dichiarative, proprio come i tipi 1 e 2. Questo tipo non è testimoniato in altri autori campidanesi a parte Antonio María. La particella modale mo deriva da como adesso < lat. quomŏdo, che dà l esito imò/imoi come avverbio di tempo; nella forma non aferetica essa fu usata dal logudorese Gerolamo Araolla nel Cinquecento 36. Il passaggio dal valore temporale al valore modale è riscontrabile in e però a parri miu non depu mo molestari, che si può intendere letteralmente ed etimologicamente come e perciò a parer mio non devo ora molestarlo, quindi come non dovrei molestarlo, ovverosia è meglio non molestarlo (parla uno dei giudici del Sinedrio in riferimento a Gesú accusato). In questo passo però sorprende il fatto che, mentre s aspetterebbe un soggetto di IV persona, si abbia il verbo alla I persona, tanto che un errore di copiatura non può essere escluso. Per maggiore chiarezza, vista anche la singolarità di tale costrutto in campidanese, diamo la coniugazione del condizionale presente e passato del verbo fare, indicando con un asterisco le forme ricostruite: presente *ei mo fàiri, esti mo fàiri, et mo fàiri, *emus mo fàiri, *estis mo fàiri, ent mo fàiri; passato *ei m àiri fatu, esti m àiri fatu, et m àiri fatu, *emus m àiri fatu, *estis m àiri fatu, ent m àiri fatu. Le forme indefinite sono le seguenti: Infinito: -ari (-ai è la rara forma apocopata 37 ); -iri (-i forma apocopata). 36 Si veda ad esempio t isti como ispantare ti spaventeresti (Rimas spirituales 52, lin. 67, esempio tratto da Officina Linguistica, a cura di Giulio Paulis, anno I, num. 1, Settembre 1997, pag. 147). L avverbio imò è dotato di i- (< in-) avverbiale e, nella forma imòi, anche di i- paragogica. 37 Vi fu prima apocope (-ari > -à) analoga a quella della coniugazione in -iri, poi si generò vocale epitetica (-à > -ai): non si tratta di dileguo di -r-. L uscita in -ai è presente in passi che riproducono la lingua parlata popolare, dunque è probabile che fosse ritenuta un volgarismo. 21
22 Gerundio: -endu(-ru) e raramente -ende(-ru) per entrambe le coniugazioni sono le forme comuni 38, ma per la I con. sono frequentemente attestate anche -andu(-ru) e -ande(-ru). Participio: il presente non c è, il passato esce di norma in -adu (I con.) e -idu (II) ed è regolarmente declinato come gli aggettivi (-adu, -ada, -adus, -adas ecc.). Vi sono poi verbi con il participio cosiddetto forte, il quale deriva, talvolta per analogia, da forme latine: esso è caratterizzato di solito dal suffisso -tu. Verbi ausiliari La coniugazione dei due verbi ausiliari 39, avere ed essere, è la seguente. airi essiri Indicativo presente apu seu as-i ses-i at-i est-i, es eus seus eis seis ant-i funt-i, sunt-i, sunt-u, fun In un caso si ha sesis, con prolungamento in -s per evitare iato. Indicativo imperfetto aia fui aiast, iast fusti aiat, iat fuit, fut-i ayastis... aiant... Indicativo perfetto... ai... esti 38 Questo -ru è un prolungamento sorto per analogia con la desinenza -ri dell infinito. 39 Entrambi i verbi sono usati anche autonomamente: essiri nelle frasi nominali, airi come transitivo in alternanza con tenniri. 22
23 ... ait, et-i è supplito dal verbo stari apistis... apisint ent-i Il verbo avere è ripartito in due colonne: la prima riguarda le forme transitive (le quali indicano il possesso, e per significato equivalgono al verbo tenniri), la seconda le forme ausiliarie. Il perfetto è appunto l unico tempo in cui esistono forme morfologicamente distinte a seconda della funzione; quelle comincianti con e- sono adoperate per il solo tipo 4) di condizionale, già esaminato nelle righe precedenti. Per essere c è almeno un caso in cui fut-i si può interpretare come perfetto e non imperfetto: fudi decretadu... qui essit mortu in sa Ruxi era (> fu) decretato che fosse morto (= morisse) in croce. Congiuntivo presente apa... appas sias apat siat apais siais Congiuntivo imperfetto airi essiri airis essisti 40 ait essit aireus... aireis... airint, arint... La III persona di airi, che coincide con la corrispondente dell ind. perfetto, è dovuta a sincope. Gli altri tempi dell indicativo e del congiuntivo hanno formazione analitica, analoga a quella dei verbi regolari; il futuro di essiri rifiuta la preposizione a: at essi sarà. 40 Nel manoscritto si legge esisti, con -s- scempia alla maniera spagnola. 23
24 Il condizionale di essiri, accanto al normale costrutto analitico, presente l eccezionale forma sereus saremmo di IV persona, che è probabilmente formata sulla base dello spagnolo seríamos (sereus causa de meda discuncertu). L imperativo dei due verbi ausiliari non è usato. Le forme infinite sono: Infinito: airi (ai è la forma apocopata) e essiri (essi); Gerundio: aendu (haendu con grafia etimologica) e essendu(-ru) (sendu è la forma aferetica); Participio passato: per il verbo avere è supplito da tentu (da tenniri), per il verbo essere è supplito da (i)stadu (participio di stari). Verbi irregolari Esistono diversi verbi che presentano forme irregolari o particolari, generalmente per ragioni etimologiche o analogiche. Vediamo i principali, indicando alcune delle persone attestate, che, all interno della coniugazione, mostrano i tratti piú interessanti. Verbo stari (istari) 41. Ind. pres.: stau e istu, stas-i, istat-i, istaus,..., istant-i. Imperf.: III p. istaiat. Perf.: I istei, III istetisit. Cong. pres.: II istes-i, V istetais, VI istint-i. Imper.: II istai, V stadi e staxi. Verbo andari. Imper.: II bai e banda, V baxi. Varie forme con accento sulla prima vocale premettono b-. Verbo dari. Ind. pres.: dau, das, dat-i,..., dais,... Imperf.: I da. Perf.: I dei e jey 42, III dedi. Cong. pres.: det-i, des-i, det-i,..., deis, dent-i. Imperf.: III darit. Imper.: II dai, V dadi. Verbo donari. Ind. pres.: I donju. Cong. pres.: IV dongaus. Verbo narri. Ind. pres.: naru, naras e nas, narat e nat, naraus e naus, narais e nais, naranta e nanta 43. Perf.: II naresti, III naredi e ned. Cong. pres.: I neri, II neris, IV nareus, V nareis, VI nerinti. Imper.: V naradi e nadi. Part.: naradu e nadu 44. Verbo fairi (fari). Ind. pres.: I fatzu. Imperf.: III faiat. Perf.: III facisit. Cong. pres.: V fatzais. Imper.: II fai, V fedi (feedi) 45. Part.: fat(t)u. Verbo biri. Ind. pres.: II bisi. Perf.: I bissisi. Cong. pres.: I bia. Part.: bistu e bidu. 41 Ricordiamo la presenza non costante della i- prostetica nelle parole che cominciano con s + consonante. L infinito di stare compare anche sotto la forma estary. 42 Per palatalizzazione. 43 Le forme senza -ra- sono meno frequenti. 44 Il participio nadu è uguale a quello del verbo naxiri, che presenta anche naxidu. 45 Nel manoscritto si trova anche un altro imperativo di II persona plurale, fiedi, che può spiegarsi a partire da feedi, con e > i in iato. 24
25 Verbo boliri (oliri) 46. Ind. pres.: I bollu, bolis, bolit, boleus, boleis e bolleis 47, bolint. Imperf.: I bolia. Cong. pres.: I bolla, bollas, bollat, bollaus, bollais, bollant. Part.: bofidu 48. Verbo morriri. Ind. perf.: III morxisit. Cong. pres.: V morjais. Ger. morendu. Verbo podi 49. Ind. pres.: I potzu. Perf. III potzisid. Cong. pres.: III potzat. Part.: potzidu. Verbo tenniri (tenni, teni). Ind. pres.: tenju, tenis, tenit, teneus, teneis, teninti. Imperf.: I tenia, V tenestis. Perf.: III tengisit 50. Cong. pres.: tenja, tenjas, tengiat, tenjaus, tenjais, tenjanta e tenganta 51. Part.: tentu. Verbo ixiri. Ind. imperf. III xiada 52. Cong. pres.: II ixipias. Part.: ixipidu. Varî verbi hanno participio forte: poniri dà postu, ungiri dà untu ecc. Altri, che oggi hanno participio forte, qui hanno forma regolare: connoxiri dà conoxidu. Il verbo lassari ha il cong. pres. con vocale radicale regolarmente in -a-: VI lassint. Il verbo crèiri presenta contrazione: ind. pres. IV creus; il congiuntivo presente con vocale tematica regolare in -a-: II creas, III creat. Il verbo trairi tradire, il cui infinito non è attestato 53, ha il participio forte traitu. Sintassi La sintassi verbale offre indicazioni molto interessanti per la storia del campidanese. I pronomi personali atoni, in unione con le varie forme verbali, possono essere proclitici o enclitici: mi avisari avvisarmi e biriddu vederlo, fatzatsi si faccia, e aligradiosi rallegratevi e mi lassa lasciami. Il presente durativo è espresso con istari o essiri + gerundio: seu spetandu, staus lagrimandu, istanti miranduru; raramente con andari + gerundio (idd andas defendendu). Il concetto di essere sul punto di è reso piú spesso con essiri po (a) + infinito: seu po os essi mama naturali sto per esservi madre naturale, issu ancora esti a baxari egli deve ancora calare (in quest ultimo esempio è anche un idea di necessità); talora anche con istari: istu po mi ndi pesari sto per alzarmi. 46 La caduta di b- è originariamente dovuta alla fonetica sintattica: nel testo le forme con e senza b- si alternano liberamente. 47 Il rafforzamento di l- può essere dovuto ad analogia con la prima persona, che ha ll- dal lat. volgare *vol-jo (classico volo). Nella lingua moderna tale raddoppiamento è frequente. 48 La consonante -f- è sorta per analogia con la forma di perfetto vol-ui > *bolwi> *bolfi. 49 I verbi, che hanno origine nella coniugazione latina in -ere, all infinito hanno spesso apocope dell ultima sillaba. 50 Ugualmente si ha bengisit da benni, verbo che condivide le stesse particolarità di tenni. 51 Ugualmente si ha I donju (ind. pres.) da donari, I ponju (ind. pres.) e III pongiat (cong. pres.) da poniri, I benju (ind. pres.) e III benjat (cong. pres.) ma VI benganta da benniri. Le forme in ng- dei tre verbi suddetti sono dovute ad influsso spagnolo. 52 Qui la contrazione di -ii- è espressa da -i- semplice. 53 Può essere traíri o traíxiri. 25
26 L ausiliare airi è preferito a essiri quando si vuole esprimere l impersonalità: de cantus ind at naxidu di quanti sono nati (con pronome relativo ridondante), peruna non ndi at nadu in sa terra non ce ne è nessuna che sia nata sulla terra (si noti il participio passato maschile che non concorda con il pronome indefinito femminile); di rado è usato con verbi intransitivi o riflessivi apparenti: iddi at essidu fueddu discumpostu gli è uscita parola scomposta, itta disgracia... ti at costadu che disgrazia ti è capitata!, ad resuscitadu è resuscitato, e si at pigadu tantu ardiri s è preso tanto ardire. L idea di esserci è resa di solito con (i)nchi + airi: de pagari inchadi arrestu c è un resto da pagare ; meno spesso con (i)nchi + essiri: non chesti ni mancu pintadu, e con ddu + airi: ixiu ca ddu ad sufissientia. Si ha un italianismo sintattico nell uso di beniri come ausiliare per la forma passiva: de invidia beneis ispintus; un altro si ritrova nella locuzione fradi miu andas erradu. A proposito della forma passiva, qualche passo, in cui meglio emerge la lingua colloquiale, mostra la scarso gradimento della lingua per la suddetta diatesi, che si evita grazie al soggetto sottinteso di sesta persona: non siais genti molesta po qui os anta a castigari non siate gente molesta perché sarete castigati. Il gerundio ha un uso ampio nella subordinazione, e lo si ritrova anche la funzione, tipica del sardo, di participio congiunto all oggetto o pronome relativo: biu benni genti cun sonu de trumbita cerriendu vedo venire gente gridare con suono di tromba ; in imi eis a biri portari istraxinendu a sonu de trumbita y achotadu mi vedrete portare trascinato (lett. trascinando[mi] ) al suono delle trombe e flagellato il gerundio concorda con un soggetto sottinteso 54. Talvolta invece, come in italiano, il soggetto è il medesimo della proposizione principale: sa genti siada avolotada... sentenduriddi tantis cosas predicari. Un gerundio sostantivato può essere equivalente a un infinito sostantivato italiano: no pensis... qui m aconortu de dissimulendu de sa imbaxada non pensare che (io) mi consoli dall occultarti la notizia. Nelle frasi esclamative-desiderative è usato mancari seguito dal congiuntivo: sia trapassato (mancari imi essiri abruxadu almeno mi fossi bruciato! ) sia presente (mancari seguis... cussu xelus); è presente, inoltre, il particolare costrutto con forcis + congiuntivo imperfetto: forçis alcansari gracia cun piedadi potessi ricevere grazia e pietà!, forcis innantis de morri agatari cudda cara beniña e serena potessi, prima di morire, trovare quella faccia benevola e serena!. Nei due esempî si noti il congiuntivo imperfetto (sempre di valore ottativo) di I persona singolare, omofono dell infinito: è chiaro però che d infinito non si tratta. Il congiuntivo trapassato può anche essere privo dell interiezione: mortu essiri ixerbeddadu fossi morto scervellato! ; de su qui imoi idi impudas idi dd airis pençadu avessi (tu) pensato (prima) a ciò di cui adesso t accusi! lett. te lo fossi pensato. 54 Quest uso del gerundio è insolito, sia perché gli manca il pronome -mi enclitico, sia perché è seguito dal participio achotadu: la scelta del gerundio in vece dell atteso participio istraxinadu deve spiegarsi con ragioni metriche. 26
27 Il congiuntivo esortativo è usato anche alla I persona in frasi negative: non bia cussas carris istrachari che io non veda lacerare codeste carni. L indicativo sovente è preferito al congiuntivo nelle oggettive dipendenti da verbi d opinione: no pensis qui mi aconortu non pensare che mi consoli. Un passo come il seguente rivela la predizione della lingua viva per la forma attiva piuttosto che passiva: sa sanctissima trinidadi... hoy de unu arricu mantu da coberinti La santissima Trinità... oggi è coperta un ricco manto. È frequentissimo l uso di naru con funzione incidentale (e, in realtà, anche come riempitivo metrico): ses ancora lamadu de is monarchas naru de genti Ebrea et non Gentili; soli naru splendenti, et luminosu sole dico splendente e luminoso. L articolo determinativo e le preposizioni articolate non sono ripetuti nelle enumerazioni: lassadimindi ancora... parti de su dolori, lagrimas e pęna. Il complemento oggetto di persona è spesso introdotto dalla preposizione a: as mortu a su Innocenti (si noti anche il verbo morriri, qui transitivo), a quini apu a mandari chi manderò? ; molto raramente questa costruzione è impiegata per animali e cose: cumbidu a is angelus... a is chelus... a is pillonis. I pronomi personali clitici possono avere funzione affettiva (si mi miru a is xelus iddus biu tottu obscuradus); talvolta si evita l accumulazione di pronomi (su coru... mi resolvidi in lagrimas, et prantu il cuore... mi si scioglie in lacrime e pianto ). Il relativo qui è polivalente e può avere anche il valore di avverbio di luogo relativo: su caminu qui passada il cammino che percorre ; dama qui a totus maravilla causat solus sa fama dama di cui solo la sola fama causa a tutti meraviglia. La particella (i)ndi ha valore rafforzativo in casi quali istu po mi ndi pesari sto per alzarmi e inde ddu abaxeis lo calate da là, e può unirsi ai pronomi personali in espressioni pleonastiche: lassadimindi ancora a mimi parti de su dolori lett. parte del dolore lasciatemene anche a me. Per cause poetiche o metriche l aggettivo possessivo può seguire il sostantivo anziché precederlo (sa nosta ingratissima natura), ed è frequente trovare l inversione dell ordine di parole consueto: soggetto-verbo-oggetto-complementi varî. Nel complemento vocativo è impiegato l articolo determinativo: firmadi is astrus su velochi motu fermate, o astri, il moto veloce. Il complemento d agente può essere espresso attraverso la preposizione cun: cun milla borqueris ses guardada sei custodita da mille scudi. 27
28 Nella subordinazione è diffuso l impiego del costrutto implicito con l infinito e il cambiamento di soggetto rispetto alla reggente: innantis de cantari su caboni imi as a negari prima che il gallo canti mi rinnegherai, ada arrestari po sempiri... finsa su mundu acabari resterà per sempre... fino a che il mondo non finisca ; in cantu injustamenti eis patidu danduosi mala fama e peus nomini quanto ingiustamente avete patito, quando vi si è attribuito (lett. dandovisi ) cattiva fama e peggior nome! si ha il gerundio temporal-causale. Per quello che riguarda la correlazione dei tempi, si nota la predilezione per l uso del congiuntivo trapassato, e non imperfetto o passato, sia in frasi finali e dopo verbi desiderativi: apu votadu qui non dd airinti molestadu ho votato perché non lo condannassero, mi naredi qui deu idd airi cundennadu mi disse che io lo condannassi, im at pregadu qui idd airi dimandadu mi ha pregato che gli chiedessi, unu inferru po mei solu po qui airi patidu un inferno per me solo, affinché soffrissi ; sia in frasi dichiarative, come tenju sa lisentia... qui a totus airi intradu ho la licenza di far entrare tutti. Le proposizioni subordinate, ripartite secondo gli schemi tradizionali della grammatica, presentano le caratteristiche seguenti: Le proposizioni oggettive, soggettive e dichiarative esplicite sono introdotte dalla congiunzione qui. Richiedono il modo indicativo anche per i verbi d opinione: tui penças ca fui deu tu pensavi che fossi io. La posteriorità rispetto ad un azione collocata nel passato è espressa con il condizionale presente 55 : non penzasta ca aiada a guadanjari non pensavi che avrebbe guadagnato, non pencei qui in custa aia a parari non pensai che sarei andato a parare in questa, profecia de Simeoni... qui aiada a passari sa anima mia de dolu e pena forti una ispada profezia di Simeone: il fatto che la mia anima sarebbe stata trapassata da una spada di dolore e pena intensa. Le implicite sono introdotte da de, che raramente manca: is modus bellus nari funti tantis i modi belli per dirlo sono tanti. Le proposizioni causali sono introdotte da essendu essendu qui, po qui, jai qui, qui, ca, pues, pues qui: poyta non prangeis jay qui moridi perché non piangete giacché muore?, mi fait tremiri de ispantu forcis qui est fillu de Deus mi fa tremare di spavento, forse perché è figlio di Dio, beni prestu... qui custa anima mia tanti bramat. Le proposizioni concessive sono introdotte da ancu qui, ancora qui, si benis. La locuzione preposizionale ancu qui, parimenti a si benis, richiede l indicativo: ancu qui apu pecadu anche se ho peccato, ancu qui de pagari inch at arrestu anche se c è ancora un resto da pagare ; al contrario ancora qui è usata col congiuntivo: ancora qui sianta crudelis paganus. 55 Come si è già detto, l italiano letterario, all incirca dal Seicento, è l unico idioma neolatino che adoperi il condizionale passato in tale contesto. 28
29 Le proposizioni finali sono introdotte da po qui, qui sempre seguite dal modo congiuntivo: po qui bollais a mimi ancora perdonari perché vogliate perdonarmi, qui Rei sias in totu piga po cetru una canna affinché tu sia re completamente, prende una canna per scettro. Le implicite hanno po e infinito, anche con cambiamento di soggetto: mi neris si ses Christu... po ti adorari dimmi se sei Cristo affinché ti si adori. Le proposizioni consecutive sono generalmente introdotte da qui, e precedute da una principale che, di solito, contiene l avverbio tanti. Non è frequente l omissione dell avverbio: ti pregu... qui postru in terra corona e cetru Reali ti prego... tanto che depongo in terra corona e scettro reale. Le consecutive implicite hanno de e infinito: si veda l esempio già proposto per le proposizioni concessive, arrestu de pagari. Le proposizioni relative sono introdotte da qui, ma è frequente, come s è già detto, l uso del gerundio con funzione relativa. Le proposizioni temporali sono introdotte da candu, luegu qui, finsa qui e fina qui, imò qui: imo qui juntus seus adesso che siamo giunti. Le implicite hanno innantis de con l infinito: innantis de cantari su caboni. Le proposizioni comparative sono introdotte da comenti, que. Le proposizioni ipotetiche (condizionali) sono introdotte da si, piú raramente da qui (a biri qui s ada aguetari una domu a vedere se si troverà una casa : in questo passo il linguaggio è colloquiale). Il periodo ipotetico dell irrealtà può essere espresso per mezzo dell indicativo imperfetto, sia nell apodosi sia nella protasi: si xiada aiada a fueddari se sapesse, parlerebbe, Herodes a ti idi boliada dari sa morti... si podiada Erode a te avrebbe voluto dar(ti) la morte, se avesse potuto ; è impiegato anche il trapassato prossimo tanto nella reggente quanto nella subordinata: si iat açeptadu idd aianta fattu Rei se avesse accettato, l avrebbero fatto re. Nell apodosi dell irrealtà si può avere però anche il condizionale con uno dei costrutti summentovati; questi ultimi sono sempre usati nel periodo ipotetico della possibilità, che nella protasi richiede un tempo del congiuntivo (qui hayreus arruinadu.. su templu gloriosu.. issu idd edi m airi reedificadu se avessimo distrutto il glorioso tempio egli l avrebbe ricostruito ), a meno che è il caso del periodo ipotetico detto misto non si preferisca l indicativo per dare piú espressività all ipotesi: si cussu liberaus is Romanus enti mo essiri e is enti mo impadroniri de su logu qui ocupaus se liberassimo (lett. liberiamo ) costui, i Romani si moverebbero (lett. uscirebbero ) e s impadronirebbero del luogo che occupiamo. Nel periodo ipotetico della realtà, infine, la protasi ha l indicativo, mentre nell apodosi si possono trovare varî modi. Le proposizioni modali sono introdotte da segundu e segundu qui, e le implicite, molto frequenti, si servono del gerundio. 29
30 Le proposizioni esclusive sono introdotte da sino qui e sino ca; le implicite hanno senza seguito dall infinito. Le proposizioni eccettuative sono introdotte da ultra qui. Lessico Il lessico del Libro de comedias ha quattro componenti principali: voci sarde neolatine, che costituiscono sicuramente il fondo basilare, e poi iberismi, italianismi e latinismi. Gli iberismi sono molto numerosi: ciò non deve sorprendere, se si considera che l opera è composta all epoca del maggiore influsso spagnolo in Sardegna. In ogni settore del lessico troviamo esempî interessanti di parole che sono poi uscite dall uso comune, di solito sostituite dai corrispondenti moderni italianismi: aconortari confortare (< ant. sp. conhortar), atorgari ammettere (< ant. sp. atorgar 56 ), callari tacere, rematari terminare, assolari sconfiggere (< sp. asolar devastare ), realzadu rilevante, dugali cavezza (< sp. dogal), vera margine, parabenis complimenti (< sp. parabién), si alvorai alzarsi a cantare (< alborear, letteralmente alzarsi per fare l alvorada, che è la canzone o musica dell alba 57 ), gusari osare (< cat. gosar, diverso dallo sp. gozar godere > camp. gosari), galanu leggiadro, mas piú. Sono presenti anche locuzioni, quali por ventura per caso. Fra le cospicue voci d origine italiana si hanno ardiri, avilidu, grandu, impicari; c è un interessante rampanari sopportare, che è un derivato di rampone. Influssi italiani si hanno anche in locuzioni quali de su totu del tutto, no fatzanta capu non facciano capo. Parecchie parole entrarono in sardo dall antico toscano, prima che l italiano letterario si fosse formato, e sono documentate nei testi medievali: si hanno bellu, biancu, donniunu, ma, lestu ecc. I cultismi sono diffusi soprattutto in relazione al lessico sacro e illustre: gloria, padri, eternu, inclitu, formosu e simili; alcuni sono termini poco diffusi: gemibundu, rutilanti, rubicundu. Diamo l elenco dei vocaboli inediti presenti nell opera di Frate Antonio María. I singoli versi sono citati con l indicazione del numero, preceduto da una delle lettere seguenti, che indicano i singoli componimenti del Libro de comedias: N = Conçueta del Nacimiento de Christo, P = Comedia de la Passion de nuestro señor Jesu Christo, D = Representaçion de la comedia del Desenclavamiento de la Cruz de Jesu Christo nuestro señor, V = Versos que se representan el Dia de la Resurrection, A = Comedia grande sobre la Assumption de la virgen Maria senora nuestra a los cięlos. 56 Wagner registrò questo verbo come solo logudorese; in sp. mod. si dice otorgar. 57 alborear amanecer ó rayar el dia, primam diei lucem emicare, alborada... música que se da al rayar el dia (V. SALVÀ, Nuevo diccionario de la lengua castellana, Paris, 1865). 30
31 Le seguenti abbreviazioni indicano lingue: sp. = spagnolo, cat. = catalano, tosc. = toscano, it. = italiano; le altre abbreviazioni, largamente diffuse, hanno significati grammaticali. I vocaboli che, eccezion fatta per i cultismi piú comuni, non sono presenti nei principali dizionarî (Porru, Spano, Wagner) sono: alvorada, alvorari, amançiosu, apella, asolari (1), assentu (nel significato di seggio ), astrologali, bofitu, cerrialla, desnudu, doctoria, gineta, hierru (2), illostrosu, illuminosu, iscarniri schernire, ixutari, ixutu, juntu, murrioni, nigunu, paranju, passijari, perenali, perjudiciali, perjurari, posta paga, presurosu, profidiari, realzadu, rematari, revoltori, rubinadu, sino, solitudi, tempestuosu, traballu (nel significato di pena ), vera. Sono in larga prevalenza iberismi. I vocaboli presenti nei dizionarî sardi, ma attribuiti al solo logudorese, sono: atorgari, asolari (2), cursari, desfalliri, ingastari, isvariadu, pesosu. alvorada s.f. canto o musica dell alba in N517 (Intoninti a su mundu sa alvorada). Dallo sp. alborada. alvorari v. rifl. alzarsi all alba per cantare, ovverosia per fare l alvorada, in N1238 (si funti alvoradus po intonari cudda gloria in excelsis). Derivato dal su indicato s.f. alvorada. amançiosu agg. q. mansueto in V386 (acudiri prestu meda amançiosus). Deverbale da amansiri. apella s.f. appello in P2843 (No arrichinti apella in custa cosa Non accolgono appello in questa vicenda ). Può essere un troncamento dello sp. apelación. asolari (1) v. tr. sconfiggere in N15 (soli qui asolas totu sa malicia) e N503 (su peccadu assolari). È scritto anche assolari. Dallo sp. asolar e cat. assolar devastare, radere al suolo. assentu s.m. 1) riposo in P514 (eus a chircari una dij de assentu). 2) seggio in P276 (is cadiras de assentu i seggi appositi ). Dallo sp. asiento. astrologali agg. q. astrologico in N121 (O arti astrologali misteriosa) e N166 (vigilias astrologalis). Derivato di astrologia, con suffisso -ali. 31
32 bofitu s.m. schiaffo in P112 (cun ispudus e boffitus affeadu) e P133 (adevina... quini ti dat bofitus ispietadus). È scritto anche boffitu. Dal tosc. buffetto, con -i- per chiusura vocalica e -oforse dovuta all influenza dello sp. bofetada. cerrialla s.f. fracasso in N1186 (sa cerrialla de custu paranju il fracasso di questo luogo ). Derivato di cerriari gridare. desnudu agg. q. nudo in N500 (sa spada jay desnuda la spada già sguainata ). Dallo sp. desnudo. doctoria s.f. dottorato in N1085 (sa borla de doctoria il simbolo di dottorato ). Derivato di doctori. gineta s.f. lancia in D677 (lassu custa gineta a una parti). Dallo sp. jineta. hierru (2) s.m. sbaglio in P2196 (aichi anta acabari is qui fainti tali hierru). Dallo sp. yerro. L omografo hierru (1) è s.m. inverno. illostrosu agg. q. lucente in V351 (es tanti illostrosa, qui dat luxi et guia). Dallo sp. lustroso e cat. llustrós lucido, con i- iniziale dovuta all influsso di illustri. illuminosu agg. q. luminoso in P1102 (soli illuminosu). Da luminosu: la i- iniziale è dovuta all influenza di illuminari. iscarniri v. tr. schernire in P1412 (iscarniu deu apessiri de sa genti sarò schernito dalla gente ). Denominale, da iscarnu s.m. scherno in P148 (custa notti est deus omnipotenti unu iscarnu, y arrisu de sa genti), che proviene dal cat. escarni. ixutari v. tr. asciugare in P938 (calis peis is pilus anta ixutari). Deaggettivale da ixutu. ixutu agg. q. asciutto in P3103 e D178 (passandudi in su mari a pei ixutu). Dal cat. eixut. juntu agg. q. congiunto, unito in varî passi (nara imò qui juntus seus di, ora che siamo riuniti! ). Dallo sp. junto. 32
33 murrioni s.m. elmo in D678 (murrioni de ferru). Dallo sp. mo(r)rión. nigunu pron. ind. nessuno in D1074 (de nigunu seu diletu). Dallo sp. ninguno, con perdita di -nper influsso degli altri indefiniti e forse del tosc. niuno. paranju s.m. luogo in N1186 (sa cerrialla de custu paranju). Dal cat. paratge e sp. paraje, con infisso nasale e cambio di desinenza. passijari v. intr. passeggiare in P1207 (est hora de passijari è ora di passeggiare? ). Dal cat. passejar. perenali agg. q. perenne in N548 (funtanas perenalis). Dallo sp. perennal. perjudiciali agg. q. nocivo in D344 (unu mali a nosu perjudiciali). Dallo sp. e cat. perjudicial. perjurari v. intr. spergiurare in P1993 (jurei, et perjurey qui non fuit beru). Dallo sp. perjurar. posta s.f. paga, quota in P584 (unu soddu a posta mia). Dall it. posta. presurosu agg. q. 1) frettoloso in P1063 (presurosus passus). 2) urgente in N727 (sa causa est tantu presurosa). Dallo sp. presuroso. profidiari v. intr. insistere in N1138 (nara no bollas profidiari parla, non voler insistere ). Denominale dal cat. porfídia insistenza, testardaggine, con metatesi -or- > -ro- (per ragioni fonetiche non può derivare dal corrispondente verbo porfidiejar). realzadu agg. q. rilevante in N180 (is prodigius realzadus de is signalis). In origine participio passato, dallo sp. realzar rialzare, rilevare. rematari v. intr. affrettarsi in N63 (ti nara qui non tardis ma remata ti dice di non tardare, ma affrettati ). Dallo sp. e cat. rematar finire. 33
34 revoltori s.m. sovvertitore in P3000 (de totu su Regnu revoltoris). Voce che pare costruita sulla base di revoltari e revoltosu. rubinadu s.m. rubino in D1194 (sa ucca de rubinadu la bocca color rubino ). Derivato di rubinu. sino prep. tranne, fuorché in varî passi (non si intendat prus lamentu sino dulchi melodia). In P437 il suo valore si avvicina a quello della cong. avv. ma (no acuncentu qui issu siada liberadu sino qui siada chircadu). È usata anche la forma sinò, e compone loc. prep.: sino ca, sino qui. Dallo sp. sino e cat. sinó. solitudi s.f. solitudine in N481 (si ad a aligrari ancora su desertu cuni sa solitudi). Dal cat. solitud. tempestuosu agg. q. tempestoso in P1472 e D51 (que mari tempestuosu conturbada). Dallo sp. tempestuoso e cat. tempestuós. È usata nell opera anche la forma tempestosu. traballu s.m. travaglio, fatica in N1061 (benedictu su traballu su stentu su sudori) e D146 (beni... su mundu os at pagadu su traballu... qui... eis tentu). vera s.f. margine in N504 (su peccadu assolari... cun is veras scacciare il peccato (relegandolo) ai margini, alle estremità ). Dallo sp. vera. Seguono adesso i vocaboli che, come s è detto, sono presenti nei dizionarî sardi, ma sono attribuiti al solo logudorese. asolari (2) v. rifl. ritirarsi, restare solo in P2768 (que fera asoladu solo come una belva ). Deaggettivale da solu. atorgari v. tr. ammettere in P2274 (seu obligadu cunffessari et ancu de atorgari) e D279 (si mali as nadu imoy iddu atorgas). Dallo sp. ant. atorgar (oggi otorgar) e cat. atorgar. cursari v. tr. percorrere in N69 (o soli cursa prestu cussa sfera). Dallo sp. e cat. cursar. 34
35 desfalliri v. intr. venir meno in V212 (a is presentis y a is qui fun desfallidus). Dal cat. ant. desfallir (oggi defallir) e sp. ant. defallir (oggi desfallecer). ingastari v. tr. incastonare in V346 (parinti jaçintus in oru ingastadas). Dallo sp. engastar. isvariadu agg. q. demente, imbarbogito in P1948 (hay tristu de mei bechu isvariadu!). Dallo sp. desvariado. pesosu agg. q. pesante in P2967 (Ruxi a is palas tanti pesosa). Denominale da pesu. 35
36 2. SALVADOR VIDAL e JUAN FRANCISCO CARMONA: le prime attestazioni del campidanese Piú antichi di Antonio María da Esterzili sono Salvador Vidal e Juan Francisco Carmona. Vidal, al secolo Juan Andrea Cóntini da Mara Calagonis ( ), frate francescano, visse a lungo in Italia e Spagna e fu scrittore fecondissimo, adoperando con eguale efficacia il latino, il castigliano e l italiano. In sardo compose un unica opera, il poema Urania Sulcitana (1638) sulla vita di S. Antioco 58, e quando in campidanese non era stata ancora composta nessun opera letteraria, cinquant anni prima del Libro de comedias decise d adoperare il logudorese: nella dedica a don Juan Dexart egli illustra le cagioni della scelta, giustificandola con la maggiore vicinanza del logudorese al latino, benché poi fornisca un elenco di parole campidanesi che, a differenza delle corrispondenti logudoresi, si sono mantenute uguali al latino; il campidanese sarebbe in effetti piú conservativo, ma la lingua di Cagliari sostiene il frate marense si è corrotta per l afflusso al porto di genti dal mare. Vidal dichiara che il logudorese è per lui una lingua straniera, ma aggiunge di avere ormai dimenticato il proprio idioma nativo dopo diciannove anni d assenza da Mara 59. Nel poema Vidal si lascia sfuggire parecchie parole campidanesi, alle quali fornisce talvolta desinenza logudorese, confermando di non saper maneggiare bene la lingua scelta: si vedano, come esempî di tale tendenza, Lu spollant (XVI, 41) in luogo del log. Lu ispozan, e Si cantit à sas Ninfas (XXI, 31) anziché Si cantet. Nella Vida di S. Antioco in prosa castigliana 60, della quale possediamo il manoscritto, Vidal inserisce alcune parole in campidanese: Xeas, che indica un determinato tipo di terreno (il camp. cea, vocabolo preromano, significa pianura ), e l intera frase idindi hadi a bogari is xerbeddus ti schiaccerà le cervella, lett. te ne toglierà le cervella, pronunziata da un eremita del Capo di Sotto. La lingua di questa frase, che, visto il contesto, apparteneva certo al registro colloquiale, non si discosta da quella di Antonio María da Esterzili: il pronome di seconda persona ti possiede i- prostetica analogica; il relativo enclitico ndi è pleonastico; il futuro è costruito analiticamente (con l ausiliare hat dotato di vocale paragogica -i e l infinito in -ari); l affricata prepalatale sorda iniziale è indicata con x-, come già nel succitato xeas. 58 Urania Sulcitana, de sa vida, martyriu, & morte de su bonaventuradu S. Antiocu, Patronu de sa isula de Sardigna. 59 La scelta fu forse dovuta anche al fatto che Vidal si trovava a risiedere in un convento di Sassari e voleva essere capito dai confratelli, ma non si può nemmeno escludere che egli, oltre a ritenere il logudorese illustre, il quale già vantava opere scritte importanti, la lingua letteraria di tutta la Sardegna, avesse realmente perso dimestichezza con la propria lingua nativa. 60 Vida, martirio y milagros de San Antiogo sulcitano, sec. XVII, manoscritto S.P , Biblioteca Universitaria di Cagliari. 36
37 Carmona nacque nella seconda metà del XVI secolo, e fu forse giurato di Cagliari nel Nelle sue Alabanças de los santos de Serdeña (1631), raccolta di componimenti sacri in castigliano e catalano, è presente un testo (le Alabanças de San George obispo suelense calaritano) in cui si presenta un contrasto fra un cólto cittadino di Cagliari ed un pastore di Suelli: il cittadino è indotto a parlare in campidanese perché il suo interlocutore non capisce lo spagnolo. I versi endecasillabi in campidanese sono trentaquattro, e mostrano una lingua vicina a quella di Frate Antonio María; la stessa grafia è modellata su quella castigliana. Differenze sono nelle forme verbali pongu e tengu, modellate sullo spagnolo, mentre Antonio María usa ancora le forme neolatine ponju e tenju (< lat. *ponjo < poněo): ciò è indice di un maggiore influsso iberico in Cagliari capitale. È rilevante la forma ais, V persona indicativo presente del verbo dari: dari e donari, qui usato in un arriali os dongu col sugnificato di donare piuttosto che di dare, sono ancora in concorrenza, e nel Settecento s imporrà dona(r)i. Per bere è impiegato biri, omofono del verbo vedere. Notevole è l avversione per le consonanti geminate (bida paese, maravila, onipotenti; è data doppia la sola -rr-, e lo stesso nome del paese del pastore, Suedi, vede l occlusiva cacuminale sonora espressa con la consonante scempia). Un esempio di fonetica sintattica si trova in sa ia. Per esprimere l assenza Carmona usa no dua (= no dhu [< dhoi] at), mentre Frate Antonio María preferirà no nchi at. Il pronome interrogativo è ite che cosa?, meno frequente rispetto a it(t)a in A.M. In canta genti c è concordanza dell aggettivo col sostantivo (in A.M. sempre cantu invariabile). La congiunzione copulativa è ne (in A.M. ni). Potrebbe risalire al Cinquecento un canto epico dedicato alla vittoria dei Sardi antichi, guidati da Oroèni, sui Cartaginesi di Malco. Non si sa se sia stato mai pubblicato, né chi sia l autore; fu tramandato oralmente per molte generazioni 62. I primi quattro versi probabilmente sonavano cosí, o almeno hanno poi assunto questa forma 63 : Ca dh at-i bintu Oroèni a Malcu s urrèi gherreri de is Cartaxinèsus a pustis-i de unus-u dèx annus gherrèndi contras a is Afriganus. 61 Ciò secondo un interpretazione di S. Bullegas (Il teatro in Sardegna tra cinquecento e seicento, Editrice Democratica Sarda, Cagliari, 1976, pagg , nota 275); non concorda Cenza Thermes, a parere della quale il Carmona, visti i contenuti delle sue opere, poteva essere un sacerdote (Iuan Francisco Carmona, questo sconosciuto, Quaderni Sardi, Trois editore, Cagliari, 1994, pag. 10). 62 L argomento trattato presuppone conoscenze storiche che solo un poeta colto o semicolto poteva possedere. Si veda il sito informatico A kini da scit sa poesia de Oroeni?. 63 Usiamo il sistema di scrittura del campidanese già visto nell introduzione, con l aggiunta, indicata da un trattino, delle vocali paragogiche necessarie per la lettura corretta dei versi. 37
38 3. SA DOTRINA CHRISTIANA A SA LINGUA SARDISCA Già nel XVI secolo la Chiesa sentí il bisogno di servirsi della lingua del popolo per la predicazione, e si ebbero catechismi sia in logudorese, sia in campidanese 64. Per quel che concerne la parte meridionale dell isola, l opera piú antica, di cui si abbia notizia, fu stampata per la diocesi di Ales nel 1566, e fu presto seguito da altri: una nel 1568, una nel 1587, con ristampe negli anni 1589, 1594, Si ebbe poi una riproduzione nel 1695, presso la stamperia cagliaritano di Honofrio Martín e Juan Antonio Pisá, in occasione del sinodo della diocesi di Cagliari del 9 Gennaio 1695, tenuto dall arcivescovo Francisco De Sobrecasas: il breve testo campidanese, denominato Sa dotrina Christiana a sa lingua sardisca, si trova nelle ultime pagine delle Costituzioni sinodali, scritte in lingua spagnola ed emanate dal suddetto prelato. Quest ultima versione del catechismo, che fu ritrovata da Luigi Spanu nei primi anni Ottanta e pubblicata nel , è disponibile, e su di essa ora ci soffermeremo, ponendola in confronto con le opere già esaminate. La grafia, cosí come ogni aspetto linguistico, è vicina a quella usata da Frate Antonio María: si hanno giu- e ju- per l affricata prepalatale sonora (giuicari e juigari, bengiat); l affricata prepalatale sorda è espressa in piú modi (chincu cinque, rechiri, celu, dulci); la lettera x è adoperata per varî fonemi (xelus, ruxi, proximu), ma talvolta certi grafemi o digrammi si avvicinano al modello italiano (isciri); la c davanti a vocale palatale può leggersi come affricata o fricativa (incerrant); le occlusive intervocaliche presentano grafia oscillante (seti e setti, dat criadu l ha creato ; l articolo si fonde spesso col nome (sanima, ma anche sa hora); la tilde di frequente è omessa (sinu ma señori); non mancano le scritture etimologiche (octava, hoi), e gli errori di stampa appaiono numerosi (per esempio sembra difficile credere che cadidadi presenti assimilazione a partire da caridadi). Fonetica: sporadicamente si leggono desinenze etimologiche in -e anziché in -i (gemende, omnipotente), le quali, accostate ad esiti di tipo logudorese (doigui dodici e batordigui quattordici 66, con conservazione della velare e lenizione, ed esito labiale dell originaria labiovelare, che in casi come quaturu mostra aspetto campidanese genuino), fanno pensare a una provenienza del redattore dalla zona oristanese di confine, oppure alla presenza di un originale logudorese successivamente tradotto in campidanese, nel quale tali forme si sarebbero mantenute; si hanno esempî di i- prostetica (isciri), talvolta restituita (ei sanima e l anima, contra icustus contro questi, a icudu qui a quello che ); casi di lenizione anche in cultismi (juigari accanto a 64 Si veda un catechismo in sardo del 1777, a cura di Tonino Cabizzosu e Mario Puddu, L Unione Sarda, 2004, introduzione. 65 Sulla rivista S ischiglia, num. 10, pp Tali sono ancor oggi i suddetti numerali nei paesi a settentrione di Oristano. 38
39 giuicari 67, miserigordia, padiri patire ); rotacismo popolare di -l- (sarbari salvare ); esiti particolari (jari dare, che è qui meno frequente di dari). Morfologia. Si hanno diversi esempî di preposizioni articolate, come des (alibiu des penas), ais accanto a de sa, de is ecc. Fra le preposizioni sono usate de, da, dae da, peri, suba, inter tra ; interessante locuzione è da inter (resuscitedi dainteris mortus resuscitò di tra i morti ). Gli aggettivi numerali ordinali seguono la fila latina (segundu, terzu, quartu ecc.). Nomi: alternanza di maschile e femminile per ventre : su ventri e sa entri. Pronomi: in un caso è usato il pronome proclitico lu (lu lassat), per il resto sempre iddu oggetto (su pani nostu de onia dij dai nos iddu hoi dacci oggi il nostro pane quotidiano ) e di indiretto; come pronome complemento c è ancora ti (a ti e totu proprio a te ); l indefinito totu mostra oscillazione di forma al plurale: totus is cosas ma anche totu is cosas. Verbi: il perfetto è ben conservato: resuscitedi, arcedi, caledi, boguedi (coniugazione in -ari), e nascesidi, mentre sono usati con valore di perfetto i due presenti recipidi e ascendidi (-iri); al presente si segnalano seidi siede, ruidi cade, suntu (essi) sono ; l infinito di fare e dire risulta fairi e narri; il gerundio è di solito in -andu/ -endu, ma in un paio di occasioni termina in -e (gemende, pla<n>gende); i participî sono in -adu e -idu (nadu nato, bandidus). Avverbî: presenti ini lí e imo adesso, forme in -menti (ligermenti); è usato iddu per esserci (i duat seti virtudis vi sono sette virtú ). Congiunzioni: po qui, sendu qui, si se, a benis qui benché. Sintassi: il presente durativo usa l ausiliare stari (istanta aspetendu), il futuro è analitico. Il complemento oggetto di persona vuole la preposizione a (honorari a babu tuu). Lessico: gli iberismi sono molti (fra essi pasiencia, dulzura, alibiu sollievo ); si conservano numerose voci oggi in disuso (mandiari mangiare, biri bere, ea e hea ecco 68, paraula parola, cominigari, verdaderu, corparisi colpirsi ). 67 Qui c è anche caduta di -d- intervocalica. 68 Si veda Wagner (DES, I, p. 484). 39
40 4. JUAN MARÍA CONTU Juan María Contu è il primo prosatore campidanese moderno. La sua opera, il Novenariu cun platicas a su amantissimu coru de Jesus, è un codice manoscritto conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, insieme con altre due suoi libri in lingua spagnola. L autore, Reverendo Padre appartenente all ordine dei Frati Minori, nella prima pagina si presenta come Calaritanu, de sa Regulari Observancia de su S.P.S. 69 Franciscu, Letori in Sagrada Theologia, Qualificadori de sa Santa Inquisicioni in su Archibiscobadu de Oristanis, e Predicadori Apostolicu in sa Provincia de S. Saturninu Martiri Calaritanu in Sardiña. Le cariche sopra elencate, che dimostrano il notevolissimo livello di cultura raggiunto dal Contu, erano fra le piú prestigiose per un ecclesiastico sardo, e il Contu vi accesse certamente dopo il 1726, anno in cui fu predicatore conventuale annuale e, in tale veste, prese parte al capitolo provinciale, celebrato nel convento di S. Mauro in Cagliari il 2 ottobre Il Contu morí nel 1762, cosicché la composizione del Novenariu è da collocare fra codeste due date. L unica pubblicazione dell intera opera fu curata da Maria Teresa Atzori nel Il Novenariu è una corposa opera paraliturgica, che descrive la corretta celebrazione della novena, ovverosia dei riti che si svolgono nei nove dí precedenti le piú importanti festività cristiane. Le platicas del titolo sono le prediche tenute in ciascuno dei giorni di novena. Il libro si compone di una dedica, un prologo, sermoni e preghiere ordinati secondo le nove giornate, un indice d avvertenze, un catalogo degli autori citati, un indice dei passi della Sacra Scrittura e, infine, un indice delle cose notevoli. Vediamo dapprima fonetica e grafia: quest ultima appare ben piú coerente di quella di frate Antonio María. La lettera c ha pronunzia velare sorda davanti ad a, o, u (causa, coru), mentre prima di e ed i può indicare affricata dentale sorda (arciari, preciadu prezioso ), e fricativa dentale sorda (resucitari, incerrari: in quest ultimo caso però si potrebbe avere una pronunzia già affricata). Per l affricata dentale sorda talvolta è usato anche il gruppo tz (potzessint), per indicare suono piú intenso. Il gruppo qu indica la labiovelare sorda (quindixi), ma è adoperato soprattutto per l occlusiva velare sorda davanti alle vocali e/i (pitiqueddu, arriquiri); gu è il corrispondente sonoro (guia, guerra). Il digramma ch esprime l affricata prepalatale sorda (aichi, bechu, mancha macchia ), mentre i fonemi palatali hanno scrittura spagnoleggiante: quello nasale con ñ (cariñu, intrañas), quello laterale con ll (llaga). La lettera x può indicare sia l affricata prepalatale sorda (xena, xircari) e sonora (lixit, anxulu, ponxu), sia i due fonemi spiranti prepalatali, sordo (nexunu, ixacuari) e sonoro 69 Serafico Padre Santo. 40
41 (mexinas). La lettera j esprime di regola l affricata prepalatale sonora davanti a tutte le vocali (morjesit, monjas, sujetu). La nn intensa compare in forma scempia (danu, pina pinna ): le consonanti doppie sono infatti rarissime. La lettera z indica fricativa dentale sonora intervocalica (belleza, rezant pregano ), ma piú spesso affricata dentale sorda (descanzu riposo, zurpu cieco ) e sonora (zelosu). La grafia etimologica è ben presente, soprattutto in h iniziale (hora, homini), ct (perfectamenti, actu, aflictu), th (thema, authoridadi: falsa etimologia), x (exorcistas) e l nei gruppi consonantici (dulchi, planta). La i prostetica è usata di norma (iscarexiri). Si ha assimilazione in catodixi quattordici, apocope negli infiniti come aberrir aprire. Il sostantivo mochidorxu mattatoio mostra che la m- di mochiri, già vista nel Libro de comedias, aveva larga diffusione in campidanese. Nella morfologia verbale si ha il congiuntivo imperfetto in -essi (tenxessi, potzessint ecc.), di origine catalana 70. È regolarmente usato il perfetto sigmatico (-esi, -esti, -esit, -estus, -estis, -esint): si noti la IV persona, che in Antonio María non è attestata: Contu dà merexestus meritammo. Talvolta il trapassato prossimo pare acquisire il significato del perfetto (hestis miradu avevate osservato o forse osservaste, fiat naxidu era nato ma meglio nacque ), testimoniando il processo che ha portato alla scomparsa del perfetto nella lingua moderna. All imperfetto di I coniugazione si hanno -aa (xircaa cercavo ) alla I persona e -astis (habitastis) alla V. Nell imperativo, nelle cui forme con pronome enclitico non è mai segnato l accento sull ultima sillaba 71, la consonante lenita, di solito conservata, può ridursi a zero, soprattutto in vicinanza di altra -d-: confirmadi, guiadimi, intendedimi ma concedeinosi, adornaiddu e ajudaimi. Il participio passato esce in -adu e -idu. L infinito passato di forma attiva ha sempre àiri come ausiliare: depustis de hairi fatu dopo aver fatto. Nel verbo èssiri al presente la forma di VI persona è sunti; all imperfetto sono impiegate sia forme in fi- (fiat), sia forme in fu- (fustis). Fra i pronomi atoni, quelli plurali di I e II persona sono nos(i) e os(i), ma quest ultimo sporadicamente subisce aferesi: si agradant vi aggradano ; il possessivo vostro è ostu. L interrogativo ita è usato tanto come pronome, quanto come aggettivo (itas mexinas). Frequente è l impiego del pronome relativo letterario su cali. Il sostantivo di giorno è maschile (claru di). L opera di Contu segna l apice della spagnolizzazione linguistica della Sardegna: il lessico abbonda d iberismi, anche grafici (flechas frecce ), alcuni forse mai veramente entrati nell uso (remontari sollevare ), altri oggi antiquati (tambeni anche, ancora ). Ecco un elenco degli iberismi presenti nell opera, i quali non compaiono sui principali dizionarî: 70 Il congiuntivo imperfetto italiano è morfologicamente simile e può avere influito sulla formazione di questo tempo. Le terminazioni sono: -essi, -essis, -essit, -éssimus, -éssidis/-estis, -essint. La vocale tonica è sempre chiusa. 71 Poiché Contu non indica l accento non possiamo sapere se tali imperativi per accento siano tronchi o sdruccioli. 41
42 aficionari v. tr. affezionare, far amare. Novenariu, paragrafo 9: MARIA... cun su exemplu súu aficionat a is animus de is Christianus a su xelu Maria... col suo esempio affeziona gli animi dei cristiani al cielo. Dallo sp. aficionar. aficioni s.f. affetto, affezione. Dallo sp. afición. alevosia s.f. perfidia, tradimento. Dallo sp. alevosía. altercadu s.m. alterco. Dallo sp. altercado. arboleda s.f. boschetto. Dallo sp. arboleda. arrastrari v. tr. strisciare, strascinare. Nov. 361: aychi llagada sa lingua, da arrastrada quindixi bortas in sa terra. Wagner (DES, II, p.338) segnala la voce log. rastrare. Dallo sp. arrastrar. cantari (2) s.m. canzone di gesta. Dallo sp. cantar. comparziri v. tr. ripartire, dividere. Composto di cun e parziri dividere. cuchillada s.f. coltellata, non contese, risse come sostiene la Atzori (pag. 38). Nov. 214: piguesinti sa vida a cuchilladas a cuddu Christianu cautivu. Dallo sp. cuchillada. cytara s.f. cetra. Dallo sp. cítara. chupari v. tr. succhiare. Wagner (DES, I, p.455) segnala la voce come log. sett. Dallo sp. chupar. dañosu agg. q. dannoso. Dallo sp. dañoso. deleitari v. tr. dilettare. Dallo sp. deleitar. deleites s.m.pl. diletti. Voce spagnola non adattata alla morfologia campidanese. 42
43 desambainari v. tr. sguainare. Nov., 214: cun is zimitarras desambainadas; desambainesinti is zimitarras. Dallo sp. desenvainar e cat. ant. desembainar (oggi desembeinar). descalsu agg. q. scalzo. Dallo sp. descalzo e cat. descalç. destilari v. tr. distillato. Dallo sp. destilar. donaires s.m. pl. facezie. Voce sp., oggi al sing. grazia, garbo. duque s.m. duca. Voce sp. duracioni s.f. durata. Dallo sp. duración. eduziri v. tr. estrarre. Dallo sp. educir. fealdadi s.f. bruttezza. Dallo sp. fealdad. flacu agg. q. fiacco. Dallo sp. flaco e cat. flac debole, magro. galanteari v. intr. galanteggiare. Dallo sp. galantear. iglesia s.f. chiesa. Dallo sp. iglesia. Inglaterra s.f. Inghilterra. Dallo sp. Inglaterra. isquerdu agg. q. sinistro. Dallo sp. izquierdo. larga s.f. dilazione. Dallo sp. largas (plur.). leyenda s.f. leggenda. Dallo sp. leyenda. navidadi s.f. natività. Dallo sp. navidad. 43
44 nen cong. cop. né. Wagner (DES, II, p.161) segnala la voce per il sardo medievale e i dialetti centrali. Dal lat. nec con -n di non. osculu s.m. bacio. Spano (Vocabulariu, II, p.252) segnala la voce come log. Cultismo. paraysu s.m. paradiso. Dallo sp. paraíso. pensioni s.f. dazio, tributo, non premio come sostiene la Atzori (pag. 52). Nov. 448: discurriat de amoris, e de cariñus, paguendu pensionis de afectu a sa civilidadi de su tratu discorreva di amori e tenerezze, pagando dazio alla cortesia del suo comportamento (in senso metaforico). Dallo sp. pensión. perfumu s.m. profumo. Dal cat. perfum o sp. perfume, con cambiamento di declinazione. platicari v. intr. conversare. Dallo sp. platicar. presa s.f. preda. Dallo sp. e cat. presa. queridu agg. q. caro. Dallo sp. querido. quizas avv. giud. forse. Wagner (DES, I, p.346) segnala la voce come log. ant. Dallo sp. quizás. rasgari v. tr. lacerare. Dallo sp. rasgar. recamara s.f. guardaroba. Wagner (DES, II, p.341) segnala la voce recàmera come log. Dallo sp. recámara. receta s.f. ricetta. Dallo sp. receta. recomendacioni s.f. raccomandazione. Dallo sp. recomendación. recopilari v. tr. riassumere. Nov. 294: in unu coru ingratu si binti compendiadus, e recopiladus totu is vicius. Dallo sp. recopilar. 44
45 remontari v. intr. salire. Dallo sp. remontar. renzilla s.f. risentimento. Dallo sp. rencilla alterco. resplandeziri v. intr. risplendere. Dallo sp. resplandecer. resplandori s.m. splendore. Dallo sp. resplandor. ruidu s.m. rumore. Dallo sp. ruido. sino 1) cong. avv. ma. 2) prep. tranne. Dallo sp. sino. tercu agg. q. ostinato, duro. Nov. 319: O coru miu tercu, y obstinadu! Dallo sp. terco. torpeza s.f. turpitudine, non torpore come sostiene la Atzori (pag. 40). Nov. 158: su coru nostu esti in sa torpeza. Dallo sp. torpeza turpitudine, goffaggine, lentezza, pesantezza, inettitudine. zimitarra s.f. scimitarra. Spano (Voc., IV, p.274) segnala la voce come log. Dallo sp. cimitarra. La Atzori a pag. 38 segnala la voce bodas godi, interpretata come II p. ind. pres. di un inesistente verbo *bodari: si tratta invece del sost. boda matrimonio (dallo sp. e cat. boda): Nov. 427: In is bodas de Cana de Galilea Alle nozze di Cana in Galilea. Anche le voci *amistu amico e *cenaculadu cenacolo, che a parere della Atzori sono tratte dai corrispondenti termini spagnoli, risultano inesistenti nel Novenariu. 45
46 5. LA VIDA DE SANTU POTITU La Vida, Miraculus, e Martiriu de Santu Potitu è un codice manoscritto anonimo non datato di quattro fogli, facente parte della collezione Baylle e conservato alla Biblioteca Universitaria di Cagliari. Nel sottotitolo esso è detto traduzione in sardo dell opera scritta in latino, presente in un codice cagliaritano e già inviata al famoso annalista ecclesiastico, il cardinale Cesare Baronio ( ). La Vida descrive le straordinarie imprese di San Potito, sardo di nascita e martire all età di soli tredici anni. Al termine della narrazione della vita del santo, è citato il passo degli Annales Sardiniae di frate Salvador Vidal ( ), nel quale è trattato tale argomento. La Vida è un importante documento della lingua campidanese, ancor oggi facilmente comprensibile. Ecco le caratteristiche piú interessanti, a cominciare dalla grafia. I gruppi ch e gh, davanti a e ed i, indicano suono gutturale, come in italiano, e cosí pure i corrispondenti suoni palatali sono espressi alla maniera italiana con ci/ce e gi/ge; per l affricata prepalatale sonora davanti a u, a, o, sono presenti le due forme con gi- e j-, quest ultima alla spagnola (Angiulu e Anjulu, giai e disiju). La cacuminale sonora è sempre data dal digramma dh (cudha), qui attestato per la prima volta nella storia della lingua campidanese. Le occlusive e nasali intervocaliche sono rese o con scempia, o con geminata (babbu, possibbili, immoi ma ecu, comenti, imoi; subbitu e accapiau manifestano, in una parola stessa, le due diverse tendenze di scrittura). Le palatali nasali e laterali si presentano con gn e gl seguite da e/i: in un occasione sola si ha degoglaidhu. La fricativa prepalatale sorda è espressa con sc (apparescit), con x (executau) e con sx (nisxunu), la corrispondente sonora solo con x (boxis, quindixi). L affricata dentale sorda è resa sempre con z scempia (poza). Non mancano, infine, esempî di scritture etimologiche (exiliau, Christu). Ciò che piú colpisce nel manoscritto, peraltro, è l accentazione indicata nella maggioranza delle parole, e la distinzione delle vocali e ed o secondo la loro apertura e chiusura: le vocali toniche i ed u (per natura sempre chiuse), a (per natura sempre aperta), e aperta e o aperta sono segnate tutte con accento grave, mentre e ed o chiuse sono indicate con i due punti soprastanti (ë, ö). Un indicazione tanto meticolosa induce a pensare ad un traduttore dagli spiccati interessi linguistici, ma il fatto che spesso l accento sia una correzione del punto sopra la i, consente di supporre l intervento successivo di una mano diversa, come suggerisce pure l inserimento a bordo di pagina della congiunzione chi dopo un pues: ciò, probabilmente, è opera di un altra persona, benché poi vi sia un occorrenza dello stesso pues chi (pués è congiunzione causale castigliana, passata in sardo ed usata, fra gli altri, da Giovanni Delogu Ibba nel Settecento e Antonio María da Esterzili alla fine del Seicento; cominciò quindi a indebolirsi il suo valore causale a vantaggio di quello d avverbio di 46
47 tempo, e le si aggiunse allora, per mantenere il significato causale, l altra congiunzione chi, forse per influsso dell italiano poiché). Nella punteggiatura va rilevato l uso, anch esso secentesco, della virgola prima della congiunzione e. Sul piano specificamente fonetico, è notevole l uso del verbo getai, con affricata prepalatale sonora, in luogo del moderno ghetai 72 ; in bandat e bessiri s osserva l incorporazione dell originario avverbio di luogo bi nel verbo per fonetica sintattica, mentre l articolo determinativo non subisce elisione, ché invece avviene aferesi della vocale successiva (su mperiu). In morfologia si nota: l uso di uno specifico pronome complemento per la seconda persona singolare (de tei); forme d imperfetto in -eda, alternate con quelle in -iat, nella coniugazione in -iri; gerundio in -endu, talvolta prolungato in -enduru; congiuntivo presente di lassai in lessi; congiuntivo imperfetto regolarmente in -essi, ma è presente anche un fussit, di sicura origine italiana, al posto dell abituale fessit; compresenza di forme participiali diverse in uno stesso verbo (istada e istetia). Il participio passato della coniugazione in -ai è -au al maschile, mentre la coniugazione in -iri (e piana e sdrucciola) mantiene la fricativa intervocalica (posseída, lómpida). Il perfetto non è attestato, ed è normalmente supplito nelle sue funzioni dal trapassato prossimo. Nella sintassi meritano attenzione l uso del condizionale presente nella dichiarativa subordinata, quando essa esprime un azione futura (naràda chi no nd iat a benni); la protasi dell irrealtà all indicativo imperfetto (si no beniat...); il gerundio con funzione di participio congiunto (henduridhu agatau fend orazioni); la subordinata implicita con soggetto diverso da quello della reggente (dhu presentant a is leonis po essiri devorau). Il lessico è caratterizzato da una gran mole d ispanismi, alcuni non rintracciabili nei vocabolarî di sardo (apparesciri < cat. appareixer, posseída < sp. e cat. pos(s)eida). Non è però da trascurare il peso degli italianismi, dei quali alcuni esprimono sottili sfumature di significato (portai sopportare e parai prospettare, dall it. porgere, offrire ), altri sono calchi (is calis). In definitiva, la Vida de Santu Potitu sembra ascrivibile all epoca di transizione culturale della Sardegna dall orbita spagnola a quella italiana, ed è lecito collocare cronologicamente la composizione del manoscritto intorno all anno Poiché tanto Frate Antonio María quanto Cossu testimoniano la forma palatalizzata, l esistenza di getai accanto a ghetai è indubbia: è chiaro che, nel campo della palatalizzazione, la fonetica storica campidanese va rivista. 47
48 6. I GOCCIUS DE SANTA BARBARA Il componimento è conservato alla Biblioteca Universitaria di Cagliari, fra i manoscritti Laconi. I Goccius de Santa Barbara, in base all indicazione di catalogo, furono composti a seguito della caduta di un ala del monastero di Santa Caterina in Cagliari, il 27 Dicembre Alcuni tratti lessicali e morfologici inducono a credere che l anonimo poeta fosse cagliaritano, come lo stesso argomento e le stesse circostanze di composizione confermano. Per quanto riguarda la grafia, si nota che essa, trent anni dopo il passaggio dell isola ai Savoia, è di tipo italiano: gn indica palatale nasale (carignus), gia affricata prepalatale (giai), ghe e chi gutturali sonore e sorde (preghera, chi). Un tratto superstite di scrittura iberica è invece la x, usata per rappresentare la fricativa prepalatale sorda (naximentu). La lettera z indica affricata dentale sorda (innozenti), ed in un caso è impiegata anche dopo n per esprimere l effettiva pronunzia del gruppo ns (cunzervas, ma inserras con grafia etimologica); si nota inoltre oscillazione di scrittura fra -t e -d nella desinenza verbale di III persona singolare (assegurad, mandad ma anche mandat). In morfologia si rilevano il genere maschile di dus fontis due fonti, che è un cultismo d origine italiana (l autore adopera duas funtanas come sinonimo), il congiuntivo imperfetto in -essi (maltratessit) e il gerundio in -endu (timendu). Gli elementi caratteristici ma non esclusivi del campidanese di Cagliari sono l uso di fiat e non fut come imperfetto di èssiri (III persona singolare), e i termini sèu cattedrale, de undi di dove e inní lí per quanto attiene al lessico. Sul piano della sintassi, si rileva l uso del congiuntivo trapassato in una proposizione finale, laddove in italiano compare il congiuntivo imperfetto: po chi inní ti essinti fertu. Nello stesso foglio, sul cui lato sinistro si trova l ultima parte dei Goccius de Santa Barbara, comincia un altro inno sacro, scritto da mano diversa: i Goccius de su sacratissimu e dulcissimu coru de Gesú Redentori nostru, che portano la data del La lingua non si allontana da quella del precedente componimento, se non per un gerundio in -endi (concedendiddi); si ha poi gli per la palatale laterale (briglianti), e nos come clitico di I persona plurale. Molto numerosi furono i componimenti di questo genere, onde gli autori sono rimasti per lo piú anonimi: parecchî non ebbero mai pubblicazione scritta, e certo ve ne sono alcuni rimasti conservati in qualche biblioteca senza essere stati ancora divulgati. Codesti di Santa Barbara e del Cuore di Gesú sembrano essere fra i piú antichi. 48
49 7. IL CATECHISMO DEL CORONGIU In Italia ebbe vasta diffusione, nella seconda metà del Settecento, il catechismo di monsignor Michele Casati ( ). Il testo fu tradotto in campidanese nel 1777 per iniziativa di don Francesco Maria Corongiu, che però non fu l esecutore dell opera, affidata a un altro sacerdote rimasto anonimo ma sotto la supervisione dello stesso Corongiu. Il Catezismu rivela la preoccupazione della Chiesa di trasmettere al popolo i principî della fede, e fu una delle principali fonti per l istruzione dei fedeli di Cagliari e della Sardegna meridionale; essa occupa poi un posto importante nella storia delle traduzioni in sardo. L autore mostra di nutrire scarsa fiducia nelle capacità espressive del sardo: eus procurau... chi fussit tradusiu in su Sardu vulgari de custu Cabu, in sa mellus manera, ch est istau possibili, atendida sa variedadi, e iscarzesa de sa pronunzia, e de is terminus de custu dialetu 73. L inclinazione del traduttore è ad attenersi strettamente al testo del Casati, e di semplificare, dove è possibile, i concetti: il periodo dobbiamo particolarmente ricorrere al nostro Angelo custode, a Santi, di cui portiamo il nome, e a Santi Protettori della diocesi, e della Parrocchia è reso pedissequamente con depéus particularmenti recurriri a s Angiulu nostu Custodiu, a is Santus de is calis portaus su nomini, e a is Santus Protettóris de sa Diozesi, e de sa Parrocchia. Talvolta anche parole sarde genuine assumono il valore semantico italiano, come intendiri nel senso di volere, e il sintagma benganta variadas siano variate. La grafia segue il modello italiano, pur con qualche tratto superstite iberico. Uno è l uso di x (e talvolta xi- davanti a a, o, u) per la prepalatale sorda: connoxi, nixunu, exercitai, naxias nate ; la stessa lettera è adoperata anche per la corrispondente consonante sonora: xelu. Sporadicamente si trovano anche qu- e gu- velari davanti a e, i: ispliquendu spiegando, piguit prenda. In fonetica si notano frequenti adattamenti di termini cólti alla pronunzia campidanese: recuberai, iscarzesa, Diozesi. La i- prostetica è frequente: iscola ne è esempio. Vi sono varî esempî di arprostetico: arresussitau, arrobas beni, arrebivai ravvivare. Tra i casi d epentesi, aturus altri. Il pronome di II persona plurale atono è osi, quello di I è nosi, quello di III è insoru. Il pronome clitico è posposto all infinito verbale: accusaisí, salvaisí, proponniosí proporvi, salvainosí salvarci ; alla terza persona singolare può perdersi -s di ddis: comenti d iat fatu come aveva fatto loro. Il pronome personale può essere rafforzato con e totu: nos e totu proprio noi. Il pronome relativo è usato alla maniera italiana: oltre al cultismo cali, si veda chi, adoperato in quest esempio: modus, cun chi de bosaturus s annunziat sa santa Lei modi, coi quali da voialtri è annunziata la santa Legge. L indefinito tottu, al nome, si declina al plurale: tottus is ominis. 73 Si noti la scelta del vocabolo dialetu; esso è inoltre definito su Sardu vulgari de custu Cabu: il termine campidanese non era ancora usato. 49
50 Nel settore verbale, si segnala come rarissimo l uso del perfetto in -esi (cumenzesid). Il congiuntivo imperfetto fussint fossero è preso dall italiano. Il gerundio, di regola in -endu, può ampliarsi in -endur-, soprattutto se è seguito da pronome: accumpangenduriddus, declarenduriddis dichiarando loro, in alternanza con -end- (dimandendiddi e donendiddi). I participî passati sono in -adu (meno spesso -au) e -iu (ma talvolta -idu): preparadu e istimadus ma istau stato, intendius, intimorius. Nel verbo essere, est del presente diviene piú d una volta es davanti a consonante sonora: es Deus, es nezessariu. Per esistere, esserci è preferito il sintagma inci airi: non c iat duda non v è dubbio. Il periodo ipotetico dell irrealtà ha il condizionale nella proposizione principale, e il congiuntivo imperfetto nella subordinata: iant a essiri... si s osservessit. Il futuro anteriore s avvale di airi come ausiliare: ant ai aprendi beni avranno appreso bene. Di frequente l aggettivo è preposto al nome: particulari instruzioni, Santissima Trinidadi. Diffusa è la congiunzione povinzas finché parimenti a poita chi causale, mentre benisí benché è calco dell italiano. Modellati sull italiano sono anche i numerosi avverbî uscenti in -menti. Appartiene certo alla lingua viva il nesso di preposizione con participio: depustis papau dopo aver mangiato. Il verbo imparai è usato con costruzione personale, equivale cioè a istruire. Molti forestierismi spagnoli ben si riconoscono nella grafia di tipo italiano: glianu piano, resussitai, sienzia scienza. Il lessico d origine iberica è davvero significativo: vi sono voci oggi scomparse in sardo, quali chissàs forse, recaídas cadute. 50
51 8. ANTONIO PURQUEDDU Il sacerdote gesuita Antonio Purqueddu (Senorbí 1743-Cagliari 1810) è autore di un poema didascalico in campidanese con versione italiana, De su tesoru de sa Sardigna, pubblicato nel L opera si compone di tre canti in ottave, con l aggiunta di un corposo apparato di note, e tratta dell allevamento dei bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, i quali in quel tempo, secondo le direttive dell amministrazione sabauda, parevano rappresentare occasione di grande sviluppo economico per l isola. Sul piano linguistico si rileva subito che il modello ortografico è tutto italiano, senza tratti iberici, come dimostrano le voci lettisceddus, rescioni, boscis, in cui la fricativa prepalatale sonora è resa con sc- e mai con x; in escemplu esempio è riflessa la pronunzia spagnola con grafia italiana. La consonante cacuminale è espressa con d: du, da, peddi, cudda. Alcuni fatti fonetici, quali le assimilazioni di rc > cc in cicanta < circant-a cercano e accovecada < acobercada coperchiata dimostrano la provenienza dell autore dalla pianura del Campidano. C è epentesi in quatturu quattro. Dopo l articolo determinativo plurale is, è d obbligo i- prostetica, che negli altri casi è facoltativa: is istrofas, is isprigus, e a istrubbai a disturbare, o istofas, ma cun sperimentus, una strofa. Anche fenomeni di fonetica sintattica trovano interessante espressione nella scrittura del Purqueddu: in bosci e bagadia voce di vergine d- della preposizione è caduta senza lasciare traccia; d- cade anche in casi quali no d ongais non dategli, mentre in ed a < e a la congiunzione acquista qeusta -d eufonica italianeggiante forse per esigenze di metrica. Il pronome enclitico di II persona, che doveva subire lenizione nella pronunzia, è scritto con la consonante originaria: faitì tenni. I pronomi atoni di I e II persona plurale sono nos(i) e os(i), mentre il pronome soggetto di II è bosu o bosateras. Dopo la preposizione cun, si hanno forme quali cun tegus. La desinenza verbale di III persona singolare cade davanti a consonante: dis podi fairi dannu può far loro danno, di mudi gli muti, si oli nadu si vuol detto ; anche -nt di III plurale per esigenze metriche può cadere (portan). Il futuro è costruito sempre analiticamante (has a biri), si conserva il perfetto in -esi: cantesi, conservesti, patesit patí. L imperfetto di airi, usato anche come ausiliare per il condizionale, ha ia alla I persona: ia bolli intendiri vorrei sentire. Il congiuntivo imperfetto di èssiri presenta forme di origine italiana (fussi, fussint) anziché catalana in -essi, come hanno gli altri verbi, tra cui airi (essinti ecc.) L infinito di prima coniugazione esce in -airi o -ai: incontrairi, pensairi, e dimandai, donai; quello di seconda e terza coniugazione in -iri (intendiri, concluiri, balliri) può troncarsi (bolli). Nel participio la consonante desinenziale -d- non sempre è mantenuta, in quanto la prima coniugazione mostra -adu prevalente su -au (cambiadu ma duplicau), e la seconda alterna -idu/-ida 51
52 con -iu/-ia: dormidus e nascida, ma intendiu e tradusia. Il gerundio esce soltanto in -endu, talora prolungato in -ru. In alcuni verbi sono presenti forme di origine spagnola, come tengu e bengu. Il verbo airi è usato spesso come transitivo: has hai dis avrai giorni, han sa prus gravi cura. Il verbo andai, per influsso italiano, è usato talvolta come ausiliare: andu liggendu vado leggendo. Nelle proposizioni subordinate è largamente usato il modo congiuntivo: pochì stetanta, o tottu essinti bistu. Come congiunzione condizionale è sempre usata si. Per quanto riguarda il lessico, non mancano crudi italianismi, come pancia ed ecco. 52
53 9. GIUSEPPE COSSU 53
54 Giuseppe Cossu ( ), cagliaritano, avvocato ed economista, nel 1767 fu nominato Segretario della giunta istituita per amministrare i Monti frumentarî o granatici, cioè i magazzini di raccolta del frumento, esistenti negli antichi consorzî agricoli; nel 1770 ottenne la carica di Censore generale. Fra il 1788 e il 1789 pubblicò due dialoghi in campidanese con versione italiana a fianco, intitolati Moriografia sarda e Seriografia sarda: nel primo s insegna la coltivazione dei gelsi, nel secondo s illustrano le tecniche per allevare i bachi e produrre la seta. Di Cossu possediamo documenti piú antichi: fra le carte della collezione Laconi, per esempio, è presente la copia di una circolare, redatta nell Aprile del 1769 e rivolta alle amministrazioni locali per sollecitarle a fornire alcuni chiarimenti sulla produzione agricola, la quale presentiamo in appendice. Il testo sardo, nelle opere di Cossu, si presenta come una traduzione dall italiano, non letterale e spesso semplificata: il suo scopo è di rendere comprensibili anche ai destinatarî esclusivamente sardofoni le disposizioni impartite. La grafia adoperata s ispira al modello italiano, ma sono evidenti alcuni tratti spagnoli: il digramma gu per esprimere la velare sonora davanti alle vocali e ed i (siguinti seguono, piguendu prendendo ), e qu piú raro per la velare sorda (qui pronome relativo); la lettera x per rendere la fricativa prepalatale sorda (connoxit conosce, paxxit pasce, exemplu). Le occlusive intervocaliche e le vocali paragogiche presentano oscillazione nella scrittura: depint/depinti/deppinti, addirittura piticu/piticcu/pitticu/pitticcu. Nel testo sardo, differentemente da quello italiano, si trovano anche pochi casi di scrittura etimologica: existenti. In fonetica è importante l alternanza di gettai e ghettai. La i- prostetica è usata sovente: isperdida, istendiriddas stenderle, ma stasoni stagione accanto a istasoni (sp. estación); frequente è l uso di ar- prostetico (arremonai rimembrare, arrespostas). Nel verbo si segnala la presenza del gruppo -ng- in alcune forme verbali (tengu: è spagnolismo), e l alternanza di sunti e funti. Il congiuntivo imperfetto è in -essi, ma fussi per il verbo essere. Il gerundio può assumere il prolungamento in -ru: si hanno, per lo stesso verbo, le due forme di gerundio spezifichendu e ispezifichenduru; i participî passati sia in -adu e -idu, sia in -au e -iu. Il verbo nàrriri è vicino alla forma originaria (lat. narrĕre). Fra gli indefiniti si segnala nisciunu regolarmente posposto (duda nisciuna). Gli aggettivi propriu e grandu (d origine rispettivamente spagnola e italiana), premessi a nomi femminili, sono lasciati invariati: sa propriu Bidazoni, una grandu diferenzia. Il condizionale è sempre del tipo in iat a + infinito. Un calco dall italiano è la locuzione preposizionale baxu pena de sotto pena di. 54
55 La prosa di Cossu segue il ritmo di quella italiana, con periodi lunghi e complessi, ma trovano posto anche tipici costrutti sardi, come il relativo polivalente: is plantas si manteninti attraendu de sa terra cuddas particulas, chi ddis abbastada po mesu de is arrexinis le piante si mantengono attraendo dalla terra quelle particelle, che lor convengono per mezzo delle radici. La Moriografia e la Seriografia, riunite in un volume dal titolo La coltivazione de gelsi e la propogazione de filugelli in Sardegna, sono particolarmente preziose per le testimonianze nell ambito del lessico: l opera non tratta temi religiosi, come le altre opere in prosa già esaminate, che abbondavano dei cultismi del settore, e si apre dunque al linguaggio vivo del mondo contadino, facendo ricorso a tutti i necessarî tecnicismi. Nel libro di Cossu troviamo diverse parole che nei dizionarî antichi e moderni mancano, ovvero sono presenti ma non ritenute campidanesi: si hanno voci quali abrigai riparare (< sp. abrigar) e arrancai, ritenute da Wagner solo logudorese, copiolus gemelli (derivato dell it. coppia), dal Tedesco ascritta al logud. settentrionale, avrincaisí piegarsi (da avra < lat. aura), inconesciu inopportuno, incoerente (sp. inconexo sconnesso ). Si trovano anche parole dotte in forma spagnola (esciofagu, influxu) ed è da rimarcare la presenza di svariati iberismi (porventura forse ). 55
56 10. EFISIO PINTOR SIRIGU Il noto avvocato cagliaritano Efisio Pintor Sirigu ( ) detto Pintoredhu, protagonista delle vicende politiche del suo tempo, compose liriche in latino e italiano, e scrisse in campidanese una serie di poesie satiriche, molto elaborate metricamente, sí che furono denominate cantzonis a curba canzoni a strofe. Gli furono attribuite le rime religiose pubblicate nel 1833 a Cagliari nella raccolta dei Canti popolari di Sardegna, ma esse risultano essere opera del contemporaneo Efisio Luigi Pintor Navoni. La lingua di Pintor Sirigu si può ben definire cagliaritana, perciocché in essa si trova testimonianza di quegli elementi, soprattutto morfologici e lessicali, che i glottologi moderni hanno ritenuto caratteristici del campidanese meridionale, e dalla zona di Cagliari diffusisi poi in quasi tutto il Capo di Sotto: pronomi enclitici di I e II persona plurale in si (< nosi e bosi); imperfetto di prima persona in -emu (II classe) piú frequente che in -ia; imperfetto di essere con femu e fiat; congiuntivo imperfetto in -essi anche per il verbo essere ; infiniti solo in -ai e -iri, quest ultimo frequentemente troncato in -i; participî solo in -au e -iu; forme dei verbi tenere e venire con -ngspagnolo (tengu, bengant ecc.); l infinito passato ha l ausiliare èssiri e non àiri (su dd essi acchistau il fatto d averlo acquistato ). Per alcuni altri aspetti la lingua di Pintor Sirigu è piú conservativa: il gerundio esce sia in -endi, sia in -endu, ed entrambe le forme possono prolungarsi in -ru; è frequente la prostesi di i- dinanzi ai gruppi consonantici con s-, in ogni posizione; est del verbo essere passa a es davanti a consonante sonora. Si può insomma sostenere che la grammatica campidanese, nei duecento anni che separano Pintor Sirigu dalla lingua scritta contemporanea, non abbia subito variazioni di rilievo. 56
57 11. LE CONSTITUZIONIS PO SA CUNFRARIA DE SANT EFIS Le Constituzionis po sa Illustri Cunfraria de Sant Efis de sa bidda de Quartu (1802) 74 mostrano un processo di italianizzazione decisamente avanzato. L italiano è divenuto l indiscussa e unica fonte letteraria di riferimento e questo testo, che comunque mantiene è bene precisarlo una struttura fonomorfologica rigorosamente sarda, appare molte volte una traduzione dall italiano in campidanese: prova di ciò è la frase una maggiori devozioni iguali a sa maggiori regolaridadi de sa giai nada alternativa. Vi sono anche prestiti italiani nemmeno adattati: Settembre, Marzo. La grafia, come è facile dedurre da tale premessa, è basata su quella italiana: la fricativa prepalatale sonora, che in italiano non esiste, è resa con x, mentre l occlusiva cacuminale sonora compare ora come doppia dd (si ddi glie lo ), ora come d scempia (dus li, pronome proclitico). La x, d altra parte, per eredità spagnola può indicare anche la prepalatale sorda, come in exerziri effettuare e in merexiaus meritiamo (congiuntivo presente): si noti il gruppo xia- scritto in analogia con scia-, parimenti che in dexiottu. Nell aggettivo possessivo inzoru loro si manifesta il passaggio -nts- < -ns-. Le incertezze grafiche non sono molto frequenti: tra queste in dat a podiri fai ne potrà fare, con in dat in luogo di indi at. In morfologia è rilevante il mantenimento della forma non aferetica dei pronomi personali: illuminainosi illuminateci, nos perdonit, os airi ofendiu. Il gerundio con uscita in -endu prevale su quello in -endi, e si trova anche -enduru. Il participio passato del verbo stare è debole: cun tegus est istau. Fra gli aggettivi indefiniti è ancora vitale alguna. A parte il relativo su cali, non raro in letteratura, un calco sintattico dell italiano si trova nell espressione s at a stai congreghendu. Una voce spagnola antiquata è desde da (desde su primu annu) 75. L aggettivo asuli azzurro, che ci pare non essere attestato altrove, è variante di asulu (< sp. azul). Il sostantivo abidu, specifico del lessico ecclesiastico, significa abito talare. Non bisogna dimenticare che, nonostante l influenza italiana già posta in evidenza, nel terreno della Chiesa erano fissate radici iberiche ancora ben salde, come prova la nota d approvazione dello statuto, firmata dall arcivescovo di Cagliari Diego e controfirmata dal segretario Juán Zapata, la quale è scritta in ispagnolo. Discorso simile, riguardo all influsso italiano, può essere fatto per altri libri ottocenteschi, i quali, piú che traduzioni in sardo di testi italiani, sono le stesse opere italiane in veste morfologica sarda: buon esempio forniscono le Brevis lezionis de ostetricia del chirurgo cagliaritano Efis Nonnis, che, nella dedica al professor Solinas, dichiara mi seu serbiu ancoras de sa lingua patria po sa prus 74 L edizione piú recente è a cura di Anna Castellino e Linda Garavaglia, Gasperini, Cagliari, Nell edizione del 1998 si legge dende. 57
58 facili intelligenzia de dognunu. Che volgarizzazioni di questo genere fossero accessibili ad un pubblico poco cólto, si può legittimamente dubitare, visto il costante impiego dei termini tecnici della medicina italiana. 58
59 12. LA PARAFRASI DEL SALMO CINQUANTESIMO L opera, pubblicata dalla stamperia civica di Carlo Timon nel 1823, proviene dalla raccolta Laconi ed è un componimento di centoquarantaquattro versi in ottave. Il termine parafrasi è inteso non solo e non tanto come esposizione del testo latino, per mezzo di parole diverse, quanto come libera riflessione e meditazione dei varî passi del salmo. L opera, stilisticamente ben curata, è un buon esempio di campidanese illustre del primo Ottocento, e offre elementi utili per la storia della lingua. La grafia segue decisamente l alfabeto italiano, e di spagnolo resta un solo tratto, la lettera x che, in concorrenza con sce/sci, indica la fricativa prepalatale sorda: a sciu e conosci conoscere si contrappongono conoxiu, in cui la -i- è inutile simbolo grafico in analogia con lo stesso trigramma italiano sci-, ed exemplu (qui il grafema non pare avere valore etimologico); la x è usata anche per la corrispondente consonante sonora, inesistente nel sistema fonologico italiano (rexoni, cumplaxeis). Per l affricata dentale sorda si usa solo z: zerriau, pozza che io possa. La vocale e in iato può passare a i (di essiri, i heis a essiri). Le consonanti intervocaliche dalla pronunzia intensa sono quasi sempre scritte doppie. Sono segnati gli accenti per indicare il timbro delle vocali e ed o. L infinito apocopato è segnato con l apostrofo. Un incertezza grafica si riscontra al verso 70: non de ddu pighéis, con de che sta per relativo di luogo nde/ndi. Nelle forme del verbo avere compare h- etimologica, ed il pronome relativo è scritto su quali. Numerosi sono i fatti interessanti di morfologia. I pronomi enclitici, uniti all imperativo dei verbi, prendono sempre l accento (castiaimì, agatendumì); il pronome di II persona plurale si presenta nelle diverse forme bosu (tonico), os(i) e si (atoni). Il congiuntivo imperfetto ha desinenza -essi (fessi). Il gerundio esce in -endu (sighendu, cantendu), in un caso allungato in -ru (essenduru). Il participio passato solitamente esce in -au/-ada e iu/-ia (incadenau, obbligau, benìu, dividìu), ma quello di seconda coniugazione per motivi metrici può mantenere -d-: seu stetid obbligau. Si nota l assenza del perfetto, sostituito nelle sue funzioni dal trapassato prossimo (idd hestis revelau lo rivelaste ). La congiunzione concessiva mancai richiede il verbo al modo congiuntivo (mancai dignu non sia), il quale modo è usato nelle proposizioni finali (osì pregu, chi innantis mi limpiéis).e temporali (innantis chi deu torri). Esempî di stile letterario sono il pronome relativo su quali e il frequente uso della forma passiva. Un tipico costrutto implicito sardo si ritrova al v. 60: su quali pregu a bosu a mi donai. Un evidente italianismo sintattico, a parte l aggettivo anche possessivo spesso preposto al nome, è la locuzione avverbiale de su tottu del tutto. L aggettivo femminile esenta è una forma antiquata del moderno esente, e riprende il latino exemptus. 59
60 13. IL VANGELO DI MATTEO TRADOTTO DA FEDERIGO ABIS L opera rientra nel progetto del principe Luigi Luciano Bonaparte ( ), che si poneva il fine di documentare comparativamente gli idiomi parlati in Europa, per mezzo della traduzione di passi biblici. Nel 1858 uscí il Vangelo di Matteo tradotto in sardo logudorese dal canonico Giovanni Soano, due anni piú tardi il Vangelo di S. Matteo, volgarizzato in dialetto sardo cagliaritano dall Avv. Federigo Abis. Entrambe le versioni dal latino (Vulgata Clementina) furono pubblicate a Londra in una tiratura di sole duecentocinquanta copie, e furono seguite dalle traduzioni del Libro di Rut, del Cantico de Cantici di Salomone, dalla Profezia di Giona e dalla Storia di Giuseppe Ebreo. La grafia è ispirata al modello italiano, con eccezione di qualche cediglia (çittadi, saçerdotus), e non s ispira a criterî etimologici, piuttosto cerca di esprimere la pronunzia reale (cattodixi quattordici ). È usato il pronome relativo su cali, cultismo. I pronomi personali atono di I e II persona plurale non presenta aferesi: liberanosì de dogna mali, osi nau, osi battiu vi battezzo. Per quanto riguarda i verbi, si notano bidit egli vede, stiant stavano ; l imperativo di andai esce sia in baxi sia in andai. Il participio di cumparri è cumpartu (fiat cumparta). L indicativo perfetto non è usato, ed in sua vece si impiega di norma il trapassato prossimo: E candu fiant intraus a Gerusalemmi, si fiat posta in motu totu sa çittadi. Il congiuntivo imperfetto, usato frequentemente, è sempre in -essi (bollessit, si citessint si zittissero ). Anche nomi proprî sono adattati alla morfologia campidanese, come Nazarettu e il succitato Gerusalemmi. Sul piano della sintassi, sono evidenti alcuni cultismi e italianismi, come il gerundio narrativo, usato con funzione di subordinazione causale-temporale: essendisì sposada sa mamma de Issu Maria cun Giuseppi, innantis chi bivessint impari, s est incontrada pringia po opra de su Spiritu Santu, ovvero hendi Gesus acabau totu custus discursus. Per indicare la posteriorità rispetto ad un azione del passato, è adoperato il condizionale presente: ddis domandàt aundi hiat a nasciri Cristus domandava loro dove sarebbe nato Cristo. Compare anche il costrutto passivo: su ch est stetiu nau de su Signori. Il verbo sfendiai partorire è costruito con de: sfendiai de unu fillu. Il lessico rivela lo sforzo di esprimere i concetti con parole in uso, e non con latinismi evangelici: frastimai e frastimu si contrappongono a blasphemare e blasphemia, presenti nella traduzione di 60
61 Spano in logudorese; il lat. redemptio è reso con rescatu, dilectus è vòlto in stimau. L evangelico mensas nummulariorum... evertit, rovescia i tavoli dei cambiavalute, per esempio, è tradotto con sciusciat is mesas de is cambistas. Sono presenti anche iberismi che, al tempo di Abis, già dovevano essere poco diffusi: offressiri offrire (dallo sp. ofrecer), accumpliri compiere (dal cat. acomplir). Nel complesso si può dire che le scelte linguistiche di Abis rispecchino l idioma campidanese vivo, a differenza della versione di Spano, densa di cultismi ortografici e lessicali e ispirata ad estremo letteralismo. Lo Spano tradusse poi lo stesso vangelo in sassarese nel 1866, preceduto dalla versione nel gallurese di Tempio, curata da padre G.M. Mundula nel 1861: anche il principe Bonaparte, cultore di linguistica appassionato delle lingue di minoranze, aveva riconosciuto l esistenze di quattro idiomi distinti in Sardegna. 61
62 14. SA SCOMUNIGA DE PREDI ANTIOGU ARRETTORI DE MASUDDAS Questo poemetto anonimo in settenarî ebbe diffusione orale per qualche decennio, e fu pubblicato per la prima volta sur un foglio volante nel 1879: secondo il curatore Antonello Satta Sa scomuniga fu composta intorno alla metà del secolo, all epoca dell abolizione delle decime. Prima del 1983 vi era già stata una decina d edizioni, alcune con differenze significative rispetto alle altre, giacché la poesia ebbe vasta diffusione orale, e i criterî di grafia variarono notevolmente, anche a causa delle difficoltà ad esprimere taluni suoni; l edizione del 1942 è la piú famosa, poiché fu curata da Wagner. Colui si occupò di questo componimento, perché è il primo documento letterario di chiara impronta campidanese rustica, precisamente della zona della Marmilla, nella quale si trova il paese del titolo, e la lingua usata non sembra pagare il solito debito dei testi letterarî sardi verso la tradizione cólta. Delle caratteristiche dell area in questione, che nel poemetto sono fedelmente rispecchiate (in particolare le metatesi e le assimilazioni e dissimilazioni vocaliche), si dirà nel prossimo capitolo; qui accenniamo brevemente al lessico, che presenta parecchie voci notevoli. Parole quali archiladori sgarrettatore, traberecu tabernacolo, manastai mescolare (da manestu minestra, piuttosto che da amonestai ammonire incrociato con amesturai), incappa forse, perunu nessuno (aggettivo indefinito, sempre posposto), fadigu miseria, annischizzai infastidire, acuiai condurre all ovile, cada verso (preposizione, < sp. cara), intregai consegnare forniscono preziose testimonianze di lingua popolare e oggi sono, per la maggior parte, cadute in disuso. Si nota poi che i- prostetica è molto diffusa (qui ben piú che nel campidanese rustico dei giorni nostri), il pronome si ha del tutto soppiantato (b)osi alla seconda persona plurale, il verbo essere ha forme particolari (imperfetto VI persona: fuant e fuènt-a), il congiuntivo imperfetto di avere e essere esce in essi e fessi, l infinito passato attivo ha l ausiliare ai (no ai sonau non aver sonato ). Dall area oristanese provengono altri testi poemetti popolari anonimi, piú moderni di Sa scomuniga: da Cabras Sa giorronada e Conchiattu, da Sanluri (Sedhori) Sa predica de su para Usai, mentre un disco ormai raro tramanda Is predicas de Predi Poddighe A. Satta, Sa scomuniga, Cagliari, Della Torre, 1983, pag. 23. Conchiattu = conca de gatu. 62
63 15. GLI SCRITTORI DEL NOVECENTO In questo libro si è cercato di esaminare i maggiori testi scritti, ma non bisogna dmenticare che in tutto il Capo di Sotto esiste un antica tradizione poetica d improvvisazione, e le voci dei cantatori del Novecento sono state registrate. In qualche caso la poesia orale è stata messa per iscritto: per la conoscenza del cagliaritano del primo Novecento, per esempio, la fonte migliore rimane la raccolta di Raffa Garzia: i mille mottetti della tradizione sono preziosissima testimonianza di versificazione popolare. Lo schema metrico di gran lunga prevalente nei mutettus è la quartina di settenarî in rima alternata: Candu fait araxi / s asçutant is paperis; / is mèris de Stampaxi / funt is arrigateris; oppure Dúnnia àrburi ch infrorit / su frutu in terra lassat: / tristu de chini morit / ca su prantu gi passat. Ho usato il sistema di scrittura presentato nell introduzione, servendosi Garzia di una grafia fonetica illeggibile per i profani: la meticolosità della sua opera gli vale un posto di rilievo fra i linguisti sardi del primo Novecento. Fra i meriti del Garzia, si ha che, dopo la Vita di San Potito, finalmente in un testo scritto è indicato il timbro di e/o: possiamo dunque sapere che, per esempio, ai suoi tempi si diceva morit (oggi è piú usato mòrrit); si alternavano benit e bènit, senza il rafforzamento della nasale che adesso è comune, e allora c era solo al participio: bénniu, in concorrenza con beniu proprio come oggi; bessit aveva sempre la vocale chiusa, mentre mi còyu/mi coyu presentava duplice timbro (ma nelle altre persone la o era sempre chiusa). Dall ultimo mottetto citato, si nota anche che dúnnia era preferito a dónnia, pòburu aveva vocale aperta, e cosí via per altre particolarità cagliaritane. Ai primi decenni del Novecento risalgono le commedie di Efisio Vincenzo Melis. Nelle sue opere, segnatamente in Ziu Paddori, il tema principale è l inizio della diffusione dell italiano in un ambiente sardofono; sono testi preziosi soprattutto per lo studio dell italiano regionale di Sardegna, ma offrono anche esempî interessanti sulla sintassi e sul lessico sardi. Di qualche decennio posteriori sono le commedie di Antonio Garau, che hanno avuto una certa successo a partire dagli anni Cinquanta. Cagliari annovera un buon numero di poeti: a cavallo fra i due secoli Ottone Baccaredda ( ), Ignazio Cogotti ( ) e Gaetano Canelles ( ), poi nel Novecento Teresa Mundula Crespellani ( ), Luigino Cocco ( ), Aquilino Cannas ( ), Franca Ferraris Cornaglia (1926), Luciana Muscas Aresu (1929) e altri. I tratti dialettali cagliaritani si fanno sempre piú evidenti con gli autori piú recenti: Cocco, per esempio scrive sempre mera per meda, come effettivamente oggi si pronunzia. I poeti cagliaritani sono importanti per la storia della lingua, giacché badano in primo luogo a mantenere memoria del 63
64 sardo parlato nei quartieri storici cagliaritani, soprattutto quella usato dai ceti elevati, a cui essi in maggioranza appartengono, tanto che danno testimonianza di molte parole notevoli; salvo poche eccezioni, non paiono minimamente interessati alle parlate campidanesi nel loro complesso, anzi autori quali Canelles nei proprî versi compiutamente esprimono il tradizionale disprezzo provato dai patrizî cittadini (ma il discorso vale anche per i popolani castedhayus) nei confronti dei paesani, chiamati mayòlus, bidhunculòsus e cosí via. Il modello ortografico scelto da questi scrittori è solitamente italiano: come scrive la Ferraris Ogni sardo ha imparato e impara a scrivere e a leggere esattamente in lingua italiana. Nelle poesie degli autori suddetti s incontrano taluni vocaboli che mancano nelle principali selezioni lessicografiche: Matteo Porru segnala, fra gli altri, incutuliu sporco, rancinosu rauco, stridulo, afateriai faticare 77. Il prosatore e poeta Francesco Carlini di Vallermosa (sardo Badhi Ermosa) rappresenta meglio di altri l indirizzo arcaizzante degli scrittori campidanesi moderni: vivi sono in loro il fastidio per l italianizzazione della lingua e il timore della sua scomparsa, cosicché eglino cercano di recuperare quei termini, spesso usciti dall uso comune, i quali fanno parte del patrimonio lessicale storico del campidanese. Poiché la maggioranza dei lettori oggi non comprende buona parte degli arcaismi da lui proposti, Carlini aggiunge la traduzione in italiano: siamo già nell ottica della scrittura a fini non soltanto letterarî, ma viepiú di difesa di della lingua. La prosa di Carlini è limpida, essenziale, moderatamente influenzata dalla varietà rustica, e nel complesso definibile campidanese comune. Salvator Angelo Spano, scomparso nel 2004, è autore di commedie e di Sa vida e Gesu Gristu a sa manera nosta, una raccolta di trecentocinquanta sonetti ispirati ai principali episodî del Vangelo. L opera è in puro campidanese rustico, e l assetto metrico dei singoli componimenti si basa sulla fonetica specifica di tale parlata, con le sue nasalizzazioni e cadute di vocali: volta in un altra varietà campidanese, la struttura della Vida e Gesu Gristu non si reggerebbe piú in piedi. Spano, pur talvolta costretto da esigenze metriche ad adottare alcune soluzioni stilistiche lontane dal parlato comune, riesce ad esprimere bene in un testo letterario la lingua viva, ed inserisce nell opera vocaboli desueti, segnalati con un asterisco nel glossario finale. Come Carlini, cosí pure Spano dà la traduzione in lingua italiana. La recente opera Apedala, dimòniu! di Amos Cardia (2004) è espressione letteraria della scuola grammaticale di Antonio Lepori, e si pone soprattutto il fine di contrastare l italianizzazione del lessico sardo 78 ; cotanto sforzo non trova però corrispondenza nelle scelte sintattiche, che, a 77 M. Porru, Cagliari e i suoi poeti in lingua sarda, Edizioni Castello, Cagliari, 1999, pp Quest orientamento, fatto proprio da Cardia, giunse fino a proporre fantasiose sardizzazioni popolari di cultismi: ricordo addirittura un sonétiga da fonétiga. 64
65 cominciare dall uso costante del gerundio narrativo, presentano periodi talvolta complessi invariabilmente modellati sull italiano. 65
66 16. LA SUDDIVISIONE DEL CAMPIDANESE IN VARIETÀ DIATOPICHE Il territorio del Capo di Sotto può essere ripartito in diverse zone. La tradizionale suddivisione del campidanese in varietà diatopiche si basa su isoglosse caratteristiche ed è fondata soprattutto su fatti fonetici, ma essa potrebbe subire variazioni se si tenessero prevalentemente in conto fattori morfosintattici. La ripartizione che presentiamo è dunque quella maggiormente conosciuta, e sostanzialmente ha corrispondenza con le principali regioni storico-geografiche della Sardegna meridionale. Si ha dunque: d1): compresa fra il Sarcidano meridionale e l Ogliastra, è l area dai tratti meno marcati, nel senso che questo campidanese di Nurri e Orroli è probabilmente il piú comprensibile per gli abitanti di tutte le altre zone, e si avvicina al concetto di campidanese comune. Quasi tutta la letteratura campidanese, infatti, per fonetica, morfologia e sintassi rispecchia quest area, che un tempo non si distingueva dalla successiva area d2: è molto rilevante, per esempio, il mantenimento di -L- e -Nintervocalici, benché, come scrive Maurizio Virdis, con la loro pronunzia intensa potrebbero far pensare a una loro reintroduzione seriore che avrebbe sostituito degli esiti diversi 79. Il gruppo latino -LJ- diviene /l:/, mentre -TJ-/-CJ- passa a /ʦ/: fillu, palla, e pratza, fatzu ecc. Nello stesso libro di Virdis d1 e d2 sono unite, ma tra esse non c è contiguità territoriale. d2): è l area meridionale costiera, contraddistinta dalla presenza della capitale Cagliari 80. Parte da Teulada, a occidente, e giunge fino a Villasimius (Bidha Simius) a oriente, e attraverso Castiadas arriva a Burcei. Cagliari, e in particolare le sue variabili diastratiche e diafasiche, ha funto da varietà cólta per tutto il Capo di Sotto: la sua influenza ha toccato tutti i centri urbani di dimensioni non piccole. L area d2 presenta molte analogie con d1, rispetto a cui Cagliari ha introdotto alcune innovazioni: la piú evidente è -d- > -r- intervocalico, per cui meda > mera. Wagner trovava ancora quest ultimo suono diverso da /r/ originaria, e lo definiva un articolazione alveolare di scarsa sonorità 81. Oggi comunque tale distinzione non sussiste, pertanto si può ricostruire il passaggio fonetico /ð/ > /ɾ/ (monovibrante apico-alveolare sonora) > /r/, che ha toccato i comuni vicini a Cagliari (d3) fino a Iglesias. Vi è poi una spiccata tendenza allo iato, anche a partire da consonanti palatali: yerru > ierru (trisillabo), ulleras > ollieras (/u'ʎɛ:ras/ > /u'l:jɛras/ > /ol:i'ɛras/, ma si ha 79 M. Virdis, Fonetica del dialetto sardo campidanese, Cagliari, Della Torre, 1978, pag Il nome Càllari o Càlliari non è usuale in campidanese: la capitale è abitualmente chiamata Castedhu, dal nome del quartiere storico che è stato sede dei governi dell isola e, essendo situato su d un colle, oggi è detto Castedhu e susu Castello di sopra. 81 In M. Virdis, opera citata, pag
67 pure ulleras /u'l:ɛras/). Un altro tratto importante è il rafforzamento delle consonanti sonore iniziali in fonetica sintattica, laddove, nel resto del dominio campidanese, si ha piuttosto il dileguo: su bentu è pronunziato /su'b:eɲtu/, su didu /su'd:iru/ 82 (in luogo di su entu e su idu). Tende alla spirantizzazione, invece, m- in fonetica sintattica: sa mija ha per allofono /saˈμiʤa/. A Cagliari fino a cinquant anni fa circa era diffuso il passaggio di -l- intervocalica o preconsonantica a /ʟ/ (laterale velare): oggi il fenomeno è scomparso, ma ha lasciato traccia nell italiano regionale, dove, per ipercorrettismo, si ode frequentemente, per esempio, un esclamazione come albitro colnuto. La parlata popolare cagliaritana offre molti spunti d interesse: è documentata da diversi decenni la palatalizzazione delle velari davanti alla vocale a, che a sua volta tende a chiudersi verso /ɛ/, spiccatamente in fonetica sintattica: campu > /'kʲæmpu/ e /'cæmpu/, su cani > /su'ʝæni/ (fricativa palatale sonora), sa gatu > /sa'ɟ:ætu/ (con occlusiva palatale sonora); nel cagliaritano volgare la palatalizzazione delle velari ha toccato anche la vocale o: custa cosa è pronunziato / ˌkuʃta:'ʝɔz:a/. In contesti particolari 83, si ode talora palatalizzazione perfino davanti a u: su cucu /su:'ʝuku/. L ultimo esempio palesa poi il frequente passaggio di -st- mediano all allofono /ʃt/, il rafforzamento della sibilante sonora intervocalica a /z:/ e soprattutto l allungamento della vocale pretonica, che conferisce al cagliaritano popolare la sua caratteristica cadenza, passata pari pari nell italiano regionale. In fonetica sintattica si rileva che su lati, pronunziato in campidanese comune col fonema debole, talvolta velarizzato, /su'lati/ o /su'lˠati/, diventa in taluni quartieri di Cagliari /su'l:ati/ o addirittura, nella parlata bassa cagliaritana, /su:'ɭ:at:i/ con cacuminalizzazione. Ancora nel cagliaritano volgare oggi si segnalano l assordimento, se non l aferesi, della i- dell articolo plurale e il passaggio delle vocali postoniche al timbro indistinto /ǝ/: is canis s ode talvolta pronunziato /'ʃcæ:nǝzǝ/. Sul piano morfologico, tutta d2 si segnala per l estensione della desinenza -mu alla I persona dell indicativo imperfetto della coniugazione in -iri: perdèmu e dromèmu al posto del camp. comune perdia e dromia. Tale innovazione, evidentemente dovuta ad analogia con cantamu della I coniugazione, ha investito anche altre aree, e fèmu io ero prevale su fui e fia in tutto il Campidano. Come III pers. dell imperf. indic. di èssi qui inoltre è preferita la forma fiat (/'fiara/ < /'fiaða/) a 82 Non c è mai è bene ricordarlo opposizione fonematica fra tali occlusive sonore, pronunziate con particolare intensità in fonetica sintattica, e le altre occlusive sonore intervocaliche. 83 Che io definirei autoimitativi, nel senso che il parlante, cosciente della sua cadenza, la calca ancora di piú. Simile pronunzia è verificabile anche quando è assunto un tono minaccioso verso un inferiore. 67
68 fut /'fuði/ o /'fuða/. Il gerundio, soprattutto a Cagliari, esce sempre in -endi, mentre il pronome di IV persona può presentarsi come nòsus. Un tratto morfologico proprio della parlata cagliaritana è l estensione di -t alla I persona del congiuntivo, sia presente sia, soprattutto, imperfetto (dèu siat, dèu fessit): lo si trova attestato nei mottetti di Garzia, e pare dovuto a fonetica sintattica piú che ad analogia con le altre desinenze (che escono tutte in consinante, differenziandosi dalla stessa I persona). d3): è l area centrale del Capo di Sotto. Essa parte dalla periferia di Cagliari, ovverosia già da Pirri storica e Monserrato (Pauli), e giunge, a settentrione, fino a Nuragus e Ísili (Sarcidano) attraverso il Gerrei e il Parteolla. Si deve però osservare che tutto il circondario di Cagliari oggi è ripopolato da cagliaritani, i quali, quando ancora padroneggiano il sardo, diffondono la loro d2. Tratto fonetico caratteristico è la rotacizzazione di -L- > /ʀ/ (vibrante uvulare): mèli diventa /'mɛʀi/. Oggi però, soprattutto in fonetica sintattica, l indebolimento articolatorio porta generalmente al dileguo della consonante: sa luxi dà l esito /sa'uʒi/. A Ísili -N- dà occlusiva glottidale sorda /ʔ/ con nasalizzazione della vocale precedente: su pani > /su'ßaʔi/. A Siurgus-Donigala il colpo di glottide è invece esito di -L-: pilu > /'piʔu/. d4): è l area del Sàrrabus orientale, comprendente tre soli paesi: Muravera (Murera), San Vito (Santu Idu) e Villaputzu (Bidha e Putzu). Qui è avvenuto il passaggio di -L- e -N- a /ʔ/, per cui sa luna è pronunziato /sa'ʔuʔa/. -N-, come si vede, lascia una traccia di nasalizzazione; presso le generazioni giovani il colpo di glottide tende al dileguo: /sa'ua/. d5): è l area che abbraccia tutta la pianura del Campidano, da Oristano (Aristanis) a Uta (Uda) ed Assèmini. Tipici di questa parte del dominio campidanese, ben documentati in Sa scomuniga, sono: la caduta di -N- intervocalica con nasalizzazione della vocale precedente (su pani > /su'ßãi/); il passaggio di -L- intervocalico a /ß/ o /w/, per cui sòli diviene /'sɔßi/ o /'sɔwi/; assimilazioni consonantiche di r davanti a t e c: mòrti > mòti, circai > cicai; predilezione per la sillaba aperta, a cui si giunge spesso per mezzo di metatesi: marjani > mraxani (con ispirantizzazione), sèrpi > srèpi, órdini > ódrini; dissimilazioni e assimilazioni vocaliche (bassiri < bessiri, discannotu < disconnotu, dannuntziai < denuntziai 84 tzaramonieri < tzerimonieri, arrasutau < arresurtau 84 Si noti anche il raddoppiamento della nasale intervocalica: la parola citata è un forestierismo. 68
69 risultato ), con ispiccata predilezione per a pretonica (anche in mamentu < momentu); -rintervocalico passa solitamente a /ɾ/. Per esprimere l imperativo negativo di II persona, il congiuntivo impiegato assume di regola l uscita in -st: no timast, no benjast. Ciò è piú raro nelle altre aree campidanesi. d6): è l area del Sulcis-Iglesiente. Qui TJ-/-CJ- > /ʧ/, mentre -N- si conserva. -L- invece ha duplice esito: dileguo in posizione postonica (sali > sai, fèli > fèi), rotacizzazione in posizione pretonica, con passaggio a /ʀ/ (bolai > /bɔ'ʀai/). È molto frequente, inoltre, la caduta di -R- intervocalica: se non cade, essa, alla pari di -T- > /ð/ intervocalica, dà l esito /ɾ/ già visto per il cagliaritano. La vocale o di domu ha timbro chiuso: ciò è un indizio di arcaicità, ma non rimanda a una fase di latinità antica. Il Sulcis possiede un tratto morfologico molto caratteristico: le forme verbali dell imperfetto derivano prevalentemente dal perfetto latino. Si hanno quindi coniugazioni come papài (alternato con papàmu), papàsta, papàda (con /ɾ/), papàstisi (/pa'pastizi/, forma comune di IV e V persona), papànta; bivèi (e bivèmu), bivèsta, bivèda, bivèstisi, bivènta. Altro fatto notevole è l assenza del congiuntivo imperfetto. Iglesias (Igrésias) ha perso molti dei tratti tipici dell area, ma li possedeva sino a tempi recenti, come testimoniano insegne e cartelli stradali con -ç- invece di -tz-: puçu, praça ecc. Oggi Iglesias condivide coi paesini sulcitani il solo mantenimento di -rt-, che nei centri vicini presenta assimilazione (mortu di contro a motu), e l indebolimento di -R- intervocalico. d7): è l area dell Ogliastra (Ollastra). Qui -CE-/-CI- preceduti da vocale danno /ʤe/ e /ʤi/ (pagi e pragèri per paxi e prexèri); -TJ-/-CJ- > /s:/ (prassa per pratza); -LJ- > /ʎ/ (laterale palatale e non dentale) o /ʤ/ o /ʒ/; la -s finale dell articolo subisce sonorizzazione davanti a consonante sonora (ir manus). L esito delle labiovelari è di tipo logudorese: limba, sàmbini. In molte località ogliastrine, inoltre, le vocali paragogiche sono assenti o fortemente assordite, e -s finale non si sonorizza stabilmente. I fenomeni elencati sono proprî dei centri dell Ogliastra centrale: soltanto -ss- per -tz- è presente dappertutto, pure a occidente, comprendendo Sàdali, Seui ed Esterzili. Poiché nell opera di frate Antonio María non si ha traccia di codesto esito consonantico, si può pensare ad influsso ogliastrino recente. Anche qui, come nel Sulcis, la vocale tonica di domu ha timbro chiuso. 69
70 L alta Ogliastra ha caratteri piú logudoresi che campidanesi: ivi, insino ad Àrzana, piuttosto che -ss-, si ha la spirante interdentale sorda /θ/, e nei centri settentrionali si registra pure il mantenimento di -e e -o finali; a Urzulei (Urthulè) il plurale è in -os, senza oscillazioni, mentre a Baunei i plurali in -os e -us s alternano: dopo le vocali chiuse u/i si preferisce -us (us pilus, ur genuglus), altrimenti -os (us ferros, us oglos). Si è vista dagli ultimi esempî la particolarità dell articolo plurale: a Urzulei è os/as, a Baunei us/as. Urzulei è stata toccata altresí dal passaggio -k- > /h/, tipico di Dorgali. Si sono viste dunque sette varietà diatopiche le quali, in linguistica sincronica, si possono chiamare dialetti del campidanese: in definitiva soltanto i paesi del Sulcis e dell Ogliastra centrale possiedono tratti diatopici piuttosto spiccati. Bisogna adesso trattare della zona di confine, quella in cui i tratti tipici campidanesi si diradano e lasciano spazio a fenomeni via via sempre piú proprî del logudorese. d8): è l area nord-occidentale, o arborense meridionale, a settentrione di Oristano, dove sono conservate le consonanti velari: chentu, chircari, lughi e pischi per centu, circai, luxi e pisci. I tre centri di Busachi, Ortueri e Sòrgono mantengono -e e -o finali, cosicché ivi si hanno plurali come pisches e procos. Le labiovelari latine danno b- iniziale e -mb- mediano: bàtoro, chimbanta, ebba cavalla. Nella zona orientale di d8 si ha -LJ- > /ʤ/. La -s finale spesso rimane sorda, finanche quando è seguita da vocale paragogica: cantas è pronunziato a volte /'kaɲtasa/, a volte /'kaɲtaza/. La vocale -a è molto usata come paragogica: pea piede, setzeisia sedetevi. Il tipo arroda/orroda è prevale nettamente sulle forme non prostetiche, mentre in alcuni paesi è attestato l uso di i- prostetica: s ispiga piuttosto che sa spiga. In morfologia spicca la conservazione dell infinito in -ari, e quella, ormai sporadica, dell antico congiuntivo imperfetto in -ari/-iri anziché in -essi (il congiuntivo imperfetto, e di conseguenza il trapassato, sono infatti scomparsi quasi in tutta l area, abitualmente sostituiti nelle loro funzioni dall indicativo imperfetto, che sta soppiantando anche il condizionale). L indicativo imperfetto di I coniugazione esce normalmente in -aia: cantaia. Quest area condivide molte caratteristiche con il sardo medievale mediano della Carta de Logu. d9): è l area della Barbagia meridionale. Qui si conservano le vocali finali -e e -o: sole, domo per sòli e dòmu. Le consonanti velari davanti a e/i subiscono sí palatalizzazione, ma tendono a restare 70
71 occlusive piuttosto che mutarsi in affricate: dal lat. circare si ha /cir'karɛ/. È diffuso il passaggio -LJ- > /ʒ/. Anche qui, come in d8, l esito delle labiovelari è di tipo logudorese: abba, sàmbene ecc. Sul piano morfologico c è grande vicinanza al gruppo d8. Va ricordato infine che le aree d8 e d9 hanno sempre adottato il logudorese come lingua letteraria 85. Nella suddivisione del campidanese in varietà diatopiche non si è dato conto delle particolarità lessicali proprie di ogni area, giacché ogni singolo paese sardo ha qualche vocabolo distintivo rispetto ai centri vicini; una classificazione di questo tipo inoltre oggi non sarebbe sufficientemente fondata, perché i repertorî lessicali per aree non sono abbastanza aggiornati. 85 Maurizio Carrus da San Vero Milis (Santu Eru) nel XVIII secolo, Antioco Casula da Désulo e Giuseppe Mereu da Tonara tra la fine dell Ottocento e i primi del Novecento scrissero tutti in logudorese letterario. 71
72 17. OPERE LESSICOGRAFICHE E GRAMMATICALI Il primo vocabolario campidanese, oltreché primo vocabolario di sardo in assoluto, è quello di don Vincenzo Porru, pubblicato nel L autore nella prefazione auspica che Condotta così la sarda favella a regole ed a sistema... anderà purificandosi anche da quelle imperfezioni di pronunzia, e d inflessioni, che dalle persone di volgo e di contado usansi in Sardegna al par che nelle altre nazioni e provincie : simili presupposti, che evidentemente fanno a pugni con le moderne concezioni glottologiche, consentono di capire bene l ostinata ricerca di legami del sardo con le piú celebri lingue scritte, e lo scarso credito, di cui godono i vocaboli ritenuti rustici. Al Porru mancò un criterio grafico preciso, il che si tradusse in un imitazione della grafia italiana; sbagliò spesso nelle ipotesi etimologiche, e inoltre fece passare per voci sarde alcune parole cólte, tanto da trarre in inganno gli studiosi: buon esempio è nùndinas (dal latino nundĭnae mercato, giorni festivi ), termine che, cosí come è presentato, potrebbe far pensare ad una sua eccezionale sopravvivenza in una lingua romanza. Wagner apprezzò l imponente opera del Porru, che fu fondamentale per la sua conoscenza del campidanese, giacché gran parte dei vocaboli citati nel DES è tratta da Porru; sull opera di Porru si basarono diversi lessicografi posteriori, come lo Spano e il Martelli. Nel 1840 uscí l Ortografia Sarda Nazionale del canonico Spano, che postulava l adozione del logudorese illustre ( illustre in quanto farcito di latinismi e scritto con grafia latineggiante) come vera lingua sarda nazionale. Lo Spano, nativo di Ploaghe, nel suo vocabolario volle inserire voci campidanesi e galluresi: come scrive Antonio Lepori, però, la bilancia delle voci pende così nettamente a vantaggio del logudorese... che anche il vocabolario dello Spano può essere considerato monodialettale 86. Il vocabolarietto di Martelli ebbe ai suoi tempi un certo valore pratico, ma è in realtà inaffidabile sotto ogni aspetto, essendo composto da un toscano poco appena giunto in Sardegna e poco ferrato in linguistica. Ai primi del Novecento cominciarono ad apparire dizionarî dedicati a singole sezioni del lessico: si ha l ottimo Vocabolario domestico di Emilio Atzeni (1912) 87, i glossarî di Efisio Marcialis sulla fauna del Golfo di Cagliari (1913) e della Sardegna tutta, e la molto piú recente Flora pratica sarda illustrata di Amatore Cossu (1968). Tali opere avevano il fine primo di diffondere la conoscenza dell italiano fra i sardi, non erano concepite per migliorare l apprendimento del sardo, ché ancora esso avveniva già naturalmente. 86 A. LEPORI, Dizionario italiano-sardo campidanese, Cagliari, Edizioni Castello, 1988, prefazione, pag. I. 87 Atzeni aveva in animo di scrivere un vocabolario univerasale campidanese-italiano, ma non riuscí a completare nemmeno la lettera a. 72
73 L opera di Wagner, i cui interessi erano soprattutto etimologici e rivolti all epoca della nascita del sardo, segna la nascita dello studio scientifico della lingua; non è necessario soffermarsi a lungo sui meriti del glottologo tedesco, i di cui Dizionario etimologico della lingua sarda e Fonetica storica del sardo sono punti di riferimento imprescindibili per chiunque s accosti ad una qualsiasi varietà di logudorese e campidanese: vedremo invece nei prossimi capitoli a quali rischî si vada incontro se si segue acriticamente il punto di vista di Wagner, e, a maggior ragione, se si travisa il suo pensiero. Negli ultimi anni, con l impellenza di scongiurare la scomparsa della lingua, sono state pubblicate varie raccolte lessicografiche, talune delle quali, come quelle il Casciu e il Melis Onnis, abbracciano tutte le varietà campidanesi, altre, come i dizionarî di Artizzu e Giovanni Mura, sono specifiche di singoli centri. Soprattutto il volume del Mura sulla parlata di Isili è pregevole, perché, oltre a riportare tutti i vocaboli d uso comune, alcuni dei quali non presenti negli altri vocabolarî, segnala i principali modi di dire e locuzioni idiomatiche, che contraddistinguono la lingua viva del centro sarcidanese. Il piú importante fra i vocabolarî moderni è il Ditzionariu di Mario Puddu, che comprende le voci logudoresi e campidanesi. Nel 1988, ad opera di Antonio Lepori, che già si era occupato di sinonimi e contrarî, uscí il primo vocabolario italiano-campidanese. Ciò è indicativo delle nuove condizioni linguistiche della Sardegna: lo scopo ora è quello insegnare il sardo a chi parla prevalentemente in italiano, e far conoscere i vocaboli campidanesi genuini a chi usa un lessico italianizzato. Nell opera infatti non sono inseriti i termini italiani moderni entrati in campidanese, ma solamente le voci che corrispondono a parole campidanesi affatto diverse; per la prima volta si dà spazio a neoformazioni autoctone, ottenute principalmente con l ausilio dei suffissi -mentu e -adura. Sulle orme di Lepori, che usa una grafia distante da quella italiana, un gruppo di giovani cultori del campidanese si dedica alla difesa delle parole tipiche campidanesi e soprattutto alla coniazione di neologismi: coloro lavorano sui siti internet Il grande Dizionario Universale della lingua di Sardegna di Antonino Rubattu traduce tutte le parole italiane in logudorese, nuorese, campidanese, turritano e gallurese, e dà pure i vocaboli corrispondenti nelle principali lingue europee: inevitabilmente, in un opera di dimensioni tanto rilevanti, le sfumature sinonimiche sono sovente trascurate, e spesso occorre cercare i significati precisi in uno specifico vocabolario sardo-italiano. Parimenti la prima grammatica sarda è opera di Vissentu Porru: Saggio di grammatica sul dialetto sardo meridionale (1811). Del 1842 è l opera di don Giovanni Rossi, scritta tutta in campidanese, Elementus de gramatica de su dialettu sardu meridionali: l autore, il quale, come il suo 73
74 predecessore voleva offrire uno strumento per facilitare lo studio della lingua italiana, ancor piú di Porru si limita a dotare di desinenze campidanesi i termini grammaticali italiani; la povertà del lavoro è affatto evidente. A metà dell Ottocento Vittorio Angius, nell ambito del Dizionario degli Stati di Sardegna di Goffredo Casalis, compose una grammatica sarda, nella quale furono presi in esame principalmente i documenti medievali, in particolare la Carta de Logu. L opera, notevole per precisione e meticolosità, è basata su di una ripartizione della Sardegna in Parte Susu e Parte Jossu: a ciò corrispondono le divergenze già medievali fra logudorese e campidanese, che ad Angius apparivano ben chiare. Vi è poi un vuoto di oltre cent anni, e nel 1978 Maurizio Virdis, sulla base della Fonetica del Wagner, pubblica il primo manuale sulla fonetica campidanese. Negli anni Ottanta gli studiosi, consci del pericolo d estinzione delle parlate sarde, cominciano a dedicarsi alla compilazione di opere sulla struttura della lingua. Esce dapprima nel 1984 una notabile Storia linguistica della Sardegna di Eduardo Blasco Ferrer, poi lo stesso linguista catalano a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta pubblica alcune grammatiche sarde. Vi sono inoltre alcune brevi opere di Francesco Corda, esperto di gallurese: ognuna di esse è dedicata a una specifica parlata sarda. La prima grammatica moderna solo campidanese, scritta in campidanese con versione italiana, è opera di Antonio Lepori (2001): essa, che nasce dichiaratamente con l intento di insegnare un buon sardo ai sardi, è molto valida, ed ottima nel tentativo di creare un lessico grammaticale, ma troppo sintetica sotto certi aspetti, quali la fonetica e la sintassi. A proposito di sintassi, è stata tradotta in italiano pochi anni or sono l opera dell inglese Allen Sardinian Syntax, che prende in considerazione le varietà nuoresi ritenute maggiormente conservative. Gli autori odierni propendono a dedicare grammatiche specifiche alle diverse parlate sarde: bonissimo, fra gli altri, è il lavoro monografico di Piras sulla varietà sulcitana. 74
75 18. IL CAMPIDANESE NEL VENTUNESIMO SECOLO Oggi il campidanese appare abbastanza unitario, e il suo insegnamento, cosí come il suo uso in documenti ufficiali, non pone difficoltà di rilievo da nessun punto di vista. Ciò sarebbe un valido mezzo per difenderlo, per poi propagarlo eziandio, ma non basta a garantirne la sopravvivenza: la sua tutela comincia dalle mura domestiche. Come ogni sardo sa, e come qualsiasi semplice indagine sociologica può dimostrare, se oggi molti Sardi non solo non parlano nella loro lingua, ma, almeno nei centri urbani, nemmeno la capiscono, la colpa è soprattutto degli stessi Sardi: per molti anni, diciamo per tutto il secolo XX, si è ritenuto che il parlare italiano rappresentasse una via d elevazione sociale. Peralmeno due generazioni le madri per prime, ma anche i padri, e ugualmente i nonni, in Sardegna hanno volutamente e scientificamente usato, coi loro figli e nipoti, la lingua imparata a scuola, non la propria lingua nativa: di conseguenza il sardo non è piú ben conosciuto, e, poiché l italiano parlato in famiglie dapprima solo sardofone era pieno d errori, cioè era un italiano regionale foneticamente e sintatticamente modellato sul sardo, molti abitanti dell isola oggi adoperano soltanto un italiano grammaticalmente scorretto e lessicalmente poverissimo. Il campidanese, allo stesso modo del logudorese, sul piano della fonetica, della morfologia e della sintassi resiste ancora bene, forse in virtú della sua grande lontananza dall italiano, ma sul piano lessicale subisce un influenza forte da parte della lingua ufficiale: soltanto gli studiosi del sardo oggi sono in grado di leggere facilmente e capire le opere degli scrittori, compresi i contemporanei. Ogni educazione esclusivamente italofona impartita ad un bambino è una coltellata al cuore degli idiomi locali. Questo fenomeno si riscontra in molti luoghi: in Europa tutte le lingue di minoranza, ovverosia tutti gli idiomi non usati a livello ufficiale (orale ma soprattutto scritto) negli stati sovrani, sono oggi, quando non in via d estinzione, comunque in fase di forte regresso, ad eccezione del catalano, che però vive in una condizione di bilinguismo, e non piú di diglossia, con lo spagnolo letterario d ascendenza castigliana. Vi sono d altronde lingue ufficiali le quali ricoprono funzione piú simbolica che pratica: l irlandese, per esempio, rappresenta soprattutto l unità nazionale del paese e i suoi valori culturali, ma nell uso è stato quasi completamente soppiantato dall inglese (solo l 1% della popolazione parla sempre in irlandese, e meno del 5% lo usa abitualmente). Il primo ostacolo che si deve superare, ai fini del recupero e della diffusione di una lingua di minoranza, è dunque l ostilità di parte della popolazione stessa; poiché molte persone non sanno piú parlare le lingue locali e devono quindi impararle, diviene poi indispensabile l adozione di un ortografia e, affinché l idioma in questione possa essere studiato per mezzo di grammatiche e libri appositi, la scelta di 75
76 una varietà, allorché la lingua non sia sufficientemente unitaria 88 : d altra parte è necessario verificare se le varianti prescelte non siano troppo differenti tra loro, perché in questo caso la lingua adottata non sarebbe rappresentativa di tutte le varietà diatopiche. Nel prossimo capitolo tratteremo dei tentativi di individuazione di una lingua sarda unificata; qui cominciamo a vedere le proposte di grafia per il solo campidanese. Esistono due orientamenti contrapposti: uno definibile italianista, l altro che pretende di essere indipendente dall ortografia italiana. La corrente italianista fa sue le parole della Ferraris, già ricordate, e sostiene che la gente non capirebbe una grafia diversa; gli scrittori quasi sempre hanno scelto questa strada (cosí come nel periodo spagnolo la grafia era di tipo castigliano). Per i fonemi inesistenti in italiano, nel caso di /ʒ/ gli italianisti si servono o di x, talvolta xi davanti a a, o, u secondo il parallelo sci sordo (x/xi è la soluzione piú frequente), oppure dell italiano sci, che diventa perciò ambivalente; nel caso di /ɖ/, si servono di d(d), tanto che il pronome clitico può trovarsi scritto come du o ddu. Le consonanti intervocaliche, escluse l/n/r/s, sono scritte o scempie o doppie: se la parola corrispondente esiste in italiano, la scelta è facile, ma in caso contrario manca una norma, giacché in campidanese non sussiste una distinzione del tipo fato/fatto ch esprime opposizione fonematica; si noti poi che in campidanese l opposizione fra s e ss in posizione mediana è tra un fonema sonoro ed uno sordo intenso (casu e cassu), mentre in italiano può in tal modo esprimersi anche contrapposizione fra sibilante sorda debole e forte: casa /ˈka:sa/ e cassa /ˈkas:a/ 89, róso (participio di ródere) e rósso eccetera. Con l adozione del modello italianista tutte le incoerenze grafiche dell italiano sono trasportate in sardo: mancata distinzione tra z sorda e z sonora, uso di qu-, h- iniziale nel verbo avere (ma soltanto in alcune forme, e non sempre), presenza di i grafica e non vocalica in cia, gia, scia 90. A causa di questi difetti, alcuni grammatici sardi hanno suggerito sistemi di scrittura non basati su quello italiano, da cui si discostano laddove le necessità d esprimere i suoni del sardo lo richiedano. La proposta ortografica che ha ottenuto maggiore diffusione è stata avanzata da Antonio Lepori, e le sue caratteristiche sono le seguenti: consonanti scritte sempre scempie, ad eccezione di l/r/n (che nella pronunzia sono deboli o intense), d (che quando è doppia è quasi sempre cacuminale), s (che 88 È evidente che una lingua non può essere perfettamente unitaria, se non altro perché vi sono comunque differenze tra i suoi parlanti. 89 Davvero incredibile è che addirittura grammatiche, vocabolarî e manuali d italiano per istranieri indichino casa come esempio di fricativa dentale sonora intervocalica, associandolo tale parola a rosa: ciò è una delle conseguenze piú clamorose del mancato insegnamento del sistema fonologico dell italiano a scuola, la qual cosa dipende a sua volta dall inesistenza di un luogo in cui si pronunzî correttamente detta lingua. 90 Quest ultimo mi pare il difetto maggiore: quante volte si sente che in aiuole sono presenti tutte le cinque vocali italiane? Non si insegna che /aˈjwɔ:le/ è un trisillabo con trittongo, e che l italiano ha sette vocali e non cinque. 76
77 quando è doppia è sorda intensa), senza distinzione fra sonore occlusive e sonore fricative; d cacuminale iniziale scritta scempia; tz per l affricata dentale sorda; simbolo ku in àkua acqua ; k davanti a e, i, ma gh nella medesima posizione; ç davanti a a/o/u per l affricata /ʧ/; j davanti a a/o/u per l affricata /ʤ/; sç davanti a a/o/u per la fricativa /ʃ/; x per la fricativa /ʒ/; lly e nny per le palatali mediane; y semiconsonante, ma solo ad inizio di dittongo (yayu); mancata scrittura delle vocali paragogiche, escluse quelle diverse dalle vocali immediatamente precedenti (sesi, esti, anti); mancata indicazione dell apertura di e/o; accento segnato sulle voci tronche e sdrucciole. Mario Puddu adopera una grafia vicina a quella italiana, ma scrive tz per l affricata dentale sorda e dh per la cacuminale, anche dopo n (candhu). Il tipo di scrittura che ho impiegato in questo libro s avvicina a quello di Lepori, ma con alcune differenze: 1) scrittura scempia delle intervocaliche occlusive e fricative sorde, ma doppia per le occlusive sonore, poiché le lettere scempie stanno a indicare le sonore fricative: acatai, açapai, acabbai, abrili, abbrubudhai gorgogliare, atafai immergere, aggafai afferrare. È evidente il mancato parallelismo tra sorde e sonore, ma, stante la necessità di distinguere i fonemi occlusivi da quelli fricativi, una possibilità sarebbe quella d adottare per i fonemi fricativi le lettere greche β/γ/δ, sí da potere scrivere sempre scempie anche le consonanti sonore non fricative. L uso di simboli non presenti nell alfabeto latino comporta però difficoltà, soprattutto a livello di tastiere, e tale ipotesi non pare per ora concretabile. 2) ch parallelo a gh davanti a e, i: in campidanese è regolare la lenizione della velare sorda iniziale, e k mal si presta a indicare una consonante lenita, dato che nelle lingue dove è usata, ad eccezione dello svedese, indica sempre un suono duro (gutturale occlusivo). 3) dh per la cacuminale, ma non dopo n: c è bisogno d indicare il suono esatto di verbi come addanniai e adderetzai, che hanno dentale intervocalica, mentre dopo n il gruppo nd è sempre cerebrale (ma sempre dentale per coloro che non riescono a pronunziare piú il suono antico), e una h distintiva è dunque inutile non essendovi casi d ambiguità tra ndh e nd. Abbiamo visto che il digramma dh fu adoperato già nella Vida de Santu Potitu, dunque non è un innovazione. 4) lli- (li- iniziale) e nni- (ni- iniziale) per i suoni originariamente palatali, rispettivamente laterale e nasale, in parole d origine italiana e spagnola, come caramèllia e bànnia: essi in campidanese essi sono instabili. Distinguiamo tra posizione pretonica e postonica. In posizione pretonica, di solito divengono dentali intensi con appendice approssimante, la quale crea dittongo con la vocale seguente; poi, soprattutto a Cagliari, i dittonghi cosí sviluppatisi hanno la tendenza a trasformarsi in 77
78 iati (atropelliai è pronunziato come esasillabo). Si ha dunque una forma iniziale quale atropelhai /atrɔpɛˈʎai/, che tende a divenire atropelliai con laterale dentale e approssimante /atrɔpɛ ˈl:jai/ > /atropeˈl:jai/ e perfino a produrre iato /atropel:iˈai/. Medesima situazione si ha per addanhai > addanniai; quando il fenomeno suddetto si presenti a inizio di parola, si scriverà meglio liàuna e non lhàuna, liaga e non lhaga, nióculu e non nhóculu. I suoni palatali si conservano meglio in posizione postonica, cosicché si hanno pronunzie effettive quali /karaˈmɛʎa/ e /ˈbaɲa/ forse piú frequenti di /karaˈmɛl:ja/ e /ˈban:ja/ senza che si giunga fino allo iato, tuttavia già quel che si verifica consente di parlare di allofoni e non di fonemi indipendenti, in virtú dell assenza di coppie minime 91 ; oltre a ciò, va detto che, se si adottasse il digramma specifico per i suoni palatali, nella coniugazione verbale si avrebbe un alternanza inopportuna tra atropelhaus e atropèlliant, addanhaus e addànniant eccetera. 5) indicazione dell apertura delle vocali e/o, laddove sussista eccezione al principio metafonetico, il quale richiede chiuse tali vocali quando siano seguite dalle vocali chiuse i/u, come nel caso di lèpuri e leperédhu (dunque scriviamo mullèri e mullèris, trasseri e trasseris, ómini e óminis, ma corpus e còrpus, beni vieni! e bèni bene, nasçu < nàscidu, ceréxa < cerésia ciliegia ). A parte il fatto che il campidanese possiede un sistema eptavocalico, la pronunzia errata di e/o da parte delle giovani generazioni è uno degli influssi piú forti dell italiano regionale in campo fonetico 92 ; ad ogni modo, è sicuramente da evitare che il fatto che si indichino con l accento grave vocali e/o chiuse, come prevede invece la grafia del Lepori. 6) Le vocali paragogiche non sono mai scritte (dunque ant e non *anti, cras e non *crasi); 7) I pronomi atoni sono scritti separati quando sono proclitici, uniti quando sono enclitici, senza l uso del trattino: indi dhu bògu, bogamindedhu. Il miglior sistema ortografico esprimerebbe ogni fonema con un solo specifico grafema, ma varî ostacoli impediscono ciò: tanto la storia della grafia delle lingue neolatine (con esiti diversi, per esempio, tra CA e CI latini, con quel che ne consegue), quanto gli strumenti di scrittura odierni, quali la configurazione delle tastiere, basate sulla grafie delle lingue ufficiali. Come ho già detto si potrebbero adoperare i simboli greci per le fricative intervocaliche β/γ/δ (che potrebbero comparire tutte in una sola parola quale *saβoγaδa), ma capisco che non oggidí non è possibile 93 ; a me 91 Le coppie minime sono quelle due parole che si distinguono per la presenza di un fonema, il quale assume perciò un ruolo distintivo nel sistema fonologico di una certa lingua: in campidanese, per esempio, beni e bèni si distinguono per la vocale e chiusa o aperta. 92 Può essere definito influsso di ritorno, nel senso che i giovani essenzialmente italofoni pronunziano il campidanese con influsso italiano (ad esempio *déu séu), un italiano la cui fonetica a sua volta è influenzata dal sardo (*motòre e *motório, per metafonia applicata all italiano, invece dei corretti motóre e motòrio). 93 Inoltre la lettera beta, quando è scritta maiuscola, è uguale a B latina, dunque si confonderebbero i relativi fonemi. 78
79 piacerebbe valermi d un solo grafema, come ş, per la fricativa prepalatale sorda, e si potrebbero fare altri esempî ancora; se non si possono eliminare tutti i digrammi, almeno ai trigrammi si può invece rinunziare facilmente. Il fine maggiore di un buon modello di scrittura, ad ogni modo, è di evitare che ci sia qualche combinazione di lettere la quale possa leggersi in piú d una maniera: ossia l eliminazione d ogni ambiguità. Una proposta recente è rappresentata dalle Arrègulas, presentate nel Marzo 2009: la Provincia di Cagliari affidò ad un gruppo di studiosi 94 il compito di redigere le norme per l uso del campidanese scritto. La grafia adottata si distingue da quella italiana soltanto per i simboli tz e x, e addirittura si adopera l inutile trigramma sci- per rendere /ʃ/ davanti a a/o/u. La scelta di scrivere con grafia italiana si basa sull idea che sia piú facile, soprattutto per i bambini, esprimere gli stessi suoni con le stesse lettere: orbene, a parte il fatto che i fonemi dell italiano non sono gli stessi del campidanese, tale opzione è smentita dalla realtà, essendo insegnate alle scuole elementari, se non già all asilo, lingue quali l inglese e il francese, scritte in un altra varietà di alfabeto latino. Nessuno mi risulta propone di scrivere inizialmente *giob l inglese job o *giardin il francese jardin per affinità con l ortografia italiana: come si può pensare allora che la grafia jardinu, attestata già dal Seicento, complichi la vita dei ragazzi? Il campidanese ha una sua struttura e una sua storia, indipendenti dall italiano, lingua con la quale, nel corso della storia, ha avuto un contatto meno forte che con il catalano e il castigliano: non ha nessun bisogno d essere scritto come l italiano, e, mancando una grafia consolidata, può semmai prendere il meglio dai diversi alfabeti ch esistono. Oltre ch esser segno di subalternità culturale, l ortografia italianista costituisce per giunta una scelta antieconomica: per quale ragione scrivere acciappai, quando bastano le sei sole battute di açapai? Le proposte fatte in merito all ortografia riguardano il solo campidanese comune, ossia la lingua dei documenti scritti: certo se si volesse esprimere graficamente ogni passaggio fonetico presente nelle diverse varietà campidanesi, il compito diverrebbe piú arduo; siffatta opera comunque può interessare i poeti vernacolari, ed ognuno, almeno nel proprio esercizio letterario, in fin dei conti è libero di regolarsi come meglio crede. I testi letterarî infatti presentano un uniformità che la lingua parlata difficilmente potrebbe offrire, giacché appunto molti esiti consonantici creerebbero notevoli problemi di scrittura. 94 Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda. Il comitato scientifico era composto da Amos Cardia, Stefano Cherchi, Nicola Dessí, Massimo Madrigale, Michele Madrigale, Francesco Maxia, Ivo Murgia, Pietro Perra, Oreste Pili, Antonio Pistis, Antonella Rodi, Paola Sanna, Marco Sitzia; si avvalse della consulenza di Edoardo Blasco Ferrer e Paolo Zedda. 79
80 La morfologia è ben delineata; si ha talvolta molteplicità di forme, come timèmu/timia, ma ciò si constata in qualsiasi lingua. La sintassi è omogenea. Quanto al lessico, va rilevata la sua notevolissima ricchezza, dovuta al contatto con piú idiomi, alcuni dei quali dotati di gran prestigio letterario. Sul piano diacronico notiamo: i sostrati (ben piú d uno!) preromani hanno lasciato tracce nonché nella toponomastica, ma nel lessico comune: mata arbusto, albero e pibitziri cavalletta sono fra i numerosi fitonimi e zoonimi presenti, e voci d origine ignota si hanno anche in altri settori del lessico; dopo la lunga epoca romana, i Vandali non lasciarono tracce, i Greci dell Impero Romano d Oriente ne lasciarono poche, mentre un influenza araba significativa non è dimostrabile; nel Basso Medioevo i rapporti con la Penisola Italica divennero costanti, e nel lessico, tanto sardo quanto particolarmente campidanese, entrarono parecchî vocaboli toscani e alcuni liguri; l epoca iberica (XIV secolo) cominciò con una fortissima influenza catalana (mentre rarissime sono le parole attribuibili specificamente all aragonese), la quale poi dal XVII secolo lasciò il posto al castigliano, ormai spagnolo letterario; dopo il passaggio della Sardegna ai Savoia, s iniziò il periodo italiano che dura tutt ora, e nei primi due secoli entrarono anche parole piemontesi. Di conseguenza si presentano spesso sinonimi dovuti all esistenza di superstrati diversi, e tipico è il caso in cui un iberismo tende ad essere sostituito da un ialianismo: acontèssi (sp. acontecer) oggi cede il posto a sutzèdi, gastai (sp. gastar) è rimpiazzato da spèndi, aurrai (sp. ahorrar) è caduto in disuso per la presenza di (ar)risparmiai. Lo scrittore, il giurista e l economista i quali, istruiti in istoria della lingua, vogliano preservarne il lessico dovranno favorire, per quanto possibile, l impiego delle voci piú antiche, ma senza trascurare tutte le varianti sinonimiche di una lingua lessicalmente ricchissima qual è il campidanese. Insomma il problema della codificazione, relativamente al campidanese, riguarda l ortografia, poiché il sistema linguistico, come abbiamo visto attraverso le opere letterarie, si è già codificato da sé: è una lingua già bene strutturata e idonea a qualsisia impiego scritto. 80
81 19. IPOTESI DI UNIFICAZIONE. NAZIONALISMO ED ETNOFILASSI Nei capitoli precedenti si sono visti fenomeni principali della storia del campidanese, e si sono incontrati i maggiori scrittori e le opere letterarie piú notevoli. La letteratura in lingua logudorese è piú ricca di autori e testi, e maggiormente antica di quella campidanese: il poema di Antonio Cano dedicato ai santi Gavino, Proto e Gianuario fu composto a metà del Quattrocento, in un epoca anteriore alla redazione di alcuni condaghi, come il Cabrevadu che è del XVI secolo; le opere letterarie in gallurese e turritano sono piú recenti. Da quando sono attestate le quattro favelle summenzionate, nessuna di esse si è imposta mai in tutta l isola. Specialmente dopo l approvazione della Legge Regionale 26/97 e di quella Statale 482/99, si sono susseguite varie proposte di lingua scritta pansarda, per dare alla Sardegna un idioma ufficiale unitario. Va però rimarcato subito che il gallurese ed il turritano, essendo molto diversi dal logudorese e dal campidanese oltre che parlati in aree piú ristrette, non possono in alcun modo rientrare in tale progetto: la lingua unica dovrebbe rappresentare tutto il resto dell isola, anche perché si sostiene il gallurese 95 e il turritano 96 per influsso esterno si sarebbero formati nell isola dopo la diffusione del sardo medievale 97 : gli antichi giudicati di Sassari e Gallura adoperavano la varietà settentrionale del sardo medievale, ossia il protologudorese. Innanzitutto va premesso che, fino a quando si predilige l una o l altra grafia, si affronta il problema del come scrivere una determinata lingua (è il caso già ricordato di giardinu/jardinu); se si sceglie fra due forme quali timèmu o timia si rimane nel campo della morfologia della stessa lingua, e ugualmente, ma nel campo lessicale, se si opta per uno fra betiri e portai; se però si piglia uno fra tipi molto diversi, com è il caso di log. fàghere e camp. fai, log. cantaret e camp. cantessit, allora la questione diventa che cosa scrivere. Si deve quindi ribadire quali siano le differenze principali tra logudorese e campidanese: il sistema fonologico logudorese conta ventisei fonemi, il campidanese ne ha trentadue 98 ; 95 Il gallurese, sur un sostrato logudorese, potrebbe essersi formato a seguito di un immigrazione dalla Corsica che, almeno parzialmente, avrebbe ripopolato la Gallura, forse alla fine del XIV secolo, ma non è da escludere che essa si sia protratta per un tempo piú lungo. Il gallurese è sostanzialmente intelligibile col còrso meridionale, e si può inserirlo in un gruppo romanzo còrso-gallurese. 96 Il turritano nacque forse come lingua franca ed appare oggi una sorta di creolo, giacché sul sostrato logudorese conversero toscano, ligure e còrso: quantunque quest ultimo elemento forse prevalga sul toscano e ancor piú sul ligure, è problematica la collocazione di tale idioma nel gruppo còrso-gallurese. I suoi esiti vocalici corrispondono a quelli del còrso settentrionale. 97 Il gallurese e il turritano non condividono molti dei caratteri peculiari del sardo medievale: articolo derivato dal lat. ipsu(m), plurale in -s, III e VI persona verbale in -t e -nt, formazione perifrastica di indicativo futuro e condizionale, struttura del sistema vocalico. 98 In logudorese mancano due vocali e le quattro consonanti prepalatali. 81
82 il logudorese nei polisillabi, sia flessi sia invariabili, mantiene -e/-o finali, il campidanese le muta in -i/-u, con la conseguenza che il logudorese possiede un sistema ancora pentavocalico, mentre quello campidanese è eptavocalico 99. Siffatta mutazione fonetica tocca tanto sostantivi, aggettivi e pronomi, quanto avverbî, preposizioni e congiunzioni (camp. ndi, nci, imòi, candu, innòi/innòxi, sèmpiri ecc., log. nde, nche, imoe, cando, inoghe, semper), ed ha notabili conseguenze nella morfologia, poiché in campidanese i sostantivi, aggettivi e pronomi interessati al fenomeno sopraccitato formano il plurale in -is/-us, di contro al log. -es/-os; cosí il congiuntivo presente di -are in camp. diviene canti, cantis, cantit, canteus, canteis, cantint, mentre il log. ha cante, cantes, cantet, cantemus, cantedes, canten, a causa della mutazione fonetica in sillaba finale; il campidanese gradisce le parole ossitone ancor meno di quanto le tolleri il logudorese, cosicché si serve di vocali paragogiche: log. cafè e camp. cafèi, log. però e camp. peròu, log. ja/ya e camp. jai già. Anche negli ipocoristici da troncamento, come si può osservare anche nell italiano regionale, vige la medesima tendenza: log. Manuè < Manuele/Manuela, camp. Manu < Manuèli/Manuela; in log. sono conservate le occlusive velari davanti alle vocali palatali e/i, cosicché si ha chentu e ghelu, deghe rispetto al camp. centu, gelu, dèxi; i gruppî labiovelari si conservano in camp., perdono l elemento velare in log.: camp. cuatru, àcua, sànguni/sànguini, rispetto a log. bàtoro, abba, sàmbene 100 ; da -LJ- latino si hanno gli esiti principali /z/ log., /l:/ camp. (log. fizu e camp. fillu); da -TJ-/- CJ- si hanno gli esiti principali /t/ log., /ʦ/ camp. (log. poto, camp. pòtzu); i gruppi -PL- e -FL- in camp. danno sempre -pr- e -fr- (prus, frama), nel log. letterario /pj/ e /fj/ (pius, fiama); /ʧ/ e /ʤ/ dei prestiti in log. si trasformano nelle corrispondenti affricate dentali, in camp. di norma non mutano: log. tritza e zente, camp. triça e gènti; l articolo determinativo plurale è sos/sas in log., is in camp. 101 ; i pronomi personali log. lu, la, li, bi (III pers.), mie, nois, bois, rispetto al camp. dhu, dha, dhi, si, mèi, nòsu, bòsu; 99 In logudorese il timbro vocalico di e,o è esclusivamente dalla metafonesi, e non si ha mai opposizione fonologica tra è/é, e ò/ó; in campidanese, dove la metafonesi parimenti agisce, esistono oggi sette fonemi vocalici indipendenti, come provano opposizioni del tipo sèu cattedrale / séu grasso, òru oro / óru bordo. In campidanese proprio il timbro vocalico distingue talvolta il plurale dal singolare: tempus / tèmpus, corpus / còrpus. 100 Secondo Wagner e altri il campidanese avrebbe ripristinato le labiovelari per influsso italiano, ma ciò non è stato provato. 101 Nei documenti medievali della Sardegna meridionale si trova l articolo sus/sas, ma a quei tempi doveva essere ancora diffusa la forma non aferetica issus/issas, come dimostra l evoluzione in is. 82
83 la conservazione della desinenza -nt di VI pers. in camp. mentre in log. si ha -n; la conservazione della forma originaria di congiuntivo imperfetto in log., con forme quali cantàrepo, cantares ecc., mentre il moderno camp. cantessi, cantessis deriva dal catalano ed è stato anche influenzato dall italiano (in catalano e italiano tale tempo è tratto dal congiuntivo piucchepperfetto latino); l infinito esce in -are, -ere (con frequente apocope in -er), -ire in log., mentre in campidanese l ultima sillaba si può troncare: -ai, -i (insieme con '-iri), -iri (prevalente su -í); il gerundio logudorese è in -ande, -ende, -inde, mentre in campidanese le tre coniugazioni sono unficate in -èndi/-èndu (talvolta con ampliamento: -èndiri/-ènduru) i participî passati hanno -adu/-idu in logudorese 102, mentre in camp. sono passati a -au/-iu. Ciò limitatamente ai piani fonologico e morfologico. A proposito della sintassi le differenze non sono cospicue. Una tra queste è l uso degli ausiliari nelle forme verbali composte: il logudorese impiega frequentemente dèpere per àere, mentre la maggior parte dei dialetti campidanesi oggi si serve dell infinito èssi in luogo di ai davanti a participio. Si ha dunque log. depo andare e camp. apu a andai > ap andai andrò ; log. at aer fatu e camp. at èssi fatu avrà fatto ; log. lu dio aer fatu e camp. dhu èmu èssi fatu > dh em èssi fatu l avrei fatto. Codesto impiego di èssi al posto di ai nell infinito passato, nel futuro anteriore e nel condizionale passato è particolarmente diffuso nel campidanese meridionale (Pintor Sirigu già testimonia l innovazione, mentre Sa scomuniga ancora cinquant anni dopo usa ai). Mi pare però che gli studî di sintassi logudorese e campidanese comparata non siano ancora molto sviluppati, e qualche altra differenza si possa trovare: riguardo alla subordinazione, per esempio, ho l impressione che il campidanese per i costrutti impliciti mostri una predilezione la quale in logudorese sia meno spiccata. Riguardo al lessico, si può rilevare quanto segue: l influsso toscano e ligure nel Basso Medioevo fu maggiore nel Nord della Sardegna, e provocò addirittura la nascita del turritano, mentre l ispanizzazione del Mezzogiorno fu invece piú rapida e piú profonda. Per tali ragioni si hanno esempî di un italianismo in logudorese e un iberismo in campidanese per indicare lo stesso concetto: log. otzales (dal tosc. occhiali) e camp. ullieras (< cat. ulleras, oggi ulleres), log. biazu (dal tosc. viaggio) e camp. biaxi (sp. viaje); 102 Fuorché nel Supramonte, dove -au ha ormai soppiantato -adu. Anche in campidanese l innovazione ebbe inizio cólla prima coniugazione. 83
84 nel periodo iberico ( ) l influsso catalano fu molto notevole in campidanese, mentre in logudorese prevalsero nettamente i castiglianismi: log. feu (sp. feo) e camp. leju (cat. lleig) brutto, log. gosos (sp. gozo) e camp. gòçus (dal cat. goig) letteralmente godimenti, per indicare gli inni di lode ai santi. Anche per i tempi piú antichi si possono rilevare alcune divergenze: in epoca preromana i Fenici di Cartagine diffusero la loro lingua cananea nel Sud-Ovest, e alcuni resti si sono conservati in campidanese: mitza sorgente rispetto al log. bena (dal lat. vena), tzípiri rosmarino di contro al log. romasinu; la romanizzazione del centro dell isola fu rapida e profonda 103, e fu condotta con una presenza militare cospicua già nel II secolo avanti Cristo: come dimostra il fatto che nel territorio del comune di altitudine piú elevata di tutta la Sardegna, ossia Fonni, i Romani presto costruirono la stazione di cambio di cavalli chiamata Sorabile, questa prima presenza romana si radicò, tanto da non subire le influenze dei successivi strati di latinità, che invece raggiunsero il Sud. Sul piano linguistico non solo è evidente l opposizione tra logudorese e campidanese negli esiti delle velari, ma si nota anche, in alcuni punti del Centro-Nord come Bitti, la conservazione di forme quali fúghere fuggire, testimonianza di una latinità molto antica (lat. fugere), che in gran parte dell isola furono poi soppiantate dalle forme latine piú tarde (fugire nel caso specifico); il periodo bizantino lasciò tracce molto piú consistenti nel Sud dell isola, dove il Giudicato di Cagliari fino al XIII secolo, negli atti dei sovrani, usò bolle con leggenda greca, e alcune carte in volgare furono composte in alfabeto greco: è probabile che vi sia stata un influenza greca maggiore proprio nel territorio di quel regno, ma le voci bizantine superstiti nella lingua moderna sono cosí poche che l ipotesi non può essere provata. Se si vogliono stabilire i confini dei due idiomi 104, tracciata una linea che secondo longitudine tagli precisamente in due l isola, si ottiene un approssimativo limite linguistico-geografico fra logudorese e campidanese, ma in realtà si verifica subito che i paesi logudoresi meridionali e quelli campidanesi settentrionali presentano diverse affinità. Se si cerca perciò d individuare criterî precisi di divisione, si possono indicare quattro tratti distintivi principali, che coincidono con la presenza di tutte le isoglosse maggiormente notevoli: il rafforzamento della vibrante e conseguente prostesi vocalica; la palatalizzazione delle velari davanti a vocale palatale; l articolo plurale in is per tutti i 103 Ciò spiega perché fu tanto accanita la resistenza dei Sardi alla conquista romana: se i nuovi venuti si fossero limitati a sfruttare le coste e le pianure maggiori, avrebbero potuto stabilire con gli indigeni gli stessi rapporti di buon vicinato che avevano contraddistinto il periodo punico. 104 Si veda per esempio E. Blasco Ferrer, Ello Ellus. Grammatica della lingua sarda, Nuoro, Poliedro, 1994, pag
85 due generi 105 ; la terminazione in -i/-u per le parti invariabili e variabili del discorso, le quali ultime formano dunque il plurale rispettivamente in -is e -us. Insomma è schiettamente campidanese ogni parlata che soddisfaccia a queste condizioni: arr- iniziale, centu e genugu, articolo plurale is, uscita in -i/-u di sostantivi, aggettivi, pronomi, congiunzioni ed avverbî. Il primo fra i recenti progetti di unificazione linguistica fu varato nel 2001, per iniziativa dell assessore Onida: la cosiddetta LSU, la Limba Sarda Unificada, che di unificato aveva soltanto il nome, nome invero massimamente ingannevole, giacché non si ebbe nemmeno il coraggio di ammettere che era stato adottato un tipo di logudorese 106. Non il logudorese letterario, ma una varietà vicina a quella di Macomer (Macumere) epperò artificiale, poiché si immettevano alcuni elementi ad essa estranei, come la desinenza campidanese -nt. L aspetto piú inquietante della vicenda fu il criterio di scelta: nell opuscolo pubblicato dalla Regione Sardegna si legge, a pagina 5, che la norma deliberata dalla Commissione... è rappresentativa di quelle varietà più vicine alle origini storico-evolutive della lingua sarda, meno esposte ad interferenze esogene... e fuori dalla Sardegna maggiormente insegnate e rappresentate nelle sedi universitarie e nel mondo scientifico. Come se la presunta maggiore vicinanza al latino fosse un titolo di merito! Come se i Sardi in materia linguistica dovessero agire solo in base a quello che di loro pensano gli altri! Particolarmente interessante, per esempio, è il fatto che, nel capitolo riguardante la fonetica, la LSU prenda in esame tutti gli esiti delle consonanti latine, e conceda uno spazio esiguo al trattamento dei forestierismi, ossia a tutte le decine di migliaia di vocaboli entrati nella lingua dopo la formazione dell idioma romanzo. Si noti questo caso: /ʃ/ non è ritenuto fonema indipendente in logudorese perché può volgersi in /sʲj/, e la LSU si serve del simbolo ss per tutti i prestiti in cui vi sia la fricativa prepalatale sorda, cosicché si danno come esempî issena scena e isserpa, variante molto rara, mantenendosi in realtà l it. sciarpa identico nella pronunzia in quasi tutto il dominio logudorese. Allora in casi come lo spagnolo bruja si dovrebbe scrivere *brussa? In questa ipotesi si annullerebbe l opposizione fonematica fra l iberismo cassa caccia (variante lessicale dell italianismo catza) e casça cassa : evidentemente qui bisognerebbe fare ricorso a -ssi-. La LSU, fors anche per le sue ombre autoritarie ( Per le altre consonanti, in via sperimentale, si lascia libertà di scrivere una sola consonante o due si legge, ad esempio, a pag. 11), non ha riscosso successo, ed oggi soltanto la provincia di Núoro tiene vivo il progetto del dottor Corràine, 105 I due paesi alto-ogliastrini sono gli unici che adoperano forme intermedie di articolo: a Urzulei os/as, a Baunei us/as. Si veda la trattazione dell area ogliastrina, indicata come d La Commissione di esperti era formata dai seguenti dieci: Edoardo Blasco Ferrer, Roberto Bolognesi, Diego Salvatore Corraine, Ignazio Delogu, Antonietta Dettori, Giulio Paulis, Massimo Pittau, Matteo Porru, Antonino Rubattu, Leonardo Sole, Heinz Jürgen Wolf. 85
86 vero promotore della LSU, a parere del quale le diverse varietà locali sono ammissibili solo nella lingua parlata, ché nella lingua scritta c è posto per un solo sardo: il suo. In seguito ha incontrato maggiori consensi la cosiddetta Limba de Mesania, inizialmente propugnata da Mario Puddu e da numerosi altri esperti, in prevalenza - non a caso - originarî dell area storica arborense. Criterî non soltanto linguistici, ma anche storici e idealistici, qual è il richiamo all antico Giudicato d Arborea, furono fra i motivi ispiratori del nuovo progetto. Essa è stata presentata dapprima come aperta, nel senso che la Limba de Mesania dovrebbe essere adoperata dalla Regione solo in uscita, e ognuno dovrebbe essere libero di usare la propria varietà d appartenenza nei documenti scritti, come in un articolo su L Unione Sarda 107 sostenne Giuseppe Corongiu, il quale era sempre stato molto critico verso la scarsa democraticità della LSU. La Limba de mesania, poi codificata sotto il nome di LSC, ossia Limba Sarda Comuna, si avvicina alla parlata di Samugheo, ma presenta altresí elementi di artificiosità, tant è vero che Puddu, sostenitore della scelta del sardo realmente parlato in un singolo paese, se n è discostato. Se è vero che la LSC è presentata come tipo intermedio fra logudorese e campidanese, in realtà essa è palesemente logudorese, a cominciare dalla morfologia, e non è affatto dimostrato ch essa sia comprensibile per tutti i Sardi. La LSC è stata adottata dalla Regione Sardegna il 18 Aprile 2006, quale lingua di sola uscita, ma si sta rafforzando la corrente di pensiero, sostenuta da associazioni politiche e culturali, la quale s impegna affinché l uso della LSC si diffonda, a cominciare dalle scuole e dai mezzi di comunicazione: la delberazione della Regione, infatti, di per sé ha un valore piú simbolico che pratico, e l adozione della LSC sembra un biglietto di visita a sancire il principio del bilinguismo. È necessario a questo punto riflettere su quel che significhi l idea di una lingua sarda unica. Se si vuole scegliere una varietà esistente, gran parte dell isola non capirebbe né accetterebbe l idioma adottato, qualunque esso fosse, e la storia dimostra inoltre che le quattro favelle summenzionate si sono elevate al livello di lingue letterarie, cioè vorrei che il discorso fosse piú chiaro il logudorese illustre non si è affermato in tutta l isola 108. Ancor piú che il logudorese illustre, il quale è perlomeno dotato di una tradizione letteraria e non è mai stato imposto a nessuno, i Campidanesi rifiutano e il logudorese targato LSU e il logudorese targato LSC, poché considerano estranee entrambe le lingue unificate : come si può seriamente sostenere che oggi i Campidanesi si mettano a scrivere sas berbeghes e non is brebèis? 107 E sulla torre di Babele solo la limba di Mesania, su L Unione Sarda, 26 Febbraio 2005, pag Tutte le proposte avanzate presuppongono invariabilmente la prevalenza del logudorese sul campidanese. 86
87 Se invece si pretende di trovare una lingua intermedia che rifletta tutto il sardo non gallurese e turritano, il tentativo non può che fallire, giacché il logudorese e il campidanese, in linguistica sincronica, oggi non sono due varietà della stessa lingua, ma due lingue diverse. Non lo prova soltanto il riconoscimento di esse quali idiomi distinti che i codici mondiali dei glottologi impiegano (il piú noto è l ISO 639-3), ma soprattutto il fatto che qualsiasi grammatica, quando pur voglia presentarsi come semplicemente sarda, deve sempre distinguere tra forme campidanesi e forme logudoresi. Affinché si possa sostenere l unità di una lingua in tutte le sue varietà, bisogna che vi sia una reciproca intelligibilità sufficiente, ma se grandi sono le differenze di fonologia, morfologia, sintassi e lessico, in tutti e quattro o solamente in alcuni di codesti quattro ambiti, la lingua non è piú una sola: questo è appunto il caso del rapporto fra logudorese e campidanese, e Non è verosimile una conversazione tra un nuorese e un cagliaritano se ognuno adopera la sua varietà linguistica; oggi è molto raro trovare in logudorese e campidanese due frasi non solo uguali, ma che anche non presentino diversità significative. Si può provare a unificare le varietà di un unica lingua, ossia a trovare forme comuni comprensibili per tutti i parlanti; non si possono unificare due lingue distinte. Lo stesso termine macrovarietà non è altro che un eufemismo: il Blasco, a proposito di logudorese e campidanese, lo definisce Nella dialettologia, insieme di dialetti circoscritti da un fascio di isoglosse, ossia da una barriera formata da piú isoglosse che si affastellano e s intersecano lungo un percorso poco uniforme, dove può sorgere un area grigia (anfizona) 109. E ciò è esattamente il criterio per cui si individuano due differenti lingue all interno di un gruppo, è il principio di separazione fra lingue affini. Tale situazione è evidente, ma da molte persone non è accettata a causa del dogma dell unità linguistica sarda: si pensi all ottimo lessicografo Puddu, a parere del quale sa língua sarda, puru cun totu is diferéntzias chi tènidi, est una língua rigorosamenti unitària, a su narri de is istudiosus 110 ; nello stesso manifesto della LSC si legge che le attuali differenze interne sarebbero fondamentalmente di tipo fonetico e molto limitatamente di tipo grammaticale e lessicale. Gli è che, o per idealismo sentimentalista, o per ottenebramento da nazionalismo, non si gradisce l espressione due lingue, ma una rigorosa valutazione scientifica non può fare altro che riconoscere l impossibilità dell unificazione; è alquanto ipocrito l atteggiamento di quei linguisti i quali pretendono di convincere che vi siano soltanto poche differenze limtate al settore fonetico. Una caratteristica delle varie ipotesi di codificazione e scelta d una lingua unica, a mio avviso, è che esse paiono partire dall assunto che il sardo non sia mai stato scritto: i loro sostenitori si sentono 109 E. Blasco Ferrer, Glossario di linguistica sarda, CUEC, Cagliari, 2008, pag M. Puddu, Istoria de sa limba sarda, Domus de Janas, Dolianova, 2000, pagg
88 pionieri, quasi che fossero (o si fossero) investiti del ruolo di fondatori, o forse rifondatori, di una lingua solo orale e massimamente frammentata. Non si tiene, cioè, minimamente conto della lunga storia scritta di quell insieme linguistico chiamato sardo, e di tutte le opere letterarie, le quali, benché non si elevino all altezza di capolavori, tuttavia hanno avuto larga circolazione, divenendo talvolta, come nel caso degli inni sacri, autentico patrimonio della popolazione dell isola, in larghissima maggioranza analfabeta. Le proposte recenti infatti per nulla si curano delle opere letterarie: possibile che per codificatori e glottopoieti la storia letteraria sarda non valga nulla? Possibilissimo: ché molti fra costoro non la conoscono. In merito alla lingua mediana, essa non ha niente di originale, ma solamente mescola alcuni tratti logudoresi con altri campidanesi; va poi aggiunto che codest anfizona non ha mai esercitato una forza d attrazione sulle parlate contigue, sia logudoresi sia campidanesi, ma ha consentito piuttosto ai suoi abitanti di capire a sufficienza i vicini del Capo di Sopra e del capo di Sotto. Leggo che qualcuno, dopo l uscita del libro di La Croce, pensa alla parlata di Tonara come lingua di mesania nazionale, e a me, con tutto il rispetto per i Tonaresi, per il loro paese e per il loro torrone, viene spontaneo domandare: quando i Tonaresi stessi, come il loro piú noto scrittore Peppino Mereu, hanno sempre scritto in logudorese illustre, come si può pensare che il tonarese assuma dall oggi al domani tanto prestigio da essere adottato da tutti i Sardi? Su altre idee veramente assurde, come quella di scrivere un unica varietà sarda (il logudorese, ovviamente) da pronunziare in modo differente da zona a zona, mi pare che basti dire questo: qualsiasi lingua codificata possiede una pronunzia definita, quantunque piccole variazioni siano ammesse, ma pensare che cantaret si possa automaticamente volgere in cantessit, o che deghe si legga dèxi, significa non capire il nesso fra i concetti di sistema fonematico e di scrittura fonetica. Soltanto la scrittura ideogrammica è indipendente dalla fonetica. Quanto al logudorese illustre di Araolla e Delogu Ibba e Giovanni Spano, oggi non è prospettato come lingua rappresentativa di tutta la Sardegna, essendogli preferita, come dimostra il caso della LSU, una varietà logudorese che, a parte i suoi elementi di artificiosità, risulta piú centromeridionale, ed è assolutamente priva di storia letteraria. Riguardo appunto alla tanto diffusa predilezione pel nuorese, credo che all origine di siffatta inclinazione sia un errata interpretazione dell opera di Wagner e un malinteso senso di devozione al maestro tedesco. È necessario allora ricordare brevemente la figura di Wagner. Egli è stato indiscutibilmente il fondatore della linguistica sarda, nell ambito della quale le sue opere eccellono, ed uno dei migliori glottologi romanzi. Possedeva vastissima preparazione ed instancabile curiosità intellettuale, ed era 88
89 dotato di una capacità d apprendere le lingue piú unica che rara; i suoi meriti scientifici sono assolutamente notabili. Ciò che, anche per rispetto dello stesso professore amburghese, è ingiusto fare, è che qualcuno usi Wagner per fini proprî, attribuendogli ciò che egli non disse mai e accollandogli intenzioni che giammai ebbe. Wagner era un tardo romantico, spinto dall amore per l autoctono e l avito: Tre sole regioni europee vale la pena di visitare: la Sardegna, l Albania ed il Taigeto fu una delle sue affermazioni inequivocabili. Aveva verso la Sardegna lo stesso atteggiamento degli antropologi che si recano in luoghi poco contaminati dalla civiltà moderna, come le zone piú impervie dell isola di Nuova Guinea: l avvento della civiltà moderna cambia radicalmente i costumi di vita delle popolazioni, e questo è proprio ciò che il tedesco paventava 111. Wagner non era minimamente interessato a discussioni sulla codificazione della lingua sarda quale s intende oggi, perché egli conosceva bene la letteratura sarda (ovverosia la codificazione già esistente), la quale invero non lo appassionava, essendo, a suo parere, tale letteratura dotta, latineggiante e lontana dalla lingua viva: la codificazione tende a ingessare una lingua, dunque è pericolosa per la salute della parlata popolare. Ai tempi di Wagner è bene ricordarlo quasi tutti i sardi avevano ancora un unica lingua nativa, e non si poneva il problema di preservarne l esistenza come invece accade ai nostri giorni: pigliare adesso, in nome di Wagner, per lingua scritta una tra le piú conservative varietà nuoresi significa fraintendere le idee del linguista di Monaco. Wagner era infatuato dei Sardi del centro montano, che considerava alti e belli, fieri e battaglieri, e li contrapponeva ai contadini meridionali e agli abitanti delle coste, che reputava bassi e brutti, vili e arrendevoli, giusta un paradigma degno di Lavater o Lombroso. Non nego che nelle idee di Wagner possa essere eziandio qualcosa di vero o verisimile, ma, a parte il fatto che non è dato conoscere etnie solamente virtuose o soltanto malvagie, bisogna rammentare che i Logudoresi, come dimostra il nome geografico con cui sono appellati, non sono tutti montanari, e in una parte della Barbagia stessa vive gente che parla campidanese. L amore di Wagner per il centro della Sardegna si capisce soltanto se si rammentano le sue convinzioni razziali: laddove la lingua è piú pura, la razza è piú incontaminata. Di conseguenza il sardo logudorese è piú genuino del campidanese e, ovviamente, delle altre lingue di Sardegna: i Sardi del Centro sono piú sardi degli altri. Ecco le equazioni: logudorese = puro, campidanese = bastardo. Quante volte si ode che Il logudorese è la vera lingua sarda? Nella storia s incontrano troppi popoli eletti o supposti tali: mi pare che, con tutta franchezza, in Sardegna non se ne senta il bisogno. Gli effetti disastrosi che simili opinioni mal recepite esercitano sulle convinzioni paralinguistiche e parastoriche di molta gente sono palesi: qualcuno addirittura ha pensato al sardo di Bitti come lingua ufficiale, perocché esso rappresenterebbe il miglior esempio di purezza neolatina, mentre lo 111 A questo proposito si veda l articolo di Roberto Bolognesi Quanti luoghi comuni nella lingua sarda, su L Unione Sarda, 13 Giugno 2005, pag
90 stesso benemerito Wagner, ben piú di mezzo secolo or sono, osservava che le consonanti sorde intervocaliche stavano subendo lenizione persino lí, ovverosia nella zona ritenuta la piú conservativa dell isola, e che i maestri bittesi correggevano i ragazzini del paese quando questi recitavano le preghiere secondo la pronunzia locale e non quella della lingua logudorese scritta, cioè dicevano su itzu alla bittese in luogo di su fizu! Soltanto se si valúta tutto questo, cioè se si considera l autentica vaghnerite che affligge finanche linguisti o presunti tali, si spiegano asserzioni come quelle dello stesso Bolognesi ( nessuno è stato talmente scellerato da proporre una variante campidanese come lingua standard per tutti i sardi 112 ), o di Porru, il quale minacciosamente avverte che, al posto della LSU, la commissione regionale avrebbe potuto adottare addirittura il nuorese in ossequio alle tesi rispettabilissime di Max Leopold Wagner, di Mighel de Unamuno, di Shigeaki Sugeta e di Michele Contini 113. Io dico: ma se tanto si vuole essere tanto conservatori, perché non si torna al latino, lingua sicuramente ben codificata? Non havvi ragione per inventare, col pretesto della codificazione o normalizzazione, lingue sarde nuove o originarie 114 : in Sardegna, come i testi scritti dimostrano, e come la stessa coscienza dei Sardi prova, esistono da secoli quattro diverse lingue letterarie, ovverosia esistono una letteratura logudorese, una campidanese, una gallurese e una turritana, ognuna delle quali è sufficientemente unitaria, e non havvi nemmeno ragione per cui qualcuna di queste debba essere soppressa nell uso scritto (o addirittura orale, in prospettiva). Non esiste la lingua sarda: esistono quattro lingue sarde 115. A questo punto mi pare opportuna una riflessione di carattere storico, poiché queste discussioni sull unificazione linguistica sarda risentono di un preconcetto ottocentesco, esprimibile nella formula stato-nazione. La scienza linguistica moderna si sviluppò mirabilmente ed impetuosamente nel XIX secolo, epoca che coincide con la diffusione del nazionalismo. Tale dottrina politica fu influenzata dalla glottologia, ma a sua volta influenzò grandemente i linguisti, in una maniera tanto forte che le conseguenze si avvertono agevolmente pure ai nostri tempi. Col nazionalismo, a partire dalla Francia della Rivoluzione, si affermò il principio dello stato nazionale : un territorio, una patria, una nazione, una lingua, uno stato; Alessandro Manzoni, in Marzo 1821, di nazione formulò la chiara definizione seguente: Una d arme, di lingua, 112 Per una convivenza di tutte le limbe, su L Unione Sarda, 4 Aprile 2005, pag Ma la limba non è stata sperimentata nella scuola, su L Unione Sarda, 7 Marzo 2005, pag Di scoperte di lingue nuove si potrebbe parlare se si ritrovassero testi in sardo nuragico, non a proposito del sardo neolatino. 115 E non si può essere certi affatto né che, prima della nascita del gallurese e del turritano, le tre varietà del sardo medioevale formassero un unica lingua, né che a quei tempi in Sardegna non vi fossero altri idiomi. 90
91 d altare, / Di memorie, di sangue e di cor. Conseguenza di ciò fu che essa parola (letteralmente nascita e poi etnia ) divenne sinonimo di stato, perfino nella sua accezione territoriale. Proprio la Francia, nella quale già nel Medio Evo il sentimento e la retorica nazionale furono fortemente alimentati dalla monarchia, è in Europa l esempio di stato moderno nazionalista e centralista (oltre che laicista) per eccellenza: come ha scritto Fabio Ratto Trabucco, Col passare dei secoli, nel paese transalpino si è sviluppata una politica di accentramento amministrativo che è andata di pari passo con il soffocamento delle identità regionali. la lotta contro le autonomie locali, comunali e feudali, e contro gli idiomi e le culture minoritarie, ha infatti tradizioni antiche in un paese nel quale la lingua del re fu ritenuta, fin dal Rinascimento, uno degli elementi di coesione e di unità statale. Lo Stato francese, per questa visione fondamentalista della lingua, ha sempre considerato tutte le comunità allofone del suo territorio non solo e non tanto come nemici dell organizzazione centralizzata, ma piuttosto come situazioni di anomalia culturale, da eliminare attraverso l introduzione della civilizzazione francese. Nello stesso tempo la Francia ha considerato le popolazioni del suo vasto impero coloniale come soggetti cui donare, volenti o nolenti, la sua lingua e la sua cultura 116, perché solo con l assorbimento di questi valori avrebbero potuto incamminarsi verso il progresso 117. Da queste parole chiarissime si evince altresí il legame fra nazionalismo e colonialismo, oltre all insofferenza per le minoranze etniche. Ogni stato, soprattutto gli stati nazionali, cominciò ad adottare una politica linguistica, per rafforzare la lingua della nazione dominante e affossare quelle delle minoranze; parallelamente sorse una linguistica politica, vale a dire che alcuni linguisti cominciarono ad agire non per iscopi puramente scientifici, bensí nazionalistici, al servizio del potere politico che ben li ripagò con cattedre universitarie e carriere sfolgoranti. In quel clima di esasperato nazionalismo, nell Europa della fine dell Ottocento il riconoscimento di un qualche idioma quale lingua a sé stante ea sancito con l aggettivo indipendente, che richiamava immediatamente concetti politici come quelli di indipendenza, secessione, lotta nazionale. Anche in istati ufficialmente multietnici la linguistica ha obbedito alle esigenze del potere politico: nell ex Unione Sovietica, per esempio, la Repubblica di Moldavia aveva come ufficiale la lingua chiamata moldava e non romena, affinché non fosse in nessun modo stimolata la tendenza all unificazione di quel territorio con la madrepatria romena 118 ; i glottologi sovietici si sforzarono dunque di dimostrare l indipendenza del romeno dal moldavo, amplificando ed esaltando ogni differenza tra la parlata locale e la lingua letteraria, fino a creare un modello ortografico e grammaticale distinto. Il caso forse maggiormente clamoroso, e per di piú molto recente, di 116 Per esempio nei libri scolastici in lingua francese distribuiti in Senegal si legge Noi discendiamo dai Galli. 117 Il regime linguistico e la tutela delle minoranze in Francia, pubblicato su Il Politico, Settembre-Dicembre 2005, n. 3, Milano, pagine La Moldavia è abitata anche da molti Russi e Ucraini, ed esiste pure una minoranza turca. 91
92 adeguamento della linguistica alle esigenze della politica è rappresentato dalla lingua serbo-croata o jugoslava, ufficiale nell ex Jugoslavia. Questo idioma è usato da tre principali comunità culturali e religiose: i cristiani cattolici detti Croati dal nome della regione in cui prevalgono, i cristiani ortodossi detti Serbi, i musulmani prevalenti in Bosnia. Finché la Jugoslavia rimase unita come stato, si è parlò sempre di lingua serbo-croata, soltanto suddivisa in alcune varietà, ma da quando quello stato si è decomposto, le tre nuove repubbliche di Serbia, Croazia e Bosnia hanno voluto denominare la propria lingua con il nome dello stato stesso, ed è invalsa, presso la stessa comunità scientifica, l abitudine di chiamre serba, croata e bosniaca la lingua piú diffusa nei tre nuovi rispettivi stati. In realtà le differenze tra serbo, croato e bosniaco sono prive di rilievo, e non impediscono minimamente la comunicazione e la comprensione reciproca fra i parlanti: cosí come adesso si danno tre nomi diversi alle suddette varietà della stessa lingua, non ci si dovrà stupire se ugualmente il Montenegro, ultimo nato fra gli stati indipendenti dell ex Jugoslavia, darà il proprio nome al serbo-croato, proclamandolo montenegrino. Lo Stato Italiano nacque su imitazione del modello francese, e la sua politica linguistica non se ne discostò granché. Lo Stato Italiano nel corso dei decenni ha dovuto però riconoscere la presenza di minoranze linguistiche, dapprima quelle legate ai grandi stati europei (germanofoni nel Tirolo Meridionale, francofoni in Valle d Aosta), poi il ladino dolomitico e successivamente il friulano, il sardo e le isole linguistiche greche ed albanesi, senza però consentire un autentico bilinguismo né ammettere la presenza delle corrispondenti minoranze etniche: tutte le altre parlate della Penisola non godono di nessuna tutela e ricadono sotto la qualificazione di dialetti. Orbene basta consultare un efficace fonte di conoscenza di quest epoca qual è Wikipedia, per verificare che la comunità scientifica, parimenti a istituzioni rispettate come l UNESCO, per motivi esclusivi di linguistica sincronica e senza sconfinare in campo politico, definisce lingue e non dialetti il piemontese, il lombardo, l emiliano-romagnolo, il ligure, il veneto, il campano-pugliese e il siculo-calabrosalentino. Va rammentato che la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie all Articolo 1 afferma che per lingue regionali o minoritarie si intendono le lingue... che non sono dialetti della lingua ufficiale dello stato. L atto fu approvato il 25 Giugno 1992 ed entrò in vigore il I Marzo 1998: l Italia lo firmò il 27 Giugno 2000 ma non l ha ancora ratificato. Approdò all esame della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, nel Giugno del 2009, la proposta d introdurre nelle scuole elementari l insegnamento delle lingue locali, con riferimento alle specificità culturali, geografiche e storiche delle comunità locali. Subito il quotidiano Il Secolo d Italia cosí ribatté: L apprendimento coattivo del dialetto postula sul piano culturale, 92
93 antropologico e istituzionale la dissoluzione dell unità d Italia. Oibò! Qui, con autentico paraocchî ottocentesco, si associa automaticamente il riconoscimento di una lingua all esistenza di un etnia, la quale possa rivendicare l indipendenza politica. In un epoca storica segnata dalle migrazioni e da profondi mutamenti culturali, tali convinzioni suscitano autentico sgomento. L odio nazionalista nei confronti delle lingue locali è alimentato anche da molti linguisti, che spacciano per glottologiche le situazioni sociolinguistiche: si considerino le dichiarazioni di un Gian Luigi Beccaria ( I dialetti servono soltanto per parlare di peperoni, disse una volta in televisione, e poi: Non sanno che i dialetti si parlano, non si insegnano. Né si scrivono, a meno di essere poeti. Un dialetto è un sistema linguistico che soddisfa egregiamente, delle nostre esigenze espressive, soltanto alcuni aspetti (l usuale, il pratico, l affettivo, il familiare), ma non altri (il tecnico, il filosofico, lo scientifico). «In dialetto - diceva il grande poeta dialettale Raffaello Baldini - si può parlare con Dio, non si può parlare di Dio». Non credo che in dialetto si stampino studi o si facciano dibattiti di teologia. Quando un dialettofono scrive, scrive in italiano 119 ) o di un Raffaele Simone ( Neppure sardo e friulano sono lingue a parte. Lo status di lingua concesso ad alcuni dialetti come il sardo e il friulano è di natura puramente strategica. Per evitare attriti, è stato conferito a comunità fortemente consapevoli di sé, autonome e dotate di dialetti diversi quanto basta a convincerle che le loro siano lingue. Ma in Italia c è una sola lingua, l italiano. Diverso è il caso dell albanese e del tedesco: sono lingue minoritarie 120 ). Costoro fingono di non sapere che la lingua italiana ha prosperata finché sono fiorite le lingue locali (da loro appellate dialetti ), proprio in virtú del fatto che la lingua italiana era coltivata solamente da pochi dotti: non appena si è cercato di diffonderla a scapito delle favelle delle piccole nazioni, ha cominciato a palesarsi il fenomeno dell italiano regionale: l italiano infatti ha subito negli ultimi sessant anni piú cambiamenti di quelli ch erano avvenuti in cinque secoli. E va precisato a scanso d equivoci che non è assolutamente l italiano illustre il nemico delle lingue di minoranza: tanto la lingua letteraria di Boccaccio quanto gli idiomi delle piccole nazioni sono devastati dall italiano regionale, l italiese delle cento parole. Quest ultima mezza lingua ha preso il posto di ciò che aveva avuto vigore per secoli, e per le persone di cultura era coesistito con l italiano letterario: penso che il vocabolo piú idoneo a significare che cosa rappresenta l assunzione dell italiano regionale come lingua nativa, sia disgrazia. In realtà talune lingue della Penisola, quali il veneto, il lombardo e il napoletano, godono di una letteratura illustre o sono state idiomi ufficiali dei rispettivi stati. A causa della politica linguistica di 119 Su Tuttolibri, 10 Ottobre Si noti che questo signore, a meno che non vi sia stato un refuso nell articolo, pare aver dimenticato che il verbo satisfare/sodisfare/soddisfare, parimenti a disfare, nella storia della lingua italiana, è coniugato come fare, al quale s aggiunge il prefisso bisillabo: è corretta la forma soddisfà tronca, mentre soddisfa con accento sulla penultima è colloquiale. 120 Venerdí di Repubblica, 25 Settembre
94 genocidio culturale perpetrata dallo Stato Italiano, la quale ha spinto la gente comune a disprezzare la propria parlata locale, sul piano sociolinguistico tutte le lingue minori, eccezion fatta per il francese in Valle d Aosta e il tedesco in Tirolo Meridionale 121, si sono ridotte a dialetti: ciò è indiscutibile, ma Simone omette di dire che in linguistica sincronica e diacronica la definizione di dialetto è assolutamente diversa, e che anche in sociolinguistica la situazione in passato era differente; si commette poi uno strafalcione quando si associano al tedesco, quali idiomi di minoranza, le isole linguistiche albanesi in Italia: chi parla albanese conosce certamente la varietà siciliana, calabrese o lucana della sua zona, perciocché la sua parlata è sociolinguisticamente subordinata al piú vasto idioma locale. Riguardo alla tesi per la quale in dialetto non si possano esprimere certi concetti, basti citare un esempio a proposito del Sudafrica: oggi in lingua zulu si compongono pregevoli melodrammi, mentre in passato la voce zulú era sinonimo di incivile. Il nazionalismo linguistico non è altro che una forma di razzismo. Perfino Tullio De Mauro, consapevole della notevolezza delle favelle locali ( La conoscenza del dialetto fornisce strumenti linguistici che migliorano anche la padronanza dell italiano e facilitano l apprendimento delle lingue straniere 122 ) per le quali ha sempre mostrato rispetto pur non riuscendo a considerarne bene la crisi profonda ( I dialetti in Italia godono di buona salute ha dichiarato in varie occasioni), rimane per altri aspetti prigioniero dei preconcetti ottocenteschi: nonché impiega la parola dialetto senza distinzioni, ma la sua classificazione dei volgari della Penisola appare piú la proiezione linguistica della Grande Italia vagheggiata dai garibaldini che una schietta valutazione scientifica 123. Pare che l idea di unità nazionale, tanto per lo stato-nazione quanto per le minoranze etniche, sia assurto a dogma: nella maggior parte dell Europa e dell intero Occidente non si può sostenere l esistenza di gruppi etnici indigeni, non si può parlare di stati multinazionali o nazioni composite riguardo agli autoctoni; ciò è politicamente scorretto, e l aggettivo multietnico, piú usato di multinazionale (il quale risente dell impiego scorretto del termine nazione ), è ammesso soltanto per indicare la presenza di immigrati, con le loro lingue e culture, in un certo stato. Soltanto a proposito degli stati del Terzo Mondo, e in particolare per l Africa, si riconosce la presenza di varie etnie e le si classifica per consistenza numerica: nella ricca Europa no, giacché vale il principio dell unità nazionale. Questo è l odierno pensiero dominante. 121 Con i Francesi e con i Tedeschi di Germania e Austria lo Stato Italiano, trovandosi in posizione di debolezza, non ha potuto agire con troppa prepotenza, e ha dovuto concedere il bilinguismo (e consistenti agevolazioni economiche e fiscali, quel che non è stato accordato alla Sardegna) in quelle due regioni di cultura e identità evidentemente non italiane. 122 A seguito del piano di tutela dell idioma locale in Calabria, 22 Novembre M. Dardano, Nuovo Manualetto di Linguistica Italiana, Bologna, Zanichelli,
95 Per quanto riguarda la Sardegna e i Sardi, si deve riflettere se essi costituiscano nel nostro tempo una nazione, quando un notevole numero di essi, pur non ispingendosi fino a festeggiare i centocinquant anni dello Stato Italiano, si definisce però italiano; e se la Nazione Sarda esiste, si deve valutare se essa possa essere considerata unitaria, o piuttosto un insieme di nazioni: si potrebbero adoperare forse i vocaboli sovrannazione e subnazioni, e, in altri termini, domandarsi se vi siano i Sardi e basta, ovvero se esistano innanzitutto i Campidanesi (o gente della Sardegna meridionale), i Logudoresi-Nuoresi (Sardi del Centro-Nord), i Sassaresi e i Galluresi, e se ognuno di questi quattro gruppi etnici comprenda significativi sottogruppi culturali e linguistici. Non è mia invenzione che taluni Sassaresi dicano ancor oggi Vado in Sardegna quando si spostano nelle zone di lingua diversa, e soprattutto che in Gallura e pure nel Sassarese siano chiamati li Saldi gli abitanti delle vicine aree logudoresi, per rimarcarne la diversità da chi vive a settentrione; è noto che i Campidanesi, appellando Capo di Sotto la proprie contrade, si contrappongono al Capo di Sopra che indica tutto il resto dell isola. Nel Nuorese sono detti abitualmente campidanesos quelli del Capo di Sotto. Invero Sardegna, siccome Penisola Italica e Penisola Iberica, è un nome geografico, e di per sé non esprime un concetto etnico: in ciascuno di tali spazî potrebbe vivere sí una sola nazione, ma potrebbero esservene pure due, dieci o vénti, con altrettante lingue. Di un isola quale Hispaniola pochi conoscono il nome, essendo il suo territorio suddiviso in due stati, Haiti e Repubblica Domenicana: si può forse dire che il territorio comune d Hispaniola presupponga l unità etnica? L esistenza di una lingua non equivale di per sé alla presenza di una nazione: come l etnologia insegna, vi sono altri parametri da valutare; quel che però la storia dimostra, è che di norma a differenze linguistiche si accompagnano difformità culturali. Ugualmente a proposito del cosiddetto paleosardo si riscontra la medesima cieca propensione a non tollerare la pluralità: gli elenchi dei nomi delle popolazioni sarde, che i Romani redassero indicando anche i luoghi in cui la maggior parte di esse era stanziata, suggeriscono una composizione etnica complessa. Se si riuscisse a dimostrare per prima una presenza iberica, oppure accadica, ovvero protocananea, per quale ragione si dovrebbe escludere per principio qualsiasi altro elemento etnico e linguistico, come quello berbero, illirico, o etrusco? Perché dunque credere sia esistito un solo linguaggio paleosardo e non i paleosardi? 95
96 Chi dunque, con un mal celato ideale di purezza della razza, vuole eliminare il campidanese ritenendolo un ostacolo all unificazione linguistica, rammenti che esso è parlato, o almeno conosciuto bene o male, da circa un milione di persone, cioè la maggioranza assoluta dei Sardi. Tale tendenza si manifestò dopoché, il 16 Marzo 2010, la Provincia di Cagliari ebbe scelto il campidanese, codificato nelle Arregulas suddette, quale lingua coufficiale con l italiano. Subito si ebbero reazioni durissime, soprattutto e non può essere un caso da parte di forze politiche nazionaliste e indipendentiste. IRS il 18 Marzo nel suo sito Internet intitolò un articolo Due lingue sarde. Una follia della Provincia di Cagliari e proclamò: IRS indipendèntzia Repùbrica de Sardigna denuncia l iniziativa della Provincia di Cagliari che ha votato nella giornata di ieri all unanimità in Consiglio Provinciale una normalizzazione grafica della variante meridionale del sardo... con il risultato di sancire politicamente la divisione della lingua sarda in due vere e proprie lingue, intese arbitrariamente come campidanese e logudorese... Il sistema linguistico sardo è un sistema unitario, nel quale le differenze fonetiche sono considerate una ricchezza di forme espressive e non possono essere utilizzate arbitrariamente per stabilire rigidi confini interni. IRS ritiene che una norma scritta unitaria seria e ragionata debba essere il trampolino di lancio per un utilizzo maturo e serio della propria lingua storica nel futuro... La Provincia di Cagliari si appresta a votare una proposta che divide arbitrariamente la lingua sarda in due lingue, sfruttando le costruzioni mentali e culturali frutto di decenni di opposizione al processo di rivivificazione della lingua sarda ; Sardigna Natzione, a conclusione di una sua nota, scrisse: Stante che la lingua è quella che si parla - con la sua multiforme ricchezza locale - e il passaggio dall'oralità alla scrittura ne determina una rappresentazione, Sardigna Natzione ribadisce la necessità' che questa rappresentazione sia unitaria in tutto il territorio nazionale. Come si vede, la mentalità è la medesima del nazionalismo italiano: un territorio nazionale, una sola lingua nazionale. Coloro non capiscono che imporre in tutta la Sardegna un qualsiasi tipo di logudorese a scapito delle varietà locali, cioè scavalcandole, è un atto di violenza che appare concepito col fine d annullare le realtà locali; nelle scuole poi ciò significa introdurre una nuova lingua straniera: errore gravissimo sul piano glottodidattico, tale da ostacolare ancor piú la sardofonia. Uguale giudizio varrebbe se qualcuno pensasse di obbligare a usare il campidanese a Núoro, il gallurese a Oristano e il turritano a Cagliari. Dopo la pubblicazione dell articolo Un po di arregulas per affossare il sardo e vincere le elezioni (18 Marzo), nel quale si contestava l adozione del campidanese da parte della Provincia in quanto una parte, non so quanto grande, degli autori de is arregulas lavorano per due standard e due lingue, al sito uno fra i piú aggiornati luoghi di dibattito 96
97 sulla cultura sarda 124, io inviai il 20 Marzo la lettera intitolata Sardínnia: curturas e línguas diferèntis che qui riporto: Saludi. A parri miu sa detzididura de sa Provinça e Càllari espressat s arrealidadi sceti, ne prus ne mancu: in Sardínnia dhoi at cuàturu línguas indígenas noulatinas òi: logudoresu e campidanesu, galluresu e sassaresu, is primas duas de unu grupu, is segundas de un atru. Is assótzius mundialis de linguistas dhu testimonjant (castiai su códixi ISO 639-3, su jassu / Languages of Italy ecètera), e nòsi ndi acataus nòsu totus, si no teneus su paraògus. Mancai custa situatziòni dispraxat a calincunu, candu is sistemas gramatalicalis (est a nai fonologia, morfologia e sintassi, in prus de is fuèdhus umperaus) bessint diferèntis e comunigai a pari est barrancu mannu, tocat a chistionai de línguas e totu, e no si cuai desuta e bariantis, bariedadis o atru, chi nci funt aintru e dónnia língua e indidant intamus is mudàntzias piticas de bidha a bidha. Agoa no si dèpit scarèsci chi a donniuna de is cuàturu línguas no dhi mancant obras literàrias. Sa situatziòni est custa ca s istória at ocasionau custu: pòdit èssi chi siat una farta, ma pòdit èssi un arrichesa puru. Sardínnia est innanti e totu unu lómini jogràfigu, cumènti e is fuèdhus Itàlia e Ispànnia, e un ísula de sèi, cumènti e ísula, no tènnit po fortza una natziòni sola o una língua úniga. In beridadi, a sa própiu manera chi s Itàlia e s Ispànnia tènnint medas curturas e medas natziònis, in Sardínnia puru bivint unas cantu e gèntis diferèntis. No dennègu chi de Natziòni Sarda si potzat chistionai, ma si dhoi at, cussa est una Natziòni de Natziònis, po dhu nai cumènti afirmat sa lèi ispanniola: bollinai una natziòni conjugada a su prurali. Liju chi IRS e SN funt primadas cun sa Provinça e Castedhu, e dèu, chi no cuncòrdu nemancu cun s assentu e scriidura chi cussa dh at sçoberau, a is de IRS e SN dhis pregòntu: poita no si funt chesçaus tanti candu sa própiu cosa dh at fata chini pigat sa LSU o sa LSC? fortzis timint a chitai s independéntzia e sa Sardínnia s umperu e su sardu de Cabu e suta? fortzis ind unu stadu, comarca o arrejòni dhoi dèpit èssi una língua arreconnota sola? fortzis candu sa Sardínnia fiat líbbera dhoi fiat una língua ufitziali sola, e si proibbiant is atras? E fortzis intzandus dhoi fiat unu stadu unitàriu solu? 124 Gianfranco Pintore sostiene l uso di una sola varietà sarda come lingua scritta per tutta la Sardegna. 97
98 E si pòdit açungi: a su tempus de is nuraxis fortzis si chistionàt una língua sceti? Chini nòsi dh amostat? No bastat a tzitai Ispànnia, Svítzera o Belju, ma arremònu chi in Perú calisiollat língua logali est ufitziali sigumènti arreconnota, e, tanti po ndi argunas, in s Uniòni Soviétiga passada is línguas de Ceremissus e Morduinus fiant ufitzialis in duas bariedadis (bollinai línguas) e sa de is Vógulus- Ostiagus in tres. S agualamentu e sa bidea de terra cun sa bidea de natziòni úniga est un eredadi mala de su natzionalismu oprimidòri de s Otuxèntus, arrexòni e sçacus mannus in s istória probiana: a caristia sa mentalidadi centralista est bia tambèni, e bòllit arremprasai su stadu italianu cund un atru stadu, sardu e pitichedhu ma acentradòri. Po chi su spetat a igusta chistiòni, a palas apubu unu pentzamentu fadhiu: su logudoresu iat èssi sa língua pura de is Sardus sintzillus, is Sardus bèrus, e is atrus iant èssi burdus. A mèi mi parrit una cosa arratzista de spreai: gosintisidha is chi ndi funt cumbintus, is tzurpus ecisaus chi sighint a Wagner, grandu linguista ma arromàntigu arratzista arrorosu puru, chi peròu no dh importàt nudha de propostas assuba e línguas ufitzialis. S efetu e custas atziònis est chi is Sardus si spartzint de prus, e intzandus dhu nau ladinu: is campidanèsus tènnint una literadura de trexèntus cincuanta annus e prus, de Para Antoni Maria de Stertzili fintzas a Frantziscu Carlini, e no intèndint sintidu e inferioridadi perunu cun nèmus; no arrenúntziant a sa língua intzòru, ne fuedhada ne scrita. Che fare dunque? In una sua opera del 1994, il Blasco scriveva: Se capiamo la profondità e l importanza di questa frattura, fra campidanese e logudorese, che come si vede è storica, accetteremo più facilmente una norma duplice, che rispetti l evoluzione differenziata del latino nelle due regioni dell isola 125. Egli, prima di convertirsi, forse solo temporaneamente, all ipotesi della LSU, proponeva dunque inequivocabilmente una doppia codificazione del sardo, cosí come torna a proporre adesso, dopo aver pensato all adozione di una lingua mediana del tipo che stiamo per discutere: vale a dire che le due macrovarietà sarde non sarebbero piú riconducibili ad una norma unica; ha poi sostenuto ancor piú convintamente: In Sardegna la storia, già a partire dal latino, ha creato una netta biforcazione tra le varietà logudoresi e le varietà campidanesi, sicché la ricerca di uno standard che si basi su una varietà logudorese schiaccia l identità etnicolinguistica dei Campidanesi, e viceversa una lingua comune formata sulla base del campidanese annulla le peculiarità linguistiche, e in fondo storico-linguistiche dei Logudoresi 126. Non solamente di doppia codificazione si parla, ma si accenna anche all intoccabile tema delle differenze etniche. 125 E. Blasco Ferrer, Ello Ellus, pag. 167; si veda anche pag. 52 del medesimo libro. 126 E. Blasco Ferrer, Tecniche di apprendimento e di insegnamento del sardo, Della Torre, Cagliari, 2005, pag
99 Qualcuno obiettava e obietta però che non ci sarebbero esempî di doppia codificazione e che essa sarebbe d ostacolo allo sviluppo di una lingua nazionale. Consideriamo allora la vecchia Unione Sovietica. Fra le decine di lingue che furono interessate a un processo di codificazione autentica prima codificazione, si badi bene, giacché parecchie non erano mai state scritte erano molte della famiglia uralica. Orbene tre di queste lingue, appartenenti al gruppo ugro-finnico (sottogruppo finnico), furono e sono tuttora scritte in due diverse varietà: si tratta del morduino, del comi, e del mari (detto pure ceremisso). Un altra lingua dello stesso gruppo, ma appartenente al sottogruppo ugro, ebbe addirittura tripla codificazione: è il hanty (prima chiamato ostiaco), usato da poche migliaia di individui. È vero che la politica linguistica dell Unione Sovietica, non dissimilmente, d altronde, da ogni altra politica linguistica proprio in quanto politica, tenne conto di fattori non esclusivamente glottologici e spesso serví da sostegno alle decisioni governative, ma in quest ultimo caso non si può certamente affermare che un piccolo popolo di pescatori ugri (oggi sono meno di quindicimila) potesse rappresentare un pericolo per la stabilità dell URSS, o almeno che simile conseguenza potesse avere una codificazione unica e non triplice, la quale, in pratica, si sarebbe tradotta nella scelta della parlata di un piccolo gruppo di villaggi come lingua scritta: semplicemente si constatò che le differenze fra le diverse parlate rendevano preferibile l adozione di tre varietà diverse come lingue scritte. Fu dunque una scelta di praticità linguistica, non dovuta a calcoli politici: sul piano glottologico, si hanno effettivamente due lingue morduine (erzya e moksha), due comi (sirieno e permiacco), due mari (occidentale e orientale). A me pare che si possano evitare contrasti per questioni linguistiche, se si giunge ad accettare il principio seguente: ciascuna lingua sia riconosciuta ufficialmente nel luogo in cui si usa, cosicché ogni autorità pubblica ed ogni istituzione giuridica e politica siano tenuti ad usare anche la lingua locale, non soltanto quella ufficiale (o quelle ufficiali, se sono piú d una) dello stato centrale. Dunque nonché comune e provincia, ma regione e stato centrale e qualsivoglia altra entità giuridica presente o avvenire, cosí come ospedali, scuole, questure e ogni ente ed istituzione pubblica, nel caso della Sardegna, dovrebbero redigere documenti e mostrare cartelli in logudorese, campidanese, gallurese e turritano, nelle zone in cui tali idiomi sono usati 127. Bisogna costringere ogni istituzione a usare la lingua locale a non imporre soltanto la propria: se, per esempio, un domani lo Stato Italiano o l Unione Europea vendessero la Sardegna, o solo parte di essa, alla Tunisia o alla Cina, 127 E ciò significa esattamente: a Carloforte il ligure, a Luras il logudorese, a Budoni centro il gallurese, ad Olbia città il logudorese ma in alcune sue frazioni il gallurese; ogni comune, secondo tradizioni e necessità, scelga quella lingua che le è propria o che sente piú vicina. A ciascuno il suo. 99
100 dai nuovi dominatori si dovrebbe ugualmente esigere il rispetto della realtà linguistica. Tale criterio, insomma, si limita a proteggere le lingue locali, senza imporre in alcun luogo l uso esclusivo di idiomi estranei: ciò è il contrario del nazionalismo, poiché è la semplice protezione del patrimonio linguistico esistente in un certo luogo. Il riconoscimento delle quattro lingue sarde esistenti, tutte di uguale dignità, non è cagione di divisione e di scontro, ma va visto come motivo di coesione: unità nella diversità; Sardi sí, ma Sardi Logudoresi, Campidanesi, Galluresi e Turritani. Non è detto che una o piú lingue si conservino meglio soltanto in uno stato indipendente: è sufficiente che uno stato ammetta la sua natura multiculturale e ammetta il plurilinguismo. Il contrario di quel che fa il nazionalismo: un nuovo stato indipendente può essere molto piú repressivo verso le sue minoranze rispetto all entità statale di provenienza. Qualcuno potrebbe obiettare che a questo punto ogni paese, giusta il criterio suddetto, potrebbe codificarsi la sua lingua sarda, e per esempio si potrebbe domandare: che accadrebbe se il consiglio comunale di Giba scrivesse praça e non pratza? Non accadrebbe niente: sempre campidanese sarebbe, e si tratterebbe di questione meramente municipale. Il nazionalismo ottocentesco si configurò come esaltazione bellicosa di una nazione e conseguente aggressione a danno di nemici interni ed esterni, non fu sola protezione dei valori della nazione stessa: il nazionalismo è stato, ed è ancora, non difesa ma offesa; è violenza, attacco, sopraffazione. Piuttosto che distinguere fra nazionalismo offensivo e nazionalismo difensivo, preferisco contrapporre a nazionalismo il composto greco etnofilassi, ossia protezione della nazione. Il nazionalismo sardo in materia linguistica, per esempio, giunge insino al punto di affermare con tono reboante che il logudorese e il campidanese sarebbero, come lessi alcuni mesi fa da qualche parte, invenzioni del colonizzatore straniero per dividere i Sardi e impedire lo sviluppo di una vera lingua nazionale 128. In conclusione, parlare ed insegnare ai bambini qualsiasi idioma e varietà sarda è una risposta al nazionalismo italiano, e impiegare nello scritto il turritano, il gallurese e il campidanese oltre al logudorese è una difesa dal nazionalismo sardo; al nazionalismo glottofago di qualsivoglia matrice tanto italiano quanto sardo, o in futuro di altro tipo è opportuno rispondere che i Sardi Meridionali, ossia Is de Parti e Yòssu ovvero de Cabu e Suta, hanno una loro lingua e una loro letteratura, che vanno curate e protette laddove la gente le senta ancora proprie: la Nazione Campidanese non accètta che la sua identità sia sacrificata all idolo nazionalista. 128 Ecco perché mi convinco che certuni non conoscano la letteratura sarda. Vien da domandarsi, per esempio, quanto potesse interessare agli Spagnoli che Frate Antonio María componesse il Libro de comedias in campidanese: forse per codesti eruditi nazionalisti egli sarà stato pagato al fine di distruggere l unità linguistica dell isola, diabolico ispiratore d una cospirazione a danno della limba sarda comuna. 100
101 Tabella su alcuni dei principali fatti ortografici e morfologici nei primi autori campidanesi ( circa) /k/ /g/ /ʃ/ /ʒ/ /ɲ/ /ʎ/ /ʧ/ /ʤ/ Ant.M.Es t. qui gui sci, x x ñ, gn ll ch, ci, ç j, gi, x Contu S.Potito S.Barbar a qui chi chi gui ghi ghi x x ñ ll ch j, x x, sci, sx x gn gl ci gi, j sci, x x gn gl ci gi Corongiu Cossu Purquedd u chi, qui chi, qui chi ghi, gui ghi, gui ghi x x gn gl ci gi sci, x, xx x gn gl ci gi sci sci gn gl ci gi Pintor S. /ʦ/ ç, c,z, tz c, z, tz z z z z z z, zz /ɖ/ d(d) d(d) dh d(d) d(d) d(d) d(d) d(d) (cacum.) Perfetto -ei; -isi -esi manca manca -esi raro manca -esi manca Condiz.p res. aiat a inf. edimo iat a inf. iat a inf.? iat a inf. iat a inf. iat a inf. iat a inf. Cong.im perf. essere Infinito -are Gerundio inf. -(a)iri essiri -essi -essi fussi, fessi -essi fessi -essi fussi -essi fussi -essi fussi -ari -ari -ai -ai -ai -ari, -ai -airi, -ai -ai -endi -endu(ru) andu(ru) -endu -endu(ru) -endi -endu -endu(ru) -endu(ru) -endu(ru) chi ghi sci x gn gl ci gi -essi fessi -endi(ri) -endu(ru) Participio -adu -idu -adu -idu -au -idu, -iu -adu -idu -adu,-au -idu,-iu -adu,-au -idu,-iu -adu,-au -idu,-iu -au -iu Fut-fiat fuit, fut fiat fiat, fet fiat fut fiat fut fiat Tengutenju tenju tenju?? tengu tengu tengu tengu Nosi Bosi nosi osi, si?? nosi? nosi osi nosi osi nosi osi si si nosi bosi, osi, si (raro) I primi sei fenomeni riguardano l espressione di alcuni fonemi, i successivi sono morfologici. Con Pintor Sirigu la lingua giunge ad un grado d evoluzione grammaticale da cui, in sostanza, non si è ancora allontanata. 101
102 BIBLIOGRAFIA È necessario distinguere i testi degli autori campidanesi, trattati in questa relazione, dalle opere grammaticali e lessicografiche sulla lingua sarda in generale e sul campidanese in particolare. Per i manoscritti valgono le indicazioni sulla collocazione nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, date nei capitoli precedenti. EDIZIONI DI DOCUMENTI LETTERARÎ IN CAMPIDANESE Anonimo, Sa scomuniga de Predi Antiogu arrettori de Masuddas, a cura di Antonello Satta, Cagliari, Della Torre, Frate ANTONIO MARÍA DA ESTERZILI, Libro de comedias, a cura di A. Luca de Martini, Cagliari, Dicembre 2006, Centro di studi filologici sardi / Cuec. S. BULLEGAS, Il teatro in Sardegna fra Cinque e Seicento, Cagliari, EDES, 1976 (su Carmona). S. BULLEGAS, La Spagna, il teatro, la Sardegna, Cagliari, CUEC, 1992 (su Antonio María da Esterzili). S. BULLEGAS, La scena e il paesaggio, Dell Orso, 1997 (su Vidal). S. BULLEGAS, L Urania Sulcitana di Salvatore Vidal. Classicità e teatralità della lingua sarda, Cagliari, Della Torre, T. CABIZZOSU e M. PUDDU, Un catechismo in sardo del 1777, Cagliari, L Unione Sarda, A. CARDIA, Apedala, dimòniu!, Cagliari, I sardi, F. CARLINI, S omini chi bendiat su tempus, Sestu, Zonza, L. COCCO, Poesias de Casteddu, Cagliari, Della Torre,
103 G.M. CONTU, Novenariu cun platicas a su amantissimu coru de Jesus, a cura di M.T. Atzori, Modena, STEM, G. COSSU, La coltivazione de gelsi e propagazione de filugelli in Sardegna, a cura di Giuseppe Marci, Cagliari, CFS/CUEC, 2002, prima edizione R. FRESIA, Ziu Pedru in Casteddu!, Cagliari. D. GARBATI, Contus casteddaius, Cagliari, Condaghes, Mutettus cagliaritani raccolti da Raffa Garzia, Cagliari, EDES, 1977, ristampa dell edizione del 1917 (Bologna, Stabilimenti Poligrafici Riuniti). E.V. MELIS, Ziu Paddori, Cagliari, E. NONNIS, Brevis lezionis de ostetricia, Cagliari, 3T, 1981, ristampa anastatica dell edizione Timon del A. PURQUEDDU, De su tesoru de sa Sardigna, a cura di Giuseppe Marci, Cagliari, CUEC, 1999, prima edizione S.A. SPANO, Sa vid e Gesu Gristu a sa manera nosta, Cagliari, Della Torre, OPERE DI CRITICI, GRAMMATICI E LESSICOGRAFI V. ANGIUS, Sardegna Linguistica Cenni sulla lingua de Sardi scritta e parlata, XIX volume dell opera Dizionario Geografico-Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna di G. Casalis, Cagliari, L Unione Sarda, 2005, ristampa dell edizione Maspero (Torino) del Autori varî, Il meglio della grande poesia in lingua sarda, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, Della Torre, 1975 (su Pintor Sirigu e autori in lingua logudorese). L. ARTIZZU, Il Dizionario di Cagliari, Cagliari, Della Torre,
104 E. ATZENI, Vocabolario domestico sardo-italiano e prontuario italiano-sardo, Cagliari, Forni, 1978, ristampa dell edizione del E. BLASCO FERRER, Storia linguistica della Sardegna, Tübingen, Niemeyer, E. BLASCO FERRER, La lingua sarda contemporanea. Grammatica del logudorese e del campidanese, Cagliari, Della Torre, E. BLASCO FERRER, Ello Ellus. Grammatica della lingua sarda, Nuoro, Poliedro, E. BLASCO FERRER, Pro domo. Grammatica essenziale della lingua sarda, Cagliari, Condaghes, E. BLASCO FERRER, Glossario di linguistica sarda, Cagliari, CUEC, G. CASCIU, Vocabolariu sardu campidanesu-italianu, Dolianova, Grafica del Parteolla, A.L. DE MARTINI, La Limba sarda unificada: un atto di autocolonialismo, su InformAcsit, periodico dell Associazione culturale Sardi in Toscana, anno XIV, Ottobre 2001, pp P.L. LA CROCE, Limbas de Mesania. Grammatica de su sardu e vocabolariu, PTM, A. LEPORI, Dizionario italiano-sardo campidanese, Cagliari, Edizioni Castello, A. LEPORI, Gramàtiga sarda po is campidanesus, Quartu Sant Elena, Edizioni C.R., Limba sarda comuna, a cura della Commissione degli esperti, Regione autonoma della Sardegna, Cagliari, Limba Sarda Unificada, a cura della Commissione degli esperti, Regione autonoma della Sardegna, Cagliari,
105 V. MARTELLI, Vocabolario logudorese-campidanese italiano, Cagliari, Della Torre, 1989, riproduzione anastatica dell edizione del A.R. MAXIA, La grammatica del dialetto cagliaritano, Cagliari, Della Torre, G. MELIS ONNIS, Fueddariu sardu campidanesu-italianu, Selargius, Domus de Janas, G. MURA, Fueddus e chistionis in sardu e italianu, Nuoro, Istituto superiore regionale etnografico, G. PAULIS, Studi sul sardo medievale, su Officina linguistica, Anno I, n. 1, Nuoro, Ilisso, Settembre M. PIRAS, La varietà linguistica del Sulcis, Cagliari, Della Torre, G. PIRODDA, Sardegna, nella collana Letteratura delle regioni d Italia. Storia e testi, Brescia, La Scuola, V. PORRU, Nou dizionariu universali sardu-italianu, Cagliari, 3T, 1981, ristampa anastatica dell edizione del M. PORRU, Cagliari e i suoi poeti in lingua sarda, Cagliari, Edizioni Castello, M. PUDDU, Istoria de sa limba sarda, Selargius, Domus de Janas, M. PUDDU, Ditzionariu de sa limba e de sa cultura sarda, Cagliari, Condaghes, G. ROSSI, Elementus de gramatica de su dialettu sardu meridionali e de sa lingua italiana, Cagliari, A. RUBATTU, Dizionario universale della lingua di Sardegna, Sassari, EDES, Su Sardu de totus, a cura di Comitau Sardu de totus, Quartu,
106 A. SOLMI, Le Carte volgari dell Archivio arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII, su Archivio storico italiano, ser. V, 35, pp , G. SPANO, Vocabolariu sardu-italianu, a cura di Giulio Paulis, Nuoro, Ilisso, 1998, prima edizione M. VIRDIS, Fonetica del dialetto sardo campidanese, Cagliari, Della Torre, M.L. WAGNER, La vita rustica, a cura di Giulio Paulis, Nuoro, Ilisso, 1996, edizione italiana di Wagner M.L. WAGNER, Fonetica storica del sardo, con introduzione, traduzione e appendice di Giulio Paulis, Cagliari, 3T, 1984, edizione italiana di Wagner M.L. WAGNER, La lingua sarda. Storia, spirito e forma, Tübingen-Basel, Francke, 1993, edizione italiana di Wagner M.L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, Cagliari, 3T, 1989, edizione italiana di Wagner
107 Appendice I Giuda nel Libro de comedias di Antonio María da Esterzili La Comedia de la Passion de nuestro Señor Jesu Christo è la piú corposa fra le sacre rappresentazioni del Libro de comedias (1688) di Antonio María da Esterzili. Abbiamo scelto il passo seguente (versi ) come esemplificazione di lingua e stili del frate cappuccino. Le didascalie sono in castigliano. (Agora entran a Christo, y sale Judas con la bolsa en manos echa el dinero en la mesa y se desespera y se ahorca diziendo) Judas. Maledicta siat sa sorti 2070 qui ay gustu imat portadu! Et poita mala morti no mi ayada acabadu innantis de custa notti? Mancari imessiri 129 abruxadu 2075 de una infernali flama po no benni ay gustu istadu! Maladita siat sa mama qui a mimi adi ingendradu. Mortu essiri ixerbeddadu 2080 innantis de custa dij! Mortu essiri apugnaladu solus po non birimi ay custu puntu torradu! Deu, Judas, maledictu 2085 sia de Deus primeramenti 129 = imi essiri. 107
108 essendu qui apu traitu cuddu sanguini innocenti de avaricia ispintu. Cuddus Angelus sagradus 2090 mi malaixanta in ęternu; contra de mei ayradus si mostinti in sempiternu po qui biva cun is dañadus. Maledictu siat su lati 2095 qui mat 130 dadu mama mia! Maladixu in custu instanti is xelus in cumpañia qui a mimi cobertu imanti 131. Maledita siat sa terra 2100 aundi seu abitadu! Contra de mei sa perda cun totu su quest criadu mi fatzanta dura guerra! Maleditu siat totu 2105 qui a mimi at dadu elementu! Po birimi in custu afrontu malaixu aqua et bentu qui andadus mi sunti a tortu. Est impossibili mai 2110 qui alcansi misericordia: segura est capa a istari in continua discordia e in su infferru abruxari. 130 = mi at. 131 = imi anti. 108
109 Disgratiadu, itta appu fattu 2115 de bendiri a su maistu? Certu ca a impicari mappu 132 comenti e vellacu e tristu qui a tottus serbat de ispantu. Ma innantis bollu andari 2120 a is jugis de su senadu po qui iddis bollu torrari sa paga qui manti dadu e de pustis imi impicari. (Va Judas a consejo y buelve el dinero diziendo) Judas. Custus dinaris pigadi 2125 ca no mi gustat su pattu: imeis 133 boffidu ingannari et deu quali mi agatu senza de guadanjari! Cayphas. Pagu idi importat, Judas, 2130 qui cun nosu istesi ayradu: de su qui imoi idi impudas ididdairis pençadu innantis de fairi su peccadu. Tui e tottu bengisisti 2135 e intresti in su senadu y ancu nos promitisti darinosiddu ligadu. 132 = mi appu. 133 = imi eis. 109
110 (Agora se entra el consejo y judas queda en el cadalso diziendo) Judas. Et poitta incontinenti no abaxada unu lampu 2140 in presentia de sa genti possu 134 mali qui appu fattu et torridimi a nienti? O furias infernalis de dimonius in cust hora, 2145 Luciferu principali et Sathanas ancora benjanta po mi impicari. (Agora salen Lucifer, y Sathanas con furia, y dize Lucifer) Luciffer. Itte olis? Nara, amigu, mira cantu prestu seu: 2150 ay guddus qui amu eu iddis accudu et non trigu. Deu seu Lucifferu, cuddu qui tui as llamadu: prontu seu y aparichadu 2155 po ti portari a su infferru. Sathanas. Deu seu Sathanas et benju po ti ajudari si ti olis impicari 134 = po su. 110
111 po qui mai no appas pasu Itte ti pençasta fairi, babu de vera discordia? Non cha 135 prus misericordia undi ti potzas salvari. Ei ga pençis agatari 2165 miserigordia in Deu? Ma comenti deu seu in su infferru asa istari. Judas. Aduncas itta apa a fairi, tristu de mei isventuradu? 2170 Luciffer. Su dugali est pręparadu qui ti potzas impicari, de pustis ti apa a portari a su inferru condennadu. Judas. Ajudadimi aduncas tottu 2175 jai qui seis benidus; fedi qui perda is sentidus et prestu qui sia mortu. Sathanas. Si impicari os boleis custa funi est preparada: 2180 sa cosa a manu teneis, no perdais sa jornada. 135 = non chi at < no inchi at. 111
112 (Judas se pone la cuerda al cuello: con vos temerosa dize) Judas. Hay de mei tristu mesquinu, miradi ainca mat portadu su vadu miu et destinu 2185 que est 136 de morriri impicadu et de mei sia buchinu. A su infferru ęternali intregu custa personi po qui ini apa a pagari 2190 una tali traiçioni qui apu bofidu portari. Luciffer. Andeus imo a su inferru po in sempiternu pęnari y aichi anta acabari 2195 is qui fainti tali hierru. (Judas queda haorcado) (Adesso portano fuori Cristo; sale Giuda con la borsa in mano, getta il denaro sul tavolo, si dispera e s impicca dicendo) Giuda. Maledetta sia la sorte 2070 che a questo mi ha portato! E perché crudele morte 136 = qui est. 112
113 non mi colse prima di questa notte? Magari mi fossi arso 2075 di un infernale fiamma per non venire a questo stato! Maledetta sia la mamma la quale me mi ha generato! Morto fossi con le cervella schiacciate 2080 prima di questo giorno! Morto fossi pugnalato solo per non vedermi giunto a questo punto! Io, Giuda, maledetto 2085 sia da Dio primieramente, essendo che ho tradito quel sangue innocente, spinto da avidità. Quegli angeli sacri 2090 mi maledicano in eterno, contro di me irati si mostrino per sempre, affinché viva con i dannati. Maledetto sia il latte 2095 che m ha dato mamma mia: maledico in quest istante i cieli in sua compagnia, che mi hanno sovrastato. Maledetta sia la terra
114 dove io sono vissuto! Contro di me la pietra, con tutto ciò che è creato, mi facciano dura guerra! Maledetto sia ogni elemento 2105 che a me è toccato perché mi vedessi in questa sorte! Maledico acqua e vento che mi hanno fatto torto. È impossibile che mai 2110 ottenga misericordia: sicuramente starò in perenne sventura, e all inferno brucerò. Disgraziato, che ho fatto? 2115 Vendere il maestro! Certo che m impiccherò come mascalzone tristo: che a tutti serva da sgomento. Ma prima voglio andare 2120 dai giudici del senato poiché voglio loro restituire la paga che mi han dato, e poi impiccarmi. (Va Giuda al consiglio e restituisce il denaro, dicendo) Giuda. Prendete questo denaro 2125 ché non mi aggrada il patto: 114
115 mi avete voluto ingannare, ed io, quale mi trovo, senza niente guadagnare! Caifa. Poco t importa, Giuda, 2130 che con noi stia irato: a quello di cui ora t accusi avresti dovuto pensare 137 prima di commettere peccato. Proprio tu venisti 2135 ed entrasti in senato, ed anche ci promettesti di consegnarcelo legato. (Adesso esce il consiglio e Giuda rimane sul palco dicendo) Giuda. Ma perché immediatamente non scende un lampo 2140 in presenza della gente, per il male che ho fatto, ad annullarmi? O furie infernali, fra i demòni adesso 2145 Lucifero per primo ed anche Satana vengano ad impiccarmi! (Adesso salgono Lucifero e Satana con furia, e dice Lucifero) 137 Lett. te lo fossi pensato! esclamativo. 115
116 Lucifero. Che vuoi? Di, amico, mira quanto sono lesto 2150 Da coloro che io amo accorro presto e non tardo. Io sono Lucifero, quello che tu hai chiamato: sono pronto e preparato 2155 per portarti all inferno. Satana. Io sono Satanasso e vengo per aiutarti se ti vuoi impiccare, perché giammai abbia riposo Che cosa ti credevi di fare, padre di vera discordia: non c è piú misericordia con cui ti possa salvare. E che pensi di trovare 2165 misericordia in Dio? Come è vero che son io, all inferno tu starai. Giuda. Dunque che cosa farò, me meschino sventurato? 2170 Lucifero. La cavezza è preparata, con cui ti possa impiccare, 116
117 poi ti porterò all inferno condannato. Giuda. Aiutatemi dunque tutti 2175 giacché siete venuti: fate che perda i sensi e che sia morto presto. Satana. Se impiccare vi volete questa fune è preparata: 2180 l opportunità avete in mano, non perdete l occasione. (Giuda si pone la corda al collo, e con voce tremante dice) Giuda. Ahimé tristo meschino, guardate dove mi ha portato il mio fato e destino, 2185 che è di morire impiccato ed essere di me carnefice. All inferno eterno consegno questa persona, poiché lí pagherò 2190 un tale tradimento che ho voluto perpetrare. Lucifero. Andiamo adesso all inferno per patire in eterno, e lí finiranno
118 quelli che fanno tale sbaglio. (Giuda resta impiccato). 118
119 Appendice II Il contrasto in campidanese di J.F. Carmona Il cagliaritano Juan Francisco Carmona nacque nella seconda metà del XVI secolo, e fu forse giurato di Cagliari nel Fu autore di un breve dramma sacro in castigliano 139 e delle Alabanças de los santos de Serdeña (1631), manoscritto conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, sotto la sigla Ms. S.P , il quale comprende componimenti in castigliano e catalano. In una delle lodi dei santi (le Alabanças de San George obispo suelense calaritano) l autore inserisce un contrasto fra un colto cittadino di Cagliari ed un pastore di Suelli, nel quale il cittadino è indotto a parlare in campidanese perché il suo interlocutore non capisce il castigliano. Il suddetto testo, che qui si prende in esame, ha grande importanza perché è, fra i monumenti finora conosciuti, la prima attestazione scritta del campidanese moderno, idioma che dal raffinato e ispaneggiantissimo Carmona è adoperata per solo scopo comico. I versi in campidanese sono trentaquattro, e mostrano una lingua sicuramente vicina a quella di Frate Antonio María da Esterzili, posteriore a Carmona di almeno due generazioni e autore della prima opera letteraria in campidanese (Libro de comedias, 1688) 140. È opportuno dunque un confronto fra i due autori, che metta in evidenza le principali differenze linguistiche. Le forme verbali pongu e tengu sono modellate sullo spagnolo, mentre Antonio María userà ancora le forme neolatine ponju e tenju (< lat. *ponjo < poněo): ciò è indice di un maggiore influsso iberico in Cagliari capitale. È rilevante la forma ais (da dais con caduta di d- in fonetica sintattica), V persona dell indicativo presente del verbo dari: i verbi donari e dari sono ancora in competizione, e nel Settecento s imporrà dona(r)i. Un altro esempio di fonetica sintattica si trova in sa ia. Per bere è usato biri, omofono del verbo vedere. Per esprimere l assenza Carmona usa no dua (= no dhu [< dhoi] at), mentre Frate Antonio María preferirà no nchi at. Il pronome interrogativo è ite che cosa?, meno frequente rispetto a it(t)a in Antonio María. In canta genti c è concordanza dell aggettivo col sostantivo (in A.M. sempre cantu invariabile), e cosí pure l indefinito tanta, che al plurale fa tantas, non presenta cambio di declinazione. La congiunzione copulativa è ne (in A.M. ni). La forma *feisti, che si trova in Bullegas 1976, è frutto di un errata lettura del presente feis voi fate. 138 Ciò secondo un interpretazione di S. Bullegas (Il teatro in Sardegna tra cinquecento e seicento, Editrice Democratica Sarda, Cagliari, 1976, pagg , nota 275); non concorda Cenza Thermes, a parere della quale il Carmona, visti i contenuti delle sue opere, poteva essere un sacerdote (Iuan Francisco Carmona, questo sconosciuto, Quaderni Sardi, Trois editore, Cagliari, 1994, pag. 10). 139 Passion de Christo nuestro Señor, pubblicato da F. Alziator nel Non integralmente in campidanese, però, giacché le didascalie sono in castigliano e nei dialoghi sono usati anche il logudorese, il latino e il castigliano. 119
120 Fra gli iberismi semantici in Carmona, si segnala il verbo intendiri col significato dello spagnolo entender capire. In alcuni casi sono presenti forme morfologicamente irregolari, in contrasto con il resto del testo: santo (con -o invece di -u), narademi (e non *naradimi, alla pari di guardadimi). La grafia per molti aspetti si allontana dal modello castigliano: la fricativa prepalatale sorda è espressa con sci (scipiais), la nasale palatale è resa con gn (monsignori), l affricata prepalatale sonora con gi (giorgiu); d altronde si ha ch (aparichadu) per l affricata prepalatale sorda, e l influsso spagnolo è evidente nell avversione per le consonanti geminate (bida paese, seda sella, maravila, onipotenti): è data doppia la sola -rr-, e lo stesso nome del paese del pastore, Suedi, vede l occlusiva cacuminale sonora espressa con la consonante scempia. Il complemento vocativo prevede l uso dell articolo (O sa Virgini maria O Vergine Maria, nada mi su pastori dimmi, pastore ). L interiezione o è marcata da due trattini obliqui sottoscritti. Le maiuscole non sono adoperate con coerenza, e di solito dopo tutti i segni d interpunzione si ha iniziale minuscola. La calligrafia dell opera è poco curata, piena di svolazzi, cosicché spesso parole distinte, scritte non attaccate, risultano unite fra loro. Sul piano metrico, dopo l apostrofe iniziale al pubblico (cinque terzine in rima incatenata), nelle successive strofe di lunghezza variabile, le quali corrispondono agli interventi del cittadino e del pastore, si nota l uso di rime incrociate, alternate e di rado baciate, liberamente disposte; il verso piú usato è l endecasillabo. Per quanto riguarda l aspetto retorico-stilistico, l autore sa ben servirsi di giochi di parole per effetto comico, e frequentemente fa ricorso all allitterazione. Fra i simboli usati in quest edizione, indica lettere aggiunte sopra la parole, M designa il manoscritto. Alabanças de san George obispo Suelense Calaritano Señores 141 hoj silensio a todos pido en este rato y entretenimiento muj alto y celestial dendos 142 oido. No ponga nadie algun Impedimento Ciudadano mas con animo llano y muj devoto 5 de cada qual al alma su alimento. 141 Sopra la lettera n sta un segno arcuato, che pare rappresentare la moderna tilde. 142 In M è possibile leggere anche dendeos (= dend os), ovvero den de os. 120
121 A todos la atension eo mucho exorto pues oira 143 de san George los favores y como Dios con el fue manirroto. Oiran de la su vida los lohores 10 y del premio a las obras conveniente y de la su laureola las flores. Veran nuestro discurso en que es pediente decreto dara fin y necesario quedando a todos claro y muj patente. 15 Pastor. O sa Virgini 144 maria e 145 canta genti in suedi no dua tantas berbeis, ne arboris o deus onipotenti. In artu istau e in seda pongu is peis simbilada asu sartu e asu medadu 20 eite? mi scurtais e no mi rispondeis? Ciudadano. Que tienes di pastor de que te espantas? que nunca has visto pueblo congregado? Pastor. Eite mi nais si seu coiadu? Ciudadano. Que no me entiendes? 25 o que pastor bosal aqui me vino. Pastor. A fidi tengu sidi e istau fadiadu scipiais que es meda atesu su caminu 143 = oiran. La lettera a è sormontata da un archetto. 144 In M è possibile leggere anche Vurigini, che sarebbe una grafia errata di Virgini. 145 La e a inizio di parola di solito è segnata con una virgoletta simile ad un apostrofo. 121
122 e si a biri mi ais, riscotu os apa dari e ancora os tengu casu aparichadu. 30 Ciudadano. Mejor sera que en sardo tanbien able pues algo dello 146 se y nos oigamos nada mi su pastori de undi seis? Pastor. De suedi mi senori e manti cumandadu portari unu presenti a monsignori. 35 Ciudadano. Imoj ià mi Intendeis su que apu nadu. Pastor. Narademi eite este tanta genti In copangia 147 e de quali santu feis inoxi festa? que biu totu sa ia e is fenestras prenas de genti que esti maravila. 40 Ciudadano. Non bieis que hoj feus sa festa e prosesioni di santu giorgiu nostru ecu sa Imagini. Pastor. di santu georgiu di suedi? Ciudadano. Si. Pastor. O santo georgiu nostru beneditu = de ello. 147 = compangia. La lettera p descrive un archetto sopra la o. 122
123 de is sardus abogadu poderosu pregadi pro me poveru e 148 aflitu un arriali os dongu o gloriosu sucurredimi in sa nesesidadi e guardadimi sepiri 149 de onia mali. 50 Ciudadano. Pesadiosindi e basti sa orationi no disturbeis sa festa que eus a fari miradi qui os ispetanta a masoni. Pastor. A una parti cuadu mapa 150 istari fina a biri sa festa a comprimentu 55 e totu apusti in bida apa contari.... (continua in ispagnolo, con l entrata in scena di un cavaliere e di un ecclesiastico) Cittadino. Signori, oggi silenzio chiedo a tutti in questo tempo ed intrattenimento altissimo e sublime, costí da voi a udirsi. Non ponga niun alcun impedimento, ma con animo calmo e assai devoto 5 all alma ognuno dia il suo alimento. A tutti l attenzione molto esorto, l opere udranno infatti di San Giorgio, e come Dio con lui fu generoso. Della sua vita udiranno gli elogi, 10 e del premio adeguato alle sue azioni, e della sua corona i fiori. 148 Qui la lettera e è scritta senza la virgoletta, ed è seguita da una macchia. 149 = sempiri. Le lettere ep sono sormontate da un archetto. 150 M ma pa, con pa. 123
124 Vedranno dove tende il mio sermone: darà giudizio fine e necessario, restando a tutti chiaro e assai palese. 15 Pastore. O Vergine Maria, quanta gente! A Suelli tante pecore non sono, né alberi, o Dio onnipotente! In alto sto e in sella pongo i piedi, somiglia alla campagna e fattoria. 20 Che? M ascoltate e non mi rispondete? Cittadino. Che hai? Parla, pastor, di che hai timore? Non hai mai visto gente riunita? Pastore. Che cosa dite, se sono sposato? Cittadino Non mi capisci? 25 O che pastore sciocco qua m è giunto! Pastore. In fede sento sete e sono stanco, sappiate che il cammino è molto lungo: se a ber mi date, ricotta vi darò; per voi ho anche pronto del formaggio. 30 Cittadino. Meglio sarà che in sardo allora parli, ché so di lui qualcosa, per capirci. Dimmi, pastore, da dove venite 151? 151 Il cittadino, usando il sardo, passa dal tu al voi, mentre in castigliano dava del tu. 124
125 Pastore. Da Suelli, signor mio: m hanno ordinato di portare un regalo a monsignore. 35 Cittadino. Adesso sí, capite quel che ho detto. Pastore. Dite: chi è tutta questa gente insieme e di qual santo qui fate la festa? Vedo la via e tutte le finestre piene di gente, ch è una meraviglia! 40 Cittadino. Non vedete la festa e processione di Santo Giorgio nostro: ecco l immagine. Pastore. Di San Giorgio di Suelli? Cittadino. Sí. Pastore. O Santo Giorgio nostro benedetto, 45 dei sardi difensore poderoso, pregate per me povero ed afflitto. Una moneta dovvi, o glorioso: soccorretemi nella ristrettezza, proteggetemi sempre da ogni male. 50 Cittadino. Alzatevi e vi basti la preghiera! 125
126 Non turbate la festa che faremo: badate che v attendono all ovile. Pastore. Nascosto da una parte mi starò fino a veder la festa a compimento, 55 racconterò poi tutto al mio paese. Glossario Le persone verbali sono indicate con numerazione crescente in cifre romane: le tre persone singolari sono contraddistinte dai numeri I, II e III, le tre plurali dai numeri IV, V e VI. Fra parentesi quadre si trovano quelle forme d infinito, che nel testo non sono presenti. a a 1) prep. Regge il compl. avv. di modo: 27 (a fidi tengu sidi), 55 (biri sa festa a comprimentu); il compl. di termine: 35 (portari unu presenti a monsignori); il compl. di stato in luogo: 54 (a una parti cuadu). 2) cong. Introduce la prop. temporale dopo fina: 55 (fina a biri sa festa a comprimentu). Si usa per il futuro analitico, costrutto in cui può fondersi col verbo ausiliare: 29 due volte (si a biri mi ais, rescotu os apa dari = os apu a dari), 52 (eus a fari), 54 (mapa istari = mi apu a istari), 56 (apa contari = apu a contari). 3) Seguita dall articolo compone la preposizione articolata asu: 20 (simbilada asu sartu e asu medadu). abogadu s.m. difensore : 46 (abogadu poderosu). [afligiri] v. tr. Part. m.s. aflitu: 47 (pregadi pro me poveru e aflitu). [airi] v. intr. avere. Indic. pres.: I apu: 36 (su que apu nadu), e ap-: 29 (riscotu os apa dari), 56 (apa contari racconterò ); III -a: 17 (in suedi no dua tantis berbeis a Suelli non vi sono tante pecore : è da rilevare il costrutto impersonale con du- e airi); IV eus: 52 (sa festa que eus a fari); VI -anti: 34 (manti cumandadu). È usato sempre come ausiliare, tranne che col significato di esservi. ancora avv. m. inoltre : 30 (ancora os tengu casu aparichadu). 126
127 [aparichari] v. tr. preparare. Part. m.s. aparichadu: 30 (os tengu casu aparichadu per voi ho formaggio preparato ). apusti avv. tempo poi : 56 (totu apusti in bida apa contari). arboris s.f. pl. alberi : 18 (in suedi no dua tantas berbeis, ne arboris). arriali s.m. soldo : 48 (un arriali os dongu). artu agg. qual. m.s. alto, usato con valore avv.: 19 (in artu istau sto in alto ). atesu agg. qual. m.s. lungo : 28 (es meda atesu su caminu). basti inter. basta : 51 (basti sa orationi). beneditu agg. qual. m.s. benedetto : 45 (o santo georgiu nostru beneditu). berbeis s.f. pl. pecore : 17 (in suedi no dua tantas berbeis). bida s.f. paese : 56 (totu apusti in bida apa contari). biri (1) v. tr. vedere. Inf.: 55 (fina a biri sa festa a comprimentu). Indic. pres. I biu: 39 (biu totu sa ia e is fenestras). V bieis: 41 (no bieis que hoj feus sa festa). biri (2) v. tr. bere. Inf.: 29 (si a biri mi ais se mi date da bere ). caminu s.m. cammino : 28 (es meda atesu su caminu). canta agg. interr. f.s. quanta, con valore esclamativo: 16 (canta genti). casu s.m. formaggio : 30 (casu aparichadu). [coiari] v. intr. sposare. Part. m.s. coiadu, usato come agg. q.: 24 (Eite mi nais si seu coiadu?). 127
128 comprimentu s.m. compimento : 55 (fina a biri sa festa a comprimentu: ha valore avv.). contari v. tr. raccontare : 56 (totu apusti in bida apa contari). copangia (= compangia) s.f. compagnia : 37 (tanta genti in copangia). [cuari] v. tr. nascondere. Part. m. s. cuadu: 54 (a una parti cuadu mapa istari). [cumandari] v. tr. comandare. Part. m.s. cumandadu: 34 (manti cumandadu portari unu presenti a monsignori). dari v. tr. dare. Inf. (riscotu os apa dari). Ind. pres. V ais, con caduta di d- in fonetica sintattica: 29 (si a biri mi ais). de prep. di. Esprime di solito specificazione o provenienza: 33, 34, 38, 40 (prenas de genti: compl. d abbondanza), 46, 50; di: 42, 43 due volte. deus s.m. Dio : 18 (deus onipotenti). [disturbari] v. tr. disturbare. Cong. pres. V disturbeis: 52 (no distubeis sa festa que eus a fari). [donari] v. tr. donare. Ind. pres. I dongu: 48 (un arriali os dongu o gloriosu). du- avv. luogo ci : 17 (in suedi no dua tantis brebeis). e cong. cop. e : 16, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 34, 38, 39, 41, 47, 50, 51, 56. Ha valore esclamativo in 16 (O sa Virgini maria e canta genti). ecu avv. giud. presentat. ecco : 42 (ecu sa Imagini). eite pron. interr. che cosa? : 21, 24 (eite mi nais si seu coiadu),
129 [essiri] v. intr. essere. Indic. pres. I seu: 24 (Eite mi nais si seu coiadu?); III es: 28 (es meda atesu su caminu), esti: 40 (prenas de genti que esti maravila), e este: 37 (eite este tanta genti In copangia); V seis: 33 (de undi seis?). [fadiari] v. intr. faticare. Part. m.s. fadiadu, con significato di agg. q. stanco : 27 (istau fadiadu). fari v. tr. fare. Inf.: 52 (sa festa que eus a fari). Indic. pres. IV feus: 41 (hoj feus sa festa e prosesioni); V feis: 38 (de quali santu feis inoxi festa?). fenestras s.f. pl. finestre : 39 (totu sa ia e is fenestras). festa s.f. festa : 38 (de quali santu feis inoxi festa?), 52 (no disturbeis sa festa que eus a fari), 55 (fina a biri sa festa a comprimentu). fidi s.f. fede. È usato in senso avv.: 27 (a fidi tengu sidi in fede, effettivamente ho sete ). fina prep. fino : 55 (fina a biri). genti s.f. gente : 16 (canta genti), 37 (tanta genti In copangia), 40 (prenas de genti). georgiu n.p. Giorgio : 43, 45; giorgiu: 42. È San Giorgio, vescovo e patrono di Suelli, morto nel gloriosu agg. qual. m.s. glorioso : 48 (un arriali os dongu o gloriosu). [guardari] v. tr. proteggere. Imp. II p.p. guardadi- (guardadimi sempiri de onia mali). hoj avv. tempo oggi : 41 (hoj feus festa e prosesioni). ia s.f. via : 39 (biu totu sa ia e is fenestras / prenas de genti). Deriva da bia, con caduta della vocale iniziale in fonetica sintattica. ià avv. tempo già : 36 (ià mi Intendeis). 129
130 Imagini s.f. immagine : 42 (di santu giorgiu nostru ecu sa Imagini). Imoj avv. tempo adesso : 36 (Imoj ià mi Intendeis). in prep. in. Regge il complemento di stato in luogo, anche figurato: 17, 19 due volte, 37 (maiuscolo), 49, 56. inoxi avv. luogo qui : 38 (de quali santu feis inoxi festa?). [intendiri] v. tr. intendere. Indic. pres. V Intendeis: 36 (ià mi Intendeis su que apu nadu). [ispetari] v. tr. aspettare. Indic. pres. VI ispetanta: 53 (os ispetanta a masoni). istari v. intr. stare. Inf.: 54 (a una parti cuadu mapa istari). Indic. pres. I istau: 19 (in artu istau), 27 (istau fadiadu). mali s.m. male : 50 (guardadimi sempiri de onia mali). maravila s.f. meraviglia : 40 (prenas de genti que esti maravila). maria s.f. Maria : 16 (Virgini maria). masoni s.m. ovile : 53 (os ispetanta a masoni). me pron. pers. compl. I p. mi : 47. La forma atona è mi (1): proclitica in 21 due volte, 24, 29, 36, e scritta m- davanti al verbo in 34 (manti cumandadu) e 54 (mapa istari); enclitica in 33, 37, 49, 50. meda avv. quant. molto : 28 (es meda atesu su caminu). medadu s.m. fattoria : 20 (simbilada asu sartu e asu medadu). mi (2) agg. poss. mio : 34 (mi senori). [mirari] v. intr. badare. Imp. V miradi: 53 (miradi qui os ispetanta a masoni). 130
131 monsignori s.m. monsignore, vescovo : 35 (portari unu presenti a monsignori). [narri] v. tr. dire. Indic. pres. V nais: 24 (Eite mi nais si seu coiadu). Imp. II nada-: 33 (nada mi su pastori de undi seis); V narade-: 37 (narademi eite este tanta genti). Part. m.s. nadu: 36 (su que apu nadu). -ndi pron. pers. ne : 51 (pesadiosindi). ne cong. cop. né : 18. nesesidadi s.f. necessità : 49 (sucurredimi in sa nesesidadi). no avv. giud. neg. non : 52; non: 41. nostru agg. poss. nostro : 42 (santu giorgiu nostru), 45. o interiez. o : 16 (O sa Virgini maria), 18 (o deus onipotenti), 45 (O santo georgiu), 48 (o gloriosu). onia agg. indef. ogni (onia mali): 50 (guardadimi sempiri de onia mali). onipotenti agg. qual. m.s. onnipotente : 18 (deus onipotenti). orationi s.f. orazione : 51 (pesadiosindi e basti sa orationi). os pron. pers. compl. atono V p. vi : 29, 30, 48, 53; -osi-: 51 (pesadiosindi). parti s.f. parte : 54 (a una parti cuadu). peis s. m. pl. piedi : 19 (in seda pongu is peis). pesari v. rifl. alzarsi. Imp. V pesadi-: 51 (pesadiosindi e basti sa orationi). 131
132 poderosu agg. qual. m.s. potente : 46 (abogadu poderosu). [poniri] v. tr. porre. Indic. pres. I pongu: 19 (in seda pongu is peis). portari v. tr. portare. Inf.: 34 (portari unu presenti a monsignori). poveru agg. qual. m.s. povero : 47 (pregadi pro me poveru e aflitu). [pregari] v. intr. pregare. Imp. V pregadi: 47 (pregadi pro me poveru e aflitu). prenas agg. qual. f.p.: 40 (sa ia e is fenestras / prenas de genti). presenti s.m. presente, dono : 35 (portari unu presenti a monsignori). pro prep. per : 47 (pregadi pro me poveru e aflitu). prosesioni s.f. processione : 41 (no bieis que hoj feus sa festa e prosesioni). quali agg. interr. m.s. quale : 38 (de quali santu feis inoxi festa?). que (1) cong. che. 1) dichiarativa: 41 (no bieis que hoj feus sa festa e prosesioni). 2) causale: 39 (que biu totu sa ia e is fenestras); qui: 53 (miradi qui os ispetanta a masoni). 3) consecutiva: 40 (sa ia e is fenestras / prenas de genti que esti maravila). que (2) pron. rel. che : 36 (su que apu nadu), 52 (sa festa que eus a fari). riscotu s.m. ricotta : 29 (riscotu os apa dari). [rispondiri] v. intr. rispondere. Indic. pres. V rispondeis: 21 (mi scurtais e no mi rispondeis?). santu s.m. santo : 38 (de quali santu feis inoxi festa?); santo: 45 (o santo georgiu nostru). sardus s.m. pl. sardi : 46 (de is sardus abogadu poderosu). 132
133 sartu s.m. campagna : 20 (simbilada asu sartu). [sciri] v. tr. sapere. Cong. pres. V scipiais: 28 (scipiais que es meda atesu su caminu). [scurtari] v. tr. ascoltare. Indic. pres. V scurtais: 21 (mi scurtais e no mi rispondeis?). seda s.f. sella : 19 (in seda pongu is peis). sepiri (= sempiri) avv. tempo sempre : 50 (guardadimi sempiri de onia mali). senori s.m. signore : 34 (mi senori). si (1) avv. giud. afferm. sí : 44. si (2) cong. condiz. se : 24 (Eite mi nais si seu coiadu?), 29 (si a biri mi ais). sidi s.m. sete : 27 (A fidi tengu sidi). [simbilari] v. intr. somigliare. Indic. pres. III simbilada: 20 (simbilada asu sartu). su 1) art. det. m.s. il : 28, 33 (nada mi su pastori: introduce il compl. vocativo); f.s. sa: 16, 39, 41, 42, 49, 51, 52, 55; m.p. is: 19, 46; f.p. 39. Forma prep. artic. con a: 20 (asu sartu e asu medadu). 2) pron. dim. m.s. ciò : 36 (su que apu nadu). [sucurriri] v. tr. soccorrere. Imp. V sucurredi-: 49 (sucurredimi in sa nesesidadi). suedi s.m. Suelli : 17, 34, 43. È il paese del pastore e di San Giorgio. tanta agg. indef. f.s. tanta : 37 (tanta genti in copangia); f.p. tantis: 17 (tantis berbeis). [teniri] v. tr. avere. Indic. pres. I tengu: 27 (A fidi tengu sidi). 133
134 totu agg. e pron. indef. tutto. Pron. m.s.: 56 (totu apusti in bida apa contari). Agg. f.s. e p.: 39 (totu sa ia e is fenestras: usato davanti ai sostantivi, cui si riferisce, non muta per genere e numero). undi avv. luogo dove : 33 (de undi seis?). unu art. indet. m.s. uno : 35 (portari unu presenti); un: 48 (un arriali os dongu). Femm. una: 54 (a una parti cuadu mapa istari). Virgini s.f. vergine : 16 (Virgini maria). (Pubblicato sul numero 15 di NAE) 134
135 Appendice III Due poesie dal Novenariu di J.M. Contu Il Novenariu cun platicas a su amantissimu coru de Jesus è un codice manoscritto conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, dove è siglato Ms. 152, e consta di 318 fogli. L autore è il Reverendo Padre Juan María Contu, appartenente all ordine dei Frati Minori, che nella prima pagina si presenta come Calaritanu, de sa Regulari Observancia de su S.P.S. 152 Franciscu, Letori in Sagrada Theologia, Qualificadori de sa Santa Inquisicioni in su Archibiscobadu de Oristanis, e Predicadori Apostolicu in sa Provincia de S. Saturninu Martiri Calaritanu in Sardiña. Le cariche sopra elencate erano fra le piú prestigiose per un ecclesiastico sardo, e il Contu vi accesse certamente dopo il 1726, anno in cui fu predicatore conventuale annuale e, in tale veste, prese parte al capitolo provinciale, celebrato nel convento di S. Mauro in Cagliari il 2 ottobre Il Contu morí nel 1762, cosicché la composizione del Novenariu è da collocare fra le due date suddette. Scrisse altre due opere, entrambe in lingua spagnola, che sono anch esse custodite alla Biblioteca Universitaria di Cagliari, la Obra poetica, sermon y novenario del Beato Salvador de Horta (Ms. S.P ), e la Vida del Venerable Fray Salvador Vidal marense (Ms. S.P ). Il Novenariu è una corposa opera paraliturgica, che descrive la corretta celebrazione della novena, ovvero dei riti che si svolgono nei nove dí precedenti le piú importanti festività cristiane. Le platicas 153 del titolo sono le prediche tenute in ciascuno dei giorni di novena. Il libro si compone di una dedica, un prologo, sermoni e preghiere ordinati secondo le nove giornate, un indice d avvertenze, un catalogo degli autori citati, un indice dei passi della Sacra Scrittura e, infine, un indice delle cose notevoli. Il Novenariu occupa un posto importante nella storia della lingua sarda campidanese, soprattutto perché è la prima opera moderna in prosa pervenutaci: essa è scritta in uno stile limpido e scorrevole, di gradevole lettura anche per i profani. Particolarmente accurati sono gli indici, nei quali sono riportate tutte le citazioni poste, nei paragrafi dedicati alle singole giornate della novena, ai bordi di pagina: il Contu appare un uomo di Chiesa colto e particolarmente meticoloso, come mostra la sua pregevole calligrafia, e, pur agendo da pioniere nel campo della prosa religiosa campidanese, mostra una padronanza linguistica considerevole. Le sue scelte grafiche, per esempio, sono coerenti perché, soprattutto, non rivelano quelle oscillazioni che invece caratterizzano autori a lui precedenti e contemporanei (e per la verità anche successivi). Indichiamo ora qualche tratto linguistico importante. Nel campo della grafia il grafema x è usato per indicare diversi fonemi: /ʒ/, /dʒ/ (in alternanza con j e, di rado, g), / / (in netta prevalenza su z) e /t /, anche in fonetica sintattica. In morfologia spicca la conservazione del perfetto, di tipo sigmatico 152 Serafico Padre Santo. 153 Sp. platica predica, sermone, oggi piú adoperato nel senso di conversazione, colloquio. 135
136 in (-esi) e regolarmente impiegato: morjesit morí. Il gerundio è in -endu; sono conservative le forme dell infinito in -ari e -iri, e del participio passato maschile in -adu, -idu, mentre all imperativo troviamo sia confirmadi e concedeinosi concedeteci (con mantenimento della fricativa), sia adornaiddu e preneidda, forme piú moderne. I pronomi con funzioni di complemento, alla I e II persona plurale, sono -nos(i) e -os(i), ma spunta anche qualche -si proclitico, oggi prevalente in campidanese. Non mancano voci colte e lontane dall uso popolare, come su cali e quartu. Nel lessico sono riscontrabili varî iberismi, che il Contu adopera moderatamente ma palesando, allo stesso tempo, un ottima conoscenza dello spagnolo. Presentiamo qui due poesie, inserite rispettivamente nella prima e nella terza giornata di novena, le quali, per caratteristiche tematiche e formali, rientrano nel genere letterario delle lodi dei santi, che in Sardegna presero il nome di gosos in logudorese e gòçus in campidanese. La prima poesia, in versi ottonarî, che si trova alle pagine 30 e 31 del manoscritto, è costituita da una quartina con schema metrico ABBA, che funge anche da ritornello; cinque ottave, lo schema metrico della prima delle quali è CDDCBAxy, dove x e y sono gli stessi versi terzo e quarto della quartina iniziale, mentre B è in rima con x e A è in rima con y; una quartina finale, dove, in confronto colla quartina iniziale, il primo verso è differente ma in rima col corrispondente primo verso, mentre i versi restanti sono uguali. La seconda poesia proposta (pp ), pure essa dedicata al cuore di Gesú, ha la particolarità d essere scritta in versi senarî: ciò costituisce una rarità nella letteratura sacra sarda, ma non mancano esempî di suo uso in antiche lodi e italiane e spagnole, nelle quali ultime il primo accento metrico del singolo verso cadeva sulla terza sillaba anziché sulla seconda, come di norma in un senario (in Contu codesto primo accento cade a volte sulla seconda sillaba, a volte sulla terza). Un altra differenza col primo componimento sta nella struttura strofica, che qui è, come si vede nella prima ottava, CDDCCAxy, dove il sesto verso è in rima col primo e col quarto della quartina iniziale ABBA. Anche in questa poesia le ottave sono composte secondo il principio della rima incrociata. Si segnalano in nota i fatti linguistici interessanti. VERSUS SARDUS DE SU AMANTISSIMU CORU DE JESUS 136
137 po sa prima di de sa Novena. O coru divinizadu! Ti istimu, ti amu 154, e ti adoru; O dulzura de su coru! Sentu 155, qui non ti apu amadu. Si repitit. Si despidis 156 resplandoris Est po mi donari luxi; Posta in su coru sa ruxi Manifestu prus amoris; O instrumentu sonoru Cun is llamas concertadu 157! O dulzura de su coru! Sentu, qui non ti apu amadu. Si repitit. Cun invencionis divinas, E ingenius 158 prenus de amoris, Ses gravellu inter is floris; Ses Rosa inter is ispinas 159 ; Inter metallus, ses oru 154 E usata qui la coppia di verbi stimai e amai. Scrive Wagner, citando R. Garzia: amare,-ai... ha un significato generico, quindi piuttosto vago e indeterminato: è quel bene momentaneo che si vuole a una persona o a una cosa che desta e attira la nostra attenzione, anzi la nostra simpatia: Stimai è dell amore profondo, schietto, intimo, dell amore in una parola (Garzia, Mut. Cagl., no. 151) (M.L.WAGNER, Dizionario Etimologico Sardo, ed. Trois 1989, vol. I, pag. 77). 155 sentire, -i log. e camp. sentire (ma mai nel senso di sentire coll udito... che è intèndere, - iri). Invece si impiega spesso nel senso di dolere, essere spiacevole... Questo è il senso dello sp. e cat. sentir. Anche sentimentu ha il senso di dolore, compianto... = sp. sentimiento... cat. sentiment (DES, II, 405). 156 dispeđire log.: dispiđiri camp. congedare, = sp.-cat. despedir... In log. si usa... anche nel senso di spargere, spandere ( difundir o esparcir olor, rayos de luz )... In questo senso lo usava anche Fra A.M. di Esterzili (DES, I, 472). Abbiamo qui dunque un altra attestazione del suddetto senso secondario. Anche il resplandoris seguente è schietto spagnolismo. 157 Questo verbo ha qui, piuttosto che il senso primario di comporre, ordinare, aggiustare = sp.-cat. concertar (DES, I, 434), la specifica accezione musicale di accordare (Dizionario italiano-spagnolo e spagnolo-italiano, Collins Mondadori, 1985, parte II, pag. 46). 158 Anche questa parola, nel significato di ispirazioni, è uno spagnolismo: ingenio m. enginy; ingeni; inspiració (Canigó, diccionari iŀlustrat català-castellà castellà-català, Sopena, Barcelona, 1990, pag. 708). 159 In campidanese i sostantivi con s+cons. iniziale di parola prendono, al plurale, e obbligatoriamente quando seguono l articolo determinativo, una i- prostetica, che è facoltativa al singolare. Il Contu la usa anche al singolare. 137
138 Brillanti, e purificadu. O dulzura de su coru! Sentu, qui non ti apu amadu. Si repitit. Sentu meda sa lanzada Qui su coru ti hat abertu, E sentu, qui restis 160 fertu Cun llaga tanti penada; Qui est de su amori, no ignoru Cussu coru traspassadu. O dulzura de su coru! Sentu, qui non ti apu amadu. Si repitit. Sentu, qui non sentu prus Su tempus, qui apu perdidu; Sentu, qui ti apu ofendidu Clementissimu JESUS; Cun is intrañas ti adoru Coru, de coru istimadu. O dulzura de su coru! Sentu qui non ti apu amadu. Si repitit. Sa ingratitudini mia Cun tanti dolori sentu, Qui de puru sentimentu 161 Morrir 162 milli ortas 163 bolia 164. O celestiali thesoru! Perdonami, qui apu erradu. 160 Questa voce verbale è sicuramente un presente indicativo di II pers. sing., dunque ci aspetteremmo * restas e non restis: poiché non si tratta di vocabolo sardo genuino, è probabile che sia un italianismo morfologico. 161 Cfr. nota n Apocope per morriri. 163 Caduta di b- iniziale in fonetica sintattica. 164 L imperfetto indicativo può sostituire il condizionale passato nel periodo ipotetico. 138
139 O dulzura de su coru! Sentu, qui non ti apu amadu. Si repitit. O coru amanti, e sagradu! Ti istimu, ti amu, e ti adoru; O dulzura de su coru! Sentu, qui non ti apu amadu. Si repitit. Versi sardi dell amorosissimo cuore di Gesú per il primo giorno della novena O cuore divinizzato! T amo, ti voglio bene e t adoro; o dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) Se diffondi bagliori è per darmi luce; posta nel cuore la croce tu manifesti piú amori; o strumento sonoro accordato con le fiamme! O dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) Con invenzioni divine e ispirazioni piene d amore sei garofano tra i fiori, 139
140 e sei rosa fra le spine; tra i metalli sei oro brillante e purificato. O dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) Patisco molto la ferita che t ha aperto il cuore, e sento che resti ferito con piaga tanto penosa; non ignoro che codesto cuore è trapassato d amore. O dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) Soffro perché non percepisco piú il tempo che ho perso, sento che t ho offeso, clementissimo Gesú; con le viscere t adoro, o cuore, amato di cuore. o dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) La mia ingratitudine patisco con tanto dolore, che, di puro compianto, vorrei morire mille volte. O celestiale tesoro! Perdonami poiché ho errato. O dolcezza del cuore! 140
141 Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) O cuore amoroso e consacrato! T amo, ti voglio bene e t adoro; o dolcezza del cuore! Mi dolgo di non averti amato. (Si ripete) ****** VERSUS po sa terza di de sa Novena. Coru prus preciadu De sa plata, y oru; De JESUS 165 su coru Siat alabadu. Si repitit. O coru divinu! Qui nos donas luxi, Cun sa hermosa ruxi Qui portas in sinu; Coru amanti finu 166 De pagus amadu. De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. 165 In tutto il Novenariu i nomi JESUS e MARIA sono sempre scritti maiuscoli. 166 Italianismo (fino, variante regionale di fine, dal lat. finis), come il fiu della quarta strofa. 141
142 Coru, qui ti inclinas A su pecadori; O coru de amori! E gracias divinas, De cruelis ispinas 167 Coru traspassadu. De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. Po su coru ostu Divinu JESUS, Non boleus prus Custu coru nostu; O coru dispostu A essi llagadu! De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. Su sanguni a fiu Currit de is llagas, E cun cussu pagas Su pecadu miu; O JESUS confiu Essi perdonadu De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. E poita mi clamas Coru adoloridu 168? 167 Cfr. nota n Dal cat. adolorir. 142
143 Si ti apu ofendidu Poita tanti mi amas? In ardentis llamas 169 Restas inflamadu. De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. De xelu 170 abaxadu Celesti thesoru, De JESUS su coru Siat alabadu. Si repitit. Versi per il terzo giorno della novena. Cuore piú prezioso dell argento e dell oro; di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) O cuore divino, che ci dài luce con la bella croce che porti in seno! cuore amoroso e puro da pochi amato. Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) 169 Dallo sp. llama; la voce sarda è flama / frama, che si ritrova nella radice dell inflamadu al verso seguente. 170 Scrittura fonetica per su celu. 143
144 Cuore, che ti inchini al peccatore; o cuore d amore e grazie divine! Da crudeli spine cuore trapassato 171. Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) Per il cuore vostro, divino Gesú, non vogliamo piú questo cuore nostro; o cuore disposto a essere piagato! Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) Il sangue, come fio 172, scorre dalle piaghe, e con ciò paghi il mio peccato; O Gesú, confido d essere perdonato. Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) E perché mi chiami, 171 Separiamo cosí, nella traduzione, per mezzo del punto esclamativo, il quarto verso dal quinto, giacché ispinas pare legarsi soltanto a Coru traspassadu. 172 Gesú paga cioè il fio delle colpe commesse dall umanità. 144
145 o cuore addolorato? Se t ho offeso perché mi ami tanto? In fiamme ardenti resti infiammato. Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) Dal cielo disceso celeste tesoro, Di Gesú il cuore sia lodato. (Si ripete) (Pubblicato sul numero 6 di NAE) 145
146 Appendice IV La Vida de Santu Potitu La Vida, Miraculus, e Martiriu de Santu Potitu è un codice manoscritto anonimo non datato di quattro fogli, facente parte della collezione Baylle, catalogato S.P. 6 bis dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari, dove è conservato. Nel sottotitolo esso è detto traduzione in sardo dell opera scritta in latino, presente in un codice cagliaritano e già inviata al famoso annalista ecclesiastico, il cardinale Cesare Baronio ( ). La Vida descrive le straordinarie imprese di San Potito, sardo di nascita e martire all età di soli tredici anni 173. Al termine della narrazione della vita del santo, è citato il passo degli Annales Sardiniae di frate Salvador Vidal ( ), nel quale è trattato tale argomento. Si dice poi che, nel suddetto passo di Vidal, e in uno degli Annales Ecclesiastici del cardinale Baronio, è presentata la data del martirio; seguono alcune notizie sulla collocazione dei resti del santo, desunte dalla Chronica Sanctorum Sardiniae dello storico Dimas Serpi ( ). La Vida è un importante documento della lingua sarda campidanese di alcuni secoli orsono, ancor oggi facilmente comprensibile: vediamone le caratteristiche piú interessanti, a cominciare dalla grafia. I gruppi ch e gh, davanti a e ed i, indicano suono gutturale, come in italiano, e cosí pure i corrispondenti suoni palatali sono espressi alla maniera italiana con ci,ce e gi,ge; per l affricata prepalatale sonora davanti a u, a, o, sono presenti le due forme con gi- e j-, quest ultima alla spagnola (Angiulu e Anjulu, giai e disiju). La cacuminale sonora è sempre data da dh (cudha). Le occlusive e nasali intervocaliche sono rese o con scempia, o con geminata (babbu, possibbili, immoi ma ecu, comenti, imoi; subbitu e accapiau manifestano, in una parola stessa, le due diverse tendenze di scrittura). Le palatali nasali e laterali si presentano con gn e gl seguite da e/i: in un occasione sola si ha degoglaidhu. La fricativa prepalatale sorda è espressa con sc (apparescit), con x (executau) e con sx (nisxunu), la corrispondente sonora solo con x (boxis, quindixi). L affricata dentale sorda è resa sempre con z scempia (poza). Non mancano, infine, esempî di scritture etimologiche (exiliau, Christu). Ciò che piú colpisce nel manoscritto, peraltro, è l accentazione indicata nella maggioranza delle parole, e la distinzione delle vocali e ed o secondo la loro apertura e chiusura: le vocali toniche i ed u (per natura sempre chiuse), a (per natura sempre aperta), e aperta e o aperta sono segnate tutte con accento grave, mentre e ed o chiuse sono indicate con i due punti soprastanti (ë, ö). Un indicazione tanto meticolosa induce a pensare ad un traduttore dagli spiccati interessi linguistici, ma il fatto che spesso l accento sia una correzione del punto sopra 173 Alle gesta di San Potito, diffuse nella narrativa popolare cristiana, dedicò un libro raffinato e ironico l umanista Leon Battista Alberti, per criticare l esaltazione della passività e della devozione al martirio tanto apprezzati dalla Chiesa. 146
147 la i, consente di supporre l intervento successivo di una mano diversa, come suggerisce pure l inserimento a bordo di pagina della congiunzione chi dopo un pues: ciò, probabilmente, è opera di un altra persona, benché poi vi sia un occorrenza dello stesso pues chi (pués è congiunzione causale castigliana, passata in sardo ed usata, fra gli altri, da Giovanni Delogu Ibba nel Settecento e Antonio María da Esterzili alla fine del Seicento; cominciò quindi a indebolirsi il suo valore causale a vantaggio di quello d avverbio di tempo, e le si aggiunse allora, per mantenere il significato causale, l altra congiunzione chi, forse per influsso dell italiano poiché). Nella punteggiatura va rilevato l uso, anch esso secentesco, della virgola prima della congiunzione e. Sul piano specificamente fonetico, è notevole l uso del verbo getai, con affricata prepalatale sonora, in luogo del moderno ghettai; in bandat e bessiri s osserva l incorporazione dell originario avverbio di luogo bi nel verbo per fonetica sintattica, mentre l articolo determinativo non subisce elisione, ché invece avviene aferesi della vocale successiva (su mperiu). In morfologia si nota: l uso di uno specifico pronome complemento per la seconda persona singolare (de tei); forme d imperfetto in -eda, alternate con quelle in -iat, nella coniugazione in -iri; gerundio in -endu, talvolta prolungato in -enduru; congiuntivo presente di lassai in lessi; congiuntivo imperfetto regolarmente in -essi, ma è presente anche un fussit, di sicura origine italiana, al posto dell abituale fessit; compresenza di forme participiali diverse in uno stesso verbo (istada e istetia). Il participio passato della coniugazione in -ai è -au al maschile, mentre la coniugazione in -iri (e piana e sdrucciola) mantiene la fricativa intervocalica (posseída, lömpida). Il perfetto non è attestato, ed è normalmente supplito nelle sue funzioni dal trapassato prossimo. Nella sintassi meritano attenzione l uso del condizionale presente nella dichiarativa subordinata, quando essa esprime un azione futura (naràda chi no nd iat a benni); la protasi dell irrealtà all indicativo imperfetto (si no beniat...); il gerundio con funzione di participio congiunto (henduridhu agatau fend orazioni); la subordinata implicita con soggetto diverso da quello della reggente (dhu presentant a is leonis po essiri devorau). Il lessico è caratterizzato da una gran mole d ispanismi, alcuni non rintracciabili nei vocabolarî di sardo (è il caso di apparesciri < cat. appareixer, e posseída < sp. e cat. pos(s)eida). Non è però da trascurare il peso degli italianismi, dei quali alcuni esprimono sottili sfumature di significato (portai sopportare e parai prospettare, dall it. porgere, offrire ), altri sono calchi (is calis). In definitiva, la Vida de Santu Potitu sembra ascrivibile all epoca di transizione culturale della Sardegna dall orbita spagnola a quella italiana, ed è lecito collocare cronologicamente la composizione del manoscritto intorno all anno Vida, Miráculus e Martíriu de 147
148 Santu Potítu 174, Tradúsida in sardu de sa scritta in latínu in su Cödigu Calaritánu, sa chi si fiat imbiáda a Cardináli Baröniu zélebri Annalísta Ecclesiásticu. su Santu Potítu Sardu de nazióni, fillu de Hila hömini nobbilíssimu, de pitichëdhu híat cumenzáu a serbíri a su Dëus de xëlu, e terra. Biéndu Hilas idólatra, chi su fillu suu Potítu fiat Cristiánu, dhu portât pesadamente: e ponéda tötu su cuidáu possíbbili po ndëdhu appartái de Gësu Christu 175 ; ma in vanu fiat andáu töttu su trabbállu suu. Po su chi dh híat pöstu in presóni, proibendurídhi töt alimëntu, e naréndur idhi: biáus immói, 176 si su Dëus, chi adóras t hat a donái pani po papái. Ma Potítu recurrénd a Dëus cun s orazióni fed istëtiu alimentáu po mësu de un Ángiulu; aíci coménti su Proféta Abacúc, sendu in su lacu de is Leónis, híat tëntu s alimëntu po manus de s Anjulu. 177 De custa manéra Potítu po ispáziu de medas dîs fiat istáu sustentáu de un Ánjulu. 178 Meda tëmpus fiat passáu in chi cun losíngus, e ammelézus hiat procuráu Hilas distráiri a Potítu de sa fidi Christiána senza bessiríndi cun su ntëntu. A su fini podit Potítu fuíri de presóni, e acuáisí in dunu böscu 179 appartenénti a Zëperu, aundi s Ánjulu si dh 180 apparéxidi, paréndur idhi is persecuziónis, e gherras de su Dimöniu, e preparéndur idhu 181 cun instruziónis contra is insídias, e tentaziónis de s Enemígu. Apénas s apártat s Ánjulu, écu Satanássu grandu dimöniu si apparéscit arriéndu, e coment e chi dh olëssit abbrassái dhi narat: o Potítu ita fais? Torra a domu de babbu tû, chi de lögu in lögu ti circat prangéndu, e gosadí de is benis, e richésas suas 182 ; pues chi 183 no tenit atturu, sinó a tui; tui ses sa pipía de is ogus sûs. Respóndit Potítu. Chini ses tui, po chi poza 184 obbidíri a is cunzillus, chi mi donas? Narat Satanás. Deu seu Gesu Christu Segnóri, e Dëus tû, chi disíju 185 meda sa salúdi de s ánima tua. Dhu mirat attëntu Potítu, e avértit chi portáda is carcánjus eleváus de terra, luégu si fait sa Gruxi, e arzend is ógus a Cëlu pregat a Dëus: súbbitu su dimöniu si únfrada, e s árziat in ária casi quíndixi brazus. Isclámat Potítu: foras de mei Satanás, torra in palas, poíta 186 mi tentas? No has a pódiri prevaléssiri contra de mei, chi seu sërvu de Gësu Christu. Su dimöniu inzáras si fúrriat in mallöru e muinéndu, cun grandu fierésa paríat de bóllir imbistíri contra 174 Sopra il titolo si legge N. XI, che è scritto dalla stessa mano dell autore anonimo; a destra della prima riga si legge 1., che indica il primo foglio; a destra della seconda riga si legge /ms. Baille Questi ultimi sono tutti segni di catalogazione, aggiunti successivamente alla stesura del manoscritto. 175 Una linea unisce la -u alla C-. Ciò avviene sempre in presenza del nome Gesu Christu. 176 Sopra la virgola si può leggere un puntino. 177 Segue una cancellatura ( ). In De cu- l inchiostro è molto denso. 178 In M il punto manca. 179 Segue. 180 Una linea prolunga la -i in segno d unione alla d-, che si trova a capo della riga successiva dh- si legge a malapena a causa di una macchia d inchiostro. 182 La s- è coperta da una macchia. 183 Questo chi pare essere aggiunto da mano diversa. 184 Segue. 185 disiju > disíju. 186 poita > poíta. 148
149 Potítu, ma issu fendusí sa Gruxi dhi getat manus in pizus, e 187 aferréndurídhu a is corrus, dhu getat a terra, dh accápiat a quatru peis, e dhi stat asúba acarcighendur idhu; issu peró de suta vomitáda flamas de fögu de is ogus, cárigas, e buca, fendu talis boxis, chi paríat trémiri sa terra a ingíriu. In su mentras pregáda a Potítu naréndu: Lassa m andái po chi pighi algúnu refrigëriu de is torméntus, chi mi donas. Poita m has getáu in tanti fögu? Tötu m abbrúxu; teni cumpassioni de mei, e de is dolóris mius. Sa Gruxi de Gësu Christu (narat S.Potítu) t hat accapiáu; ma si olis chi ti lëssi ti cumandu, bëstia infernali, po virtúdi da sa Santa Gruxi, chi no fazas mali a Christiánu perúnu. Inzáras su dimöniu zerriéndu prus forti, e strepiténdu narat: ahi chi unu pipíu mi bíncit 188! Ma ti promíttu, ch in pena de su chi m has fattu, has a accabbái sa vida in torméntus: iscíu, Potítu, su ch hapa a fai in Roma 189 : bai po imói, e ispétta 190 sa vengánza. Fuíu si fíat 191 su dimöniu boxinéndu përi su böscu, e Potítu dhu insultada. Áttara dî Potítu bandat a sa Ziutádi de Valëria, e accánt e s arríu 192, chi currit bixinu, si sezit po si discanzái; pustis intrat in sa Ziutádi predichéndu a su pöpulu. Inci fiat inní una fëmina chi si narát Luiríaca 193, mulléri de Agathóni Senadóri, tott issa prena de lepra, a sa chi S.Potítu dh íat sanáda cun sölus fairídhi sa Gruxi; e a vistas de custu miráculu issa cun meda pöpulu de cudhu lögu si fet convërtia a sa fidi de Gësu Christu. Intertántu Hilas babbu de Potítu circáda de torrái a arrególliri su fillu, ne dh híat pöziu ténnir in manus, 194 po essir istëtiu avisáu Potítu de s Ánjulu; hendu 195 pués agatáu bastimëntu s imbárcat, e andat a Roma. Inní passát sa vida piadosamenti, e santamenti cun átterus christiánus. Ma no podéndu istái occúlta sa santidádi sua, Dëus híat böfiu, chi fëssit ancóra manifésta a su Mperadóri Antonínu Piu, su cali teníat sa filla sua Agnesa ispiridáda, e posseída de su pröpiu dimöniu, chi Potítu 196 híat afrontáu, e attormentáu in Zëperu. 197 Custu fuedhendu in buca de Agnesa naráda 198 chi no ndíat a bessíri de cörpus de issa, si no beníat Potítu Sardu antis 199 chi dh hiat a bocíri. Intendéndu custu su Mperadóri cumándat si circhit Potítu 200, y hendurídhu agatáu in su monti fend orazióni, dhu pórtant a presënzia de su Mperadóri, su chi dhu fuedhat in custa manéra. Su struëndu, e sa fama de is cosas maravigliósas chi fais est lömpida a is orígas mias; Potítu, si líbberas a filla mia de su dimöniu, t hapa carrigái de richésas, e in sa corti mia de honóris. Dhi 187 e. 188 bincit > bíncit. 189 Sopra la -o- c è un punto. 190 In interlinea ( ) una macchia. Un altra piccola macchia è sotto la -e fiat > fíat. 192 arriu > arríu. 193 Luíriaca > Luiríaca. 194 Il punto è corretto in virgola. 195 M Hendu. 196 potítu > Potítu. 197 Dopo Zëperu il punto è ripetuto. 198 Dopo naráda si può leggere una virgola. 199 La -s è coperta da una macchia. 200 Potitu > Potítu. 149
150 respóndit Potítu: prus honóri, e prus richésa est serbíri a Gësu Christu Creadóri de Celu, e terra, e 201 chi rëinat in su Cëlu: crei in Iesu, o Imperadóri, poíta ch esti su verdadëru Dëus. Niénti a custu respondéndu su Mperadóri, tórrat a dhi nai: Potítu líbbera a filla mia de su dimöniu, custu esti su chi 202 bollu de tei. Inzáras Potítu cumándat a su dimöniu, in nómini de Gësu Christu, ch indi bessat de cudha criatúra, e súbbitu ndi bëssit in presënzia de töt is chi fenta inní; is calis a grandus boxis naránta, chi grandu e potentíssimu fiat su Dëus de Potítu. Intándu su 203 Mperadóri cun medas arrexónis solizitàda 204 a Potítu, chi sacrifichëssit a is Ídolus 205, promitténdur idhi grandus arregálus, ma issu forti, e immöbbili coménte iscögliu in mës e mari, predicáda sa fidi Christiána, e sind arríat de is promissas de su Mperadóri; custu dhu pórtat 206 cun sëgus a su tëmplu de is ídolus, e sendur in faci insóru dhi narat: mira Potítu, custus sunt is verdadérus déus, chi si tui dhus adóras, e dhis donas inzënsu, t hap a fai Prínzipi in su mpëriu miu. Ma Potítu arzénd is ogus a Cëlu, pregat a Dëus, e luégu nd arrúint is ídolus a terra fattus a rogus. Indinnáu de custu su Mperadori, cumándat siat pöstu Potítu in presóni, e 207 incadenáu, e ségliat sa porta de presoni cun 208 su sëgliu suu, po chi nisxúnu dhi portëssit ita papái, ne dhu fuedhëssit. Ma s Ánjulu de su Segnóri abbásxat de su xëlu, illúminat su presóni, e iscállat, comente cera is cadénas cun is chi fiat incadenáu su Sërvu de Dëus. Bistu tali resplendóri is guárdias de su presóni, cúrrint a su Mperadóri, naréndur idhi, chi Potítu aíntr e presóni fuedhát cun dunu gióvunu, chi dhi brigliát sa faci comente Soli, e chi fiat intráu resténdu sa porta serráda cun su sëgliu. Su Mperadóri, a custa notízia, timéndu de su Dëus de Potítu, e rezeléndu 209 de no fai contra is deus suus calencún átturu mali, coment híat fattu innántis in su tëmplu, dhu mbiat exiliáu; iscriéndu a Gelásiu Presidénti chi si Potítu persistíat in s ostinazióni sua, dh attormentëssit finzas a ndëdhi pigái sa vida. Po tantu imbarcáu Potítu fed istëtiu portáu aundi Gelásiu fiat Presidenti. Custu passádas algúnas dîs in is chi no híat pöziu superái sa constánzia de sa fidi in Potítu, dhu fait bogái a su Teátru, aundi pustis de varius torméntus 210, cruelménti fed istëtiu ancora 211 attormentáu in s Equléu 212 ; dhi fiant istëtias applicádas hácias de fögu a un e áturu ladus, e bogádas de is didus is ungas. Töttu custus torméntus hiat bintu Potítu cun sa virtúdi de Gësu Christu a chini de coru 201 e. 202 chi. 203 su è coperto da una macchia. 204 L accento qui segnato è grave. 205 ídolus > Ídolus. 206 portát > pórtat. 207 e. 208 La parola si conclude con una macchia dopo -n. 209 reseléndu > rezeléndu. 210 tormëntus > torméntus. 211 ancora. 212 L accento in realtà sta sulla -u-, come dimostra, quattro righe in basso, la grafia eqúleu. 150
151 istimáda, e serbéda; beféndusí de su tyranu, e donéndu grazias a Dëus. Su pöpulu, biéndu custas cosas, clamáda a boxis mannas alabéndu su Dëus de Potítu. Líbberu giái de su tormëntu de s eqúleu, e de su fögu, dhu preséntant a is leónis po essiri devoráu, ma issus, depósta sa fierésa insóru, dhi língint is peis, e stenta anánti sû, comente angiónis. Bistu custu miráculu medas de is zircumstántis, abbandonéndu is ídolus, si fíanta cunvërtius a sa fidi Christiána. A biri custu su Presidénti, cun ira prus infogáda cumandat chi dhu gétinti a una sartáina prena 213 de öllu, a prumu arbigáu; ma niénti henta molestáu a Potítu custas matërias infogádas, antis beni in mësu de issas cantáda alabanzas divinas ; e comente chi fëssit in mësu de s arrösu de un amënu campu si gosáda, e cumplaxíat cun Dëus, chi feda sa saludi sua. Gelásiu biendusí bintu de Potítu, prus e prus s infuriáda contra issu, no sciéndu su mödu, comenti pódiri 214 pigái ndëdhi sa vida. Po su chi cumándat, chi dhu tórrint a presóni, mentras issu penzat sa manéra de dhi donái sa morti. Sa dî sighenti cumándat portaídhu a sa presënzia sua, e appústis de várius, e longus discúrsus fattus in vanu po tróciri a su Sërvu de Dëus de su camínu de sa vera fidi, cumándat dhi siat claváu un obbílu in conca. Pöstu custu in execuzióni, Dëus hiat fattu, chi su dolóri, chi depíat patíri su Martiri, dhu patëssit issetöttu, e cudhu no; e po tantu cuménzat a zerriái a grandus boxis: Potitu teni cumpassióni de mei, chi giái hapu sperimentáu cantu mannu, e poderösu esti su Dëus tuu. Inzáras dhu nsultat Potítu, naréndu: poíta no t agiúdant is Deus tuus? A s hora si pesat unu grandu bisbígliu in su pöpulu, naréndu: manna esti sa fidi, e su podéri de custu picínnu 215, pöstu chi bincit is deus nostus. Niénti de mancu Potítu fendu su segnáli de sa Gruxi a su Presidénti dhu sánat de su dolóri chi teníat, abbarréndusi issu cun s obbílu claváu, ma senz avértiri dolóri, e allirgaménti. Po custu miráculu si fiat convërtia 216 una grandu multitúdini de Gentílis. Sa ricumpénsa chi su Presidénti hiat donáu a su benefattóri sû fiat istada, de ndëdhi fai segái sa lingua, e bogaindëdhi is ogus. Custa ingratitúdini hat fattu móviri casi tottu sa Ziutádi contra su tiránu; po su quali timéndu s alborötu de su pöpulu cumándat fëssit portáu Potítu átter orta a presóni, e chi a notti serráda, a iscúsi de töttus, fussit portáu a 217 unu lögu, chi si narat Apulia (Pula), e inní degoglaídhu. Su cali ördini si fiat executáu a trexi de Genárju, sèndu 219 Potítu in edádi de trëx annus. S ánima sua fed istëtia bista de is zircumstantis 220 bolái a su xëlu in forma de colúmba. Su cörpus fiat istëtiu sepultáu in su pröpiu lögu, in su chi debústis is Christianus hanti 213 La -e- è coperta da una macchia. 214 pigaindëdhi. 215 picinnu > picínnu. 216 I puntini sulla -e- sono coperti da una macchia. 217 Pula. 218 trexi. 219 L accento qui segnato è grave. 220 La -r- è coperta da una macchia. 151
152 fabricáu una Crësia dedicáda a Issu. Agnésa filla de 221 su Mperadori, innantis 222 chi 223 fëssit istáu disterráu Potítu, hendusí 224 cunvërtia a sa fidi, de issetöttu hiat arricíu su Santu batizimu 225 ; sa chi debústis exiliáda a su pröpiu lögu, aúndi fiat istëtiu exiliáu Potítu, inní po sa santa fidi Christiana hat arricíu su martíriu. Vidal. Annal. Sard. tom.2 impres. Mediol. pag S annu chi fiat istëtiu martirizáu S. Potítu esti s annu 154, segundu 227 Vidal in lögu 228 citau, e Baröniu tom.2 Ann. Eccl. 229 fol.130. num III 230. Su cörpus de S. Potítu paris cun su de S. Efis inde dh hanti pigáu is Pisanus de Pula e collocau honradamente 231 in Pisa s annu 1088 ; ma sa conca de S. Potítu 232 clavada cun s obbílu, si creit siat istëtia de tëmpus meda anterióris portáda a Castëdhu, aundi s est cunserváda in sa Crësia de S. Bardíli, Cumbëntu fiat de is Trinitárius, sa chi s est agatáda accánta de s altari majori s annu 1588; e de inní trasladáda 233 a su Santuáriu de sa Seu de Castëdhu. Aíci dhu penzat Dimas Serpy in Chr. Sanct. Sard. lib.1. cap. 28. fol Vita, Miracoli e Martirio di San Potito, Tradotta in sardo da quella scritta in latino nel Codice Cagliaritano, che fu inviata al Cardinale Baronio celebre annalista ecclesiastico. San Potito, sardo di nascita, figlio di Ila uomo nobilissimo, da fanciulletto aveva cominciato a servire il Dio di cielo e terra. Vedendo Ila idolatra che suo figlio Potito era cristiano, lo sopportava a fatica, e poneva tutta la sollecitudine possibile per allontanarlo da Gesú Cristo; invano, però, andò tutto il suo lavoro. Perciò 235 lo mise in prigione, privandolo di ogni cibo e dicendogli: Vediamo ora se il Dio che adori ti darà pane per mangiare. Ma Potito, ricorrendo a Dio con l orazione, fu alimentato per mezzo di un angelo, cosí come il profeta Abacuc, essendo nella fossa 236 dei leoni 237, 221 Segue. 222 Segue un piccolo segno chi. 224 hendu- è legato a -sí da una linea. 225 batisimu > batizimu. 226 Annales Sardiniae, tomus 2, impressus Mediolani, pagina In M c è punto anziché virgola. 228 La -u è coperta da una macchia. 229 In M manca il punto. 230 Tomus 2, Annales Ecclesiastici, folium 136, numerus III. 231 M honradam. te. 232 Potitu > Potítu s. 234 Chronica Sanctorum Sardiniae, liber I, capitulum 28, folium Po su chi è calco dell it. perciocché, con valore causale. Il periodo è privo di proposizione principale. 236 lacu letteralmente significa vasca, ed è usato soprattutto per indicare l abbeveratoio degli animali. 237 Citazione biblica imprecisa. Secondo la storia di Belo e il dragone, che forma la seconda appendice deuterocanonica del Libro di Daniele, un profeta Abacuc in Giudea, spinto da un angelo, portò il cibo a Daniele, il quale era stato 152
153 aveva avuto il cibo per mano dell angelo. In questa maniera Potito, per lo spazio di molti giorni, fu sostentato da un angelo. Molto tempo era passato, nel quale con lusinghe e minacce Ila aveva tentato di distogliere Potito dalla fede cristiana, senza riuscire nell intento. Alla fine Potito può fuggire di prigione, e nascondersi in un bosco appartenente a Zèpero, dove l angelo gli appare, prospettandogli le persecuzioni e guerre del Demonio, e preparandolo con istruzioni contro le insidie e tentazioni del Nemico. Appena si parte l angelo ecco Satanasso grande demonio, che compare ridendo, e come se volesse abbracciarlo gli dice: O Potito, cosa fai? Torna a casa di tuo padre, che di luogo in luogo ti cerca piangendo, e goditi i beni e le ricchezze sue, poiché non ha altri che te; tu sei la pupilla dei suoi occhî. Risponde Potito: Chi sei tu, perché possa io obbedire ai consigli che mi dài?. Dice Satana: Io sono Gesú Cristo, Signore e Dio tuo, che desidero molto la salvezza dell anima tua. Lo osserva attento Potito, e nota che portava i calcagni sollevati da terra. Subito si fa la croce, e alzando gli occhî al cielo prega Dio: subito il Demonio si adira 238, e s alza in aria di quasi quindici braccia 239. Esclama Potito: Lungi da me, Satana, fatti indietro! Perché mi tenti? No potrai prevalere contro di me, che sono servo di Gesú Cristo. Il Demonio allora si tramuta in toro, e mugghiando con grande ferocia pareva volere assalire Potito, ma egli, facendosi la croce, gli mette le mani addosso, e afferrandolo per le corna lo getta a terra, lo lega alle quattro zampe, e gli sta sopra calpestandolo; esso però da sotto vomitava fiamme di fuoco dagli occhî, narici e bocca, facendo voci tali, che pareva tremare la terra intorno. Nel mentre implorava Potito dicendo: Lasciami andare, affinché prenda qualche refrigerio dai tormenti che mi dai. Perché m hai gettato in tanto fuoco? Mi brucio tutto: abbi pietà di me e dei miei dolori. La Croce di Gesú Cristo dice San Potito t ha legato; ma se vuoi che ti lasci ti comando, bestia infernale, per la virtú della Santa Croce, che non faccia male a nessun cristiano. Allora il Demonio, gridando piú forte e strepitando, dice: Ahimé, un bambino mi vince! Ma ti prometto che, in pena di ciò che m hai fatto, finirai la vita nei tormenti. So, Potito, quello che farò a Roma: vai per ora, e aspetta la vendetta. Fuggito se n era il Demonio urlando per il bosco, e Potito l insultava. Un altro giorno Potito va alla città di Valeria 240, e presso il fiume, che corre vicino, si siede per riposarsi; poi entra in città, predicando al popolo. Lí era una donna di nome Luiríaca, moglie del senatore Agatone, tutta piena di lebbra: Potito la guarí col solo farle la croce, e, alla vista di questo miracolo, ella con molta gente di quel luogo si convertí alla fede di Gesú Cristo. Intanto Ila, padre di Potito, cercava di tornare a gettato nella fossa dei leoni (Bibbia, Daniele, 6 e 14, 33-42). Codesto personaggio è solo omonimo del piú conosciuto Abacuc, ottavo fra i profeti minori della Bibbia. 238 In campidanese s unfrai ha il significato primario di gonfiarsi (dal lat. inflare, forse attraverso la forma volgare *unflare), da cui deriva quello di adirarsi. 239 Il braccio, adottato quale unità di misura, aveva un valore variabile da un luogo all altro, comunque intorno ai sessanta centimetri. Il Demonio si sarebbe dunque sollevato a quasi nove metri d altezza. 240 Nel periodo del Tardo Impero prese il nome di Valeria (dalla Via Valeria che l attraversava), una provincia d Italia, corrispondente pressappoco all attuale Abruzzo. Era chiamata Valeria anche una provincia della Pannonia Inferiore. 153
154 prendere il figlio, e non aveva potuto averlo in mano, essendo stato avvisato Potito da un angelo; avendo poi trovato una nave, s imbarca e va a Roma 241. Lí passava la vita devotamente e santamente con altri cristiani. Non potendo però restare occulta la sua santità, Dio volle che fosse manifesta anche 242 all imperatore Antonino Pio, il quale aveva sua figlia Agnesa spiritata e posseduta dallo stesso demonio, che Potito aveva affrontato e tormentato in Zèpero. Costui, parlando in bocca di Agnesa, diceva che non sarebbe uscito dal corpo di lei se non fosse venuto Potito, anzi l avrebbe uccisa. Udendo questo l imperatore comanda che si cerchi Potito, e avendolo trovato sul monte mentre pregava, lo portano in presenza dell imperatore, il quale 243 si rivolge 244 a lui in questa maniera: Il fragore e la fama delle cose meravigliose che fai è giunta alle mie orecchie; Potito, se liberi mia figlia dal demonio, ti caricherò di ricchezze e onori nella mia corte. Gli risponde Potito: Maggiore onore e maggiore ricchezza è servire Gesú Cristo, Creatore del cielo e della terra, che regna in cielo. Credi in Lui, o imperatore, perché è il vero Dio. Niente rispondendo a ciò, l imperatore torna a dirgli: Potito, libera mia figlia dal demonio, questo è ciò che voglio da te. Allora Potito comanda al Demonio, in nome di Gesú Cristo, che esca da quella creatura, e subito esce, in presenza di tutti coloro che erano lí; i quali a gran voce dicevano che grande e potentissimo era il Dio di Potito. Intanto l imperatore con molte ragioni sollecitava Potito che sacrificasse agl idoli, promettendogli grandi regali, ma egli, forte e immobile come scoglio in mezzo al mare, predicava la fede cristiana, e si rideva delle promesse dell imperatore. Questi lo porta con sé al tempio degl idoli, e stando di fronte a loro gli dice: Osserva, Potito, questi sono i veri dèi: se tu li adori e doni loro incenso, ti farò principe nel mio impero. Ma Potito, alzando gli occhî al cielo, prega Dio, e subito gli idoli cadono a terra, fatti a pezzi 245. Indignato di ciò l imperatore comanda che Potito sia posto in prigione e incatenato, e sigilla la porta della prigione col proprio sigillo, affinché nessuno gli porti da mangiare, né gli parli. Ma l angelo del Signore scende dal cielo, illumina la prigione e scioglie come cera le catene, con le quali era avvinto il servo di Dio. Visto tale splendore, le guardie della prigione corrono dall imperatore, dicendogli che Potito dentro la prigione parlava con un giovane, il cui vólto brillava come il sole, e ch era entrato pur restando chiusa col sigillo la porta. L imperatore a questa notizia, temendo il Dio di Potito e avendo paura che facesse contro i suoi dèi qualche altro male 246, come aveva fatto prima nel tempio, lo manda in esilio, scrivendo al preside 247 Gelasio che, se Potito avesse persistito nella propria ostinazione, lo torturasse fino a togliergli la 241 Il soggetto qui è Potito. 242 Qui l italianismo ancora ha il significato di anche piuttosto che di ancora : l uso corrisponde a quello di tambèni (dallo sp. también). 243 su chi corrisponde all it. il quale. 244 fuedhai parlare, quando regge il complemento oggetto, assume il valore di rivolgersi a qualcuno. 245 Nella scrittura a rogus non sono espresse la vocale prostetica e la consonante rafforzata del sostantivo (arrogus). 246 Il costrutto rezelendu de no fai... equivale a quello dei verba timendi latini. 247 Col termine Presidenti s indicava la carica piú alta nei tribunali anticristiani. 154
155 vita. Pertanto Potito fu portato in nave nel luogo dove Gelasio era preside. Costui, passati alcuni giorni nei quali non aveva potuto superare la costanza della fede di Potito, lo fa condurre al teatro, dove, dopo varî tormenti, crudelmente fu tormentato anche nel cavalletto 248 ; gli furono applicate torce di fuoco all uno e all altro fianco, e cavate dalle dita le unghie. Tutti questi tormenti furono vinti da Potito con la virtú di Gesú Cristo, che di cuore amava e serbava, beffandosi del tiranno, e rendendo grazia a Dio. Il popolo, vedendo queste cose, gridava ad alta voce lodando il Dio di Potito. Libero già dal tormento del cavalletto e del fuoco, lo presentano ai leoni perché fosse divorato, ma essi, lasciata la loro ferinità, gli leccano i piedi, restandogli 249 davanti come agnelli. Visto questo miracolo, molti fra i circostanti, abbandonando gli idoli, si convertirono alla fede cristiana. A vedere ciò il preside, con ira piú accesa comanda che lo gettino in una padella piena d olio, arroventato col piombo; ma per niente questa materia infocata molestò Potito, anzi in mezzo ad essa ben cantava lodi divine; e come se fosse in mezzo alla rugiada di un ameno campo godeva e si compiaceva con Dio, che era la sua salute. Gelasio, vedendosi vinto da Potito, sempre piú s infuriava con lui, non sapendo in che modo poter togliergli la vita. Perciò ordina che lo riportino in prigione, mentre egli pensa alla maniera di dargli la morte. Il giorno seguente ordina di portarlo alla sua presenza, e dopo varî e lunghi discorsi, fatti invano per isviare il servo di Dio dal cammino della vera fede, comanda che gli sia ficcato un chiodo in testa. Essendo stato eseguito ciò, Dio fece in modo che il dolore, il quale avrebbe dovuto patire il martire, patisse proprio questi, e quegli no 250 ; e pertanto comincia a gridare a gran voce: Potito, abbi pietà di me, che ho già sperimentato quanto grande e potente è il tuo Dio! Allora si leva un grande bisbiglio nel popolo, che dice: Grande è la fede, ed il potere di questo ragazzo, giacché vince i nostri dèi. Nondimeno Potito, facendo il segno della croce al preside, lo sana dal dolore che aveva, rimanendo egli col chiodo conficcato, ma senza avvertire dolore e allegramente. Per questo miracolo si convertí una grande moltitudine di pagani. La ricompensa che il preside diede al suo benefattore fu di fargli tagliare la lingua e cavargli gli occhî. Questa ingratitudine ha fatto muovere quasi tutta la città contro il tiranno; temendo perciò la sollevazione del popolo, ordina che Potito fosse portato un altra volta in prigione, e che a notte fonda, di nascosto da tutti, fosse condotto in un luogo chiamato Apulia (Pula), e lí decapitato. Il quale ordine fu eseguito il tredici di gennaio, essendo Potito in età di tredici anni. La anima sua fu vista fu vista dai circostanti volare al cielo in forma di colomba. Il corpo fu sepolto nello stesso 248 Il lat. equulĕus (eculĕus) significa puledro ed è diminutivo di equus cavallo ; già da Cicerone è usato anche nel senso traslato di cavalletto di tortura. 249 Trasformiamo in implicita la proposizione esplicita del testo sardo, nella quale avviene il frequente passaggio dal presente storico all imperfetto. 250 Gelasio soffrí dunque la pena alla quale aveva condannato Potito. 155
156 luogo, in cui poi i cristiani edificarono una chiesa a lui dedicata. Agnesa figlia dell imperatore, prima che Potito fosse esiliato, essendosi convertita alla fede ricevette da lui il santo battesimo; in seguito esiliata nello stesso luogo, dove era stato esiliato Potito, ricevette lí il martirio. Vidal, Annali di Sardegna, tomo II, stampato a Milano, pagina 161. L anno in cui fu martirizzato San Potito è il 154, secondo Vidal nel luogo citato e Baronio in Annali ecclesiastici, tomo II, foglio 136, numero III. Il corpo di San Potito, insieme con quello di Sant Efisio, dai Pisani fu prelevato da Pula e collocato onorevolmente a Pisa nell anno La testa di San Potito col chiodo conficcato, però, si crede che sia stata portata molto tempo prima a Cagliari, dove s è conservata nella chiesa di San Bardilio, convento dei Trinitarî, e fu trovata accanto all altare maggiore nell anno 1588; da là fu trasportata al santuario della Cattedrale di Cagliari. Cosí pensa Dimas Serpi in Cronaca dei santi di Sardegna, libro I, capitolo 28, foglio 48. (Pubblicato sul numero 5 di NAE) 156
157 Appendice V I Goccius de Santa Barbara Il componimento è conservato alla Biblioteca Universitaria di Cagliari, nel fascicolo n.36 dei manoscritti Laconi (Ms LI/36). I Goccius de Santa Barbara, in base all indicazione di catalogo, furono composti a seguito della caduta di un ala del monastero di Santa Caterina in Cagliari, il 27 dicembre L opera, dopo la quartina iniziale, i cui ultimi due versi fungono da ritornello dopo le sestine, si compone di quattordici strofe di ottonarî e novenarî, i quali ultimi paiono essere dovuti ad imperizia dell autore. Secondo il genere degli inni sacri, lo schema metrico della quartina è xyyx, quello delle sestine è ABBAAx, in cui x è in rima con l ultimo verso del ritornello. I Goccius sono seguiti da una breve preghiera in latino. La santa alla quale è dedicato l inno non è la vergine martire di Nicomedia in Bitinia, unica Barbara presente nel martirologio romano, bensí una donna natia di Cagliari, che visse nel III secolo, vergine e martire ; il suo culto ebbe rinnovato impulso a partire dal In quell anno, infatti, durante gli scavi nella Cripta di Santa Restituta a Cagliari, il 23 giugno fu ritrovato un loculo terragno con la seguente iscrizione Santa Barbara, vergine e martire, che visse trent anni... gli studiosi dovettero ricredersi e ammettere un caso di omonimia 251. La lingua di quest inno è il sardo campidanese: alcuni tratti lessicali e morfologici inducono a credere che l anonimo poeta fosse cagliaritano, come lo stesso argomento e le stesse circostanze di composizione confermano. Questo testo è uno dei primi in campidanese moderno, ma la lingua non è molto diversa da quella di oggi. Per quanto riguarda la grafia, si nota che il modello, trent anni dopo il passaggio dell isola ai Savoia, è l italiano: gn indica palatale nasale (carignus), gia affricata palatoalveolare (giai), ghe e chi gutturali sonore e sorde (preghera, chi). Un tratto superstite di scrittura iberica è invece la x, usata per rappresentare la fricativa palatoalveolare sorda (naximentu). La lettera z indica affricata dentale sorda (innozenti), ed in un caso è impiegata anche dopo n per esprimere l effettiva pronunzia del gruppo ns (cunzervas, ma inserras con grafia etimologica); si nota inoltre oscillazione di scrittura fra -t e -d nella desinenza verbale di III persona singolare (assegurad, mandad ma anche mandat). In morfologia si rilevano il genere maschile di dus fontis due fonti, che è un cultismo d origine italiana (l autore adopera duas funtanas come sinonimo), il congiuntivo imperfetto in -essi (maltratessit) e il gerundio in -endu (timendu). Gli elementi caratteristici ma non esclusivi del campidanese di Cagliari sono l uso di fiat e non fut come imperfetto di èssiri (III persona singolare), e i termini sèu cattedrale, de undi di dove e inní lí per quanto attiene al lessico. Sul piano della sintassi, è rilevante l uso del congiuntivo trapassato in 251 Dizionario iconografico dei patroni e dei santi della Sardegna, a cura di Ino Chisesi, Cagliari, L Unione Sarda, 2004, pag
158 una proposizione finale, laddove in italiano compare il congiuntivo imperfetto: po chi inní ti essinti fertu. Goccius de Santa Barbara Virgini, e Martiri Cagliaritana Po Cristus Martirizada In su Monti occultamenti Barbara sesi innozenti A Gesus sacrificada. 4 Barbara Calaritana nobili de naximentu tui ses gloria e ornamentu de sa patria paisana ses de sa lei pagana enemiga declarada. 10 Barbara sesi innozenti 252. Cum sa grazia batisimali ti cunzervas innozenti e merescis giuntamenti una puresa angelicali, sa corona triunphali cum sa palma duplicada. 16 Barbara sesi innozenti. Candu sa corti Romana s assegurad totalmenti chi in Casteddu sa prus genti fiat Catolica Cristiana format sa lei tirana contra cristus promulgada. 22 Barbara sesi innozenti. 252 M innoz. L abbreviazione è dovuta a motivi di spazio nel foglio. 158
159 Po su rigori vehementi ti inserras induna grutta e cum santa Restituta fiasta fida penitenti appartada de sa genti Ma de su Xelu accumpangiada. 28 Barbara sesi innozenti. A su Barbaru presidenti mandad su imperiu Romanu, po chi donnia Cristianu maltratessit aspramenti ses Barbara prontamenti de su Barbaru impresonada. 34 Barbara sesi innozenti. Cum carignus e cum rigoris, ses tentada in su presoni disprezias s adorazioni de is gentilicus erroris suffris crudelis doloris cum ispinas maltratada. 40 Barbara sesi innozenti. Su Barbaru timendu zertu sa potenti nobilesa in occultu e cum lestresa ti mandat in su desertu po chi inní ti essinti fertu fessis decapitada. 46 Barbara sesi innozenti. Moris Barbara costanti 159
160 degollada indunu monti aundi repentinu fonti si cumparid a su instanti chi po nomini incessanti si narad sa scabizada. 52 Barbara sesi innozenti. Duas funtanas de repenti osservat s esecutori una di aqua de candori s altera sanguini innozenti e Barbara in sa currenti de duas undas annegada. 58 Barbara sesi innozenti. Is dus fontis veramenti declaranta sa puresa su Martiriu e fortalesa de sa Martiri valenti chi bivit eternamenti in su Xelu coronada. 64 Barbara sesi innozenti. Dioclezianu Imperadori e Barbaru Presidenti a trinta annus resistenti moris in s aspru rigori po Cristus nostru Signori cum chini ses desposada. 70 Barbara sesi innozenti. In Casteddu occultamenti ti donant sepultura in sa grutta tanti oscura 160
161 chi abbitasta tui biventi e ses hoi presentementi in sa seu depositada. 76 Barbara sesi innozenti. Cun respettu e devozioni ses visitada in su monti sa cresia tua cun su fonti adorad dogni personi po memoria e menzioni de undi ses martirizada. 82 Barbara sesi innozenti. Giai chi has bintu sa vittoria de una gherra sanguinosa sa preghera fervorosa presenta in sa eterna gloria de chini faid memoria de tui barbara avvocada. 88 Barbara sesi innozenti A Gesus sacrificada. L orazione dell istessa Santa Barbara. 253 Ora pro nobis beata Barbara, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus qui inter cetera providentiae tuae miracula etiam in sexu fragili victoriam Martyrii contulisti, concede propitius ut qui Beatae Barbarae virginis, e Martiris tuae natalitia colimus per eius ad te exempla gradiamur. Per Christum Dominum nostrum amen. L orazione della stessa santa Barbara. Prega per noi, beata Barbara, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo te, Dio, che fra gli altri miracoli della tua provvidenza hai attribuito anche al sesso debole la vittoria del martirio. Concedi propizio a noi, i quali onoriamo l anniversario della tua beata vergine e martire Barbara, di venire a te attraverso il suo esempio. Per Cristo nostro Signore amen. 253 La didascalia è in italiano. La preghiera è inserita verticalmente al centro del foglio. 161
162 Inno di Santa Barbara vergine e martire cagliaritana Martirizzata per Cristo occultamente nel monte, Barbara sei innocente, sacrificata a Gesú. 4 Barbara cagliaritana, nobile di nascita, tu sei gloria e ornamento della patria nazionale, e sei, della legge pagana, nemica dichiarata. 10 Barbara sei innocente. Con la grazia battesimale ti conservi innocente, e congiuntamente meriti una purezza angelica e la corona trionfale con la palma 254 raddoppiata. 16 Barbara sei innocente. Quando la corte romana si assicura totalmente che a Cagliari la gente 255 era cattolica cristiana, redige la legge tiranna, promulgata contro Cristo La palma è simbolo della vittoria dei martiri. 255 Lett. la maggioranza della gente. 162
163 Barbara sei innocente. Con rigore zelante ti ritiri in una grotta e con Santa Restituta 256 divieni fida penitente, lontana dalla gente, ma accompagnata dal cielo. 28 Barbara sei innocente. L impero romano invia il presidente Barbaro 257, affinché ogni cristiano sia perseguitato duramente: tu, Barbara, sei subito imprigionata dal Barbaro. 34 Barbara sei innocente. Con allettamenti e minacce in prigione sei tentata, ma disprezzi l adorazione degli errori pagani, e soffri crudeli dolori, maltrattata con le spine. 40 Barbara sei innocente. Il Barbaro, temendo certo la potente nobiltà, di nascosto e con prontezza ti manda nel deserto, perché lí ti percotessero 256 Poiché le reliquie di Santa Barbara e quelle di Santa Restituta erano state ritrovate a breve distanza le une dalle altre, si ipotizzò che le due fossero state compagne anche nel martirio, opera citata. 257 Il nome, con il quale è indicato il presidente del tribunale anticristiano, esprime già di per sé la ferocia della persecuzione. 163
164 e poi ti tagliassero la testa. 46 Barbara sei innocente. Muori, o Barbara, con fermezza, decapitata su d un monte, dove improvvisamente compare subito una fonte, che per nome perpetuo è detto La Decapitata Barbara sei innocente. Due fontane repentinamente osserva l esecutore una d acqua limpida, l altra di sangue innocente, e Barbara nella corrente di due onde annegata. 58 Barbara sei innocente. Le due fonti veramente manifestano la purezza, il martirio e la fortezza della valorosa martire, che vive in eterno incoronata in cielo. 64 Barbara sei innocente. Sotto Diocleziano imperatore e Barbaro presidente, tenace a trent anni muori in modo duro e crudele per Cristo nostro signore, 258 Santa Barbara è chiamata infatti Sa scabitzada. Si noti la ricchezza lessicale del sardo, che possiede tre sinonimi per tagliare la testa : il neolatino scabitzai (= segai sa cabitza, voce ormai soppiantata da conca), l iberismo degollai, che entrò anche in italiano, e il cultismo decapitai. 164
165 col quale sei sposata. 70 Barbara sei innocente. In Cagliari segretamente ti danno sepoltura nella grotta cosí oscura, in cui abitavi da viva, e oggi, in questo momento sei collocata in cattedrale. 76 Barbara sei innocente. Con rispetto e devozione sei visitata nel monte, la tua chiesa con la fonte è adorata da ogni persona per memoria e ricordo del luogo del martirio. 82 Barbara sei innocente. Giacché hai ottenuto la vittoria in una guerra sanguinosa, presente la fervente preghiera nell eterna gloria di chi fa menzione di te, Barbara difenditrice. 88 Barbara sei innocente sacrificata a Gesú. L orazione della stessa santa Barbara. Prega per noi, beata Barbara, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo te, Dio, che fra gli altri miracoli della tua provvidenza hai attribuito anche al sesso debole la vittoria del 165
166 martirio. Concedi propizio a noi, i quali onoriamo l anniversario della tua beata vergine e martire Barbara, di venire a te attraverso il suo esempio. Per Cristo nostro Signore amen. (Pubblicato sul numero 13 di NAE) 166
167 Appendice VI Un inno al Cuore di Gesú (1766) Nei manoscritti Laconi si conserva, nei fogli dei Goccius de Santa Barbara già pubblicati sul numero 13 di NAE, un inno al Cuore di Gesú (Ms LI/36), anch esso scritto in campidanese, composto nel 1766, come è indicato nel manoscritto: i Goccius de su sacratissimu e dulcissimu coru de Gesú Redentori nostru. Questi Goccius, composti dunque nella seconda metà del Settecento, rivelano uno lessico di influenza ancora prevalentemente iberica: lo provano vocaboli quali l inedito malogradu sventurato (dallo spagnolo malogrado), e poi olvidu oblio, verdaderu vero, briglianti brillante, in un epoca nella quale, come dimostra l ultimo aggettivo succitato, il modello grafico italiano s era già imposto. Il verbo torgari concedere corrisponde al cat. atorgar ed allo sp. otorgar (oggi concedere, permettere; dare ): la forma antica atorgar aveva anche il valore di ammettere, confessare, e con questo significato fu usata da frate Antonio María da Esterzili nel tardo Seicento. Il verbo reparari rilevare, notare con quest accezione è spagnolismo: autori precedenti lo avevano già adoperato in tutte le accezioni dell it. riparare e dello sp. reparar. Il verbo scudiri (dal lat. tardo excutulare), che in campidanese si usa col significato di battere, scuotere, soprattutto nell accezione di abbacchiare, battere gli alberi per far cadere i frutti, qui è impiegato nel verso scudiri in gruxi ispirendu salire in croce spirando. Sul piano morfologico si rileva il troncamento nell infinito del verbo essere in chini at essi tanti ingratu. L opera, dopo la quartina iniziale, i cui ultimi due versi fungono da ritornello dopo le sestine, si compone di dieci strofe di ottonarî, con qualche novenario, che pare essere dovuto ad imperizia, piú che alla scelta dell anacrusi da parte dell autore; al termine del componimento si trova un altra quartina di supplica. Secondo il genere degli inni sacri, lo schema metrico delle quartine è xyyx, quello delle sestine è ABBAAx, in cui x è in rima con l ultimo verso del ritornello. I Goccius sono seguiti da una breve preghiera in latino. Goccius de su sacratissimu e dulcissimu coru de Gesú Redentori nostru In tronu de amori postu 167
168 cumparis meda briglianti inflama su coru nostru, Coru de Gesus amanti. 4 A su mundu ti declaras Po causa de tanti olvidu Chi in is ominis reparas 259 A is finesas tanti raras chi dispensas abbundanti. 10 Inflama... Amorosu e resentidu Cum tres insignas de amori Gruxi, spinas, e lanzada Amostas franca s intrada A su tristu peccadori Concedendiddi dolori Verdaderu 260 e penetranti. 16 Inflama... In custu coru infogadu S incendit su coru fridu S emendat dognia depidu S achistat su malogradu Tottu benit rettocadu De custu fini diamanti. 22 Inflama... Is animas fervorosas Aspiranta de continu A operas prus virtuosas Po essiri veras isposas De custu coru Divinu 259 In M segue dopo hominis. 260 In M è parzialmente coperto da una macchia d inchiostro. 168
169 Cum puru affettu e costanti. 28 Inflama... Su Babbu eternu promitit Per custu coru amurosu Conzedid meda gustosu Cant a nosu necessitit Mentras po issu si supplichit Si torgat tottu a s instanti. 34 Inflama... Custu coru appassionadu Scudiri in gruxi ispirendu A su babbu fiat preghendu Po chi ddiat crucificadu Aici nos at imparadu Su perdonu a s adversanti. 40 Inflama... A tali eccessu de amori Su coru ti hat portadu Chi ti ses sacramentadu po su giustu e peccadori O amantissimu segnori Chi t hat obligadu a tanti. 46 Inflama... Chini hat essi tanti ingratu Chi non istimit custu coru Est precissu chi siat moru Po non bolliri essi gratu O ddi pargiat su chi at fattu Chi ancora non siat bastanti. 52 Inflama
170 O arcivu de arrichesa Mari de dognia cuntentu De s inferru ses tormentu E de is angiulus bellesa Concedinosi puresa E sa grazia confirmanti. 58 Inflama... Po cuddu coru preziosu De mamma tua virginali Liberanosi de mali E de su inferru orgogliosu E po issu vitoriosu Bessant dognia agonizanti. 64 Inflama... Tottu custu s est propostu De su umili supplicanti Decreta a favori nostu Coru de Gesus amanti. 68 Antifona. Improperium expertavit 261 cor meum, et meseriam 262, et substinui, qui simul contristaretur, et non fuit, et qui consolaretur, etsi 263 inveni. Discite a me quia mitis sum, et humilis corde. Alleluia. Et invenietis requiem animabus vestris. Alleluia. Oremus. 261 Nel latino classico si usava expertum est. 262 = miseriam. 263 È scritto staccato et si. 170
171 Domine Jesu qui ineffabiles cordis tui divitias Ecclesię sponsę tuę 264 singulari beneficio aperire dignatus es: concede propitius ut gratiis celestibus 265 ex hoc dulcissimo fonte manantibus corda nostra ditari, ac rec<re>ari 266 mereantur. Qui vivis et regnas Deus in secula seculorum Inno del santissimo e dolcissimo Cuore di Gesú Redentore nostro In trono di amore posto, compari molto brillante: infiamma il core nostro, cuore di Gesú amante. 4 Al mondo ti dichiari amoroso e risentito, a causa di tanto oblio che negli uomini rilevi in cambio delle cortesie tanto singolari, che dispensi in abbondanza. 10 Infiamma... Con tre insegne d amore croce, spine e ferita, mostri aperta l entrata al tristo peccatore, dandogli dolore vero e penetrante. 16 Infiamma... In questo cuore infocato s accende il cuore freddo, s estingue ogni debito, 264 Il simbolo ę corrisponde al classico ae: Ecclesiae sponsae tuae. 265 = caelestibus. 266 Una macchia copre la parte mediana del verbo. 267 Nel latino classico saecula saeculorum. 171
172 s avvantaggia lo sventurato: tutto è migliorato da questo fine diamante. 22 Infiamma... Le anime desiderose di questo cuore divino aspirano di continuo ad opere piú virtuose per essere sue vere spose con puro affetto costante. 28 Infiamma... Il Padre eterno promette attraverso questo cuore amoroso, e accorda molto lieto quanto a noi occorre: quando per esso si supplichi si concede tutto all istante. 34 Infiamma... Questo cuore appassionato per salire in croce spirando il padre stava pregando, poiché l aveva crocifisso: cosí ci ha insegnato il perdono per il nemico. 40 Infiamma... A tale eccesso d amore il cuore t ha portato, che ti sei sacrificato 268 per il giusto e il peccatore: 268 In italiano sacramentare ha il primo significato di impartire sacramento, e non si usa come intransitivo pronominale. 172
173 o amorevolissimo Signore, chi t ha obbligato a tanto? 46 Infiamma... Chi sarà tanto ingrato da non amare questo cuore, è certo che sia moro per il non voler essere grato; o gli pare quel che ha fatto 269 ancora non essere sufficiente? 52 Infiamma... O archivio di ricchezza, mare di ogni contentezza, dell inferno sei tormento e degli angeli bellezza: concedici purezza e la grazia confermante. 58 Infiamma... Per quel cuore prezioso di tua madre vergine, liberaci dal male e dall inferno orgoglioso, e, per esso 270, vittorioso riesca 271 chiunque sia in agonia. 64 Infiamma... Tutto quanto si è preposto dall umile supplicante, decreta a favore nostro, cuore di Gesú amante Soggetto sottinteso della proposizione relativa è Gesú: soltanto un ingrato può ritenere insufficiente l atto d amore del Salvatore. 270 S intende il cuore di Gesú. 271 Il plurale bessant concorda con l indefinito singolare. 173
174 Antifona. Sperimentò improperio il mio cuore, e miseria, ed io sopportai che 272 nello stesso tempo esso si contristasse e ciò non fu e si consolasse, e tuttavia ne presi conoscenza. Imparate da me, perché sono mite e umile di cuore. Alleluia. E troverete pace per le vostre anime. Alleluia. Preghiamo. Signore Gesú, che per singolare beneficio ti sei degnato di aprire le ineffabili ricchezze del tuo cuore alla Chiesa tua sposa, concedi propizio che i nostri cuori si arricchiscano delle grazie celesti, le quali si diffondono da questa dolcissima fonte, e meritino di essere ristorati; tu, Dio che vivi e regni nei secoli dei secoli (Pubblicato sul numero 19 di NAE) 272 Il costrutto di su(b)stinere con qui e congiuntivo non appartiene al latino classico. 174
175 Appendice VII Una disposizione del segretario Cossu Fra le carte della raccolta Laconi, conservate alla Biblioteca Universitaria di Cagliari, sotto la sigla Ms. LI/36 è presente la copia di una circolare del Segretario Cossu, rivolta alle amministrazioni locali per sollecitarle a fornire alcuni chiarimenti sulla produzione agricola. Giuseppe Cossu ( ), cagliaritano, avvocato ed economista, nel 1767 fu nominato Segretario della giunta istituita per amministrare i Monti frumentarî o granatici, cioè i magazzini di raccolta del frumento, esistenti negli antichi consorzî agricoli. La circolare che qui riproponiamo è dell aprile 1769: l anno successivo il Cossu ottenne la carica piú elevata di Censore generale. La lettera è scritta secondo l italiano dell epoca, con predilezione per l ipotassi e i periodi prolissi. Si segnalano voci antiquate, e parole scritte oggi in diversamente: viglietto è schietto toscanismo, lemosina, vegnente, Segretaro, ommesso, commune sono arcaismi fonetici, morfologici e grafici. Il sostantivo fromento può essere considerato un dialettalismo. Le voci verbali avvertino (= avvertano, congiuntivo presente), deveranno e informaranno erano frequenti nell italiano antico, cosí come l articolo determinativo plurale li per i, soprattutto premesso a date 273, e l omofono li pronome atono di terza persona singolare, sia maschile, sia femminile. Il sostantivo religioni, che in questo testo compare al plurale, ha il significato di ordini religiosi 274. Il francesismo quittanza ricevuta, quietanza (< fr. quittance < quitter rinunziare < quitte libero (da debiti), con successivo accostamento all it. quieto), mantiene la forma originaria. Troviamo poi un sorprendente Prouomini, adattamento della voce d origine latina probiviri. Anche la grafia ha qualche particolarità: l uso frequente della lettera maiuscola per dare maggiore risalto ai sostantivi, e la j finale nei nomi contratti in -ii. Non mancano i sardismi, che sono anzi vocaboli d importanza fondamentale nel contesto e non sono tradotti: Villa, scritto per maggior risalto con la maiuscola alla pari di altri sostantivi, corrisponde al sardo Bidda ed è da intendere villaggio ; Vidazoni (dal latino habitatione), che in origine indicava la casa e le terre contigue comprendenti i seminarii, le vigne e i pascoli del bestiame, designa le terre ora lavorate, ora sode o novali, secondo le regole della rotazione 275 ; tancati viene dal sardo tanca terreno piú o meno ampio, recinto con muretti a secco o anche siepi, dove pascolano le greggi e il pastore ha il suo ricovero (detto pinnetta) Nello stile amministrativo quest uso non è comunque ancora scomparso. 274 Fu adoperato già da Francesco d Assisi e Dante Alighieri in tale accezione. 275 M.L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, Trois, Cagliari, 1989, vol. I, pag Entrambe le citazioni riportano passi di autori sardi, rispettivamente E. Besta e P. Porcu/G. Lallai. 276 A. GABRIELLI, Grande dizionario illustrato della lingua italiana, a cura di Grazia Gabrielli, Milano, Mondadori, 1989, pag
176 L interferenza del sardo è la causa di varie forme sbagliate (se non sono errori di stampa): sciolieranno, avisi, diffetose, estenzione, occazione, e anche convensione (ipercorrettismo) 277. Il testo sardo si presenta come una traduzione dall italiano, non letterale e spesso molto semplificata: il suo scopo è di rendere comprensibili anche ai destinatarî esclusivamente sardofoni le disposizioni impartite. La grafia adoperata si basa sul modello italiano, ma sono evidenti alcuni tratti spagnoli: il digramma gu per esprimere la velare sonora davanti alle vocali e ed i (siguinti seguono, piguendu prendendo ), e qu solo in un caso per la velare sorda (qui pronome relativo); la lettera x per rendere la fricativa prepalatale sorda (connoxit conosce, paxxit pasce ). Le occlusive intervocaliche e le vocali paragogiche presentano oscillazione nella scrittura: depint, depinti e deppinti. La i- prostetica è usata spesso: isperdida, istendiriddas stenderle, ma stasoni stagione. Il gerundio può assumere il prolungamento in -ru: si hanno, per lo stesso verbo, le due forme di gerundio spezifichendu e ispezifichenduru. Nel testo sardo, differentemente da quello italiano, si trovano anche scritture etimologiche: exemplu, existenti. Un calco dall italiano è la locuzione preposizionale baxu pena de sotto pena di. Gli aggettivi propriu e grandu (d origine rispettivamente spagnola e italiana), premessi a nomi femminili, sono lasciati invariati: sa propriu Bidazoni, una grandu diferenzia. SOPRA I MONTI GRANATICI DI SASSARI 278 LA REALE GIUNTA DIOCESANA Avendo rilevato dalle Tabelle de conti del Monte Granatico, che diversamente hanno le Amministrazioni Locali inteso l ordine di S.E. 279 di relazionarci delle terre, che nel distretto 280 di ciascheduna Villa si coltivano, e di quelle, che potendosi coltivare rimangono incolte; nell accompagnare le Tabelle prescritte nel Regolamento al tit abbiamo stimato ordinare, che nel restituirle aggiungano le Amministrazioni un foglio distinto, che ci riscontri de seguenti chiaramenti 281. Primo: Se la Villa tiene una, ò 282 più Vidazoni. 277 Esempî di pronunzia dell italiano influenzata dal sardo, la quale si riflette nella grafia, coinvolgendo poi parole affini morfologicamente. 278 Nelle note seguenti con L si indica il testo della raccolta Laconi. I fogli sono divisi in due colonne: a sinistra è la lettera in italiano, a destra quella in sardo campidanese. In entrambi i testi, italiano e sardo, sono lasciate vuote alcune righe per avere sulla stessa linea i capoversi corrispondenti nelle due lingue. La lettera s è solitamente scritta come f, ma senza il trattino orizzontale. 279 = Sua Eccellenza. Come si evince dal testo sardo, si tratta del Viceré. 280 L ristretto. 281 = chiarimenti. 282 = o. 176
177 Che quantità di frumento può seminarsi in ciascuna Vidazone, e se si seminano interpolatamente, ovvero di seguito, cioè due anni sì, e due, od uno no. Che quantità accostumasi seminare in ciascuna di queste Vidazoni. Se le Vidazoni sono proprie delle Ville, ovvero siano in parte, od in tutto in terreni di altra Villa distrutta, od esistente; specificando in quale quantità, ed indicando come chiamavasi 283 allorché esisteva. Se l orzo, ed altri legumi, canape, o lino semininsi nella medesima Vidazoni nelle quali seminasi il frumento ovvero in quelle terre in cui l anno andato, od il vegnente si semenzerà il fromento. Caso che le Vidazoni fossero ristrette, in maniera che non fossero sufficienti a capire la quantità, che vorrebbe seminarsi, ci riscontreranno se possono ampliarsi o distendersi, e suggeriranno i mezzi da usarsi, come farebbero se la Villa tiene terreni attigui di altra Villa distrutta, od esistente che rimangano incolti, specificando la distanza, che vi è della Villa a quelle terra, ed eziandio la denonziazione 284, ed estenzione 285 di quei Salti, per poter indi Noi avvanzarne 286 il riscontro a S.E.: domandandole che faccia passare quelle insinuazioni, che stimerà convenevole con quei, a cui appartengono per la concessione, mediante quella giusta convensione 287, che riuscirà di fare con quelle persone, che per parte della Communità dovessero trattare. Se nella villa, oltre le Vidazioni, si semini in tancati, Colline, o Montagne e per quanta quantità. Quanto disti il terreno incolto dalle altre terre coltivate, e quanto della Villa. Quali siano le Ville confinanti, e la distanza 288 di ciascheduna. Se il commune tiene terre sufficienti, se ve ne siano della Chiese, e Religioni, e di quanta distesa, come pure se sianvi demaniali, che non siano di dotazioni delle Ville, e di quanto spazio. Si riscontrerà l ambito, che ad un di presso possono occupare le Vigne, Orti, e Giardini della Villa. Se il bestiame destinato all agricoltura tiene pascolo sufficiente, e se il sito è vicino alla Villa, e quanto disti, e che spazio lo occupa. Se il Bestiame della Villa tiene sufficiente luogo per pascolare, o nò, e di che estenzione 13 questo sia. Ci riscontreranno eziandio di ciò, che in un giorno seminar può un giogo de bovi, e quanto un Zappatore. 283 L chiamava. 284 = denominazione. 285 = estensione. 286 = avanzarne. 287 = convenzione. 288 L distaza. 177
178 Inoltre quanto si computi quello che in tutta la 289 stagione atta al seminamento può seminare un pajo de Bovi, e quello che può seminare un Zappatore. Per relazionarci di questo li preveniamo, che debbono prendono prima le opportune notizie, mediante informativa de Prouomini, e visita de Censori, poiche 290 siamo stati riscontrati, che le più delle relazioni inviate delle terre incolte, e che si coltivano, sonosi fatte a mente, e senza aver preso le dovute notizie, di modo che S.E. ha incontrato un notabile divario dagli avisi 291, che noi li abbiamo recati da quelli, che le sono stati rassegnati da Ministri di Giustizia, all occazione 292 di rimettergli le solite consegne annuali delle granaglie raccolte. E per maggior chiarezza la risposta sarà articolo per articolo delle dommande 293, che veniamo di fare, prevenendoli, che caso mai queste Informative si riconoscano meno fedeli, o diffetose 294, spediremo a loro spese un Commissario, che transferendosi sovra luogo eseguisca, ciò che eglino hanno ommesso. Essendosi già abbastanza provveduto da S.E. per la ricuperazione de fondi del Monte col suo Vice Reggio viglietto di 10. Novembre nel articolo In non poche; per tutto il 15. di Settembre deveranno inviarsi le Tabelle de conti, sotto pena di spedire i Commissarj a spese degli Amministratori Locali. Ove mai qualuno 295 degl Individui della Villa si distinguesse in dar qualche copiosa lemosina al Monte, ce ne raguagleranno 296 distintamente, per renderne conto a S.E., che sicuramente lo gradirà. E informaranno parimenti di ciò che S.E. domandò colla sua circolare de 11. Maggio nell articolo avvertendo. Siccome debbono pagarsi i libri, e di più cose avvanzate 298 per quella Amministrazione Locale non essendovi fondo di danaro venderanno tanto grano quanto sia necessario per avere la somma di che è quella che si è calculato dover per quest anno contribuire quel Monte, e questa somma nell inviare le Tabelle de conti, la faranno prevenire nelle mani del qui sottoscritto Segretaro, facendosi far quittanza. 289 L le. 290 = poiché. 291 = avvisi. 292 = occasione. 293 = domande. 294 = difettose. 295 = qualcuno. Vista anche la traduzione in sardo con calincunu dovrebbe essere un errore di stampa, piuttosto che un composto di qual e uno, non attestato in italiano. 296 = ragguaglieranno. 297 I numeri sono sempre seguiti da un punto. 298 = avanzate. 299 L ha uno spazio vuoto. 178
179 Otto giorni doppo 300 il ricevimento della presente vogliamo essere riscontrati di aver ricevute, ed essere già al fatto del contenuto, e caso mai incontrassero alcuna dificoltà 301 ce la rassegneranno che 302 la sciolieremo 303. Coll istessa opportunità ci raguaglieranno 24, se tengono archiviati i Regolamenti di S.E. de 10. Settembre le circolari stampate delli 11. Maggio, e 10. Novembre scorso anno, e se presso i Censori rimangono le istruzioni emanate in tempo di S.E. il Signor Conte Tana. Questa nostra lettera si conserverà unitamente alle altre sì di S.E., come nostre, avvertendoli, che se mai nell ordinare alcuna visita delle scritture del Monte, venissimo riscontrati di non trovarsi li nostri ordini, a spese degli attuali Aministratori 304 faremmo provvedere de nostri Registri le copie: avvertino pertanto di tenere come è di loro dovere geloso conto delle Scritture. Cagliari li 30. Aprile PER DETTA REALE GIUNTA DIOCESANA. C O S S U. Po cantu in vista de is Tabellas de is contus de is Montis granaticus, claramenti si connoxit ch is Amministradoris Localis non funt istetius a su cabudu de s ordini c at donau su Visurrei, po chi giuntamenti cun is Tabellas chi siddis dimandat in su tit de su Regulamentu essinti fattu relazioni de is terras, chi in su distrittu de sa bidda s aranta, e de is chi non s aranta, po no essiri sboscadas; Eus pensau cummandai a is Amministradoris Localis, chi a su propriu tempus di arremitiri cussas Tabellas, imbinti ancora in ddunu foliu aparti relazioni de is notizias chi siguinti. 1. Cantus Bidazonis tenit sa Bidda. 2. Cantu trigu si podit arai in ddonnia Bidazoni: e si s aranta un annu si, e un annu no: o si s aranta de siguiu dus annus si, e dus, o unu, no. 3. Cantu s acostumat arai in dognia Bidazoni. 4. Si cussas Bidazonis funti proprias de sa bidda: o vero s in totu, o in parti sunti sartus di atera bidda 305 isperdida, o chi ancora est in pei: ispezifichenduru sa cantidadi de is terras de aturu sartu, e su nomini de cussa bidda isperdida o existenti. 300 = dopo. 301 = difficoltà. 302 = ché. 303 = scioglieremo. 304 = Amministratori. 305 L bida. 179
180 5. Si s Orgiu, Leguminis, Linu, Canniu s aranta in sa propriu Bidazoni paris cun su trigu: o si s arat in cuddas terras, aundi s annu nantis, o s annu nfattu s at arai su trigu. 6. Po su casu ch is bidazonis sianta tanti curzas, chi non ci capat sa cantidadi de su trigu, chi sa Comunidadi aiada boliri arai; depint is Amministradoris Localis informai su mediu chi s at a podiri pigai po istendiriddas prus; po exemplu si sa bidda es lacanas a pari cun calincuna atara isperdida, o cun boscu de atara bidda chi esti ancora in pei: spezifichendu su tretu chi ncesti de bidda a cussus territorius; sa denominazioni, e istenzioni de cußus 306 sartus allenus: po chi tenta cussa notizia, sidd apporgiat a su Visurrei, e siddi preghit, chi nddi fazat fueddu cun cuddus a chini tocat, po ndi lograi sa conzessioni cunddunu agiustu arrexonabili cun is Sindigus, o ataras personas chi depinti cuntratai a nomini de Communidadi. 7. Si s arat foras de Bidazoni, in cungiaus 307, ortus, o foras de sartu: isplichendu sa cantidadi. 8. Ita tretu nciat de is terras chi s aranta, a su boscu: e de custu a bidda. 9. Cant ailargu funti is biddas de su circuitu, e calis funti custas. 10. Si sa Communidadi tenit terras bastantis: e cantus terras inciat de is Cresias, Arreligionis, e de Manialis 308, chi non sianta doda de sa bidda. 11. Ita tretu piganta is Bingias, Ortus,e Giardinus de sa bidda. 12. Ita tretu pigat su sartu aundi paxxit su bestiamini destinau po arai: si cussu sartu dda abbastat, e cantu ailargu es de bidda cussu sartu. 13. Si s aturu bestiamini tenit logu bastanti po paxxiri: e cantu mannu est su paberili. 14. Cantu podit arai in dduna dì unu Giù, e cantu unu marradori. 15. Cantu si computada chi arat unu giù, e cantu unu marradori in totu sa stasoni bona po arai. Preveneus però a is Amministradoris Localis, chi po arregoliri totus custas notizias si deppint informai de Proominis, e visita de Censoris: poita est certu, chi is relazionis chi si funti imbiadas de is terras chi s aranta, si funti fattas de memoria, po non si boliri pigai su traballu de fairi is depidus averiguazionis, de modu chi Su Visurrei at notau una grandu diferenzia intr is relazionis de is Montis, e is consignas annualis, ch is Ministrus de Giustizia idd ant imbiau 309 de su trigu aregortu. E po prus claridadi; s arrespusta si depit fai articulu po articulu, de cantu si preguntat: prevenenduru chi si sa relazioni non bengiessit cumplida, o veridica; s at dispaciai unu Commissariu a gastus de is Amministradoris Localis po suppliri su defettu. No podendu serbiri de retardu sa coberanza de su fundu de su Monti, po essiri bastantis is providenzias ch at donau Su Visurrei in sa Litera sua de 10. de Dogniassantu in s articulu chi commenzat, In non poche, depinti is Amministradoris Localis arremitiri is Tabellas de is contus po 306 = cussus. 307 L cungaus. 308 = demanialis. 309 L imbiai. 180
181 totu sa dì 15. de Meseladamini senza prus dilazioni: baxu pena de si dispaciai Commissariu a gastus de is Amministradoris localis. In su casu chi calincunu de Bidda appat fattu donazioni, o limosina a su Monti; nosi deppinti informai ancora de cussu cun distincioni, po nddi donai contu a Su Visurrei, chi certamenti ddat alabai. Nos ant a informai ancora de totu su chi Su Visurrei cumandat in sa Litera sua sirculari de 11. de Mayu in s articulu chi cumanzat avvertendo. Dependurusi pagai is liburus, e de prus cosas chi si funti mbiadas po is Amministradoris Localis; no sendurinci fundu de dinai, ant a bendiri tanti trigu cant abbastada po fai sa suma de... qui si es fattu su contu chi po occannu deppit pagai cussu Monti: e custa partida, a tempus de imbiai is contus; dd ant a fai tenni is manus a su Secretariu, chi innoi si firmat: piguendu de custu s arrecida. Ottu dis depusindis de ai 310 arreciu custa litera, bolleus ixiri si ddanti tenta, isplichendu si intendint is Amministradoris su chi cuntenidi, o calis funti is difficultadis, chi nc agatanta po siddas fai intendiri. A su propriu tempus nosi deppint informai si tenint in s arcivu su Regulamentu de 10. de Meseladamini e is circularis de 11. Maiu, e 10. Donniassantu de s annu 1768.: e si in poderi de is Censoris funti is Instruzionis chi su Escell mu.311 Signor Conti Tana aiat mandau publicai. Custa litera nosta s at a cunservai paris cun is ataras de Su Visurrei e ataras nostas: avertenduru a is Amministradoris Localis, chi s in s ocasioni de visita chi podeus cummandai de is arcivus, si agatessit sa farta de calincunu 312 de is ordinis nostus ò de totus; eus a providiri de is copias, a gastus insoru: e po cußu ant a teniri su depidu cuidadu e zelu chi funti obligadus de cussas iscritturas. (Pubblicato sul numero 11 di NAE) 310 L deai. 311 = Escellentissimu. 312 L calicunu. 181
182 Appendice VIII Una parafrasi ottocentesca del Salmo cinquantesimo Tra le carte della raccolta Laconi, conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, c è una copia della parafrasi in sardo campidanese del Salmo cinquantesimo, curata dalla Confraternita di Santa Restituta. L opera era stata pubblicata dalla stamperia civica di Carlo Timon nel 1823, come dice il testo, in basso nella prima pagina: Caralis 1823 / In sa Stamp<eria> civica de CARLUS TIMON / Cun permissioni. Il termine parafrasi è inteso non solo e non tanto come esposizione del testo latino, per mezzo di parole diverse, quanto come libera riflessione e meditazione dei varî passi del salmo. La parafrasi è in ottave: i 144 versi endecasillabi complessivi sono ripartiti in 18 strofe, ciascuna delle quali ha lo schema metrico ABABABCC e prende il nome dall inizio di un verso del salmo in latino. Ogni ottava è preceduta dalla citazione del corrispondente inizio di versetto biblico in latino. L opera, stilisticamente ben curata e di discreto valore letterario, è un buon esempio di campidanese illustre del primo Ottocento, e offre elementi utili per la storia della lingua. La grafia segue decisamente il modello italiano, e di spagnolo resta un solo tratto, la lettera x che, in concorrenza con sce/sci, indica la fricativa palatoalveolare sorda: a sciu e conosci conoscere si contrappongono conoxiu, in cui la -i- è inutile simbolo grafico in analogia con lo stesso trigramma italiano sci-, ed exemplu (qui il grafema non pare avere valore etimologico); la x è usata anche per la corrispondente consonante sonora, inesistente nel sistema fonologico italiano (rexoni, cumplaxeis). Per l affricata dentale sorda si usa solo z: zerriau, pozza che io possa. La vocale e in iato può passare a i (di essiri, i heis a essiri). Le consonanti intervocaliche dalla pronunzia intensa sono quasi sempre scritte doppie. Sono segnati gli accenti per indicare il timbro delle vocali e ed o. L infinito apocopato è segnato con l apostrofo. Un incertezza grafica si riscontra al verso 70: non de ddu pighéis, con de che sta per relativo di luogo nde/ndi. Nelle forme del verbo avere compare h- etimologica, ed il pronome relativo è scritto su quali. Numerosi sono i fatti interessanti di morfologia. I pronomi enclitici, uniti all imperativo dei verbi, prendono sempre l accento (castiaimí, agatendumí); il pronome di II persona plurale si presenta nelle diverse forme bosu (tonico), os(í) e si (atoni). Il congiuntivo imperfetto ha desinenza -essi (fessi). Il gerundio esce in -endu (sighuendu, cantendu), in un caso allungato in -ru (essenduru). Il participio passato solitamente esce in -au/-ada e iu/-ia (incadenau, obbligau, beníu, dividíu), ma quello di seconda coniugazione per motivi metrici può mantenere -d-: seu stetid obbligau. Si nota l assenza del perfetto, sostituito nelle sue funzioni dal trapassato prossimo (idd hestis revelau lo rivelaste ). 182
183 Per quanto riguarda la sintassi, la congiunzione concessiva mancai richiede il verbo al modo congiuntivo (mancai dignu non sia), il quale modo è usato nelle proposizioni finali (osí pregu, chi innantis mi limpiéis) e temporali (innantis chi deu torri). Esempî di stile letterario sono il pronome relativo su quali e il frequente uso della forma passiva. Un tipico costrutto implicito sardo si ritrova al v. 60: su quali pregu a bosu a mi donai. Un evidente italianismo sintattico, a parte l aggettivo anche possessivo spesso preposto al nome, è la locuzione avverbiale de su tottu del tutto. Sul piano lessicale, l aggettivo femminile esenta è una forma antiquata del moderno esente, e riprende il latino exemptus. Gli italianismi sono numerosi e lampanti: oltraggiai, impegnau, rinforzau e altri; rimane però una significativa porzione di lessico d origine iberica: alabau, bondadi, Magestadi ecc. La punteggiatura del testo sardo è lasciata quasi sempre invariata, a testimonianza delle abitudini grafiche del tempo. La traduzione è fatta in endecasillabi, e rispetta, fin dove è possibile, lo schema metrico dell ignoto autore. Per rispetto della fonologia sarda, gli accenti acuti sulle i sono da noi mutati in gravi, mentre gli accenti sulle vocali e ed o sono mutati allorché non rispettano la natura chiusa o aperta del fonema espresso. La sigla T nelle note a piè di pagina indica la suddetta edizione ottocentesca di Timon. PARAFRASI DE SU SALMU CINQUANTESIMU DE SU R. B. D. E. L. C. PRESENTADA DE SA GERMENDADI DE S. RESTITUTA IN IS ISTAZIONIS DE CENABARA SANTA A MENGIANU 5. Miserere mei Deus Misericordia, e piedadi, o Signori, Segundu s infinita osta bondadi, 183
184 De custu indignu, e vili peccadori, Chi maliziosamenti offendiu os hadi; Mancai dignu non sia de s ostu amori Castiaimí cun ogus de piedadi, Is culpas mias si pregu, chi sburréis, Gia chi a is peis bostus umiliau mi biéis. 8 Quoniam iniquitatem meam Non serbit chi m occulti su peccau, Chi claramenti ananti mi ddu bíu, Chi po m essi cun issu incadenau Mi seu de Bosu in tottu dividíu; Est solu a Bosu a chini hapu aggraviau Chi a custu stadu finas seu beníu De appettigai cun grandu disonori Is leis bostas sagradas, o Signori Ut justificeris Giustamenti cun megus seis airau Ddu conoxiu, o Signori, e seu cumbintu; E si fessi a Giudiziu imòi zerriau De Bosu, cun rexoni hem essi bintu, Chi tanti a os oltraggiai mi seu impegnau, Cantu prus osí seis cun mei distintu; Conoxiu, chi merexiu zertamenti D essiri castigau severamenti. 24 Ecce enim in iniquitatibus 184
185 Est beru ddu cunfessu hapu peccau, Os hap offendiu maliziosamenti; Ma si appenas chi in su mundu seu intrau Senza conosci culpa po nienti Po Babbu miu seu stetid obbligau A nasci cun s infamia zertamenti, E m hat generau Mamma tali, e quali Cun cussu peccau vili originali Ecce enim veritatem dilexisti Eppuru in d unu tempus, o Signori Amastis tanti custu coru miu Cun d unu veru e cordiali amori, Chi dd hestis de tesorus arricchiu, Is occultus secretus po favori Idd hestis revelau po su chi sciu: Imòi privu dd incontru de su tottu De grazias, e de Bosu non conottu. 40 Asperges me hyssopo Chi m aspergiais, Signori osi ddu pregu Cun su misticu Isopu, e seu mundau, E si Bosu bolèis, hap essi luegu Prus biancu de sa nií zertu torrau. Custu spiritu debili os intregu Po essi de Bosu in tottu rinforzau; E ancora custu flaccu corpus miu Siat agili, gagliardu, e incoraggíu
186 8. Averte faciem meam Ma, Signori, po imòi non mi miréis, Chi m agattu de culpas aggraviau, Osí pregu, chi innantis mi limpiéis S ingratu coru miu de su peccau, Iscíu, chi prus de mei ddu conoscéis, Cho os hadi cun frequenzia abbandonau, E si no est 313 limpiu de s iniquidadi De ddu mirai nò est dignu cun piedadi. 56 Cor mundum crea in me Deus Custu coru chi portu ingratu, e impuru Mi ddu podeis, Signori, reformai Cun d un aturu coru limpiu, e puru Su quali pregu a Bosu a mi donai, Po podi cun affettu prus seguru Sa Magestadi Bosta venerai; E su spiritu miu debilitau Chi siat de Bosu ancora renovau Ne proijcias me a facie tua Gia chi mi seu, Signori a is peis postrau Osí pregu, chi no mi nci boghéis; Beru est, chi gravementi hapu peccau. 313 T est 186
187 Ma repentíu de coru giai mi biéis, E su Divinu Spiritu oltraggiau De mei, Signori, non de ddu pighéis, Chi agatendumí privu de sa grazia Torru de bell e 314 nou arrui in disgrazia. 72 Redde mihi laetitiam Cudda bell allerghía, chi deu tenía, Innantis de os offendiri, o Signori, Osí pregu, chi mi siat restituía, Po si serbiri imòi cun prus fervori, E cunfirmai cust anima mia Cun d unu spiritu veru de amori, Po chi amend osi deu sinzeramenti, Osi pozza gosai seguramenti Docebo iniquos vias tuas E cun su bonu exemplu hap a imparai A is prus impius, perversus peccadoris, Cuddus chi femu deu prevaricai Cun is abbominabilis erroris, Po podi prontamenti abbandonai Di essiri de sa lei persecutoris, Sighendu solamenti sa virtudi Chi est su veru camminu de saludi. 88 Libera me de sanguinibus 314 T bell è. 187
188 Ma chi sia però innantis liberau De sa predominanti mia passioni, Chi est sa chi m hat su coru incadenau, E m hat redusiu in custa situazioni, I heis a essiri depustis alabau De mei, Signori, cun venerazioni, Cantendu cun cuntentu, ed allerghía, Is glorias bostas cun sa lingua mia Domine labia mea aperies Ma innantis, chi deu torri a os alabai, Aberei Bosu custa bucca mia Po podi novamenti articulai Is laudis bostas cun summ allerghía Po ddas podir ancoras annunziai A genti disconnotta, e presumía Po essiri de issas puru venerau Abbandonendu in tottu su peccau. 104 Quoniam si voluisses Bosu, Segnori, sciu chi non boléis 315 Atturus sacrifizius a osi fai, Ma sciu chi prus prestu pretendéis Anima, vida, e coru a osi intregai: De is olocaustus non si cumplaxéis Po chi nò abbastant a osí satisfai; Boléis su sacrifiziu solamenti De sa mia voluntadi prontamenti T sciu, chi non bolèis. 188
189 12. Sacrificium Deo spiritus contribulatus Custu solu boléis, Signori miu, Chi a Bosu tottu sia sacrificau De s amori miu propriu dividíu Po essiri solu a Bosu uniformau; Ma unu coru umiliau, e repentíu De os hai cun culpas gravis oltraggiau Creu, chi non dd heis, Signori, a disprezziai Gia chi promittit de mai prus peccai. 120 Benigne fac Domine Po is peccaus mius, Signori, non lasséis D essi de Bosu Sion beneficada, No abbarrit prus comenti dda tenéis De su tottu de Bosu abbandonada; Osí pregu, chi ancora edifichéis Sa noa Gerusalemme disigiada, E chi tengat sa Bosta protezioni Po essiri esenta de persecuzioni Tunc acceptabis sacrificium justitiae E inzaras, o Signori, heis azzettai Tott is offertas mias benignamenti, Tott is operas bonas chi hat a fai 189
190 Su Populu d Israeli penitenti, Po podiri de su tottu applacai Cussa Giustizia Bosta Onnipotenti, Chi essenduru aici tottus repentíus Heus a essiri salvaus tott uníus. 136 Gloria patri etc. Su Babu eternu siat glorificau, E su Verbu umanau Salvadori, E siat ancora de nosu alabau Su spiritu Divinu cun fervori; Comenti in su prinzipiu esti istau, Sempiri aici had essi senz errori, Chi differenti essi non podiat Po is seculus de is Seculus, aici 316 siat. 144 Parafrasi del Salmo cinquantesimo del Beato Re Davide, presentata dalla Confraternita di Santa Restituta nelle stazioni mattutine del Venerdí santo 5. Abbi pietà di me, o Dio Misericordia e pietà 317, o Signore, per la vostra illimitata bontà, per questo indegno e vile peccatore, che maliziosamente offeso vi ha; benché degno non sia del vostro amore, 316 T Aici. 317 Sottinteso io vi chiedo. 190
191 guardatemi con occhî di pietà: le mie colpe vi prego che togliate, ché ai vostri piedi umile mi mirate. 8 Poiché la mia iniquità Non serve ch io mi celi il peccato, ché chiaramente innanzi me lo vedo: per essermi con esso incatenato mi sono da voi in tutto diviso; siete soltanto voi che io ho offeso: se a questo stato infine sono giunto, di calpestar con grande disonore le leggi vostre sacre, o Signore Affinché tu appaia giusto Giustamente con me siete adirato: riconosco, Signore, e son convinto; e se fossi a giudizio ora chiamato da Voi, con ragione sarei vinto, ché tanto ad oltraggiarvi ho lavorato, quanto piú voi m avete favorito. So che merito indubitabilmente d esser castigato severamente. 24 Ecco: nella colpa È vero, lo confesso, ho peccato, vi ho ingiuriato maliziosamente; ma essendo io nel mondo appena entrato, 191
192 senza conoscere colpa per niente, per mio padre sono stato obbligato a nascer con infamia certamente, e generommi mamma, tale e quale con quel vile peccato originale Ecco: sincerità tu vuoi Eppure in altro tempo, o Signore, tanto amavate questo cuore mio con un sincero e cordïale amore, che di tesori voi l arricchiste, e i nascosti segreti per favore rivelaste secondo quel che so: ora lo trovo privato del tutto di grazie, e da voi non conosciuto. 40 Purificami con l issopo Che m aspergiate, Signore, vi prego, con il mistico issopo, e son mondato : se volete, diverrò prestamente piú bianco della neve certamente. Questo spirito debole v affido, che sia da voi in tutto rinforzato, ed anche questo mio corpo fiacco agil, gagliardo sia e rianimato
193 Distogli lo sguardo Ma, Signore, adesso non mi guardate, ché mi trovo di colpe oltraggiato: vi prego che dapprima mi laviate l ingrato cuore mio dal peccato; so che voi piú di me lo conoscete, vi ha frequentemente abbandonato: se non è immune dall iniquità non merita esser visto con pietà. 56 Un cuore puro crea in me, o Dio Questo cuore che porto ingrato e impuro mi potete, Signore, riformare con altro cuore trasparente e puro, il quale prego Voi di donarmi, per poter, con affetto piú sicuro, la Maestade Vostra venerare; ed il mio spirito debilitato sia da Voi ancora rinnovato Non respingermi dalla tua presenza Giacché mi sono ai vostri pie prostrato, prego, Signore, non mi allontanate; vero è che gravemente ho peccato. Ma pentito di cuor già mi vedete, ed il divino spirito oltraggiato da me 318, Signore, non me lo negate, 318 Funge da complemento d agente e si lega all oltraggiau del v
194 ché, trovandomi privo della grazia, non torni io a cadere in disgrazia. 72 Rendimi la gioia Quella bella allegria che ho fruita prima che v offendeste, o Signore, vi prego che mi sia restituita per servirvi ora con piú fervore, e confermare quest anima mia con uno spirito vero d amore, perché amandovi io sinceramente possa godere voi sicuramente Insegnerò agli iniqui le tue vie E con il buon esempio ho da insegnare 319 ai piú empî, perversi peccatori, quali ero io nel prevaricare coi miei abominevoli errori, per poter prontamente abbandonare l esser di legge essi 320 i persecutori, e seguan solamente la virtute la quale è vera via di salute. 88 Liberami dal sangue Che io sia però prima liberato dalla predominante mia passione, quella che ha il mio cuore incatenato 319 Il verbo è usato in senso assoluto. 320 Funge da soggetto dell infinitiva. 194
195 e m ha ridotto in questa situazione: allor sarete di nuovo adorato da me, Signore, con venerazione, e canterò con gioia ed allegria le vostre glorie con la lingua mia Aprirai le mie labbra, o Signore Ma prima ch io torni ad adorarvi, aprite voi questa bocca mia, perch io possa novamente dirvi le vostre lodi con somma allegria, e per poter ancora annunzïarle a gente sconosciuta e presuntuosa, e siate anche da essa venerato, con l abbandono intero del peccato. 104 Poiché non gradisci Voi, o Signore, so che non volete altri sacrifizî per voi compiuti, ma so che voi piuttosto pretendete anima, vita e cuore a voi affidati: degli olocausti non vi compiacete, poiché non bastano a soddisfarvi; volete il sacrifizio solamente della mia volontade rapidamente
196 Il sacrificio a Dio è uno spirito contrito Questo solo volete, Signor mio, che a voi tutto sia sacrificato, dall amor mio proprio separato per esser solo a voi uniformato; però un cuore pentito ed umiliato d avervi con gravi colpe oltraggiato, credo, Signor, non sarà disprezzato, giacché promette non far piú peccato. 120 Nella tua benevolenza sii propizio, o Signore Per i peccati miei non lasciate, Signor, che sia Siòn beneficata e piú non resti come la tenete, da voi completamente abbandonata; vi prego che inoltre edifichiate la nuova Gerusalemme bramata, che fruisca la vostra protezione, essendo esente da persecuzione Allora gradirai i sacrifici legittimi E allora, o Signore, accetterete tutte le offerte mie benignamente, tutte le opere buone che farà il popol d Israele penitente, affinché possa tutta esser placata codesta Giustizïa Onnipotente, perché, essendo cosí tutti pentiti, 196
197 siamo salvati noi tutti uniti. 136 Gloria al padre ecc. Il Padre eterno sia glorificato e il Verbo umanato Salvatore, e sia da noi anche venerato lo spirito divino con fervore; come nel suo principio già è stato, cosí sempre sarà senza errore, poiché diverso non sarebbe stato nei secoli dei secoli, e sia. 144 (Pubblicato sul numero 20 di NAE) 197
198 Appendice IX Fastiju e S Arruga dereta Nei Mutettus cagliaritani raccolti da Raffa Garzia (Cagliari, EDES, 1977, ristampa dell edizione del 1917), compaiono, accompagnati dalla traduzione in italiano, due testi raccolti da Luigi Pompejano, trascritti con la stessa grafia fonetica dei mottetti, difficilmente leggibile per gli inesperti. Sono scenette di vita quotidiana nella Cagliari degli ultimi anni dell Ottocento: le propongo con la grafia già indicata nell introduzione, e vòlgo in campidanese anche le didascalie, oltre ad adattare l interpunzione al testo. Si può rilevare, tra l altro, che anche nella lingua corrente il periodo ipotetico della possibilità è espresso con il congiuntivo imperfetto nella protasi ed il condizionale presente nell apodosi: Si Arritixedha pighessit su fillu e gopai Jusèpi iat a bivi mellus de una sinniora; ciò smentisce chi afferma che nel parlato si usi soltanto l indicativo nelle due proposizioni. Fastiju Aposentu a su primu susu, in dòmu e panetera. Unu guardarobba. Dòxi cadiras. Una mesa. Una màchina e cosiri. Unu Santu Jusèpi e cera ind un arrencòni, cund una lampadina. In sa genna unu corru contra s oguliau. Tziu: Ita ses fèndi, pibiruda? Ti dh apu nau jai duas bortas de ti nd intrai de sa fentana. Arrita: Ma scit chi est curiosu? Dèu no sèu beça po aturai fichia aintru e s aposentu. Tziu: Comènti e chi no nci siat faina e fai in dòmu! Arrita: E ita faina dèpu fai? Ja mi sèu scuartarada bastantemènti denantarisèru cun sa lissia. Tziu: Fai sa mija! Mama: Lassadha, Arrafièli. Po imòi chi est bagadia no fait nudha su s afaçai. 198
199 Tziu (murrungèndi): Bagadia... bagadia... in is tèmpus mius is bagadias no aturànt totu sa di comènti e is cruculèus. Mama: Bah! A su tempus nostu is óminis beniant a si pregai fintzas a pèis; imòi, po ndi coberai unu, nci olint bint annus de fentana. Sòrri prus manna e Arrita: A is bortas ancora trinta (suspirat). Tziu: E chi no dh apu biu no? cussa faci e macu chi est fèndi s ogu trotu a Arritixedha? Arrita: Faulançu tziu! Faulançu tziu! Dèu no càstiu a nisçunus. Tziu (primau): Aici naras faulançu a tziu tuu? (est po si pesai). Mama (ponendisí in mesu): Lassadha! Ja scis chi si s inchietat dhi pigant is convurtziònis. Pòdit èssi chi tui apas bistu mali. Tziu: Tzurpa ses tui! Portat castorru, portat. Mama (spantada): Castorru? Castorru? (Ai Arrita) Aici ses fastigèndi cun gènti a castorru? Arrita (princhièndi): No est berus! No est berus! Faulançu, faulançu! Tziu: Faulançu a tziu tuu? (ghetat unu spumadòri chi fèrrit una tassa e dh arrogat). Mama: E ita! Sa tassa bona! Sòrri: Sa tassa de is visitas! Tziu: E si no bastat cussu... pigu sa tzirónnia puru. Arrita: No nç aturu prus, no nç aturu prus in custa dòmu! Tziu: Faidí monja e su spidali! 199
200 Mama: Citidí, Arrita, tziu tuu tènit arrexòni: nòsu no seus genti e castorru. Arrita: No sciu poita. Sòrri: No sciu poita. Arrita: Aici gomai Bonariedha no s est coyada cund unu sinniòri? Sòrri: E sentza e doda. Arrita: E sentza e doda. Tziu: Bosatras ja dha teneis sa doda (fait cun su didu mannu unu sinnu craru). Mama (si pònit in mesu): Po cussu e tanti, is pipias tènint arrexòni. A fillas mias no dhas ant a pigai spullincas. (Obèrrit su guardarobba) Castia: ses camisas, ses mudandas, dòxi mijas, fardetedhas po dòmu e po bissiri... Tziu: E totu custas chistiònis po cussa faci e macu chi passat in s arruga. Arrita: No est faci e macu, est impiegau. Mama (spantada): Impiegau? Impiegau? Sòrri: Impiegau de su guvernu. Mama (maravilliada): Impiegau de su guvernu? E intzandus castiadhu, castiadhu, filla mia! Arrita: Pigat prus de ses francus a sa di. Mama: Ahi, Santu Jusèpi bellu! Si filla mia tènit cussa sòrti t ap a tènni sa mariposa sèmpri alluta. 200
201 Tziu: Fillas macas e mama maca! Si Arritixedha pighessit su fillu e gopai Jusèpi iat a bivi mellus de una sinniora. Arrita: Dèu fusteri no ndi òllu. Tziu: E ita, babbu tuu fiat deputau? No fiat piscadòri, no? Mama (strèxit una làgrima): A sçàbbiga! Si biviat issu! (suspirat). Tziu (ascurtèndi unu sulitu chi bènit de s arruga): It est custu sulitu? Sòrri pitica: Cussu sinniòri candu passat fait sèmpri su sulitu. Tziu: Tui puru dhu connòscis! Tui puru dhu connòscis! Sorrixedha: Si, e m at chistionau puru. Totus: E it at nau? E it at nau? Sorrixedha: M at nau: È in casa la tua padroncina? Tziu: Dh at pigada po sa serbidora. Mama (umilliada): Dh at pigada po sa serbidora. Tziu: E atru t at nau? Sorrixedha: M at donau unu sodhu e m apu pigau cíxiri. Mama: E tui... ita dh as nau? Sòrri: E tui... ita dh as nau? Sorrixedha: Chi Arritixedha fiat sçacuèndi in terra. 201
202 Arrita: Ah, faci e sola (dha sighit arrennegada). Mama: La, Arrita, po imòi castiadhu sceti de sa birdiera. (Arrita intèndit torra su sulitu, bandat a sa fentana e s afaçat fichèndi sa conca aundi mancat un imbirdi) Mama (a su tziu): Arrafièli, lassadha: po castiai e fuedhai de sa fentana no nc est mali. Arrita (torrèndi atropelliada): Mama, comènti fatzu a dh arrespundi, chi m est chistionèndi in intalianu? Mama: E no dhu connòscis s intalianu? Arrita: Ap a sballiai... Mama: No fait nudha. Narasidhu chi no t intèndis de intalianu, ma chi scis fai bèni su fatu e dòmu. Arrita (s est incarada torra, e fuedhat faci a s arruga): Sissignore... Tziu: Mariuça, portamí su butilliòni e una tassa. (Sa sòrri sètzit a sa màchina e cosiri, sa mama sètzit a palas e Arrita e ascurtat). Arrita (sèmpiri fuedhèndi faci a s arruga): Sissignore... Mama: No scis nai atru che sissignore. Arrita (comènti e suba): Sissignore... Mama: Si mi pòngu dèu chistiònu mellus de tui. Tziu (bufèndi de sighida): Domandadhi cantu pigat a sa di. 202
203 Mama (fuedhèndi a pagu): Naradhi chi tui no pòdis aturai a sa fentana... chi si <ti> olit ti domandit... Arrita: Sissignore... Mama: Maladitu e sissignore! Arrita (intrèndi): Si nd est andau. Mama: E it at nau? Arrita: Arrivederci a cras. Mama (prexada meda): Bèni! Po su printzípiu no nc est mali... bastat chi acuitit. Dh apu castiau de aiségus, mi parit chi est unu sinniòri bonu. (Andèndi faci a sa stàtua) Santu Jusèpi bellu, cras t alluu sa mariposa. Sòrri (ai Arrita): Cussu est pertzona chi si ti pigat ti portat a bivi in sa Costa. Tziu (chi at bufau bèni): E ti pigat cincu bistiris de seda. Sòrri: Si arrennèscit custu, bendeus is domixedhas de Cartuçu. Tziu (scallentau): E bandu dèu puru a sa Costa. Sòrri: E besseus a capedhu. Sorrixedha: Papaus bèni... Tziu: Tàculas dúnnia di... Sorrixedha: E pabassinas
204 Tziu: E maçòni fiurratzu... Sòrri: E pudhas... Una bòxi de s arruga: Biancu e cóçulaaaaa... Biancu e cóçulaaaaa... Mama (pesendisí, a sa pitica): Tzérria cussu e sa cóçula. (Pubblicato su La vita cagliaritana, anno I, n. 33, 1900) ***** S arruga dereta S Arruga dereta (Arruga e Santa Margarita). Butegas de binu e domixedhas a s una e a s àtera ala. Imperdau sderrutu in mesu, cund un arriixedhu murenu fraghèndi. Pannus e assoliai de totu is formas e totu is colòris. Gomais, piçochèdhus e canis. Funt is nòi a menjanu. Nuntziata (a sa genna): Gomai Teresa, it est custu fragu? Teresa (in su liminarju probianu): E no dhas eis bistas cussas duas chi funt passadas? Nuntziata: Ita cosa scandalosa! E ita fragu est? Tzia Bàrbara (de una fentanedha a su basçu): Mi parit chi dhi nant múschiu. Nuntziata: Candu bivèmu in s Arruga e Gesus, de cust arratza e gènti no ndi bièmu mai (fait sa gruxi). Bàrbara: Gràtzias a Deus nòsu seus pòberas ma onoradas. 204
205 Nuntziata: E nòsu? Teresa: E nòsu? Gopai Fidèli: Cosa bona teneis a prandi, gomai Nuntziata? Nuntziata: Ghisau e unu pagu de tríllias. Fidèli: Maridu bostu ja si tratat bèni! Fillu piticu e Nuntziata: Mama, mama, Arrimundicu est ghetèndi totu su fasolu e prandi! (Nuntziata currit aintru). Fidèli: Fasolu? Nat chi teniat ghisau. Teresa (arrièndi): Ghisau de fasolu! Bàrbara: Custa gomai Nuntziata no mi parit arrobba bona. Teresa: Mancu a mèi. Mi parit tropu braghera. Nuntziata (torrèndi): Candu bivèmu in s arruga e Gesus... cussa ja fiat dòmu! Nci tenèmu tres aposèntus e sa sala. Maridu e Teresa (di aintru): Teresa! Teresa! Mi dhas acabbas is chistiònis? Aund as postu s ampudha? (Teresa bandat). Nuntziata: It arratza e maridu! Bàrbara: Maridu e mullèri... unu peus de s atra. Nuntziata: Issa puru? Bàrbara: S at comporau unu mucadòri e seda de duus francus. 205
206 Nuntziata: E fortzis no at a tènni pani po papai. Fidèli: No seis sentza e lingua, no! Bàrbara: Custu no est fuedhai mali: est nai sa beridadi. E no est beru chi issu bufat meda? E s atra di no dh at arropada? Maridu miu, chi tènit cincuant annus, cand est cun mèi parit unu pipiedhu: imòi sèu beça, e issu est sèmpri basendimí, sèmpri basendimí. Allodhu, allodhu, chi m est tzerrièndi. Bèngu, bèngu (bandat aintru). Teresa (torrèndi a cumparri in su liminarju): E tzia Bàrbara, aund est andada? Nuntziata: Nerimí, gomai Teresa, it arrobba est custa tzia Barbaredha? De ita bivit? Teresa: In dòmu sua no nci sèu stétia mai; issa bivit a is palas de is fillas. Nuntziata: Cussas chi funt in fràbbica? Teresa: Bellas chichias! Nuntziata: Totu prenas de... Teresa: Fastijant cun totus (s intèndit arremóriu e surra di aintru e dòmu e tzia Bàrbara). Nuntziata: E it est? (s apróbiat a sa genna). Fidèli (càstiat de sa genna oberricunja): Su maridu dh at donau una pariga e bucicònis. Nuntziata: A tzia Barbaredha? Teresa: Aici dh at scallentada! Bàrbara (torrat a cumparri): Ita macu cuss Arrafièli! Est coment unu pipíu: sèmpri basendimí, sèmpri basendimí. 206
207 Teresa: Castiai chi seis totu scrabionada. Bàrbara: Poita dèu no dh olèmu basai, issu m at pigau a is pilus. Ita macu! Unu póburu: Una santa limósina po s amòri e Déus! Su póburu tzurpu! Nuntziata: Piga! (donat una muneda). Póburu: Unu sodhu malu! Siat po s amòri e Deus! Nuntziata: Aici no ses tzurpu! Teresa: Açotau! Una bòxi: Lati po callai! Lati po callai! Póburu: Una santa limósina po s amòri e Deus! Totus: A perdonai. Marras: Tres arrialis! Tres arrialis! Cinque centesimi, signori... sa cantzòni de sa bagadia chi s est fuia cun s istudianti! Totus (comporant): A innòi, a innòi! Porta! Póburu: Una santa limósina po s amòri e Deus! Duus piscadòris bituleris: A scarada! A scarada s anguidha! A scarada! Gomai Arrita (scovèndi denanti e genna sua): Est pudésça cuss anguidha. Piscadòris: Pudésça ses tui. 207
208 Nuntziata: Nerit, gomai Arrita, càstît de no nd arrembulai totu s àliga a innòi! Arrita: Dèu fatzu su chi òllu. Nuntziata: Su chi òlis dhu fais in dòmu tua. Arrita: E baidindi! Nuntziata: Baidindi tui! S aliga tenididh in dòmu! Ahi, Gesugristu miu, cantu sèu pentia de mi nd èssi bissia de s Arruga e Gesus! Arrita: E citidí, chi dh as lassau prus de tres mèsis a pagai a su mèri e sa dòmu! Nuntziata: Dèu? Arrita: Tui (totu is féminas s apillant). Nuntziata: Ahi, Gesugristu miu, ita fàula! Arrita: Faulança ses tui! E ita no ti connòsçu, no? Nuntziata: Tui connòscis a mèi? Tui connòscis a mèi? Arrita: A tui, a tui! Babbu tuu fiat sabbateri ind unu portòni, tzia tua bèndit pàrdulas, mama tua fait cumandus, fradi tuu est bagamundu. Nuntziata: E la chi dh òlit, la! Arrita: Dèu fragus malus no ndi tèngu! Nuntziata: Atura! Atura! (intrat e torrat cun sa scova). Arrita: A chini? A mèi? (si batint cun is iscovas e fèrrint a unu piçocu passèndi cund una màriga e àcua. Sa màriga s arrogat). 208
209 Piçocu: Ahi, sa marighedha mia! Ahi, sa marighedha mia! Una fémina: Agitóriu! Agitóriu! Una bòxi: Sa guàrdia! Sa guàrdia! Sa guàrdia (cun su libburedhu): Chi ha rotto sa màriga? Arrita: Scurtit a mèi! Nuntziata: Lessit chistionai a mèi! Bàrbara: Bengat a innòi. Teresa: Si dhu nau dèu. Sa guardia: Silenzio! Rispettate la legge! Chi ha rotto custa marighedha? Totus: Dèu no dhu sciu. Dèu no apu bistu nudha. Sa guardia (scrièndi): Ita ti nant a tui? Nuntziata: Nunziata Puddu. Sa guardia: E a tui? Arrita: Rita Pibiri. Sa guardia: Va bene; a suo tempo sarete chiamate! (si ndi andat magestosamènti). Duus columbus (s apróbiant s unu a Nuntziata, s atru a Arrita, a bòxi basça): Si tènis abbisonju de abogau in pretura, nci sèu dèu! 209
210 (Pubblicato su La vita cagliaritana, anno I, n. 35, 1900) 210
211 Appendice X Il perfetto nella storia della lingua sarda campidanese Nel sardo medievale il perfetto, derivato dall omonimo tempo del sistema verbale latino, era regolarmente adoperato, e mostrava forme molto vicine a quelle latine: -avi, -asti, -avit, -avimus, -astis, -arun per la coniugazione in -are; -ivi, -isti, -ivit, -ivimus, [-istis], -irun per la coniugazione in -ere e -ire. In testi piú recenti si trovano anche le forme -ai (contratto in -â) e -ait (-ât) per la prima coniugazione, -ii (-î) e -iit per la seconda coniugazione 321. Il perfetto si conservò anche nei due rami in cui si suddivise la lingua medievale, ovverosia il logudorese, piú vicino al sardo antico, ed il campidanese. In campidanese esso fu usato nel Seicento e nel Settecento, e si estinse nella seconda metà del XVIII secolo stesso: tra gli scrittori dell Ottocento, infatti, nessuno piú lo adoperò. I documenti letterarî in cui è attestato il perfetto, che, come il cosiddetto passato remoto italiano, esprimeva aspetto perfettivo, cioè azione compiuta nel passato senza conseguenze sul presente 322, sono: il Libro de Comedias (1688) di frate Antonio María da Esterzili (1644/ ); il brevissimo catechismo Sa dotrina Christiana a sa lingua sardisca (1695) di autore ignoto; il Novenariu cun platicas a su amantissimu coru de Jesus (composto tra il 1726 ed il 1762) di padre Juan María Contu (morto appunto nel 1762); il Catezismu tradotto in campidanese nel 1777, su ordine di don Francesco Maria Corongiu, dal catechismo di Michele Casati; il poema didascalico De su tesoru de sa Sardigna (1779) di don Antonio Purqueddu ( ). Il perfetto presenta due tipi di paradigma, testimoniati il primo nel Seicento, il secondo nel Settecento. Il tipo piú antico distingue una coniugazione in -ari e una in '-iri/-íri. La IV persona però si noti bene è tratta dall opera settecentesca di Contu, poiché in AM compare il solo stetisistus. Primo tipo: desinenze delle due coniugazioni -ari ˈ-iri e -íri I -ei -esi -isi II -esti -isisti, -isti III -ét -esit -isit 321 Vedasi M.L. Wagner, La lingua sarda. Storia, spirito e forma, Tübingen e Basel, Francke Verlag, 1951, terza edizione 1993, pag. 335 e seguenti. La forma [-istis] non è citata nella suddetta opera del linguista tedesco. 322 Il cosiddetto passato prossimo serve invece per esprimere un azione d aspetto risultativo, ovverosia compiuta nel passato ma con conseguenze sul presente. 211
212 IV -estus -isistus, -istus V -estis -isistis, -istis VI -ént -esint -isint La coniugazione in -ari, come si può notare, a sua volta possiede due modelli: sigmatico e asigmatico. Ciò riguarda invero la I, III e VI persona, giacché nelle altre persone -s- è comunque presente per ragioni etimologiche (lat. -isti alla II, -istis alla V) e si ha dunque una sola possibile terminazione; la IV persona è formata a partire dalla V, incrociata con l originaria desinenza lat. -imus. La vocale epitetica di III e VI persona, come si deduce dalle grafie usate dagli autori, è sempre -i: /ˈeði/, /ˈeɲti/. La -e- della desinenza è dovuta probabilmente all influsso di verbi quali dari < lat. dare, che presentava raddoppiamento e variazione di timbro vocalico nel perf. dedi; altri hanno pensato ad un evoluzione -ai > -ei dal sardo medievale. Per quanto riguarda il timbro di tale vocale alla IV e V persona, bisogna pensare che essa sia chiusa, come la metafonesi richiede, e non aperta; la vocale è invece aperta nell imperfetto indicativo perché in quest ultimo tempo la -e- era già aperta di natura e divenne tonica, ad esempio in perdebamus > *perdeàmus > perdèmus perdevamo, a causa della sincope dovuta all analogia coi verbi in -āri, in cui il quadrisillabo originario è contratto in trisillabo dopo il dileguamento e la caduta dell occlusiva sonora intervocalica: cantabamus > cantàmus cantavamo. La coniugazione in ˈ-iri e -íri ha sempre perfetto sigmatico. Le forme di II, V e VI persona presentano una variante sincopata. Ecco dunque, a mo d esempio, i paradigmi dei verbi andari e arrúiri: -ari ˈ-iri e -íri I andei andesi arruisi II andesti arruisisti, arruisti III andét andesit arruisit IV andestus arruisistus, arruistus V andestis arruisistis, arruistis VI andént andesint arruisint I verbi che presentano particolarità rilevanti, attestati soprattutto in frate Antonio María da Esterzili, sono i seguenti: 212
213 àiri avere, che è usato sia come transitivo, sia come ausiliare, e per tale ragione presenta due coniugazioni distinte: apisi, apisti, apisit, apistus, apistis, apisint (le persone II, IV e V sono sempre sincopate) con valore transitivo; I ai, II esti, III ait o et-i, VI ent-i con valore di ausiliare (non sono attestate le persone IV e V); dari dare, che presenta una coniugazione derivata dal lat. dedi: dei, desti, det, destus, destis, dent; accanto ad essa compare anche, alla prima persona, il tipo gei, dovuto a palatalizzazione; narri dire, che ha due coniugazioni: una ha -r- scempia narei, naresti, narét, narestus, narestis, narént; l altra presenta sincope: nei, nesti, net ecc.; (i)stari stare (è frequente i- prostetica) ha come paradigma principale stetisi, stetisisti, stetisit, stetisistus, stetisistis, stetisint, senza nessuna forma sincopata; paradigma secondario, di uguale significato ed uso, mostra (i)stei, (i)stesti ecc. Il verbo (i)stari supplisce alla mancanza del perfetto di èssiri (il perfetto fui, fuisti, fuit ecc. ha assunto valore d imperfetto dopo la scomparsa di eram in sardo), ed è usato sia nel predicato nominale, sia come ausiliare nella forma passiva dei verbi; biri vedere ha il perf. bissisi, che sembra modellato in analogia col verbo essiri uscire ed è usato soltanto nel Libro de comedias; beniri venire ha bengisi, bengisisti ecc.; mòrriri morire ha morgisi ecc.; tènniri tenere, avere ha tengisi: tutti questi perfetti sono costruiti sulla base della I persona dell indicativo presente, rispettivamente bènju, mòrju, tènju; fàiri fare ha fatzisi, e analogamente pòdiri potere ha potzisi: anche in questo caso il perfetto è costruito sulla base del presente. Nelle sue sacre rappresentazioni, frate Antonio María da Esterzili per la coniugazione in -ari usa una sola volta il modello in -esi e per il resto sceglie sempre il perfetto asigmatico, mentre per ˈ-iri e -íri adopera tanto le forme lunghe quanto quelle sincopate, con leggera preferenza per le lunghe. In Sa doctrina Christiana si trova un passo che presenta una serie di perfetti: arcedi... nascesidi... caledi... boguedi... resuscitedi; in esso sono presenti anche le voci recipidi e ascendidi, usate verosimilmente con valore di prefetto ma morfologicamente forme di presente. Si nota dunque che per -ari è ancora preferito il perfetto asigmatico, mentre il modello in -esi si è esteso alla coniugazione in ˈ-iri e -íri: ciò indica una tendenza che nel Settecento si sarebbe manifestata compiutamente. Secondo tipo: desinenze della coniugazione comune 213
214 I II III IV V VI -esi -esti -esit -estus -estis -esint Questo modello fu usato nel XVIII secolo fino alla scomparsa del perfetto stesso. Contu e Purqueddu usano soltanto il perfetto in -esi, e si hanno dunque desi da dari (ancora impiegato, ma già donari aveva assunto il significato di dare ), fatzesi, naresi, biesi da biri vedere, bolesi da bòlliri volere. Il perfetto ponghesi è usato dal solo Purqueddu. È da rilevare che le parlate logudoresi settentrionali, le uniche in Sardegna nelle quali ancora è vivo il perfetto, si servono della medesima terminazione in -esi, alla quale sporadicamente fa concorrenza il tipo in -ei di uguale significato 323 : poiché tale -e- oggi suona chiusa, v è una ragione in piú per ritenere chiusa anche la -e- del perfetto campidanese. Sulla base delle opere letterarie, si può quindi ricapitolare la storia del perfetto nella lingua sarda campidanese: dapprima esso mostrò due coniugazioni distinte in -ari e '-iri/-íri, parimenti agli altri tempi semplici del modo indicativo; in seguito si giunse all uniformazione in un unico modello di coniugazione; poi il perfetto uscí dall uso e infine scomparve. (Pubblicato sul numero 22 di NAE) 323 Wagner, opera citata, pag
215 Appendice XI L uso dei modi indefiniti in sardo campidanese Il gerundio nella lingua della Sardegna meridionale presenta omologazione in -ènd- (sempre con e aperta) fra le tre coniugazioni, ma duplice uscita in -u e -i: cantèndi/cantèndu, perdèndi/perdèndu, dromèndi/dromèndu. Sono attestate anche forme ampliate in -èndiri/-ènduru 324. In sardo campidanese moderno il gerundio si usa in tre situazioni, le prime due delle quali sono piú diffuse della terza. 1) per esprimere, in composizione con l ausiliare essere, il presente e il passato progressivi all indicativo. Esempî: sèu nadèndi, fèmu currèndi, fèstis tzerrièndi. Si noti che l ausiliare genuino è èssi, non stai, il quale ultimo fu adoperato in passato per influsso iberico, e si è ripresentato nel Novecento, in espressioni come su pipiu stat prangèndi (soprattutto alla III persona singolare): tali costrutti oggi vanno visti come italianismi. Meno diffuso è il corrispondente impiego al congiuntivo: sia cantèndi, siast cantèndi (presente); fessi cantèndi, fessis cantèndi (passato). 2) con il valore di participio congiunto, per indicare azione d aspetto durativo o progressivo 325, già evidente nel semplice sintagma àcua budhèndi acqua bollente. In questo caso il gerundio è sempre collocato dopo l elemento cui si riferisce, il quale è espresso e mai sottinteso; quale sia l elemento della proposizione reggente cui il gerundio si leghi, dipende dal costrutto richiesto dal verbo della reggente stessa. Se il verbo della reggente è transitivo, il gerundio si congiunge di preferenza con l oggetto diretto, ma talvolta anche l oggetto indiretto (complemento di termine), e varî altri complementi: 5. t apu biu passèndi acanta e su palàtziu miu ti ho visto passare (mentre passavi) vicino al mio palazzo ; su messayu at cassau a Stèvini furèndi melòni il contadino ha visto Stefano che rubava meloni. Qui il gerundio è legato all oggetto. Si noti che nella prima frase il gerundio non è posto subito dopo l oggetto soltanto perché ti è pronome atono: poiché la frase è transitiva, il gerundio non si lega di sicuro col soggetto; quando è adoperato lo stesso pronome personale in forma tonica, si ha apu biu a tui passèndi acanta è su palàtziu miu ho visto te passare... ; 324 Nel Libro de comedias (1688), frate Antonio María da Esterzili usò saltuariamente anche la terminazione in -andu. 325 Per durativo e progressivo indico quei due diversi valori aspettuali imperfettivi dell azione, in base ai quali l italiano faccio e l inglese I do si contrappongono alle forme composte sto facendo e I am doing. 215
216 6. ant ghetau perdas a sa guàrdia artzièndi is iscalas hanno tirato pietre al vigile mentre saliva le scale ; sa monja at donau limósina a una fémina caminèndi scurtza la monaca fece l elemosina a una donna che camminava scalza. In queste frasi il gerundio concorda con l oggetto indiretto. Si può avere anche la dislocazione dell oggetto indiretto a sinistra, perciò la frase diviene a una fémina caminèndi scurtza sa monja dh at donau limósina. 7. apu fatu totu su biaxi cun filla mia cantèndi de sighiu ho fatto tutto il viaggio con mia figlia che cantava ininterrottamente. Qui il gerundio è legato al complemento di compagnia. Se il verbo della reggente è intransitivo, il gerundio si congiunge di norma col soggetto, ma anche con altri elementi della frase, dopo i quali è immediatamente collocato: aintru e sa crésia dhoi fiant duas sennoras beças arresèndi dentro la chiesa c erano due signore anziane che recitavano il rosario ; mi praxit cudhu callelledhu scoitèndi mi piace quel cagnolino che sta scodinzolando ; a s umbra e cudha mata funt sétzius piçòcus joghèndi a cartas all ombra di quell albero sono seduti ragazzi che giocano a carte. Qui il gerundio è legato al soggetto. Si può avere anche l omissione del verbo essere : bosatrus a su mari spassiendisí, dèu bocendimí a berrinai voi al mare a divertirvi, io invece ad ammazzarmi lavorando col trapano ; funt lómpius a su spidali cun su malàidu chescendisí po totu s arruga sono giunti all ospedale col malato che si lamentava per tutta la strada. Qui il gerundio è legato al sostantivo di un sintagma preposizionale, con tipica funzione di complemento indiretto; chistionamu a una piçoca ascurtèndi música parlavo a una ragazza che stava ascoltando musica. Qui si ha il gerundio legato all oggetto indiretto. Nelle ultime due frasi proposte sarebbe errato legare il gerundio al soggetto vista la sua collocazione, ma poiché, essendo il verbo principale intransitivo e potendosi dunque legare un gerundio al soggetto, un margine d ambiguità sussiste, e questo costrutto inoltre si avvicina a quelli citati nel successivo tipo 3), è possibile udire la proposizione subordinata per mezzo del relativo: apu chistionau a una piçoca chi fiat ascurtèndi música. Se invece si volesse legare il gerundio al soggetto, si avrebbe: a una piçoca dh apu chistionau ascurtèndi música (il soggetto in verità è sottinteso, ma la persona verbale ne assolve le funzioni); poiché però in questo costrutto si ha anche la messa in evidenza del complemento di termine per mezzo della sua dislocazione a sinistra, prevale fèmu ascurtèndi música e apu chistionau a una piçoca. 216
217 Si ha anche il caso in cui il gerundio esprima un azione subita e non compiuta dal nome con il quale esso è congiunto: dh apu biu atripendidhu totus l ho visto mentre tutti lo picchiavano, letteralmente l ho visto picchiandolo tutti. Ciò di deve all idiosincrasia che il campidanese mostra per la forma passiva e per il complemento d agente. Non è dato il caso che si abbiano due o piú diversi gerundî, concordanti con altrettanti diversi elementi della frase. In tutte le frasi suddette non vi sono pause tra l elemento della reggente cui il gerundio è legato, e il gerundio stesso: la subordinata deve essere ritenuta una proposizione relativa determinativa. Come si vede, in tutti casi il costrutto 2) può essere vòlto nel numero 1), mediante l uso o del pronome relativo con l impiego di un tempo verbale d aspetto durativo, o dell indicativo presente/passato progressivo. Si noti anche che il gerundio col valore suddetto non è usato solanto in dipendenza da verbi di percezione, ma presenta un impiego piú vasto. Il consueto uso del gerundio con la funzione suddetta determina i tipici costrutti dell italiano regionale, nei quali al gerundio italiano si dà il valore del gerundio sardo: *l ho sentito cantando, *vi abbiamo visto correndo eccetera. 3) con valore strumentale-modale-causale, secondo ciò che in analisi logica è chiamato complemento di mezzo, modo o causa. In quest uso, caratteristico di un nome verbale 326, il gerundio segue di solito il soggetto della frase: ita est sa vida si dh imparu dèu trabballèndi totu sa dî che cos è la vita glie l insegno io lavorando tutto il giorno ; imparais joghèndi imparate giocando, cioè per mezzo del gioco. Se si volge questo gerundio in un costrutto esplicito, si osserva un azione di tipo durativo, come nell ultimo esempio, trasformabile in bosatrus jogais e aici imparais voi giocate e cosí imparate. Come si vede, in questi casi il gerundio, giacché ha valore di nome verbale, si lega sempre al soggetto, anche quando la frase è transitiva. È possibile anche collocare questo gerundio prima del verbo principale: bufèndi binu meda s at addanniau sa saludi Bevendo troppo vino (ossia col bere troppo vino ) si è rovinato la salute, vòlto in sintagma nominale, il gerundio qui dà po mòri e su binu bufau s at addanniau sa saludi, o anche po su binu bufau In latino il gerundio era un sostantivo usato ai casi diversi dal nominativo. 217
218 Si usa poi il gerundio di essere, sèndi, in locuzione con de, per esprimere il concetto dall età di, dal tempo di : si connòsci de sèndi pipius 327 conoscersi dall età della fanciullezza, trabballai de sèndi piticu lavorare sin da giovane. Non si ha un valore modale identico a quello proprio del gerundio italiano, il quale indica un azione che si svolge in rapporto ad un altra 328, espressa nella proposizione reggente da un verbo di modo finito: il gerundio sardo campidanese, cosí come il participio, non ha mai la funzione di introdurre proposizioni subordinate. Sono dunque da ritenere costrutti letterarî, modellati sull italiano e assolutamente estranei alla lingua viva, periodi come questi: *bièndi chi fiast scidu, t apu betiu su smurzu a letu vedendo ch eri sveglio, t ho portato la colazione a letto ; *cuntziderèndi chi seus stracus, andaus a dromiri considerando che siamo stanchi, andiamo a dormire. Anche quando il gerundio italiano ha valore narrativo, temporale, concessivo o condizionale, il suo uso corrispondente in campidanese è presente nella sola lingua scritta come forma dotta: Lepori 329 propone a questo proposito un esempio poco convincente quale *limpièndi is patatas mi sèu segau unu didu nel pulire le patate mi sono tagliato un dito. Questo periodo mostra un valore narrativo e temporale molto vicino al gerundio italiano, e, allo stesso tempo, il verbo della principale è transitivo: non è perciò tipico della lingua viva, che invece meglio dice fèmu limpièndi is patatas e mi sèu segau unu didu, mentre tollera limpièndi is patatas is manus pigant fragu malu col pulire le patate le mani prendono cattivo odore, frase nella quale il valore nominale causale è chiaro (= cun sa limpiadura de is patatas...). Insomma si può dire che, nella lingua campidanese viva, l uso del gerundio presenta o un prevalente valore aspettuale (progressivo o durativo), o un meno frequente valore nominale (modale-strumentale-causale); il suo impiego in altre circostanze è da ritenere un cultismo. Da notare è ancora che il gerundio, unito a pronomi personali atoni, richiede di norma la posizione enclitica del pronome: sa língua nosta seus defentzendidha la nostra lingua la stiamo difendendo ; sèu castiendidí ti sto guardando ; è presente però anche la collocazione proclitica, dovuta forse anche all influsso moderno italiano, ma già spiegabile a partire da fatti sintattici come la dislocazione a sinistra, ch esige il pronome pleonastico: a tui ti sèu castièndi te ti sto guardando. Non esiste il gerundio passato, com è logico in base alle considerazioni fatte, e per le stesse ragioni non possono essere in usi i gerundî di verbi quali ai (ormai impiegato solo come ausiliare: èndi si 327 Esempio di Antonio Lepori, Gramàtiga sarda po is campidanesus, Edizioni C.R., 2001, pagina Spesso in linguistica generale e tipologica il gerundio è detto converbio. 329 Opera citata, pag
219 trova nelle opere letterarie), èssi (sèndi forma congiunzione con chi: sèndi chi essendo che ), bòlli (il gerundio bolèndi è del verbo bolai volare ). ***** Il participio passato esprime diatesi passiva nei verbi transitivi, attiva nei verbi di moto. Il suo impiego piú frequente lo vede grammaticalizzato nelle forme analitiche d indicativo (passato prossimo, trapassato prossimo, futuro anteriore) e congiuntivo (passato e trapassato) Il participio è usato come complemento predicativo del soggetto: issu parrit stimau de totus egli sembra amato da tutti. Questo è uno dei rari casi in cui si usa la forma passiva con l espressione del soggetto d azione (complemento d agente). Lo si trova anche per esprimere subordinazione temporale in costrutti ellittici, quali pustis curtu un ora, at dépiu atobiai s amigu dopo aver córso per un ora, dovette incontrare l amico Qui, privo dell infinito o della forma finita del verbo ausiliare (pustis èssi curtu o pustis ch iat curtu), equivale ad un sostantivo verbale. Se il verbo usato invece è transitivo, il participio concorda col sostantivo Il participio può trovarsi in proposizioni relative determinative: allodhu s ómini lómpiu anca è nòsu s atra di! ecco l uomo giunto da noi l altro giorno. Il participio non si usa invece con funzione subordinante in proposizioni relative appositive, di valore temporale o causale: *su studianti, calau de su trenu, s est scarésçu una balija; *ofentzau po s arrefudu, issu no at saludau prus. Nella lingua viva non esiste neanche il participio assoluto, corrispondente all ablativo assoluto latino: *fatas custas cosas, mi ndi sèu andau. Si tratta di un italianismo sintattico, in luogo del genuino apu fatu custas cosas e mi ndi sèu andau, ovvero pustis fatas custas cosas... Il participio presente in quanto forma verbale non esiste: come cultismo può essere ricavato dal verbo e adoperato come aggettivo o sostantivo. ***** 219
220 L infinito è impiegato frequentemente nella subordinazione, e consente di cogliere la predilezione del campidanese per i costrutti impliciti. Quel che v ha di piú caratteristico in questo tipo sintattico è la proposizione infinitiva con soggetto diverso da quello della reggente: tale costrutto implicito è usato in proposizioni finali, esclusive, temporali di anteriorità e posteriorità, ed oggettive, le quali ultime siano introdotte dai verbi di volontà, timore, desiderio, comando, richiesta, permesso e impedimento. Proposizioni finali. Esempî, tutti con la congiunzione subordinante po: apu chistionau aici po ascurtai totus ho parlato cosí perché ascoltassero tutti ; tòrru a dhu nai po bòsi nd arregordai torno a dirlo perché ve ne ricordiate. Qui il verbo della finale è intransitivo, e si noti che nel secondo periodo la presenza del pronome complemento proclitico rende inutile l espressione del soggetto; chistiònu po sciri sa beridadi sa gènti parlo affinché la gente sappia la verità. Qui il verbo della finale è transitivo, cosicché l ordine delle parole richiesto dal sintagma verbale è necessariamente è V-O-S (verbo-oggetto-soggetto); apu chistionau aici po dh arreconnòsci totus a igudhu ho parlato cosí affinché quegli lo riconoscessero tutti, o meglio ho parlato cosí affinché quegli fosse riconosciuto da tutti. Qui si ha la cosiddetta dislocazione a sinistra del pronome atono, ch è poi ripreso in forma tonica: si ha dunque O(clitico)-V-S-O; apu tzerriau po dh arrocai a su cuadhu ho gridato perché il cavallo fosse fermato. Qui si ha un costrutto simile al precedente, ma il soggetto è indefinito, perciò O(clitico)-V-O; un altra prova dell avversione che il campidanese palesa nei confronti della forma passiva. t apu contau custu fatu po cumprèndi sa beridadi ti ho raccontato questo avvenimento perché tu capisca la verità. Qui, visto il senso della frase, è chiaro che il soggetto del comprendere è tui, già presente nella reggente come complemento, e non dèu: non è perciò indispensabile l espressione del soggetto. Il costrutto esplicito, soprattutto nei testi scritti, non è raro, ma ad apu chistionau po chi ascurtessint totus si preferisce sempre la variante implicita. Proposizioni esclusive. Basti citare questa: eus imbiau sa lítera chentza e sciri nudha sòrri nosta abbiamo inviato la lettera senza che nostra sorella sapesse niente. Dopo la locuzione congiuntiva chentza de si ha anche qui l ordine V-O-S. Per questo genere di proposizione la forma esplicita non c è, ma si può ricorrere alla coordinazione: eus imbiau sa lítera, ma sòrri nosta no sciriat nudha. 220
221 Proposizioni oggettive. Si distingue in base al verbo della reggente: verbi di volontà: boleus a lograi cussu trabballu bòsu e totu vogliamo che siate proprio voi ad ottenere codesto lavoro ; sa mama no bòllit a bufai bévidas medas fillu suu la madre non vuole che suo figlio beva molte bibite ; verbi di timore: timu a s atzicai sa pipia si intèndit custu contu temo che la bambina si spaventi se sente questa storia ; verbi di desiderio o speranza: spèru a pòdi bivi mellus sa gènti e cudha comarca spero che possa vivere meglio la gente di quella contrada possa vivere meglio ; verbi di comando: su duxi iat cumandau a si pònni in filera is sordaus il comandante ordinò che i soldati si disponessero in fila ; verbi di richiesta: dimandu a abetai innòi dónnia babu e mama chiedo che ogni genitore aspetti qui ; verbi di permesso: no apu permítiu a umperai su carru miu nèmus non ho consentito che nessuno si servisse del mio carro ; verbi d impedimento: sa lèi chitat a bèndi drogas chinisisiat la legge vieta che si vendano droghe da parte di chicchessia, oppure is guàrdias proibbint a passai innias is màchinas i vigili impediscono che le automobili passino là. Riguardo al costrutto e all ordine delle parole, valgono le medesime osservazioni fatte per i casi precedenti. Con i verbi di desiderio però il costrutto esplicito è molto frequente: spèru chi ti potzas acatai de sa trobedha spero che possa accorgerti dell imbroglio ; come si vede, il modo richiesto nella subordinata è il congiuntivo. Se il soggetto della subordinata è il medesimo della reggente, si ha di solito la congiunzione de anziché a: spèru de sanai chitzi spero di guarire presto. Proposizioni temporali. Soprattutto per l anteriorità si ha il costrutto infinitivo: dèu mi scidu innanti e cantai su cabòni io mi sveglio prima che il gallo canti. Meno usato esso è per la posteriorità: apusti e si coyai fillu miu apu a torrai a terramanna dopo che mio figlio si sarà sposato tornerò in continente. Anche in proposizioni soggettive, inoltre, si possono incontrare costrutti impliciti: abbisonjat a no pròi po intrai in mari bisogna che non piova per entrare in mare ; abbisonjat a spaçai is fainas nostas bisogna che terminiamo i nostri esercizî. Nella seconda frase l aggettivo possessivo consente l omissione del soggetto, non essendovi pericolo di fraintendimento. 221
222 I costrutti impliciti sopra riportati possono apparire difficili da interpretare, e sono in effetti causa di gravi errori nell italiano regionale; essi però sono regolati in maniera rigorosa, sia perché la disposizione sintattica non è lasciata al caso, sia perché, oltre ai tratti soprassegmentali richiesti all uopo, l uso della preposizione a davanti all oggetto di persona (e di animale, come si è visto da un esempio) elimina i dubbî su quale sia il soggetto. Vediamo un ultimo caso: em a bòlli a connòsci a Pàulu, Màriu (con pausa prima di Màriu) vorrei che Mario conoscesse Paolo (la virgola qui è indispensabile, anche perché non si interpreti Pàulu Màriu quale nome unico). Costrutto V-O-S nell infinitiva; em a bòlli a dhu connòsci Màriu, a Pàulu (con pausa prima di a Pàulu) vorrei che Paolo fosse conosciuto da Mario e, piú colloquiale, vorrei che Paolo lo conoscesse Mario. Costrutto O(clitico)-V-S-O. Si può anche fare ricorso all esplicita, ch è meno usata: em a bòlli chi Màriu connoscessit a Pàulu, ovvero em a bòlli chi Màriu dhu connoscessit a Pàulu (con pausa prima di a Pàulu). 222
223 Appendice XII Dedicata a Romagnino e Beccaria Secondo lo scrittore Antonio Romagnino (cito a memoria, il senso è questo) Il sardo è la lingua del focolare, idoneo all uso domestico e all espressione dei sentimenti vivi, ma inadatto ad un impiego in campo giuridico e scientifico. Tali considerazioni mi dispiacquero assai, e mi paiono ricalcare le già riportate opinioni di Gian Luigi Beccaria, in particolare la sua citazione del poeta Baldini: «In dialetto - diceva il grande poeta dialettale Raffaello Baldini - si può parlare con Dio, non si può parlare di Dio». Non credo che in dialetto si stampino studi o si facciano dibattiti di teologia. Proprio la teologia è argomento di un libro che sto traducendo dall arabo e che, per quanto mi risulta, dovrebbe essere la prima opera di teologia islamica in campidanese: a conclusione di questo volume propongo dunque, anche a chi nutra convinzioni del tipo di quelle sopra esposte, il capitolo L unicità di Dio da Questa è la nostra dottrina 330 di Šayh Abū Muh ammad c Ās im al-maqdisī (Iddio lo preservi). Chiunque legga, a mio parere, può verificare se in campidanese l espressione anche di un solo concetto sia piú difficoltosa che in italiano, francese, inglese o russo (queste ultime tre sono le lingue di cui è disponibile la versione dall arabo): anche in campidanese si può esprimere qualsiasi idea: basta volerlo ed esserne capaci. Forse Beccaria e Romagnino non sanno che la letteratura campidanese già ha trattato temi teologici: dai primi autori è passato però molto tempo, perciò provo a dare un piccolo contributo in questo campo. ***** Sa Singularidadi e Deus De sa Singularidadi e Deus naraus chi Deus est Unu cheni e sotzu perunu, ne in sa Sennoria Sua, ne in sa Deidadi Sua, ne in is Lóminis e Calidadis Suas. Duncas no dhoi at criadòri perunu diferènti de Issu, ne sennòri perunu in prus e Issu, ne atendidòri, ne urrèi, ne aministradòri e cust esisténtzia in prus e Issu. Nòsu afirmaus chi Deus est Unu in is obras Suas, cumènti afirmaus chi est Unu in is obras nostas puru. 330 Titolo originale Hādihi c aqīdatunā; la versione inglese s intitola This is our Aqīdah, quella francese Ceci est notre Aquida, quella russa это наша идеология. 223
224 Afirmaus chi est Unu in is adoramèntus nòstus, in is tentas e boluntadis nostas, ca no dhoi at nèmus adorau in prus e Issu (grória tenjat), duncas nòsu testimonjaus chi no dhoi at deidadi in prus e Issu, su Poderosu e Sàbiu cun onestadi e justesa, a sa própiu manera chi Deus dh at testimonjau po Sèi e totu, e dh ant testimonjau is Ànjulus e is arricus de sabiesa puru. Naraus aici e seus firmus in su chi afirmat custu fuedhu primorosu, po lassai s adoramentu a Deus Solu, e a sa própiu manera puru in is bisònjus, dèpiris e derètus chi cussu fuedhu bòllit; naraus aici e dennegaus su chi cussu fuedhu dhu dennegat intra e is ispétzias de assotziamentu, siat is arrexònis siat is cuntzighéntzias. Nòsu teneus fidi chi Deus at criau sa criatziòni cun s imperòu e s adoramentu de Issu sceti, cumènti at nau s Artíssimu: No apu criau a is ispiritus e a is óminis si no po m adorai (Coranu: LI, 56). E impunnaus a sa Singularidadi Sua (grória tenjat) po dónnia ginia e adoramentu, cumènti funt sa sterrinadura, s incruada, sa promissa, sa caminada a ingíriu 331, su sagrifítziu, su sgangamentu, sa pregària, sa faidura e lèis e atru. Nara: In beridadi sa pregadoria mia e su sagrifítziu miu, sa vida mia e sa mòrti mia funt de Deus Sennòri de is mundus. No tènnit sòtzus. Custu m est cumandau e dèu sèu su primu de is mussurmanus (Coranu: VI, ). Su cumandu e su Sennòri (grória tenjat) incruit is duus cumandus, segundu s univertzu e segundu sa lèi. Aici Issu Solu (grória tenjat) tènnit su podèri univertzali e sa preneta, ei est su Dirigidòri chi judigat s esisténtzia cun su chi bòllit, segundu su chi dimandat sa sabiesa Sua: a sa própiu manera nòsu afirmaus sa Singularidadi Sua (grória tenjat) in su judítziu Suu segundu lèi, e duncas no assotziaus a nèmus in su judítziu Suu e no assotziaus a nèmus in s adoramentu Suu. A no funt Suus sa criatziòni e su cumandu? Beneitu siat Deus Sennòri de is mundus! (Coranu: VII, 54). De cussu ndi bènnit chi s acussentiu est su chi Deus at acussentiu, e su proibbiu est su chi Deus at proibbiu:... Su judítziu est de Deus sceti diadèrus. Issu bos at cumandau ai adorai a Issu sceti... (Coranu: XII, 40). Duncas in beridadi no dhoi at faidòri è lèis in prus e Issu (grória tenjat s Artíssimu), e nòsu seus allènus de calisiollat legisladòri a foras e Issu, dhu strunçaus e dhu scomunigaus, e no disijaus a 331 Sa chi si fait in su Peregrinaxi a Meca. 224
225 Sennòri perunu diferènti de Issu; in prus e Issu no pigaus a nèmus che Abbogau, e no circaus nemancu arrelijòni nisçuna diferènti de s Islami. Po igustu, totu is chi pigant unu detzidòri o unu faidòri è lèis a foras e Issu, e sighint e cuncordant in sa faidura e lèis cun chini destruit sa de Deus, totu cussus ant a pigai unu sennòri diferènti de Deus, e ant a circai un arrelijòni diferènti de s Islami. S Artíssimu at nau:... èllus is dimónius ispirant a is amigus intzòru su certu cun bosatrus. Si dhis obbedesséssidis, eis èssi assotziadòris (Coranu: VI, 121). S Artíssimu at nau: Ant pigau a is arrabbinus intzòru, a is mònjus intzòru e a su Messias fillu e Maria che sennòris sarvu Deus... (Coranu: IX, 31). A sa própiu manera nòsu afirmaus sa Singularidadi Sua (grória tenjat) in is lóminis e calidadis. Duncas no dhoi at nèmus chi tènnit is lóminis suus, chi ballit a pari, nèmus simbillanti, paris o aguali. Nara: «Issu est Deus su Síngulu, Deus su Firmíssimu. No at ingendrau e no est ingendrau, e che Issu no est mancunu» (Coranu: CXII, 1-4). Issu (grória tenjat) S at fatu Síngulu po mesu e is calidadis de magestadi e perfetziòni, chi cun igussas S at descritu in su Líbburu Suu o su Profeta Suu (beneixadidhu Deus e donghididhi paxi) Dh at descritu in su Costumu suu. Duncas nòsu no descrieus criadura peruna Sua cun calincuna de is calidadis Suas, e dai is lóminis Suus no bogaus is lóminis po nèmus; a Issu (grória tenjat) no Dh imponeus cumparàntzia peruna e no Dhu feus assimbillai a nudha de sa criatziòni, e no beneus erèjus in is calidadis de su Sennòri nostu (grória a Issu). Intamus nòsu teneus fidi in su chi Issu at descritu de Sèi e totu, e in su modu chi su Missu Suu (a issu sa pregadoria e sa paxi) Dh at descritu, cun bisura e beridadi e no cun cobertantza, chèni e malògrus e strociduras, e chèni e assétius e afiguramèntus puru.... Sua est sa cumparàntzia prus arta in is cèlus e in sa terra. Issu est su Primorosu e Sàbiu (Coranu: XXX, 27). Nòsu no dennegaus nudha de Issu, de su chi Issu (grória tenjat) s est descritu. No troceus unu fuedhu de su postu suu, e no seus cun chini interpetrat po mesu e pentzamèntus suus, o bisat cun 225
226 pantasia, po mesu e su printzípiu e s esentamentu 332 che arretzallu. Nèmus s at sarbau cun s arrelijòni sua, si no chini s at assuermau a Deus su Poderosu e Magestosu e a su Missu Suu (a issu sa pregadoria e sa paxi), e at arremandau sa sciéntzia de su chi disintèndit a chini dha connòscit. In s Islami su fundóriu no est firmu po nèmus si no candu s amostant s assuermamentu e s assugetamentu a Deus, duncas chinisisiat chi pretendat sa sciéntzia e su chi dh est interdixu, e chi no siat prexau de s assuermai a su chi cumprèndit, intzandus is pretesas suas ant a pesai una gortina intra e issu e sa fidi berdadera e sa Singularidadi pura. Teneus fidi chi Deus at calau su Líbburu Suu in fuèdhus aràbigus crarus, duncas intregaus a Deus no sa sciéntzia e su sintidu de is calidadis, ma sa de is modalidadis sceti, e naraus: Nòsu teneus fidi: totu ndi bènnit de su Sennòri nostu (Coranu: III, 7). E denanti e Deus seus allènus de su printzípiu e su lassamentu de is jamistas 333, e a su printzípiu e s afiguramentu de is musçabbiistas 334 : no nos incruaus ne a igussus ne a igudhus, e aturaus strentaxus in mesu cumènti at bófiu su Sennòri nostu, e abarraus firmus intra e sa dennega e s afirmadura. Issu (grória tenjat) at nau: Nudha est símbillanti a Issu. Issu est Su chi ascurtat e spriculat (Coranu: XLII, 11). Aici chini no si càstiat de su lassamentu e de s assimbillamentu Suu, at a fadhiri e no at a spainai su printzípiu e s esentamentu. In custa banda e s arrelijòni, cumènti in totu is atras, nòsu seus aundi fiant is Antipassaus Pius nòstus e sa Gènti de su Costumu e de sa Comunidadi. De cussu est parti su chi nòsi nd at torrau sceda Deus in su Líbburu Suu, e su chi est arrelatau de sighida dai su Missu Suu 335 (a issu sa pregadoria e sa paxi), est a nai chi Issu est apitzu e is cèlus Suus, Pesau in su Sóliu Suu, aici cumènti narat s Artíssimu: A segurus seis ca Su Chi est me in su celu no bòsi fatzat spentumai in sa terra candu trèmit? (Coranu: LXVII, 16). E cumènti est arrelatau in su diçu e sa scraa, candu su Profeta (a issu sa pregadoria e sa paxi) dh iat pregontau: Aui est Deus?, e issa iat arrespustu: Me in is cèlus. Intzandus dh iat pregontau: 332 Cun su fuedhu aràbigu tanzīh s indidat chi Deus est Esentu de farta calisiollat, ca est su Primòri berdaderu. 333 Is de sa Jahmiyya funt nomenaus cumènti e negadòris de is calidadis e Deus. 334 Is de sa Mušabbiha funt is chi stabbilèssint una simbillàntzia intra e Deus e is criaduras Suas. 335 Est a nai cun cadenas de trasmitidura seguras. 226
227 Chini sèu dèu?, e issa iat arrespustu: Tui ses su Missu e Deus. Issu iat nau: Afranchidha, est fièli diadèrus. Custa est sa beridadi chi po nòsu no dhoi at intzertesa. Cumènti iant fatu is Antipassaus Pius nòstus, aici dh allogaus de is cungeturas frassas, po assempru a pentzai chi su celu Dh umbrit o Dhu smènguit, mentras cussu est frassu. Fèmus amarollaus a arregordai custu, a dhu dennegai e a dhu stesiai de Deus, e si is antipassaus nòstus no dh arrefudànt cun sintzillesa, sa Gènti e is Annoaduras cun is bisònjus de frassesa suus iat strobbau a sa Gènti e su Costumu. S Artíssimu at nau: Su Sóliu Suu incruit is cèlus e sa terra (Coranu: II, 255). E Issu (grória tenjat) at nau: Deus poderat is cèlus e sa terra po no sparèssi cussus (Coranu: XXXV, 41); Issu poderat su celu po no sderrocai in sa terra chèni e su permissu Suu (Coranu: XXII, 65); Ei est parti e is prodijus Suus chi su celu e sa terra s arrèint po cumandu Suu (Coranu: XXX, 25). Nòsu teneus fidi chi Issu (grória tenjat) s est pesau in su Sóliu Suu, cumènti at nau s Artíssimu: Su Piadosu s est pesau in su Sóliu (Coranu: XX, 5). No interpetraus sa pesada cun su sintidu de conchista, imbeças s Artíssimu at calau su Coranu cun igustus sintidus in sa língua de is Àrabus. No feus assimbillai cussa pesada a sa pesada e calincuna cosa de sa criatziòni Sua, ma naraus cumènti at nau donnu Mālik: Sa pesada est connota, e sa fidi in custa est pretzisa. Cumènti est s innorat, e sa pregonta assuba e cussu est un annoadura. In custa manera e totu nòsu aproaus is atras calidadis Suas e is atras atziònis Suas (grória a Issu s Artíssimu), cumènti e sa calada, sa bénnida e s atru chi Issu (grória tenjat) nòsi nd at torrau sceda in su Líbburu Suu, o chi funt cunfirmadas in su Costumu berdaderu. Imparis cun sa pesada Sua a su Sóliu e cun s artesa Sua apitzu e is cèlus, nòsu teneus fidi chi Issu (grória tenjat) est Probianu a is serbidòris Suus, cumènti at nau Issu e totu (grória tenjat): Candu is serbidòris Mius ti pregontant de Mèi, Dèu sèu Probianu diadèrus! (Coranu: II, 186). E su diçu chi dhoi at cuncórdiu: O óminis! Candu pregais me in bòsu e totu, no tzerriais diadèrus a calincunu chi siat surdu o ausènti. Nossada, tzerriais a Calincunu Ch intèndit totu 227
228 e Chi bît totu. Èllus, Su Chi Dhu tzerriais bos est prus Probianu chi su tzugu e s animali e cuadhigai bostu. Issu est cun is serbidòris Suus aundisiollat chi siant, e scît su chi faint, cumènti at nau s Artíssimu: Issu est cun bosatrus aundisiollat chi siais. Deus spriculat su chi feis (Coranu: LVII, 4). No cumprendeus su fuedhu Suu ma c akum ( est cun bosatrus ) cun sa boluntadi e is discreèntis, chi po cussus Issu s est amesturau cun is serbidòris Suus, o s est tramudau ind una parti e cussa, o s est uniu cun igussa, o atras cosas chi funt creéntzias de su negamentu e de su straviamentu. Nossada, seus allènus a totu custu denanti e Deus. E Issu (grória tenjat) cun is Serbidòris fièlis Suus tènnit un atra prossimidadi spetziali, chi no est sa bixinàntzia comuna, ma sa bixinàntzia de ajudu, de arrenéscida e de schítiu 336, cumènti at nau s Artíssimu: Deus est diadèrus cun is chi Dhu timint e cun is chi funt caridadòsus (Coranu: XVI, 128). Duncas Issu (grória tenjat), imparis cun sa pesada a su Sóliu e cun s artesa Sua apitzu e is cèlus, est cun is serbidòris Suus aundisiollat chi siant e scît su chi faint; Issu est Probianu a chini Dhu pregat, est cun is serbidòris fièlis Suus, dhus amparat, dhus ajudat e dhus atèndit; sa bixinàntzia e sa prossimidadi Sua no dennegant sa pesada e s artziada Suas, ca nudha est simbillanti a Issu in is calidadis Suas (grória tenjat). Issu est Artziau in sa bixinàntzia Sua, e Probianu in s artesa Sua. Intra e is frutus de cussa Singularidadi spantosa, dhoi at su deretu e Deus assuba e is serbidòris Suus: Sa bonasòrti e s unista 337 in Deus sceti est su Paraisu e su Sennòri suu e sa sarbesa de su Fogu, cumènti si bît in su diçu e Mu c ād bin Jabal (cumpraxadasí Deus de issu). De cussu fait parti su spantu e su bàntidu e su Sennòri po mesu e sa connoscéntzia e is calidadis Suas de perfetziòni e magestadi, e in prus su de torrai grória a Issu e s esentamentu puresa dai dónnia simbillàntzia o figuramentu. A sa própiu manera ndi fait parti s arreconnoscimentu chi est scimpru chini si pigat unu pari Suu chèni e Issu, e si dh assótziat in s adoramentu, in su judítziu o in sa faidura e lèis. 336 Est a nai su sdepidamentu e su serbidòri cun su Sennòri suu. 337 In aràbigu muwah h id : bòllit nai su chi crèit in s Unu, est a nai su chi afirmat sa Singularidadi e Deus ; su fuedhu scípiu aregu prus umperau po dhu tradusi est monoteista. 228
229 E ndi est parti puru su sçusçu e s arruina de chini a Deus Dh at assotziau a sèi e totu ind unu de cussas cosas, mancai no si siat assotziau in sa criatziòni, e no tenjat mota peruna in su podèri, in sa providéntzia e in s aministramentu. De sighida e cussu, su còru e s anima si scàpiant de dónnia tzerachia a is cosas criadas. E de cussu ndi bènnit tambèni sa firmesa e su serbidòri in sa vida de custu mundu e de s atru, duncas chini est imbitzau a adorai a sòtzus arrevèsçus, e dhus pregat e sperdítziat sa paura e sa spera sua intra e cussus, no est che chini at afirmau sa Singularidadi e su Sennòri suu (grória a Issu) e at impunnau a Issu sa timoria, sa spera, sa tenta, sa boluntadi e s adoramentu suu. O Deus, o Abbogau de s Islami e de sa Gènti sua, cunfirmanosí in sa Singularidadi Tua fintzas chi T eus a atobiai! (pigau de Nòsu creeus in custu) 229
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
184 Il dialetto arzaghese
 INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
INDICE PREFAZIONE...3 Prefazione alla seconda edizione...8 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA...9 Fonemi...9 Alfabeto IPA...10 Alfabeto arzaghese e sua corrispondenza col sistema fonologico...17 Ortografia...18 Scrittura
Abdullah Luca de Martini L EVOLUZIONE DELLA LINGUA SARDA MERIDIONALE DAL SEICENTO AD OGGI. GRAMMATICA STORICA DEL CAMPIDANESE
 Abdullah Luca de Martini L EVOLUZIONE DELLA LINGUA SARDA MERIDIONALE DAL SEICENTO AD OGGI. GRAMMATICA STORICA DEL CAMPIDANESE con un appendice di testi inediti SOMMARIO: pagina Introduzione 2 1. Antonio
Abdullah Luca de Martini L EVOLUZIONE DELLA LINGUA SARDA MERIDIONALE DAL SEICENTO AD OGGI. GRAMMATICA STORICA DEL CAMPIDANESE con un appendice di testi inediti SOMMARIO: pagina Introduzione 2 1. Antonio
VIII. Indice. Unità 2 La semantica 20
 Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Presentazione Metodo e menti Struttura dell 0pera Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3
Analisi grammaticale
 Analisi grammaticale Grammatica II C - Settembre 2006 1 nome articolo aggettivo pronome verbo Le nove parti del discorso VARIABILI INVARIABILI queste parti si flettono (declinazione) secondo il e il si
Analisi grammaticale Grammatica II C - Settembre 2006 1 nome articolo aggettivo pronome verbo Le nove parti del discorso VARIABILI INVARIABILI queste parti si flettono (declinazione) secondo il e il si
PARTE PRIMA - FONETICA
 Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
Sommario PARTE PRIMA - FONETICA 1. Scrittura e pronuncia 3 1.1. Introduzione 3 1.2. L alfabeto: i segni grafici 6 1.2.1. La pronuncia del greco e la fonetica 7 1.2.2. Spiriti 10 1.2.3. Segni d interpunzione
che cosa sai fare Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5
 Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
INDICE GENERALE Capitolo 1 - preliminari... 3 Capitolo 2 - Morfologia: preliminari... 12
 INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
INDICE GENERALE Capitolo 1 - Preliminari... 3 1. L alfabeto latino...3 2. La pronunzia del latino...4 3. Vocali e semivocali...5 4. Dittonghi...6 5. La dieresi...7 6. L apofonia...7 7. Consonanti...7 8.
2 Affinità e differenze 15 La pronunzia 15 L alfabeto e la fonetica 16 Il lessico 16 La morfologia e la sintassi 17 I casi e le funzioni logiche 18
 XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
XI verso il latino 1 Il latino per strada 2 2 Il latino e la sua storia 6 1 L antica lingua di Roma 6 Il latino e l italiano 6 Perché il latino si chiama così 7 Quando si parlò l antica lingua di Roma
MORFOLOGIA ITALIANA seconda edizione riveduta ed aggiornata I N D I C E
 I N D I C E Introduzione... 1. Il verbo... 1.1. Classificazione... 1.1.1. Il significato e la funzione dei verbi... 1.1.2. Il genere dei verbi: verbi transitivi e verbi intransitivi... 1.1.3. La forma
I N D I C E Introduzione... 1. Il verbo... 1.1. Classificazione... 1.1.1. Il significato e la funzione dei verbi... 1.1.2. Il genere dei verbi: verbi transitivi e verbi intransitivi... 1.1.3. La forma
SU VERBU de AGIUDU (verbi ausiliari)
 SU VERBU de AGIUDU (verbi ausiliari) AÌ (avere): no tenit su particìpiu, e candu bolit nai possiedo tandu si ponit Tenniri : deu tengu fàmini. Si ponit puru po nai esserci, esservi : no ddoi at nemus;
SU VERBU de AGIUDU (verbi ausiliari) AÌ (avere): no tenit su particìpiu, e candu bolit nai possiedo tandu si ponit Tenniri : deu tengu fàmini. Si ponit puru po nai esserci, esservi : no ddoi at nemus;
PROGRAMMA DI GRECO ANNO 2009/10 CLASSE IV E
 LIBRO DI GRAMMATICA DESCRITTIVA CAPITOLO 1 1. L alfabeto 2. La pronuncia 3. Segni diacritici 3.1 Gli accenti 3.2 Gli spiriti 3.3 La punteggiatura 3.4 L apostrofo 3.5 La coronide CAPITOLO 2 1. Le vocali
LIBRO DI GRAMMATICA DESCRITTIVA CAPITOLO 1 1. L alfabeto 2. La pronuncia 3. Segni diacritici 3.1 Gli accenti 3.2 Gli spiriti 3.3 La punteggiatura 3.4 L apostrofo 3.5 La coronide CAPITOLO 2 1. Le vocali
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO
 Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Alda Baldaccini Patrizia Pugliese Maria Cristina Zanti IL MIO LIBRO DI ITALIANO 1998 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione
Fonologia e ortografia
 Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Programma di lingua e letteratura italiana (grammatica) 2014/2015 Prof.ssa Maria Rosaria Aliberti Classe 1BT Fonologia e ortografia I suoni e i segni Come si scrivono e come si pronunciano le lettere Uso
Opere Lemmatizzate. Etichettatura morfo-sintattica opere volgari
 Opere Lemmatizzate Etichettatura morfo-sintattica opere volgari Codifica delle forme Ogni forma viene marcata con l elemento . Due sono gli attributi obbligatori: lemma: contiene il lemma corrispondente
Opere Lemmatizzate Etichettatura morfo-sintattica opere volgari Codifica delle forme Ogni forma viene marcata con l elemento . Due sono gli attributi obbligatori: lemma: contiene il lemma corrispondente
Indice. Introduzione. Unità I. Unità 2. Unità Unità Unità Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica
 Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
Indice Introduzione Simboli impiegati nelle nozioni di grammatica storica Unità I 1.1. I1 latino lingua indoeuropea / 1.2. Le fasi della lingua latina / 11.1. L alfabeto latino / 11.2. La pronuncia del
BFLR A Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA. edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto
 BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
BFLR A 351667 Alfonso D'Agostino LO SPAGNOLO ANTICO SINTESI STORICO-DESCRITTIVA edizioni U.niuz'iiitaxU di J-ttizit economia J->iiitto INDICE ABBREVIATURE 1. Principali abbreviature usate, p. 11 n INTRODUZIONE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Federico II di Svevia PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE I SEZ. A CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof.ssa Carmen Santarsiero SEZIONE 1 - UNITA 1 1.1 Vocali
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N. Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato.
 DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
DOCENTE: ERRICO INES DISCIPLINA: GRECO CLASSE 1 N Contenuti da recuperare Tipologia della prova Modalità di recupero Morfologia del nome e del verbo. Elementi di sintassi come da programma allegato. -
INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE
 INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
INDICE Premessa... XIII Abbreviazioni... XV INTRODUZIONE: IL GERMANICO E LE LINGUE GERMANICHE 1. Le lingue germaniche... 3 1.1 Le lingue germaniche moderne... 3 1.2 Le lingue germaniche antiche e la loro
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: LATINO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Nozioni di fonetica Flocchini-Guidotti
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti. Alla scoperta dell italiano
 Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Alla scoperta dell italiano 2003 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A. PROGETTO GRAFICO Vincenzo Marineo COPERTINA Federica Giovannini ILLUSTRAZIONI Francesca Speziale
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari. Programma di Latino
 IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
IIS Via Silvestri Liceo Scientifico Anno scolastico 2014-2015 Classe I sez. D Prof. ssa Francesca Ferrari Programma di Latino Introduzione allo studio del Latino Riflessioni sulle motivazioni allo studio.
INDICE PREFAZIONE. Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE. Capitolo 2 STATO DETERMINATO E INDETERMINATO. Capitolo 3 I GENERI MASCHILE E FEMMINILE
 INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME. Competenze specifiche Abilità Conoscenze ABILITÀ MORFO-SINTATTICHE
 OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
OBIETTIVI COGNITIVI LATINO CLASSI PRIME Fonetica sue strutture morfosintattiche di base. 3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 4. Comprendere lo stretto rapporto
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Classe: 1LC (IV Ginnasio) Disciplina: GRECO Docente: TONELLI NADIA Indirizzo: CLASSICO 1 2 Elenco moduli Argomenti Strumenti / Testi Letture Fonetica L alfabeto greco; Campanini
Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali) anno scolastico 2016/17 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA
 Contenuti minimi classi prime Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING RELAZIONI INTERNAZIONALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE
Contenuti minimi classi prime Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING RELAZIONI INTERNAZIONALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna. LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale)
 ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale) Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi,
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale) Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi,
Spagnolo seconda lingua (3 ore settimanali) Anno Scolastico 2015/16 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA
 Contenuti minimi classi prime SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON BILINGUISMO (2 ore settimanali) Fonetica spagnola
Contenuti minimi classi prime SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON BILINGUISMO (2 ore settimanali) Fonetica spagnola
Indice. Fonologia e Ortografia 15. Unità 2 La scrittura corretta 48. Unità 1 La Pronuncia delle parole 16. La Comunicazione 2
 Indice Unità 0 La Comunicazione 2 n Caratteri generali 3 n Gli elementi della comunicazione 6 Come avviene la comunicazione? 6 n I segni e i codici 9 Com è fatto un segno 10 La classificazione dei segni
Indice Unità 0 La Comunicazione 2 n Caratteri generali 3 n Gli elementi della comunicazione 6 Come avviene la comunicazione? 6 n I segni e i codici 9 Com è fatto un segno 10 La classificazione dei segni
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
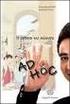 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2. Dalle linee guida CILS Livello A1
 ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2 Dalle linee guida CILS Livello A1 È il livello di avvio del processo di apprendimento dell italiano. Verifica la capacità di comprendere brevi testi e utilizzare
ALLEGATO AL CURRICOLO DI ISTITUTO ITALIANO L2 Dalle linee guida CILS Livello A1 È il livello di avvio del processo di apprendimento dell italiano. Verifica la capacità di comprendere brevi testi e utilizzare
ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO. Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio globale
 Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
Classe 1^ - FRANCESE (seconda lingua) OBIETTIVI Comprensione orale ISTITUTO LAURA BASSI - Bologna LICEO LINGUISTICO Riconoscere la situazione di comunicazione ( chi, dove e quando) Comprendere il messaggio
Indice del volume MORFOLOGIA. unità 1 Alfabeto e fonetica. unità 2 Nozioni preliminari di morfologia
 Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
Indice del volume Notizia storica MORFOLOGIA unità 1 Alfabeto e fonetica XV 1 I fonemi 2 2 L alfabeto 2 3 I fonemi del latino 3 Vocali 3 Dittonghi 4 Consonanti 4 Semivocali (o semiconsonanti) 5 4 La pronuncia
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE PRIMA Conoscere l ordine alfabetico; Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico; Riconoscere e isolare le vocali nelle parole che le contengono; Riconoscere
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Latino Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO MATERIA: latino ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROF. Maria Nivea Armellin
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE IRIS VERSARI Cesano Maderno (MB) PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO MATERIA: latino ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PROF. Maria Nivea Armellin
Materia: LATINO. Classe I sez. A. Liceo Scientifico. Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto
 Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
Materia: LATINO Classe I sez. A Liceo Scientifico Docente: Prof.ssa Carla Bonfitto a.s. 2015/2016 UNITÀ 1 L alfabeto latino e la pronuncia Vocali e dittonghi Consonanti Divisione in sillabe Quantità delle
Liceo classico Vittorio Emanuele II - Napoli. Programma di latino
 Liceo classico Vittorio Emanuele II - Napoli Classe: IV A Anno scolastico: 2016/17 Programma di latino Docente: Lina Salvadori Libri di testo: G. De Bernardis e A. Sorci, Studiamo il latino: grammatica
Liceo classico Vittorio Emanuele II - Napoli Classe: IV A Anno scolastico: 2016/17 Programma di latino Docente: Lina Salvadori Libri di testo: G. De Bernardis e A. Sorci, Studiamo il latino: grammatica
ESERCIZIO N. 2: SVOLGIMENTO DELL ANALISI LOGICA E GRAMMATICALE
 ESERCIZIO N. 2: SVOLGIMENTO DELL E GRAMMATICALE Fai l analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi. 1) Ieri Enea è andato al lavoro in scooter per lo sciopero degli autobus ma è stato multato di
ESERCIZIO N. 2: SVOLGIMENTO DELL E GRAMMATICALE Fai l analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi. 1) Ieri Enea è andato al lavoro in scooter per lo sciopero degli autobus ma è stato multato di
Ragazzini: nome comune di persona, maschile, plurale, alterato, diminutivo, concreto.
 ESERCIZIO N. 2. ANALISI GRAMMATICALE SVOLTA 1) I ragazzini giocano spesso a palla nei cortili condominiali. I: articolo determinativo, maschile, plurale. Ragazzini: nome comune di persona, maschile, plurale,
ESERCIZIO N. 2. ANALISI GRAMMATICALE SVOLTA 1) I ragazzini giocano spesso a palla nei cortili condominiali. I: articolo determinativo, maschile, plurale. Ragazzini: nome comune di persona, maschile, plurale,
ScuolaSi di Cip.Sa s.a.s. Sede Legale: Salerno Via Carmine, 127 P.IVA C.F Fax Programma del Corso di lingua Araba:
 Programma del Corso di lingua Araba: Parte preliminare Alfabeto arabo أا أ Presentazione delle lettere arabe Alif, bâ,tâ,thâ Dâl, dhâl, râ, zây, sīn, šīn Kâf, lâm, mīm, nūn Gīm, hâ, hâ, fâ,qâf Sâd, dâd,
Programma del Corso di lingua Araba: Parte preliminare Alfabeto arabo أا أ Presentazione delle lettere arabe Alif, bâ,tâ,thâ Dâl, dhâl, râ, zây, sīn, šīn Kâf, lâm, mīm, nūn Gīm, hâ, hâ, fâ,qâf Sâd, dâd,
Luca Serianni GRAMMATICA ITALIANA. Italiano comune e lingua letteraria. Con la collaborazione di. Alberto,Gastelvecchi. ni,;» ni.
 Luca Serianni GRAMMATICA ITALIANA Italiano comune e lingua letteraria Con la collaborazione di Alberto,Gastelvecchi ni,;» ni [ TTj H UTET UNIVERSITÀ C INDICE Introduzione Trascrizioni fonematiche p. Ili»
Luca Serianni GRAMMATICA ITALIANA Italiano comune e lingua letteraria Con la collaborazione di Alberto,Gastelvecchi ni,;» ni [ TTj H UTET UNIVERSITÀ C INDICE Introduzione Trascrizioni fonematiche p. Ili»
Milena Catucci Schede facilitate per esercizi di analisi logica e grammaticale
 www.ilmelograno.net Milena Catucci il QUADERNINO delle REGOLE di ITALIANO Schede facilitate per esercizi di analisi logica e grammaticale GUIDA PER FARE L ANALISI GRAMMATICALE ( come utilizzare le schede
www.ilmelograno.net Milena Catucci il QUADERNINO delle REGOLE di ITALIANO Schede facilitate per esercizi di analisi logica e grammaticale GUIDA PER FARE L ANALISI GRAMMATICALE ( come utilizzare le schede
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA
 STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA PROF. LUCA PANIERI A.A. 2012-2013 Libera Università di Lingue e comunicazione IULM Introduzione Il corso viene tenuto dal professor Luca Panieri e si occupa di tracciare la
INDICE. Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12. 1.1. Oggetto di studio 12. 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13
 INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
INDICE Ringraziamenti 11 CAPITOLOI INTRODUZIONE 12 1.1. Oggetto di studio 12 1.2. II sangiovannese nella classificazione dei dialetti calabresi 13 1.3. San Giovanni in Fiore 14 1.4. Raccolta e presentazione
PREFAZIONE...3 PREFAZIONE ALLA NONA EDIZIONE...4
 INDICE PREFAZIONE...3 PREFAZIONE ALLA NONA EDIZIONE...4 IL PRIMO CONTATTO...5 L'ALFABETO SPAGNOLO...5 Particolarità nella pronuncia di lettere e gruppi di lettere...7 Particolarità sull'uso della lettera
INDICE PREFAZIONE...3 PREFAZIONE ALLA NONA EDIZIONE...4 IL PRIMO CONTATTO...5 L'ALFABETO SPAGNOLO...5 Particolarità nella pronuncia di lettere e gruppi di lettere...7 Particolarità sull'uso della lettera
INDICE. Introduzione 9. Funzioni comunicative 52 Come comunicare la frequenza delle azioni Posso Voglio Devo
 INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
INDICE Introduzione 9 1 Essere e Avere 11 Funzioni comunicative 12 Presentarsi 2 I nomi 17 3 Gli articoli determinativi 23 4 Gli articoli indeterminativi 27 5 Gli aggettivi 31 Aggettivi della I classe:
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica. La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio. L articolo
 Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
Strumenti per comunicare 1. La competenza linguistica La Morfologia, dal greco morphé, forma e logos studio L articolo L articolo - Definizione L articolo è una parte variabile del discorso che: generalmente
La flessione Particolarità : I casi Il numero UNITA 4 LA II DECLINAZIONE
 LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II di SVEVIA MELFI PROGRAMMA DI LATINO Svolto dalla classe I sez. AS Anno scolastico 2015 2016 Prof. Giovanna Paternoster GRAMMATICA UNITA 1 FONETICA, PRONUNCIA e ACCENTO La
LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II di SVEVIA MELFI PROGRAMMA DI LATINO Svolto dalla classe I sez. AS Anno scolastico 2015 2016 Prof. Giovanna Paternoster GRAMMATICA UNITA 1 FONETICA, PRONUNCIA e ACCENTO La
Fai attenzione ai colori
 L imperativo Fai attenzione ai colori In questo PowerPoint, sono utilizzati colori diversi: Marrone= modo del verbo Rosso = persona del verbo Viola = tempo del verbo Verde = numero del verbo Verbo, modo,
L imperativo Fai attenzione ai colori In questo PowerPoint, sono utilizzati colori diversi: Marrone= modo del verbo Rosso = persona del verbo Viola = tempo del verbo Verde = numero del verbo Verbo, modo,
Carlo: nome proprio di persona, maschile, singolare, primitivo, concreto.
 ESERCIZIO N. 4: SVOLGIMENTO DELL ANALISI GRAMMATICALE Carlo e Francesca desidererebbero frequentare un corso di matematica ma i posti sono occupati. Carlo: nome proprio di persona, maschile, singolare,
ESERCIZIO N. 4: SVOLGIMENTO DELL ANALISI GRAMMATICALE Carlo e Francesca desidererebbero frequentare un corso di matematica ma i posti sono occupati. Carlo: nome proprio di persona, maschile, singolare,
1) Sebbene tu non sia molto studioso, hai una spiccata intelligenza.
 ESERCIZIO N. 3: SVOLGIMENTO DELL ANALISI GRAMMATICALE 1) Sebbene tu non sia molto studioso, hai una spiccata intelligenza. Sebbene: congiunzione concessiva. Tu: pronome personale soggetto di seconda persona
ESERCIZIO N. 3: SVOLGIMENTO DELL ANALISI GRAMMATICALE 1) Sebbene tu non sia molto studioso, hai una spiccata intelligenza. Sebbene: congiunzione concessiva. Tu: pronome personale soggetto di seconda persona
Nome. Articolo. Aggettivo. Variabili. Pronome. Parti del discorso. Verbo. Avverbio. Preposizione. Invariabili. Congiunzione.
 Nome Articolo Variabili Aggettivo Pronome Parti del discorso Verbo Avverbio Invariabili Preposizione Congiunzione Interiezione IL VERBO (dal latino verbum = parola) Parte variabile del discorso Esprime
Nome Articolo Variabili Aggettivo Pronome Parti del discorso Verbo Avverbio Invariabili Preposizione Congiunzione Interiezione IL VERBO (dal latino verbum = parola) Parte variabile del discorso Esprime
L italiano regionale. Lezione del 13 novembre 2014
 L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
L italiano regionale Lezione del 13 novembre 2014 A proposito del dialetto tra i giovani, a p. 52 del libro di testo (Marcato) si legge: Il dialettalismo, in qualche caso, può non essere diretto nel senso
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: LATINO Prof. SANTOMAURO TERESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA DIDATTICHE/MODULI
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO MATERIA: LATINO Prof. SANTOMAURO TERESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Classe I^ AS ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE/MODULI Num Titolo delle UNITA DIDATTICHE/MODULI
NORME DI LEMMATIZZAZIONE
 ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL INFORMAZIONE GIURIDICA del Consiglio Nazionale delle Ricerche Paola Mariani Biagini NORME DI LEMMATIZZAZIONE Rapporto interno n. 9/2002 Firenze Sostantivi: I sostantivi
ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL INFORMAZIONE GIURIDICA del Consiglio Nazionale delle Ricerche Paola Mariani Biagini NORME DI LEMMATIZZAZIONE Rapporto interno n. 9/2002 Firenze Sostantivi: I sostantivi
La Morfologia. L aggettivo. Pag. 164 CLASSE II C
 La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
La Morfologia L aggettivo Pag. 164 CLASSE II C 2016-2017 L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Gli aggettivi
ESERCIZIO N. 1: SVOLGIMENTO DELL ANALISI LOGICA E GRAMMATICALE. 1) Il mio vicino di casa ha fatto i bagagli ed è partito per Parigi.
 ESERCIZIO N. 1: SVOLGIMENTO DELL E GRAMMATICALE Fai l analisi logica delle seguenti frasi. 1) Il mio vicino di casa ha fatto i bagagli ed è partito per Parigi. Il mio vicino: soggetto + attributo. Di casa:
ESERCIZIO N. 1: SVOLGIMENTO DELL E GRAMMATICALE Fai l analisi logica delle seguenti frasi. 1) Il mio vicino di casa ha fatto i bagagli ed è partito per Parigi. Il mio vicino: soggetto + attributo. Di casa:
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
 LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II Classe VA scolastico 2015/2016 Anno Docente: L. Salvadori PROGRAMMA DI GRECO -FONETICA E MORFOLOGIA LA DECLINAZIONE ATEMATICA (TERZA DECLINAZIONE) TEMI IN CONSONANTE
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II Classe VA scolastico 2015/2016 Anno Docente: L. Salvadori PROGRAMMA DI GRECO -FONETICA E MORFOLOGIA LA DECLINAZIONE ATEMATICA (TERZA DECLINAZIONE) TEMI IN CONSONANTE
Liceo classico Vittorio Emanuele II Napoli. Classe V A A.s. 2016/2017. Programma di latino
 Liceo classico Vittorio Emanuele II Napoli Classe V A A.s. 2016/2017 Programma di latino Docente: Lina Salvadori Libro di testo:didici:teoria ed esercizi 2, Giovanna Barbieri- Loescher editore/ Didici:grammatica,
Liceo classico Vittorio Emanuele II Napoli Classe V A A.s. 2016/2017 Programma di latino Docente: Lina Salvadori Libro di testo:didici:teoria ed esercizi 2, Giovanna Barbieri- Loescher editore/ Didici:grammatica,
DIPARTIMENTO LETTERE CLASSICO LINGUISTICO DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico)
 Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
Educazione linguistica: Educazione letteraria: Produzione scritta: DISCIPLINA: ITALIANO (Biennio Classico e Linguistico) morfologia: il verbo. Sintassi: gli elementi fondamentali di analisi della proposizione.
PROGRAMMA DI GRECO. ANNO SCOLASTICO
 GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
GRAMMATICA INTRODUZIONE Il greco lingua indoeuropea La prima fase della lingua greca: il miceneo FONETICA E MORFOLOGIA Leggere e scrivere il greco L alfabeto La pronuncia I segni diacritici La classificazione
La Morfologia. L aggettivo
 La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
La Morfologia L aggettivo L aggettivo - Definizione L aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne qualità e caratteristiche. Esso concorda in genere e numero con il
L ARTICOLO. COME FARE Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di grammatica dedicate all articolo, completa la mappa. CHE COSA È ARTICOLO
 L ARTICOLO Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di grammatica dedicate all articolo, completa la mappa. PARTE DEL DISCORSO CHE... DETERMINATIVO INDETERMINATIVO maschile femminile singolare IL LO...
L ARTICOLO Mentre leggi e studi le pagine del tuo libro di grammatica dedicate all articolo, completa la mappa. PARTE DEL DISCORSO CHE... DETERMINATIVO INDETERMINATIVO maschile femminile singolare IL LO...
a. s CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
Alcune regole di grammatica
 Alcune regole di grammatica Sommario degli argomenti INTRODUZIONE...3 1. L ELISIONE...3 2. IL TRONCAMENTO...5 3. SEGNI DI INTERPUNZIONE...6 2 INTRODUZIONE Il manualetto che state per leggere, è un breve
Alcune regole di grammatica Sommario degli argomenti INTRODUZIONE...3 1. L ELISIONE...3 2. IL TRONCAMENTO...5 3. SEGNI DI INTERPUNZIONE...6 2 INTRODUZIONE Il manualetto che state per leggere, è un breve
Scuola secondaria I grado A. Rosas, Quartu Sant Elena
 Scuola secondaria I grado A. Rosas, Quartu Sant Elena Classe 2 F sede, a. s. 2013-2014 Il programma di grammatica della classe prima prevede lo studio delle parti variabili (il nome, l articolo, l aggettivo,
Scuola secondaria I grado A. Rosas, Quartu Sant Elena Classe 2 F sede, a. s. 2013-2014 Il programma di grammatica della classe prima prevede lo studio delle parti variabili (il nome, l articolo, l aggettivo,
1D. Programma di Italiano A.S Prof. A. Murru Testi utilizzati: Chiare stelle Bonpiani Le forme della lingua Sensini
 1D. Programma di Italiano A.S. 2014-15 Prof. A. Murru Testi utilizzati: Chiare stelle Bonpiani Le forme della lingua Sensini Epica: Argomenti trattati Unità 1.1 Epica, mito e mondo classico Che cos è l
1D. Programma di Italiano A.S. 2014-15 Prof. A. Murru Testi utilizzati: Chiare stelle Bonpiani Le forme della lingua Sensini Epica: Argomenti trattati Unità 1.1 Epica, mito e mondo classico Che cos è l
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Tipo iniziativa Titolo attività Organizzazione Corso finanziato ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 progetto Formazione linguistica. Lingua friulana Corsi di livello
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Tipo iniziativa Titolo attività Organizzazione Corso finanziato ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 progetto Formazione linguistica. Lingua friulana Corsi di livello
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE I SEZIONE H PROGRAMMA D' ITALIANO
 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE I SEZIONE H PROGRAMMA D' ITALIANO Libro di testo: M. Gineprini - B. Livi - S. Seminara, L isola, La narrazione, volume A, Ed. Loescher
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE I SEZIONE H PROGRAMMA D' ITALIANO Libro di testo: M. Gineprini - B. Livi - S. Seminara, L isola, La narrazione, volume A, Ed. Loescher
Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti
 Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti Per il livello A2 Esercizio 1 A) Stavo pensando su un viaggio 3 B) Stavo pensando ad un viaggio 4 C) Stavo pensando in un viaggio 2 D) Ero pensando ad
Esercizi VALICO per lusofoni : punteggi e commenti Per il livello A2 Esercizio 1 A) Stavo pensando su un viaggio 3 B) Stavo pensando ad un viaggio 4 C) Stavo pensando in un viaggio 2 D) Ero pensando ad
AVVERTENZE METODOLOGICHE - PRAGELATO
 1. Lemmatizzazione. Criteri generali. AVVERTENZE METODOLOGICHE - PRAGELATO Aggettivi. A lemma viene riportato di norma il maschile singolare. Vengono lemmatizzati al femminile solo gli aggettivi che non
1. Lemmatizzazione. Criteri generali. AVVERTENZE METODOLOGICHE - PRAGELATO Aggettivi. A lemma viene riportato di norma il maschile singolare. Vengono lemmatizzati al femminile solo gli aggettivi che non
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Docente: Moreno Bagarello Materia: Greco Classe: I G 1. Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che
Programmazione per competenze. SPAGNOLO Prof. GIOBBE FABIO. Classe II B 2016/2017
 Programmazione per competenze SPAGNOLO Prof. GIOBBE FABIO Classe II B 2016/2017 Unidad 02 Materiale Libro del alumno (LA) y cuaderno vol 1 Guía del profesor, Carpeta de recursos ebook + audio InClasse;
Programmazione per competenze SPAGNOLO Prof. GIOBBE FABIO Classe II B 2016/2017 Unidad 02 Materiale Libro del alumno (LA) y cuaderno vol 1 Guía del profesor, Carpeta de recursos ebook + audio InClasse;
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare. 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare
 1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
1 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: ascoltare 2 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: parlare 3 Modulo operativo: Le abilità linguistiche: leggere 4 Modulo operativo: Le abilità linguistiche:
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli
 LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico: 2015/2016 Docente: Prof.ssa Leombruno Classe: V G Materia: Latino MORFOLOGIA NOMINALE Gli aggettivi pronominali (ripetizione)
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Napoli PROGRAMMA DI LATINO Anno scolastico: 2015/2016 Docente: Prof.ssa Leombruno Classe: V G Materia: Latino MORFOLOGIA NOMINALE Gli aggettivi pronominali (ripetizione)
Andrea & Salvatore Sorci G. B. PALUMBO EDITORE
 Andrea & Salvatore Sorci G. B. PALUMBO EDITORE Indice MODULO1 La lingua dell antica Roma 1 CAPITOLO I Che cos è il latino? 2 Esercizi PAGINA 153 1 Perché il latino si chiama così? 2 2 Dove si parlava il
Andrea & Salvatore Sorci G. B. PALUMBO EDITORE Indice MODULO1 La lingua dell antica Roma 1 CAPITOLO I Che cos è il latino? 2 Esercizi PAGINA 153 1 Perché il latino si chiama così? 2 2 Dove si parlava il
Indice del volume. Storia della Lingua La lingua latina e le lingue indoeuropee, p. 9
 ndice del olume Inice del vome Indi- Indice del volume PARTE 1 Fonologia 1 L alfabeto e la pronuncia del latino 1 L alfabeto latino... 2 2 Il sistema fonetico... 2 3 La pronuncia... 4 4 La sillaba e la
ndice del olume Inice del vome Indi- Indice del volume PARTE 1 Fonologia 1 L alfabeto e la pronuncia del latino 1 L alfabeto latino... 2 2 Il sistema fonetico... 2 3 La pronuncia... 4 4 La sillaba e la
Liceo Scientifico statale Benedetto Croce, Palermo Programma di Latino e Geografia a.s. 2013/2014. Latino. Classe II Q prof.ssa F.
 Liceo Scientifico statale Benedetto Croce, Palermo Programma di Latino e Geografia a.s. 2013/2014 Latino Classe II Q prof.ssa F. Marchese DA NICOLA FLOCCHINI, PIERA GUIDOTTI BACCI, MARCO MOSCIO, IL NUOVO
Liceo Scientifico statale Benedetto Croce, Palermo Programma di Latino e Geografia a.s. 2013/2014 Latino Classe II Q prof.ssa F. Marchese DA NICOLA FLOCCHINI, PIERA GUIDOTTI BACCI, MARCO MOSCIO, IL NUOVO
VERBO IN BASE ALLA CONIUGAZIONE IN BASE AL GENERE IN BASE FORMA. FINITO (sono 4) IN BASE AL MODO (sono 7) INDEFINITO (sono 3) RISPETTO ALLA PERSONA
 Il VERBO è quella parte variabile del discorso che indica un azione, un attività o uno stato. Il verbo è la parte più importante, infatti senza il verbo non sarebbe possibile esprimere un pensiero e quindi
Il VERBO è quella parte variabile del discorso che indica un azione, un attività o uno stato. Il verbo è la parte più importante, infatti senza il verbo non sarebbe possibile esprimere un pensiero e quindi
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE
 PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO? LICEO TECNICO? ISTITUTO TECNICO AMM INISTRAZI FINANZA E MARKETING M ATERIA: LATINO Prof.ssa Luisella Ronda ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Classe
PIANO DI LAVORO DEL PROFESSORE Indirizzo : LICEO SCIENTIFICO? LICEO TECNICO? ISTITUTO TECNICO AMM INISTRAZI FINANZA E MARKETING M ATERIA: LATINO Prof.ssa Luisella Ronda ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Classe
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
 Pag. 1 di 6 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DOCENTE: BONA ARIANNA DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE: I SEZ A AFM LIBRI DI TESTO: Tiziano Franzi-Simonetta Damele, Più italiano, Pearson; Beatrice Panebianco-Antonella
Pag. 1 di 6 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DOCENTE: BONA ARIANNA DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE: I SEZ A AFM LIBRI DI TESTO: Tiziano Franzi-Simonetta Damele, Più italiano, Pearson; Beatrice Panebianco-Antonella
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C. MAXWELL Data Pag. di PROGRAMMA SVOLTO
 materia: lingua e letteratura italiana docente : D Alberton Silvia Paola classe : 1BLS ATTIVITA CONTENUTI PERIODO / DURATA Comprendere-analizzarediscutere i testi. Gli elementi della narrazione. Il testo,
materia: lingua e letteratura italiana docente : D Alberton Silvia Paola classe : 1BLS ATTIVITA CONTENUTI PERIODO / DURATA Comprendere-analizzarediscutere i testi. Gli elementi della narrazione. Il testo,
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti. Una lingua per crescere
 Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Una lingua per crescere 2000 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione Daniela Mariani Silvia
Alda Baldaccini Maria Cristina Zanti Una lingua per crescere 2000 by G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. progetto grafico e coordinamento tecnico Federica Giovannini videoimpaginazione Daniela Mariani Silvia
A. Richiami di elementi di grammatica
 A. Richiami di elementi di grammatica A.1 Frase semplice e frase complessa: le proposizioni A.2 La sintassi del periodo A.2.1 La coordinazione A.2.2 La subordinazione A.3 La punteggiatura L appendice riporta
A. Richiami di elementi di grammatica A.1 Frase semplice e frase complessa: le proposizioni A.2 La sintassi del periodo A.2.1 La coordinazione A.2.2 La subordinazione A.3 La punteggiatura L appendice riporta
Corso base di Lingua Portoghese
 Corso base di Lingua Portoghese Lezione 1 L alfabeto I pronomi (io, tu, lui, lei) Il verbo ser parte I Salutare Presentarsi Alfabeto illustrato Variazioni lessicali La lingua portoghese nel mondo Il Brasile
Corso base di Lingua Portoghese Lezione 1 L alfabeto I pronomi (io, tu, lui, lei) Il verbo ser parte I Salutare Presentarsi Alfabeto illustrato Variazioni lessicali La lingua portoghese nel mondo Il Brasile
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
CURRICOLO DI FRANCESE SPAGNOLO CLASSE PRIMA TRAGUARDI DI COMPETENZA Comprendere il significato globale di un breve e semplice messaggio orale e riconoscere in esso informazioni utili. NUCLEI TEMATICI ASCOLTO
VOCALISMO ATONO. N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione pdf». Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū
 N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
N.B.: Portare anche gli schemi del vocalismo tonico contenuti nel file «Esercitazione 07.03.2012.pdf». VOCALISMO ATONO Ī Ĭ Ē Ĕ ĀĂ Ŏ Ō Ŭ Ū ITALO-ROMANZO (toscano+ area perimediana, ligure, veneto centrale
Indice. Presentazione. Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati. Unità 1 Il lessico 2
 Presentazione IV Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 CHE COSA SAI FARE? 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3 3. La struttura
Presentazione IV Percorso A Il lessico: parole, suoni, segni e significati Unità 1 Il lessico 2 CHE COSA SAI FARE? 2 1. Che cos è il lessico 3 2. La forma delle parole: il significante 3 3. La struttura
1 PARTE I - IL PERIMETRO DELLA GRAMMATICA: LA LINGUA NELLA COMUNICA- ZIONE
 Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
Indice generale XI XV XIX XX XXIII XXV XXVII XXVHI XXX Indice dei box e delle tabelle notevoli Introduzione Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 1. Regole e scelte 2. Strutture
Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1
 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 1 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 2 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 3 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 4 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 2 5 Passe-Partout
Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 1 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 2 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 3 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 1 4 Passe-Partout 1 - Grammaire Unité 2 5 Passe-Partout
DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE. PRIMO BIENNIO LATINO Primo anno
 DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PRIMO BIENNIO LATINO Primo anno Competenze Abilità Conoscenze Tempi Riconoscere gli elementi morfosintattici della lingua latina. e tradurre testi latini di difficoltà
DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE PRIMO BIENNIO LATINO Primo anno Competenze Abilità Conoscenze Tempi Riconoscere gli elementi morfosintattici della lingua latina. e tradurre testi latini di difficoltà
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A..
 COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
COMPETENZE IN ITALIANO L2 DELL ALUNNO/ A.. IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Anno Scolastico Anno di nascita Anno di arrivo in Italia Scuola media frequentata Insegnante facilitatore L alunn
A R R I V O I N I T A L I A
 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11
Istituto Comprensivo
 CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
CURRICOLO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) Comprendere frasi semplici, brevi registrazioni trattanti argomenti con significati molto
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DEL DOCENTE 2010/2011
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon n. 4-35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554 Distretto 45 - PD Ovest PDIS017007-Cod. fiscale 80016340285 sito web: www.lbalberti.it;
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon n. 4-35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554 Distretto 45 - PD Ovest PDIS017007-Cod. fiscale 80016340285 sito web: www.lbalberti.it;
Trimestre Autunnale (16 settimane ore)
 Trimestre Autunnale (16 settimane - 368 ore) -2017 (io, tu, lui/lei/lei, noi, salutare e fare lo spelling di - le formule di saluto/1 voi,loro) congedarsi; una parola; fare i pronomi soggetto presentarsi
Trimestre Autunnale (16 settimane - 368 ore) -2017 (io, tu, lui/lei/lei, noi, salutare e fare lo spelling di - le formule di saluto/1 voi,loro) congedarsi; una parola; fare i pronomi soggetto presentarsi
Indice. 3 Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni
 01_649_DEAGOS_Le regole.qxp 10-11-2006 17:01 Pagina v XV Introduzione 3 Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 4 1 Regole e scelte 1.1 Opzioni e funzioni, p. 6 9 2 Relazioni grammaticali
01_649_DEAGOS_Le regole.qxp 10-11-2006 17:01 Pagina v XV Introduzione 3 Premessa. La grammatica: regole e scelte, strutture e funzioni 4 1 Regole e scelte 1.1 Opzioni e funzioni, p. 6 9 2 Relazioni grammaticali
