CORSO DI INTRODUZIONE AL NT. Massimo SCOTELLARO
|
|
|
- Brigida Guerra
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 12 a) Differenze geografiche (Palestina/Diaspora)/ricettive (diversi gradi di ellenizzazione)/caratteriali (diverse prospettive escatologiche, una più marcata tendenza a giudaizzare i gentili in quelli della Diaspora, etc.) b) Uniformità nel vincolo etico-religioso/nell identità etnico-spirituale. 2. Sviluppo cronologico Primo Giudaismo (o del Secondo Tempio) e Giudaismo rabbinico (o, meno propriamente, Tardo Giudaismo) 3. Le caratteristiche (a) L unicità di Dio; l appartenenza al popolo di Dio (di cui la circoncisione era segno); (b) l obbedienza alla Legge; (c) la strutturazione della società in sacerdoti/leviti/israeliti/proseliti; (d) la centralità del Tempio; (e) l osservanza delle festività giudaiche; (f) la frequentazione della sinagoga; (g) una concezione escatologica (nazionale o universale); (h) una visione dualistica del mondo (luce/tenebre, cielo/terra, etc.); (i) una prospettiva eterna diversa (resurrezione dopo la morte vs prosperità sulla terra); (l) il passaggio da una comunicazione profetica ad una apocalittica. 4. La comunità di Qumran e il NT a) Quella di Qumran era una comunità escatologica di tipo monastico sulla riva nord-occidentale del Mar Morto, guidata da un maestro di giustizia. b) Le dottrine: fede e pratica della legge di Mosè/ricerca della santificazione interiore e rituale/credenza negli angeli/credenza nella risurrezione dei morti/ credenze escatologiche. c) Tratti comuni e differenze col NT i. Bagni purificatori/battesimo; ultimi tempi/regno di Dio tra noi; pasto sacro/cena del Signore; aspettativa messianica/realizzazione messianica. ii. Altre espressioni o concetti presenti a Qumran le ritroviamo nei Vangeli (Figlio di Dio/Figlio dell Altissimo/figli della luce/figli delle tenebre/nuovo Patto), negli Atti (vendere le proprietà e mettere tutto in comune), nelle Epistole (opere della carne/fede/giustizia di Dio/idoli-tempio di Dio/lucetenebre/la figura di Melchisedek/la citazione di 1 Enoch in Giuda) e nell Apocalisse (gli ultimi tempi/il conflitto finale/giudizio finale/la Nuova Gerusalemme/il Tempio celeste) 2) Il contesto greco-romano: milieu neotestamentario 1. Ellenismo a) Diffusione e fusione b) Caratteristiche (1) globalizzazione cosmopolita ; (2) utilizzo di una lingua comune, la koiné; (3) sincretismo; (4) la creazione di nuove città di stile greco; (5) globalizzazione anche in campo commerciale e corporazioni artigiane; (6) pensiero cosmopolita; (7) modelli culturali standardizzati; (8) relativismo morale e culturale; (9) disprezzo per le proprie tradizioni; (10) civiltà dell immagine. 2. Imperialismo L imperialismo romano di questo periodo presentava le seguenti caratteristiche: (a) solida struttura statale e militare; (b) relativa tolleranza in campo religioso; (c) principio del divide et impera; (d) stabilimento della pax romana; (e) progressiva perdita dei valori morali e corruzione dei costumi (mores). 3. Nascita del Cristianesimo Il Cristianesimo (a) nasce in ambiente giudaico; (b) si presenta come un ulteriore sviluppo delle fede giudaica; (c) presenta elementi di continuità con la fede giudaica (fede in Yahweh, centralità delle Scritture giudaiche), (d) ma anche elementi di discontinuità (centralità dell opera della croce e del movimento dello Spirito,
2 13 superamento degli aspetti legalistici, universalizzazione della salvezza) ed (e) una prospettiva escatologica che incarna le attese messianiche intertestamentarie (il Messia come liberatore spirituale, realizzazione di un Nuovo Patto, entrata in una nuova dimensione relativa agli ultimi tempi, prospettiva di un eternità dopo la morte, giudizio finale); (f) il Cristianesimo non è riducibile ad una dimensione sociologica: la Chiesa è il prodotto di Cristo, e non vice versa. D. L ASPETTO sociale 1) Il patronato Per usufruire di vantaggi, ci si poneva sotto la protezione di un patrono, un personaggio più ricco, influente o importante, rendendogli in cambio vari servigi. (cfr.1 Cor. 6:1 e Giac 2:6). 2) Il principio di onore-vergogna Nella società greco-romana era presente un orientamento culturale basato sul principio di onore/vergogna dove il riconoscimento pubblico era spesso più importante dei fatti 14. Paolo si rifà proprio a tale atteggiamento culturale, ad esempio, in 1 Cor. 11, dove dice che il capo coperto fa disonore al suo capo, per una donna è cosa vergognosa, è un disonore, è un onore, etc. 3) L associazionismo Nel mondo greco-romano esistevano numerose associazioni cui le persone potevano legarsi: commerciali, culturali, sportive, religiose, etc. La presenza di tali associazioni ci aiuta a capire i riferimenti alla partecipazione alle feste idolatriche in 1 Cor. 8:10; 10:21, o la reazione dei costruttori di idoli in Atti 19: ) La schiavitù Quella della schiavitù era un istituzione sociale diffusa e radicata ai tempi del NT. La concezione cristiana livellava la figura dello schiavo a quella del ricco dinanzi a Dio, ma non aboliva le differenziazioni sociali ed economiche, pur condannando chi speculava sulla vita degli altri (1 Tim. 1:10, mercanti di schiavi ). L invito allo schiavo era quello di apprezzare la sua libertà in Cristo (1 Cor. 7:22seg.) facendo il proprio dovere (Ef. 6:5); l invito al padrone era quello di usare benevolenza sapendo che dinanzi a Dio non ci sono favoritismi (Ef. 6:9). Il Vangelo ebbe larga diffusione proprio tra i ceti più svantaggiati, e l episodio di Onesimo nell epistola a Filemone è esemplificativo di uno spirito cristiano. E. L ASPETTO religioso-politico 1) Giudaismo 1. Le istituzioni a) Il Tempio Istituzione religiosa e commerciale, simbolo dell unità nazionale e dell identità giudaica, sede dell adorazione al vero Dio, amministrato da sacerdoti e leviti e diretto dal Sommo Sacerdote. Cessò di esistere dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d.c. b) La sinagoga Istituzione probabilmente postesilica, nata come punto di aggregazione in assenza del Tempio, divenne luogo di adorazione e di insegnamento della Legge. Qui si affermarono le figure degli scribi e quelle degli anziani. 2. I partiti e i gruppi giudaici a) I Sadducei L etimologia del nome è incerta: c è chi la fa risalire al sommo sacerdote Sadok (1 Re 2:35), e chi lo fa derivare dal termine ebraico qydic; (ƒaddîq, giusto ). Ciò 14 Witherington, Ben, III (1995) Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (8). Grand Rapids: Eerdmans and Carlisle: Paternoster.
3 14 che sappiamo di loro è che: (a) facevano parte dell aristocrazia sacerdotale; (b) ritenevano vincolante solo la Torah (il Pentateuco), meno vincolanti gli Scritti e i Profeti (il resto del canone veterotestamentario) e affatto vincolanti le tradizioni religiose; (c) erano propensi al compromesso con le autorità politiche d occupazione; (d) negavano l esistenza della vita dopo la morte e di un giudizio futuro; (e) negavano l esistenza di angeli e demoni; (f) avevano una visione utilitaristica della vita; (g) scomparvero come gruppo dopo la caduta del Tempio. b) Gli Asidei ( asidim) Il nome deriva dall ebraico dysix' (µasid) che indica colui che è fedele e obbediente a Dio e si riferisce a coloro che sono pii. Nato come un movimento pietistico spontaneo nel II secolo a.c. Le caratteristiche: (a) più stretta aderenza alla Legge e ai rituali di purezza e (b) chiusura ad altre culture; (c) lotta per la libertà religiosa; (d) dopo il conseguimento dell indipendenza religiosa scompare; (e) divennero i precursori degli Esseni e dei Farisei. c) I Farisei Il loro nome deriva, probabilmente, dall ebraico vr;p (phāraš, separare ) ma essi preferivano definirsi ~yri±bex] (haḇērîm, compagni ): (a) costituivano la classe degli scribi laici ; (b) affiancavano all autorità delle Scrittura quella delle tradizioni; (c) credevano che Dio avesse l assoluto controllo degli eventi; (d) credevano nella risurrezione dei morti e nella remunerazione o punizione finale; (e) credevano all esistenza di angeli e demoni; (f) avevano un aspettazione messianica; (g) i Farisei rinunciavano all uso della violenza; (h) conseguirono, dopo la caduta del Tempio, la massima autorevolezza; (i) furono spesso condannati da Gesù. Questa condanna non significa, però, che tutta la classe dei Farisei versasse in tale condizione (cfr. Lc.13:31; Giov. 3:1-21; Lc. 7:36; 11:37; 14:1; Mt. 27:57; Lc. 23:51a; Lc. 23:52-53; At. 5:34-39; 15:5; 23:9). d) Gli Zeloti L origine degli Zeloti (gr. zhlwth,j, zēlōtḗs, aram. qanʼānā) è argomento di dibattito, e alcuni la fanno risalire al movimento creato da Giuda il Galileo verso il 6 d.c. (a) il loro movimento è il risultato della fuga di molti perseguitati dai Romani; (b) costituirono un movimento di liberazione nazionale; (c) la loro furia si abbatté anche sui Giudei che collaboravano coi Romani; (d) il loro scopo era ristabilire un governo teocratico; (e) essi avevano una speranza escatologica. e) Gli Erodiani Molte ipotesi sono state fatte per identificare gli Erodiani (~Hrw dianoi, Hērōdianói): (i) erano un gruppo religioso che vedeva in Erode il Messia (ma Erode non ha mai coltivato aspirazioni religiose!); (ii) erano un partito politico che intendeva promuovere un governo filoromano (ma è inconsistente asserire questo solo perché gli Erodiani sollevarono la questione delle tasse a Cesare in Mc. 12:13!); (iii) erano una confraternita simili a quelle presenti a Roma aventi lo scopo di onorare la memoria di un imperatore morto (ma tali club sorsero solo dopo la morte di Augusto, cioè tempo dopo!); (iv) erano degli ufficiali dello stato (ma, in tal caso, poiché li disprezzavano, i Farisei non sarebbero entrati in combutta con loro!); (v) erano soldati, sudditi o parenti di Erode (non avendo conferme in tal senso, tali idee restano solo speculazioni); (vi) erano un gruppo di persone influenti tra il popolo, non un partito, che coltivava simpatie per la dinastia di Erode (ipotesi più probabile). f) Gli Esseni Pur non essendo mai citati nella Bibbia, gli Esseni, il cui nome forse deriverebbe dal siriano pio o dall ebraico guaritore, compaiono circa nel 200 a.c. Sorgono
4 15 probabilmente da un opposizione a quanto accadeva dopo il 152 a.c. nel Tempio, ove corruzione e infedeltà dilagavano. Essi, sotto la guida di un maestro di giustizia, si isolavano in comunità chiuse, coltivando una speranza messianica. Da qualcuno sono stati assimilati agli Asidei. Per le particolarità del loro credo e della loro organizzazione, vedi l esposizione precedente della comunità di Qumran sotto il paragrafo contesto giudaico. g) Gli Scribi Lo scriba (ebr. Rpeso, sōphḗr) era colui che come professione scriveva, servendo come ufficiale dei documenti legali (2 Re 18:18; Ger. 36:12), come ministro delle finanze (2 Re 22:3), come consigliere del re (1 Cron. 27:32) o come amministratore (Esd. 4:8). Nel NT è definito come scriba (grammateu,j, grammatéus), ma si trova anche l appellativo di esperto nella legge (nomiko,j, nomikós NRV: dottore della legge, Mt. 22:35; Lc. 7:30; 10:25; 11:45seg; etc.), dottore della legge (nomodida,skaloj, nomodidáskalos cf. Lc. 5:17; At. 5:34), rabbi (ràbbi,, Mt. 23:7seg.), signore (ku,rioj, kúrios cfr. Mt. 8:2, 6, 8, 21, 25; etc.), insegnante (dida,skaloj, didáskalos NRV: maestro, cfr. Mt. 8:19; 12:38; 19:16; etc.), maestro (evpista,thj, epistátēs cf. Lc. 5:5; 9:33), padre (path,r, patḗr Mt. 23:9), e guida/conduttore (kaqhghth,j, kathēgētḗs Mt. 23:10). Essi (a) svolgevano anche funzioni di insegnanti; (b) prima dell esilio non svolgevano una funzione religiosa; (c) il loro compito divenne quello di preservare la legge e riapplicarla ai nuovi contesti; (d) divennero giuristi, in particolar modo nel Sinedrio (Mc. 14:43, 53); (e) dal periodo asmoneo furono soprattutto i Farisei a diventare scribi; (f) compaiono nel NT come fieri oppositori di Gesù e sono da Lui apertamente condannati; (g) dopo la caduta del Tempio nel 70 d.c., essi divennero le figure più autorevoli. h) Il popolo del paese (#r<a'ªh'-~[;, am hāʼāreƒ) Come ci è detto nel Talmud, è così definito quel gruppo di Giudei che trascurava: (a) il pagamento fedele della decima, (b) l osservanza del sabato, (c) le leggi di purificazione, (d) l apprendimento della Torah. L espressione popolo del paese usata nel periodo intertestamentario non corrisponde a quella in uso nell AT (Ez. 7:27). Esso è stato diversamente identificato come (1) quella parte del popolo di Israele stabilitosi dopo il ritorno dall esilio nelle aree rurali, gente, probabilmente citata in Giov. 7:49, che aveva colto l incongruenza legalistica dei Farisei; (2) il popolo cristiano che si asteneva da un adempimento ritualistico; (3) più che un gruppo organizzato, il risultato di una tendenza che creava un adesione trasversale nella società israelita a partire dal periodo asmoneo (ipotesi più accreditata). 2) Paganesimo 1. La mitologia a) La religione greca I Greci credevano di essere circondati da una moltitudine di esseri divini, fautori di tutti quei fenomeni naturali ai quali essi non avevano spiegazione. Con le opere di Omero (800 a.c. ca) si stabilì un pantheon più definito di dèi. (a) Erano divinità antropomorfe, capricciose e bizzarre; (b) In loro onore venivano organizzati giochi e feste, anche a sfondo sessuale; (c) queste credenze alla lunga non generarono una genuina devozione, talché si levarono voci critiche verso tali divinità e, sempre più spesso, i Greci cercarono spiegazioni razionali e filosofiche o si sentirono attratti dalle religioni orientali. b) La religione romana
5 16 Nella religione romana, (a) all inizio non c erano immagini o templi, ma una serie di forze e divinità locali e familiari; (b) Questa devozione privata si concretizzava in una pietas personale e in sacrifici agli dèi che, di rimando, offrivano con certezza la loro protezione perché vincolati dal sacrificio; (c) a contatto con le mitologie greche ed orientali, la religione romana perse questo aspetto privato per internazionalizzarsi, cosicché le divinità romane trovarono la loro controparte in quelle straniere e greche in particolare, formando un unico pantheon. (d) Anche a Roma, ben presto la fede negli dèi declinò, e la gente cadde nel razionalismo e nel materialismo o si rivolse ai culti misterici. 2. Il culto imperiale (a) Nelle civiltà orientali il sovrano veniva visto ed adorato come un dio assoluto al di sopra degli uomini; (b) I Greci respingevano l idea di sovrano divino assoluto, ma, a contatto con la cultura orientale, questa pratica si fece strada a partire da Alessandro Magno; (c) il primo condottiero romano ad essere divinizzato in Oriente, dove il costume era radicato, fu Ottaviano, e solo da Caligola in poi la figura dell imperatore fu equiparata a quella di un dio anche in occidente. (d) La religione cristiana all inizio godette degli stessi privilegi di quella giudaica, essendo identificata con questa, ma più tardi, specie sotto Nerone, Domiziano e Traiano, la persecuzione verso i Cristiani si fece sempre più consistente. 3. I culti misterici Le religioni misteriche provenienti dall Oriente divennero un rifugio per tanti che erano disorientati e intimoriti, consapevoli della vacuità delle religioni tradizionali. Esse (a) si presentavano come un culto privato e non statale, (b) erano denominate misteriche perché l iniziazione a tali culti prevedeva un rituale assolutamente segreto; (c) promettevano all individuo la liberazione da poteri demoniaci e la deificazione o la possibilità di diventare uno con la deità; (d) il rituale prevedeva l aspersione o l immersione in sangue o acqua, il vestimento di abiti sacri o l ingestione di cibi particolari; (e) tale rituale garantiva la morte alla vecchia vita, una nuova vita e l immortalità; (f) tutti gli iniziati diventavano membri della confraternita senza che ci fosse più tra loro alcuna distinzione di status sociale o razza; (g) l appartenenza ad un culto non impediva di essere iniziati anche ad altri culti misterici. C è chi ha voluto sottolineare gli aspetti comuni tra i culti misterici e i racconti dei Vangeli, stabilendo, così, che il Cristianesimo è una religione sincretistica che ha assimilato e sviluppato credenze pagane preesistenti (la resurrezione, il battesimo, il pasto sacro//cena del Signore, l immortalità, l unione col divino, il rito del sangue, la possibilità di una nuova vita, il principio di uguaglianza e fratellanza tra gli uomini, etc.). Tale visione parte da false premesse, cioè (1) quella secondo cui solo l originalità della dottrina cristiana è sinonimo di genuinità e di reale ispirazione divina, e (2) quella secondo cui ogni elemento che non presenti una caratteristica di assoluta novità sia semplicemente frutto della ricezione e dell influenza di tradizioni precedenti. Sono necessarie, a nostro avviso, delle precisazioni importanti: (a) un esame accurato deve tener conto delle similarità ed anche delle diversità: le prime non annullano le seconde, e vice versa, di modo che similarità non significa identicità. Osserveremo, perciò, che l idea biblica di immortalità differisce da quella extrabiblica, così come le storie pagane di resurrezione non assumono valore espiatorio e redentivo, il battesimo cristiano non è un atto d iniziazione, ma una testimonianza, l accesso ad una nuova vita nel Vangelo viene presentato come universale, non elitario, il contatto con Dio non prevede una deificazione dell uomo, ma la presenza di Dio nell uomo in modo inconciliabile con una visione panteistica,
6 17 etc.; (b) la caratteristica distintiva del messaggio cristiano non è l originalità, ma la veridicità: il fatto che le banconote false assomiglino alle vere, non le rende moneta corrente; (c) la similarità con alcuni contesti extrabiblici non indica necessariamente dipendenza. Dio ha parlato ad un uditorio preciso in un certo contesto culturale e, necessariamente, si è servito di riferimenti e simboli comuni, adatti a veicolare la comprensione del Suo messaggio, senza per questo validare i contenuti della tradizione entro cui tali simboli e riferimenti acquistavano significato; (d) è impensabile che princìpi eterni, valori morali e verità che Dio ha trasmesso nella Sua Parola non possano e non debbano trovare riscontro in tradizioni extrabibliche, precedenti, contemporanee o successive alla rivelazione, pena la delegittimazione della verità biblica. Tale eventualità mostra semplicemente come Dio abbia messo nel cuore dell uomo il pensiero dell eternità (Eccl.3:11) e abbia lasciato un segno del Suo amore e delle Sue leggi nella coscienza dell individuo (Rom. 2:15). 4. La divinazione Nell antichità erano diffuse le arti mantiche, quella forma di previsione che i Romani chiamavano divinatio, cioè il tentativo da parte di àuguri e indovini, di scoprire la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli o le interiora di animali sacrificati. Per gli stessi motivi era comune anche ricorrere agli oracoli, dove le divinità parlavano attraverso medium, come la Pizia presso l oracolo di Apollo a Delfi o la Sibilla di Cuma. 5. L astrologia e la magia Lo studio degli astri si trasformò presto, dietro l influsso dei Babilonesi prima e dei Greci poi, nel tentativo di poter leggere nelle stelle il destino dell uomo: nacque così l astrologia. In qualche modo pare che, nell annuncio della nascita di Cristo, sia stata utilizzata questa credenza diffusa per porre l attenzione sul Salvatore del mondo mediante una stella che ne indicava il luogo di nascita (Mt. 2:2). Anche Paolo, probabilmente, fa riferimento a tali pratiche (Gal. 4:3,9; Col. 2:8, 20), e lo stesso Gesù viene denominato stella del mattino per sottolineare la Sua preminenza e il fatto che Egli aveva realmente nelle mani il destino dell uomo (2 Pt. 1:19; Apoc. 22:16). Sempre nell ambito della superstizione, troviamo la pratica della magia che, ampiamente praticata in Egitto e nel mondo assiro-babilonese, si diffuse poi in età imperiale nel mondo greco-romano. Si avvaleva di formule per scacciare la maledizione e i poteri demoniaci, ed accordava particolare importanza ai sogni come segni premonitori. 6. Il culto dei morti Nel mondo ellenistico prima e in quello romano dopo si vennero a creare delle associazioni intese ad onorare e rinnovare la memoria dei defunti. Questi club della morte, come talvolta venivano chiamati, nascevano ad opera di parenti del defunto o di persone che erano legate al morto da vincoli professionali, appartenendo essi alla stessa corporazione professionale del defunto, e rinnovavano la memoria dei morti attraverso pasti comuni una volta all anno. Alcuni hanno visto in questa pratica un collegamento con l istituzione della Cena del Signore, ma la più grande differenza è che essi celebravano un morto, mentre l istituzione cristiana celebra un vivente! 7. Le figure del salvatore Tipica del mondo antico era la credenza che la guarigione da malattie si potesse ottenere in modo miracoloso. Gli dèi che presiedevano a tali guarigioni erano detti salvatori (swth/rej, sōtḗres), e spesso presso gli altari a tali divinità si portavano offerte votive con la forma delle parti del corpo guarite. Tra gli dèi preposti alla guarigione troviamo Asclepio (lat. Esculapio), simboleggiato dal serpente, presso il cui tempio ad Epidauro gli ammalati si addormentavano di notte per ricevere la
DISCIPLINA: Religione Cattolica
 CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
1 CAPITOLO : La terra di Gesù
 GESU' CRISTO: vero Uomo e vero Dio 1 CAPITOLO : La terra di Gesù 1.7 Il SINEDRIO Al tempo di Gesù l istituzione più importante era il Sinedrio (dal greco synedrion, che significa assemblea, consiglio)
GESU' CRISTO: vero Uomo e vero Dio 1 CAPITOLO : La terra di Gesù 1.7 Il SINEDRIO Al tempo di Gesù l istituzione più importante era il Sinedrio (dal greco synedrion, che significa assemblea, consiglio)
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
CLASSE PRIMA MACRO ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI COMPETENZE 1 2 3
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL BIENNIO 1. Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2. Potenziare il dialogo interdisciplinare,
PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO
 CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
 RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
RELIGIONE: PRIMO BIENNIO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - RICONOSCERE CHE PER I CRISTIANI E TANTI CREDENTI IL MONDO E LA VITA SONO DONI DI DIO. - OSSERVARE CON STUPORE E MERAVIGLIA IL MONDO. - SCOPRIRE
PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 INDICATORI CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE. Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia
PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 INDICATORI CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE. Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia
Liceo G. Galilei Trento
 Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
La parola VANGELO significa LIETO ANNUNCIO, BUONA NOVELLA. Il lieto annuncio è:
 La parola VANGELO significa LIETO ANNUNCIO, BUONA NOVELLA. Il lieto annuncio è: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui abbia la vita. Il lieto annuncio è Gesù
La parola VANGELO significa LIETO ANNUNCIO, BUONA NOVELLA. Il lieto annuncio è: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui abbia la vita. Il lieto annuncio è Gesù
Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I
 CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO
 III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
III CIRCOLO DIDATTICO DI COLLEGNO PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIRCOLO - IRC - ANNO SCOLASTICO 2016/17 CLASSI PRIME Percepire la dimensione del sé, dell altro e della condivisione nello stare insieme Scoprire
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Traguardi delle competenze L alunno: Riconosce che la Bibbia
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Traguardi delle competenze L alunno: Riconosce che la Bibbia
AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE
 BIBLIOLOGIA AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE SISTEMA DI SEGNI AI QUALI VIENE DATO UN SIGNIFICATO ARBITRARIO CHI HA INVENTATO LA SCRITTURA? GE 4:15 DIO HA SCELTO DI UTILIZZARE QUESTO METODO PER TRASMETTERCI
BIBLIOLOGIA AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE SISTEMA DI SEGNI AI QUALI VIENE DATO UN SIGNIFICATO ARBITRARIO CHI HA INVENTATO LA SCRITTURA? GE 4:15 DIO HA SCELTO DI UTILIZZARE QUESTO METODO PER TRASMETTERCI
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
INDICE GENERALE. Ringraziamenti... 5
 INDICE GENERALE Ringraziamenti.......................................... 5 Introduzione al Volume 4: IL GESÙ STORICO È IL GESÙ HALAKHICO.. 9 I. Le molteplici difficoltà nella trattazione del rapporto tra
INDICE GENERALE Ringraziamenti.......................................... 5 Introduzione al Volume 4: IL GESÙ STORICO È IL GESÙ HALAKHICO.. 9 I. Le molteplici difficoltà nella trattazione del rapporto tra
Scuola Secondaria di 1 grado
 Scuola Secondaria di 1 grado ins. Loreno Miotto CLASSE PRIMA - UNITA DI APPRENDIMENTO SCANSIONE UNITA DI APPRENDIMENTO Unità di apprendimento n. 1: RELIGIONE E RELIGIOSITA L alunno scopre l importanza
Scuola Secondaria di 1 grado ins. Loreno Miotto CLASSE PRIMA - UNITA DI APPRENDIMENTO SCANSIONE UNITA DI APPRENDIMENTO Unità di apprendimento n. 1: RELIGIONE E RELIGIOSITA L alunno scopre l importanza
Studio Biblico. La Croce di Cristo
 La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
La Croce di Cristo Infatti mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza e con gran timore. La mia parola e la mia predicazione
INDICE. 1. Imperialismo e romanizzazione 21 2. La politica imperialista romana in Oriente nell epoca repubblicana 23
 INDICE Premessa 7 Introduzione 9 PARTE PRIMA INQUADRAMENTO STORICO 11 1. LA CONQUISTA ROMANA DELL ORIENTE 13 1. Quadro storico generale (I sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
INDICE Premessa 7 Introduzione 9 PARTE PRIMA INQUADRAMENTO STORICO 11 1. LA CONQUISTA ROMANA DELL ORIENTE 13 1. Quadro storico generale (I sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
CURRICOLO DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Senso religioso Qualcuno più grande di noi Religioni primitive Religioni dell antichità Religioni abramitiche La e altre Come si usa
PARTE BIBLICA. 1. La missione del Figlio. 2. La missione dello Spirito Santo
 PARTE BIBLICA Anticipazioni trinitarie nell AT 1. La missione del Figlio Padre nell AT. Dio Padre di Gesù. Gesù il Figlio di Dio. I misteri della vita di Cristo nella prospettiva trinitaria: l Incarnazione;
PARTE BIBLICA Anticipazioni trinitarie nell AT 1. La missione del Figlio Padre nell AT. Dio Padre di Gesù. Gesù il Figlio di Dio. I misteri della vita di Cristo nella prospettiva trinitaria: l Incarnazione;
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA. Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo
 CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
Indice. 1. Motivi e importanza della questione retrospettiva Le più antiche raccolte ed esposizioni complessive La Fonte dei discorsi 27
 Prefazione........................................ 5 1. Il nuovo inizio postpasquale...................... 9 1. Le più antiche formule di fede e di professione di fede 9 1.1. La formula della risurrezione
Prefazione........................................ 5 1. Il nuovo inizio postpasquale...................... 9 1. Le più antiche formule di fede e di professione di fede 9 1.1. La formula della risurrezione
L IMPERO ROMANO DOPO LA MORTE DI CESARE, IL POTERE PASSÒ A SUO NIPOTE OTTAVIANO. NEL 27 A.C. IL SENATO LO NOMINÒ AUGUSTO, CIOÈ DEGNO DI ONORE.
 L IMPERO ROMANO DOPO LA MORTE DI CESARE, IL POTERE PASSÒ A SUO NIPOTE OTTAVIANO. EGLI CONCENTRÒ TUTTI I POTERI NELLE SUE MANI. NEL 27 A.C. IL SENATO LO NOMINÒ AUGUSTO, CIOÈ DEGNO DI ONORE. COSÌ... FINIVA
L IMPERO ROMANO DOPO LA MORTE DI CESARE, IL POTERE PASSÒ A SUO NIPOTE OTTAVIANO. EGLI CONCENTRÒ TUTTI I POTERI NELLE SUE MANI. NEL 27 A.C. IL SENATO LO NOMINÒ AUGUSTO, CIOÈ DEGNO DI ONORE. COSÌ... FINIVA
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione
 COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
COMPETENZE DISCIPLINARI Religione AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO RELIGIONE COMPETENZA ABILITA L alunno è in grado di CONOSCENZE L alunno conosce Esperienze di vita - Universalità/molteplicità del fatto religioso
Il Presidente della Repubblica
 VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
NUCLEI FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
DAI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI D APPRENDIMENTO -CURRICOLO DI Religione.. - SCUOLA PRIMARIA FONDANTI 1 DIO E L UOMO 2 LA BIBBIA E LE FONTI 3 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 4 I VALORI ETICI E RELIGIOSI
PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO
 PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it N U O V O GUIDA ALLA STRUTTURA DELLA BIBBIA Vangeli
PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it N U O V O GUIDA ALLA STRUTTURA DELLA BIBBIA Vangeli
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 4. Gesù Cristo Gesù Cristo (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Su un cartellone, con un lavoro di gruppo, attraverso la tecnica del fumetto, riproduci
Attività di potenziamento e recupero 4. Gesù Cristo Gesù Cristo (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Su un cartellone, con un lavoro di gruppo, attraverso la tecnica del fumetto, riproduci
CURRICOLO DI RELIGIONE
 ISTITUTO COMPRENSIVO Lorenzo Lotto CURRICOLO DI RELIGIONE elaborato dai docenti di scuola primaria F. Conti e Mestica a.s. 2013/14 coordinatore Ins. Campana Anna Maria CLASSE PRIMA DIO E L UOMO Dio creatore
ISTITUTO COMPRENSIVO Lorenzo Lotto CURRICOLO DI RELIGIONE elaborato dai docenti di scuola primaria F. Conti e Mestica a.s. 2013/14 coordinatore Ins. Campana Anna Maria CLASSE PRIMA DIO E L UOMO Dio creatore
CRISTIANI NON CRISTIANI
 CRISTIANI ORTODOSSI CATTOLICI PROTESTANTI NON CRISTIANI EBREI ISLAMICI INDUISTI BUDDISTI Nel giorno di Pentecoste Gesù mantenne la promessa e inviò lo Spirito Santo SPIRITO SANTO APOSTOLI Rumore Vento
CRISTIANI ORTODOSSI CATTOLICI PROTESTANTI NON CRISTIANI EBREI ISLAMICI INDUISTI BUDDISTI Nel giorno di Pentecoste Gesù mantenne la promessa e inviò lo Spirito Santo SPIRITO SANTO APOSTOLI Rumore Vento
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA CONOSCENZE (I SAPERI) ABILITA' (SAPER FARE) DIO E L'UOMO DI COMPETENZA
 RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
Una delle più classiche è quella della donna giovane e bella, in. abbigliamento belle epoque che convive con una donna anziana, dal naso e dai
 Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Matteo 6, 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ci sono delle immagini che
Il Presidente della Repubblica
 Il Presidente della Repubblica Visto Vista l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
Il Presidente della Repubblica Visto Vista l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
U.d.A. RELIGIONE CATTOLICA
 U.d.A. 1, 2, 3, 4, 5, CLASSE PRIMARIA "G. Calò" - "Marinaio d'italia" A. sc. 2016/2017 Le insegnanti: Blasi Giovanna Rebecca Cagnazzo Luigina Lamendola Anna Rita AMICO MONDO CLASSI PRIMA PRIMARIA Ottobre
U.d.A. 1, 2, 3, 4, 5, CLASSE PRIMARIA "G. Calò" - "Marinaio d'italia" A. sc. 2016/2017 Le insegnanti: Blasi Giovanna Rebecca Cagnazzo Luigina Lamendola Anna Rita AMICO MONDO CLASSI PRIMA PRIMARIA Ottobre
Piccola lectio divina su Marco
 PARROCCHIA S. LUCIA AUGUSTA @mail: santalucia.augusta@alice.it Piccola lectio divina su Marco 1) Ritirati in un angolo della tua casa Unisciti alla tua famiglia Incontra qualcuno degli amici o vicini 2)
PARROCCHIA S. LUCIA AUGUSTA @mail: santalucia.augusta@alice.it Piccola lectio divina su Marco 1) Ritirati in un angolo della tua casa Unisciti alla tua famiglia Incontra qualcuno degli amici o vicini 2)
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna. Introduzione
 Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 II LEZIONE BREVE STORIA DIISRAELE
Scuola di Formazione Teologica San Pier Crisologo Ravenna Introduzione alla Sacra Scrittura appunti per gli studenti a cura del prof. don Gianni Passarella anno 2011/2012 II LEZIONE BREVE STORIA DIISRAELE
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE
 PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve
Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti la presenza di Dio Padre e Creatore.
 PROGETTAZIONI ANNUALI I.R.C. CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI E SPECIFICI CONTENUTI-ABILITA COMPETENZE IN USCITA Osservare con stupore e meraviglia il mondo. Scoprire che per i cristiani
PROGETTAZIONI ANNUALI I.R.C. CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI E SPECIFICI CONTENUTI-ABILITA COMPETENZE IN USCITA Osservare con stupore e meraviglia il mondo. Scoprire che per i cristiani
RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Gli Obiettivi di Apprendimento per ogni fascia di età sono articolati in quattro ambiti tematici : Dio e l uomo, con i principali riferimenti
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Gli Obiettivi di Apprendimento per ogni fascia di età sono articolati in quattro ambiti tematici : Dio e l uomo, con i principali riferimenti
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
Attività di potenziamento e recupero 9. Una Legge d amore Una Legge d amore (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet prova a consultare siti della
RELIGIONE CATTOLICA. Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione
 Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
UN TERMINE RELIGIOSO
 UN TERMINE RELIGIOSO Il termine martire deriva dal greco martus : il testimone. Fin dall antichità, per il cristianesimo il martire è colui che ha testimoniato con il sacrificio della propria vita la fede
UN TERMINE RELIGIOSO Il termine martire deriva dal greco martus : il testimone. Fin dall antichità, per il cristianesimo il martire è colui che ha testimoniato con il sacrificio della propria vita la fede
La parola Bibbia deriva dal greco. ta biblia. e significa I LIBRI
 LA BIBBIA La parola Bibbia deriva dal greco ta biblia e significa I LIBRI Insieme di tanti libri di generi letterari diversi. Diversità di stili, di ambienti e di periodi storici. La storia del popolo
LA BIBBIA La parola Bibbia deriva dal greco ta biblia e significa I LIBRI Insieme di tanti libri di generi letterari diversi. Diversità di stili, di ambienti e di periodi storici. La storia del popolo
PROGRAMMAZIONE ANNUALE RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2016/2017 Classe Prima INDICATORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.
 EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
EUROPEE CULTURALE Classe Prima 1. DIO E L UOMO Esprimere stupore per le meraviglie del creato. Scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 2. LA BIBBIA E LE Identifica le caratteristiche
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione riconoscimento -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio
 RELIGIONE CATTOLICA nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione classe 1^ -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio sa riflettere -su Dio Creatore -su Dio Padre sa osservare
RELIGIONE CATTOLICA nuclei fondanti indicatori descrittori valutazione classe 1^ -presenza di Dio -aspetti dell ambiente di vita del Figlio di Dio sa riflettere -su Dio Creatore -su Dio Padre sa osservare
RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita
ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita
Scuola Primaria Longhena Bologna
 Scuola Primaria Longhena Bologna PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC A.S.2013/2014 1 CLASSE PRIMA Unità di Apprendimento Obiettivi Formativi Obiettivi Specifici Di Apprendimento Indicatori di Competenza LA CREAZIONE
Scuola Primaria Longhena Bologna PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC A.S.2013/2014 1 CLASSE PRIMA Unità di Apprendimento Obiettivi Formativi Obiettivi Specifici Di Apprendimento Indicatori di Competenza LA CREAZIONE
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA
 IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
CREDO IN CREDO LA PROFESSO ASPETTO DIO PADRE UN SOLO CREATORE GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CHIESA
 DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
DIO PADRE UN SOLO CREATORE CREDO IN GESU CRISTO SIGNORE SALVATORE SPIRITO SANTO VIVIFICANTE PARLATORE CREDO LA CHIESA UNA CATTOLICA SANTA APOSTOLICA PROFESSO UN SOLO BATTESIMO LA RISURREZIONE DEI MORTI
RELIGIONE CATTOLICA. L ambiente in cui viviamo. Dal mio nome alle mie potenzialità.
 Classe 1^ Scuola Primaria COMPETENZA DI RIFERIMENTO Esprimere stupore per le meraviglie del Creato in quanto opera di Dio. Provare sentimenti di gioia e gratitudine per il dono della vita. Conoscere la
Classe 1^ Scuola Primaria COMPETENZA DI RIFERIMENTO Esprimere stupore per le meraviglie del Creato in quanto opera di Dio. Provare sentimenti di gioia e gratitudine per il dono della vita. Conoscere la
PROGRAMMA a.s
 1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
1 Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera Bernardo Buontalenti Sede e Segreteria: Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055 462781 Fax: 055
ORIGINE DELLA FESTA DEL NATALE
 ORIGINE DELLA FESTA DEL NATALE Quando viene celebrato per la prima volta il Natale Cristiano? La festa del Natale la troviamo ricordata per la prima volta nell'opera Chronographus (Cronografo) redatta
ORIGINE DELLA FESTA DEL NATALE Quando viene celebrato per la prima volta il Natale Cristiano? La festa del Natale la troviamo ricordata per la prima volta nell'opera Chronographus (Cronografo) redatta
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI
 CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
CURRICOLO VERTICALE RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA DELL INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO I.COCCHI LICCIANA NARDI per i bambini dell ultimo anno COMPETENZE al termine della SCUOLA DELL INFANZIA OSSERVARE IL
I A ISTITUTO TECNICO L. EINAUDI MURAVERA MATERIA:RELIGIONE. PROFESSORE: FAEDDA SIMONE Anno
 I A ISTITUTO TECNICO L. EINAUDI MURAVERA MATERIA:RELIGIONE. PROFESSORE: FAEDDA SIMONE 1. Unità di apprendimento: IL MISTERO DELL ESISTENZA - Chi sono io? Le domande di senso nell esistenza di qualsiasi
I A ISTITUTO TECNICO L. EINAUDI MURAVERA MATERIA:RELIGIONE. PROFESSORE: FAEDDA SIMONE 1. Unità di apprendimento: IL MISTERO DELL ESISTENZA - Chi sono io? Le domande di senso nell esistenza di qualsiasi
LA NATURA DI CRISTO. Il Figliuolo di Dio Il Signore La Parola Il Figliuolo dell Uomo Il Figliuolo di Davide
 CRISTOLOGIA LA NATURA DI CRISTO Il Figliuolo di Dio Il Signore La Parola Il Figliuolo dell Uomo Il Figliuolo di Davide GLI UFFICI DI CRISTO Profeta Sacerdote Re L OPERA DI CRISTO La Sua morte La Sua importanza
CRISTOLOGIA LA NATURA DI CRISTO Il Figliuolo di Dio Il Signore La Parola Il Figliuolo dell Uomo Il Figliuolo di Davide GLI UFFICI DI CRISTO Profeta Sacerdote Re L OPERA DI CRISTO La Sua morte La Sua importanza
PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO
 PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it N U O V O GUIDA ALLA STRUTTURA DELLA BIBBIA LETTERE
PASTORALE FAMILIARE ANIMATORI FILIPPO E GRAZIELLA ANFUSO Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it N U O V O GUIDA ALLA STRUTTURA DELLA BIBBIA LETTERE
RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas
 RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
LE RELIGIONI. Per una classificazione
 LE RELIGIONI Per una classificazione UN TERMINE AMBIGUO Il termine religione deriva dal latino religio. Fin dall antichità, esistono due etimologie possibili: religio è termine che rimanda ai rapporti
LE RELIGIONI Per una classificazione UN TERMINE AMBIGUO Il termine religione deriva dal latino religio. Fin dall antichità, esistono due etimologie possibili: religio è termine che rimanda ai rapporti
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO.
 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA AL CIELO. La celebrazione dell Assunzione al cielo di Maria nella Chiesa occidentale o della Dormizione della Vergine nella Chiesa orientale, ricorda ai cristiani
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - CORPORENO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER LE CLASSI I II III IV - V Anno scolastico 2015 2016 CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1^ Anno
Curricolo di religione
 Curricolo di religione Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado a) L alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente
Curricolo di religione Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado a) L alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente
ANTICO TESTAMENTO CRISTIANO
 ANTICO TESTAMENTO CRISTIANO È il modo con cui, a partire dal II secolo, sono state definite le Scritture ebraiche, viste come un anticipazione profetica della venuta di Cristo. Il termine Antico Testamento
ANTICO TESTAMENTO CRISTIANO È il modo con cui, a partire dal II secolo, sono state definite le Scritture ebraiche, viste come un anticipazione profetica della venuta di Cristo. Il termine Antico Testamento
Indice. Sommario dell opera 5 Elenco delle abbreviazioni 7 Premessa 11. Introduzione Compiti e metodi di una sociologia del movimento di Gesù 15
 Indice Sommario dell opera 5 Elenco delle abbreviazioni 7 Premessa 11 Introduzione Compiti e metodi di una sociologia del movimento di Gesù 15 1. I compiti di una sociologia del movimento di Gesù 16 2.
Indice Sommario dell opera 5 Elenco delle abbreviazioni 7 Premessa 11 Introduzione Compiti e metodi di una sociologia del movimento di Gesù 15 1. I compiti di una sociologia del movimento di Gesù 16 2.
ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1. Piano di Studio di Istituto RELIGIONE
 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 Piano di Studio di Istituto RELIGIONE CURRICOLO DI BASE di Religione Cattolica per il primo biennio del Primo Ciclo di istruzione Competenza Abilità Conoscenze Individuare l
ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 Piano di Studio di Istituto RELIGIONE CURRICOLO DI BASE di Religione Cattolica per il primo biennio del Primo Ciclo di istruzione Competenza Abilità Conoscenze Individuare l
AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE
 BIBLIOLOGIA AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE TUTTA 2timoteo 3:16-17 LA SCRITTURA E ISPIRATA DA DIO E UTILE A: FEDE OPERE INSEGNARE RIPRENDERE CORREGGERE EDUCARE ALLA GIUSTIZIA AFFINCHE - CIO CHE E VERO - CIO
BIBLIOLOGIA AUTORITA ISPIRAZIONE CANONE TUTTA 2timoteo 3:16-17 LA SCRITTURA E ISPIRATA DA DIO E UTILE A: FEDE OPERE INSEGNARE RIPRENDERE CORREGGERE EDUCARE ALLA GIUSTIZIA AFFINCHE - CIO CHE E VERO - CIO
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE:
 RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi delle competenze L alunno: Sa che il ha le sue radici
RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale Traguardi delle competenze L alunno: Sa che il ha le sue radici
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
IRC PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L alunno: è aperto alla sincera ricerca della verità; sa interrogarsi
Le dimore di Dio. Il tempio. La sinagoga
 I tempi di Dio Le dimore di Dio Il tempio La sinagoga Gli uomini di Dio Sommo Sacerdote Situazione sociale Classe dirigente Popolo Sacerdoti Scribi Sadducei Farisei Emarginati Pubblicani Mendicanti Gentili
I tempi di Dio Le dimore di Dio Il tempio La sinagoga Gli uomini di Dio Sommo Sacerdote Situazione sociale Classe dirigente Popolo Sacerdoti Scribi Sadducei Farisei Emarginati Pubblicani Mendicanti Gentili
CLASSE QUINTA. 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio. Attività Verifiche Valutazione. Conoscenze ( Contenuti)
 CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
Credere (aver fede) in un Dio o in più dei, (da cui politeismo/monoteismo), e in un sistema articolato di verità, denominato DOTTRINA
 Religione è Credere (aver fede) in un Dio o in più dei, (da cui politeismo/monoteismo), e in un sistema articolato di verità, denominato DOTTRINA Insieme di ATTI di CULTO (preghiere, riti, celebrazioni,
Religione è Credere (aver fede) in un Dio o in più dei, (da cui politeismo/monoteismo), e in un sistema articolato di verità, denominato DOTTRINA Insieme di ATTI di CULTO (preghiere, riti, celebrazioni,
Natale. Origini della festa
 Natale Origini della festa Nella Chiesa antica, nei primi tre secoli, oltre alla celebrazione settimanale del giorno del Signore (domenica) e a quella annuale della Pasqua, non c era alcun altra festa.
Natale Origini della festa Nella Chiesa antica, nei primi tre secoli, oltre alla celebrazione settimanale del giorno del Signore (domenica) e a quella annuale della Pasqua, non c era alcun altra festa.
RELIGIONE CATTOLICA scuola primaria
 RELIGIONE CATTOLICA scuola primaria CLASSE PRIMA 1 Unità di Apprendimento: Dio creatore del mondo e dell uomo - Dio e l uomo 1- comprendere che la vita è crescere insieme agli altri 2- comprendere che
RELIGIONE CATTOLICA scuola primaria CLASSE PRIMA 1 Unità di Apprendimento: Dio creatore del mondo e dell uomo - Dio e l uomo 1- comprendere che la vita è crescere insieme agli altri 2- comprendere che
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano-
 Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita
Prof. Antonio IZZO LA BIBBIA
 Prof. Antonio IZZO LA BIBBIA La parola Bibbia deriva dal greco (τα Βιβλια) e significa I LIBRI E il testo sacro della RELIGIONE CRISTIANA e della RELIGIONE EBRAICA Prima di essere scritta la Bibbia è stata
Prof. Antonio IZZO LA BIBBIA La parola Bibbia deriva dal greco (τα Βιβλια) e significa I LIBRI E il testo sacro della RELIGIONE CRISTIANA e della RELIGIONE EBRAICA Prima di essere scritta la Bibbia è stata
RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 RELIGIONE CLASSE2^ RELIGIONE CLASSE1^ RELIGIONE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA A.1 - Riconoscere che Dio è Creatore dell uomo e dell Universo. A.2 - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 RELIGIONE CLASSE2^ RELIGIONE CLASSE1^ RELIGIONE CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA A.1 - Riconoscere che Dio è Creatore dell uomo e dell Universo. A.2 - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA. del.
 CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA (Via Cisa n. 5-1^ traversa Sarzana) Domenica 18 settembre 2011 LITURGIA del culto battesimale Benedizione finale e AMEN cantato Attività della chiesa a martedì alterni
MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE
 Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
Josef Wohlmuth MISTERO DELLA TRASFORMAZIONE Tentativo di una escatologia tridimensionale, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea QUERINIANA Indice Prefazione..............................................
PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017
 PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE RELIGIONE CATTOLICA 1 BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE RELIGIONE CATTOLICA 1 BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
Il numero della Bestia
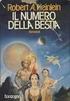 6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
6 6 6 Il numero della Bestia Da dove salta fuori il numero 666? «Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.»
Istituto Comprensivo
 CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIO E L UOMO Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-cristiana. Approfondire l identità storica di Gesù e correlarla
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIO E L UOMO Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-cristiana. Approfondire l identità storica di Gesù e correlarla
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Padre e si confronta con l esperienza religiosa. della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale. della
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE RELIGIONE CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Padre e si confronta con l esperienza religiosa. della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale. della
SBF 38º Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico Gerusalemme, 2-5 aprile 2013
 XXXVIII Corso di aggiornamento biblico-teologico 2013 Dal Primo al Secondo Tempio. L espressione della fede attorno all area del Tempio di Gerusalemme. Visita agli scavi attorno al monte del Tempio Jerusalem
XXXVIII Corso di aggiornamento biblico-teologico 2013 Dal Primo al Secondo Tempio. L espressione della fede attorno all area del Tempio di Gerusalemme. Visita agli scavi attorno al monte del Tempio Jerusalem
Pietro consacra Ermagora alla presenza di Marco. (Cripta di Aquileia) Prof.ssa Marialaura Mino
 Pietro consacra Ermagora alla presenza di Marco (Cripta di Aquileia) Prof.ssa Marialaura Mino Corso biblico zonale Zona XXI S. Maria degli angeli IL VANGELO DI MARCO 2017 Prof.ssa Marialaura Mino 1 Vangelo
Pietro consacra Ermagora alla presenza di Marco (Cripta di Aquileia) Prof.ssa Marialaura Mino Corso biblico zonale Zona XXI S. Maria degli angeli IL VANGELO DI MARCO 2017 Prof.ssa Marialaura Mino 1 Vangelo
RELIGIONE MODULI OPERATIVI:
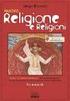 RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
RELIGIONE INDICATORE DISCIPLINARE Avviare alla conoscenza della realtà religiosa del territorio ed degli elementi essenziali del linguaggio religioso per costruire un sapere che evidenzi la dimensione
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA
 CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
Rappresentazioni dell inizio della creazione
 Indice Prefazione................................. 5 Introduzione La rilevanza delle teologie bibliche della creazione.. 7 I. Rappresentazioni dell inizio della creazione... 15 1. Gioco alterno tra caos
Indice Prefazione................................. 5 Introduzione La rilevanza delle teologie bibliche della creazione.. 7 I. Rappresentazioni dell inizio della creazione... 15 1. Gioco alterno tra caos
IL LIBRO DELL APOCALISSE LA CROCE DI CRISTO COME TRIONFO
 IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
IL LIBRO DELL APOCALISSE Nonostante non sia di facile comprensione ha fatto riflettere tutti noi sulla morte e risurrezione del Signore. Siamo invitati a volgere il nostro sguardo al Trono del Dio, là,
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO
 ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI-BRENTONICO Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI-BRENTONICO Via Giovanni XXIII, n. 64-38065 MORI Cod. Fisc. 94024510227 - Tel. 0464-918669 Fax 0464-911029 www.icmori.it e-mail: segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it
La civiltà romana L impero romano
 La civiltà romana L impero romano L impero romano nacque nel 27 a. C. quando Ottaviano, nipote di Cesare, prese il potere e riunì nella sua persona tutte le cariche della repubblica (tribuno della plebe,
La civiltà romana L impero romano L impero romano nacque nel 27 a. C. quando Ottaviano, nipote di Cesare, prese il potere e riunì nella sua persona tutte le cariche della repubblica (tribuno della plebe,
