POLITICHE SOCIALI E ANALISI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL TERZO SETTORE
|
|
|
- Arrigo Garofalo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 DISPENSA N. 13 Lezione del 27 novembre 2012 POLITICHE SOCIALI E ANALISI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL TERZO SETTORE Rete interistituzionale Il contributo della L 328/2000 Identificazione analitica dei vari soggetti, alla luce del concetto di cultura organizzativa Messa a tema, in particolare, dei due sottosistemi delle cooperative sociali e del volontariato Le modalità di relazione fra campo pubblico e campo privato, con particolare riferimento ad appalti ed accreditamenti Il ruolo delle Carte dei servizi sociali per le procedure amministrative e per la valutazione dei servizi
2 2 Questa Dispensa integra ed aggiorna: Il capitolo 4 del libro: Paolo Ferrario, POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI, Carocci Faber e in particolare questi punti della monografia: 4.8. Il Terzo sistema 4.9. Cooperative sociali, volontariato e banche del tempo (pagg )
3 3 BANCHE del TEMPO Politiche dei soggetti di Terzo Settore
4 4 Legge 328/2000 SOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IMPRENDITORIALE SOGGETTI DEL VOLONTARIATO PROGRAMMAZIONE e ORGANIZZAZIONE ENTI LOCALI REGIONI STATO CONNESSIONI PROGRAMMATORIE ED OPERATIVE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IMPRENDITORIALI e del VOLONTARIATO GESTIONE ed OFFERTA dei SERVIZI RICONOSCONO e AGEVOLANO I RUOLI dei SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PROVVEDONO ALL OFFERTA DEI SERVIZI IN QUALITA DI SOGGETTI ATTIVI NELLA PROGETTAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE CONCERTATA DEGLI INTERVENTI ORGANISMI NON LUCRATIVI DI UTILITA SOCIALE ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONI ed ENTI di PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONI ENTI di PATRONATO ALTRI SOGGETTI PRIVATI Fonti: Legge 328/2000, art. 1/c3; 1/c4; 1/c5
5 5 In realtà le relazioni inter-istituzionali sono più complesse e non riconducibili alla sola relazione fra pubblico e terzo settore
6 6 TERZO SETTORE COMPLESSO DI ISTITUZIONI CHE, PONENDOSI ALL INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO, SI COLLOCANO TRA LO STATO E IL LIBERO MERCATO CON UN RUOLO E UNA FUNZIONE SOCIALE PRECISI E SPECIFICI. IN PARTICOLARE SI TRATTA DI ENTI PRIVATI VOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DESTINATI ALLA SOCIETA CIVILE IN TUTTE LE FORME da Dizionario di economia civile, a cura di Luigino Bruni e Stefano Zamagni Citta Nuova, 2009, p. 765
7 7 Soggetti del TERZO SETTORE periodizzazione dagli anni Periodi Eventi istituzionali COOPERATIVE SOCIALI (L. 381/1991) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/1991) 1992 nuove norme sulle SOCIETA COOPERATIVE (L. 59/1992) 1997 PICCOLE SOCIETA COOPERATIVE (L. 266/1997) qualifica fiscale delle ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( L. 460/1997) inclusione e valorizzazione nella RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (L. 328/2000) regole figura del SOCIO LAVORATORE (L. 142/2001) 2006 definizione della IMPRESA SOCIALE (dlgs 155/2006
8 8 Occorre distinguere all interno dei soggetti del cosiddetto TERZO SETTORE SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE GESTISCONO ATTIVITA (anche complesse) SOGGETTI DELLA SOCIETA CIVILE A VOCAZIONE VOLONTARIA ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO che valorizzano la volontà degli associati ENTI CHE SI FONDANO SU UN PATRIMONIO
9 9 CULTURA STRUTTURA ISTITUZIONALE
10 10 COOPERATIVE SOCIALI Dal latino co e operari, nel senso di operare insieme IMPRESE COOPERATIVE CHE PRODUCONO SERVIZI SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI O CHE COINVOLGONO SOGGETTI SVANTAGGIATI NELLE LORO ATTIVITA Legge n. 381/1991
11 11 IMPRESA SOCIALE ORGANIZZAZIONI PRIVATE CHE ESERCITANO IN VIA STABILE E PRINCIPALE UN ATTIVITA ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI DI UTILITA SOCIALE DIRETTA A REALIZZARE FINALITA DI INTERESSE GENERALE Fonti giuridiche: Dlgs 155/2006 Sitografia
12 12 ASSOCIAZIONI ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE PRIVATE CHE PERSEGUONO UNO SCOPO COMUNE (IDEALITA, VALORI, ) DIVERSO DALL ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA ECONOMICA Si dividono in: ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (hanno autonomia patrimoniale) e in ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Fonti giuridiche: Cost. art , 39, 49; Codice civile art. 12; Per il diritto civile italiano l elemento soggettivo, cioè l insieme di persone, è quello essenziale e fondativo mentre quello patrimoniale è secondario
13 13 FONDAZIONI ENTE DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUITO DA UNO O PIU FONDATORI E IN POSSESSO DI UN PATRIMONIO DA DESTINARE A PRECISI SCOPI: RELIGIOSI, CULTURALI, EDUCATIVI, SOCIALI, SCIENTIFICI Fonti giuridiche: Codice Civile artt Sitografia:
14 14 fra le fondazioni che interessano il mondo culturale dei servizi occorre segnalare le FONDAZIONI BANCARIE ENTI PRIVATI CHE HANNO RIORGANIZZATO LE ATTIVITA DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO, DISTINGUENDO DUE SOGGETTI: LE FONDAZIONI LE BANCHE Fonti giuridiche: Legge 218/1990; Dlgs 153/1999 Sitografia:
15 15 FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE NON HANNO UNA SPECIFICA LEGISLAZIONE, MA MIRANO A UNIRE LA CULTURA DELLE FONDAZIONI E QUELLA DELLE ASSOCIAZIONI. L ORGANIZZAZIONE E COSTITUITA DA FONDATORI PROMOTORI, CHE PARTECIPANO DESTINANDO UNA QUOTA PATRIMONIALE E DA FONDATORI PARTECIPANTI CHE ENTRANO IN UN SECONDO MOMENTO, SULLA BASE DELLE MODALITA STABILITE DALLO STATUTO Sitografia:
16 16 ENTI RELIGIOSI ENTI CHE HANNO ORIGINE DALLE STRUTTURE E DALL ORDINAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA E POSSONO AGIRE, A DETERMINATE CONDIZIONI, NEL QUADRO DELL ORDINAMENTO DELLO STATO Fonte giuridica: Legge 222/1985, art. 1 Enti religiosi: enti costituiti o approvati dall autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto
17 17 VOLONTARIATO Le attività di volontariato sono quelle prestate in modo personale e gratuito tramite l organizzazione di cui il volontariato fa parte senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà Fonte giuridica: Legge 266/1991 Sitografia:
18 18 BANCHE DEL TEMPO Associazione fra persone il cui l obiettivo è di scambiare fra loro beni, servizi e saperi. Nella banca del tempo ogni socio mette a disposizione il suo tempo, le sue capacità, le sue competenze, affinché chi ne è in ricerca possa chiederli. In cambio verrà offerto parte del proprio tempo ad un altro socio della banca del tempo. Tutto questo richiede reciproca informazione e una organizzazione anche minima che riesca mettere in rete le persone. La cultura che tiene insieme queste persone è il principio di reciprocità Sitografia
19 19 ONLUS Nozione di assenza di fine di lucro Enti i cui statuti od atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10
20 20 ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Le ONLUS non sono nuovi soggetti fiscali che si aggiungono a quelli già noti, ma sono un contenitore fiscale a cui possono aderire i vari e diversi soggetti giuridici operanti nel campo della cultura, dello sport e della solidarietà sociale adeguando i propri statuti secondo le regole fissate dalla legge In: Adriano Propersi, Giovanna Rossi Gli enti non profit, Il Sole 24 Ore 1998, p. 159 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
21 21 COOPERATIVE SOCIALI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO le differenze Scopo Oggetto Soci ordinari Soci volontari Perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi svolgimento di attività finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate quelli previsti dalle normative sulle cooperative presenza facoltativa regolata dagli statuti apporto complementare prestazioni gratuite possono essere corrisposti rimborsi Conseguire finalità di carattere sociale, civile, culturale individuate da stato, regioni, enti locali Attività prestata per il conseguimento degli individuati fini sociali, civili, culturali Gli aderenti sono volontari Le prestazioni personali, volontarie e gratuite devono essere prevalenti l utilizzo di lavoratori dipendenti e autonomi deve essere limitato e finalizzato al funzionamento e/o a qualificare e specializzare le attività Normative regionali Agevolazio ni fiscali albi iva al 4% per le prestazioni sociosanitarie ed educative rese albi agevolazioni Iva
22 COOPERATIVE 22 ISTITUTO CON IL QUALE PIU INDIVIDUI SI ASSOCIANO AL FINE DI OTTENERE DALLA GESTIONE IN COMUNE DI UN ATTIVITA ECONOMICA BENI DI CONSUMO, OCCASIONI DI LAVORO, SERVIZI A CONDIZIONI MIGLIORI DA QUELLE OFFERTE DAL MERCATO LA REPUBBLICA RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOOPERAZIONE A CARATTERE DI MUTUALITA E SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA. LA LEGGE NE PROMUOVE E FAVORISCE L INCREMENTO CON I MEZZI PIU IDONEI E NE ASSICURA,CON GLI OPPORTUNI CONTROLLI, IL CARATTERE E LE FINALITA (COST. ART. 45) IMPRESA AVVIATA E GESTITA DAI LAVORATORI GRUPPO DI PERSONE CHE SI AGGREGA PER RAGGIUNGERE UN FINE PRINCIPI DELLA COOPERAZION: CULTURA CENTRATA SUL GRUPPO POTERE DECISIONALE AI SOCI UTILI ECONOMICI: DEVONO FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERATIVA LE PERDITE VANNO COPERTE CON IL PATRIMONIO DISPONIBILE TIPOLOGIE PER SETTORI DI ATTIVITA : COOPERATIVE EDILIZIE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVE DELLA PESCA COOPERATIVE DI TRASPORTO COOPERATIVE DI CONSUMO COOOPERATIVE AGRICOLE COOPERATIVE MISTE MUTUE COOPERATIVE COOPERATIVE SOCIALI COPVOL
23 23 COOPERATIVE EDILIZIE : rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa". COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO : Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. COOPERATIVE DELLA PESCA : Sono costituite da soci pescatori e svolgono un'attività con un impegno diretto dei soci o un'attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. COOPERATIVE DI CONSUMO : Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci. COOPERATIVE AGRICOLE : Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci COOPERATIVE SOCIALI : Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione umana dei cittadini. Si distinguono in due tipologie: 1. quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 2. quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
24 24 QUATTRO RADICI DELLA COOPERAZIONE SOCIALE LA COOPERAZIONE DI SOLIDARIETA SOCIALE, CHE HA LA SUA MATRICE NEL VOLONTARIATO CATTOLICO LA COOPERAZIONE INTEGRATA, COLLEGATA ALLE ESPERIENZE DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE PSICHIATRICA LA COOPERAZIONE DI LAVORO NEI SERVIZI SOCIALI, STIMOLATA DAGLI ENTI LOCALI LE COOPERATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI DI GENITORI ATTIVE SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELL HANDICAP Fonte: Scalvini F., CGM, 2001
25 25 COOPERATIVE SOCIALI (Legge 381/1991) PUNTI CHIAVE: OBIETTIVI (art 1/c.1; 3) TIPOLOGIA: GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI (art. 1/a) GESTIONE DI ATTIVITA PRODUTTIVE (art 1/b) CONSORZI (art. 8) RISORSE UMANE NELLE COOPERATIVE DI LAVORO SOCI ORDINARI SOCI VOLONTARI (art.2) PERSONE SVANTAGGIATE (art. 4) SGRAVI FISCALI (art. 4/3; 7) RAPPORTI INTER - ISTITUZIONALI (art. 5) REGIONI (art. 9) RICONOSCIMENTO (art. 9) ALBO (art. 9) COPVOL
26 26 COOPERATIVE SOCIALI: IMPRESE CHE VENGONO COSTITUITE PER ASSICURARE LA PROMOZIONE E L INTEGRAZIONE DI CITTADINI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA PER PROBLEMI PSICO-FISICI o PER DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NELLA VITA PRODUTTIVA TIPOLOGIA DELLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO DI PRODOTTO PERSONALE TIPO A SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI OPERATORI PROFESSIONALIZZATI TIPO B ATTIVITA AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZI FINALIZZATE ALL INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE - SOCI LAVORATORI ORDINARI - SOCI VOLONTARI - SOCI LAVORATORI PERSONE SVANTAGGIATE CONSORZI fra COOPERATIVE SOSTEGNO ORGANIZZATIVO FORMAZIONE SUPPORTO STRATEGICO COPVOL
27 27 Come si costituisce una cooperativa La cooperativa e' una società (cioè un'impresa formata da più persone). Art. 2511: Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata. La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e l'atto costitutivo deve riportare le seguenti indicazioni (art cod. civ.): 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; 2) denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie; 3) oggetto sociale; 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata; 5) la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste.il capitale sociale varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti. 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 8) le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili; 9) il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale, nonchè il numero dei componenti il collegio sindacale; 10) la durata della società Per procedere alla costituzione legale di una società cooperativa è necessario un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno. Possono essere soci anche le persone giuridiche(società, associazioni, fondazioni).
28 COOPERATIVE SOCIALI: COSTITUZIONE 28 La costituzione delle cooperative sociali avviene per atto pubblico, cioè con l intervento di un notaio. L atto costitutivo e lo statuto devono indicare: DATI ANAGRAFICI DEI SOCI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SCOPO e OGGETTO SOCIALE: IN PARTICOLARE IL SETTORE OPERATIVO (COOP. TIPO A o TIPO B). Deve essere indicato che la cooperativa ha lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE e QUOTE DI CAPITALE SOTTOSCRITTE DA CIASCUN SOCIO CONDIZIONI PER L AMMISSIONE DEI SOCI CONDIZIONI PER IL RECESSO o ESCLUSIONE DEI SOCI FORME DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE NORME PER IL RIPARTO DEGLI UTILI COOPVOL
29 29 COOPERATIVE SOCIALI: ADEMPIMENTI ATTO ATTOCOSTITUTIVO e STATUTO 1 REGISTRAZIONE CANCELLERIA DEL TRIBUNALE 2 ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE 3 ACQUISIZIONE della PERSONALITA GIURIDICA 4 DOMANDA REGISTRO PREFETTIZIO 5 ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO COOPVOL
30 30 COOPERATIVE: ASSETTO ISTITUZIONALE MINIMO 9 SOCI STATUTO STATUTO ASSEMBLEA SOCI NOMINA 3-11 MEMBRI NOMINA 3 MEMBRI PRESIDENTE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE CONTROLLA L AMMINISTRAZIONE STRUTTURE OPERATIVE DELLA COOPERATIVA
31 31 COOPERATIVE SOCIALI: GLI ATTORI DELL IMPRESA BASE SOCIALE: SOCI LAVORATORI ORDINARI SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI SOCI FRUITORI SOCI SOVVENTORI LAVORATORI: SOCI LAVORATORI ORDINARI SOCI LOVORATORI SVANTAGGIATI LAVORATORI ORDINARI NON SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI NON SOCI SOCI COLLABORATORI VOLONTARI: SOCI NON SOCI OBIETTORI DI COSCIENZA
32 32 FINALITA DEI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI STIMOLARE LA COLLABORAZIONE TRA LE COOPERATIVE FORNIRE SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA GESTIRE ATTIVITA DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO ATTUARE, DIRETTAMENTE O TRAMITE LE COOPERATIVE SOCIE, INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI ENTI PUBBLICI COORDINARE I RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI PROMUOVERE E FAVORIRE IL SORGERE DI NUOVE INIZIATIVE FAVORIRE LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA SOCIALE
33 33 COOPERATIVE SOCIALI: PERSONE SVANTAGGIATE INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI EX DEGENTI DI ISTITUTI PSICHIATRICI SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO TOSSICODIPENDENTI ALCOLISTI MINORI IN ETA LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA FAMILIARE CONDANNATI AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
34 34 LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI Le persone svantaggiate... devono costituire almeno il 30 % dei lavoratori della cooperativa (art. 4 Legge 381/1991) il calcolo percentuale va fatto rispetto al numero dei lavoratori Normodotati (Circolare Inps n. 188, 17 giugno 1994) LAVORATORI della COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO (tipo A) LAVORATORI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
35 35 RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI schema b BISOGNI DOMANDA RISORSE da COSTO a RISORSA
36 36 Le cooperative ordinarie hanno un minimo di 9 soci. Tuttavia, la vigente legislazione di settore, con l'art. 21 della legge , n. 266 (legge Bersani), ha introdotto una forma semplificata di società cooperativa caratterizzata da requisiti minimi: la piccola società cooperativa Cooperativa dalle grandi potenzialità, in quanto destinata a conciliare le esigenze di piccoli gruppi che intendano costituire la più piccola società mutualistica prevista dal nostro ordinamento.
37 37 Composizione da un minimo di 3 ad un massimo di 8 soci, tutte persone fisiche. Denominazione sociale recante l'indicazione di "Piccola società cooperativa". Amministrazione che può essere affidata all'assemblea il cui presidente avrà in tal caso le funzioni di rappresentante legale, criterio che garantisce al massimo il coinvolgimento dei soci. Collegio sindacale facoltativo richiamando le norme in tema di SRL di cui agli Art e segg. C.C.. Vale a dire che, a parte l'ipotesi in cui sia lo stesso Statuto a prevederlo, il Collegio Sindacale sarà obbligatorio laddove la P. S.C. raggiunga limiti capitale sociale stabiliti per legge
38 38 ASSOCIAZIONE VOLONTARIA una definizione UN GRUPPO ORGANIZZATO DI PERSONE CHE SI FORMA PER FAVORIRE INTERESSI COMUNI, I CUI SOCI SONO VOLONTARI NEL SENSO CHE L ADESIONE NON E OBBLIGATORIA, E CHE ESISTE INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO (D.L. Sills, in F. Mattioli, Introduzione alla sociologia dei gruppi, Seam, Roma 1998, p. 292)
39 39 MOLTI VOLONTARIATI GRUPPI ORIENTATI ALL AZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FINI SOLIDALI GRUPPI CHE INTERVENGONO SU AMBIENTE CULTURA TEMPO LIBERO GRUPPI INFORMALI GRUPPI CON STRUTTURE ORGANIZZATIVA FORMALIZZATA inoltre l azione volontaria e gratuita non è esclusiva dei mondi del volontariato: PARTITI SINDACATI ASSOCIAZIONI DI TUTELA ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI
40 40 VOLONTARIATO (Legge 266/1991) RICONOSCIMENTO SOCIALE DEL VOLONTARIATO (art. 1) ATTIVITA DI VOLONTARIATO (art. 1, 2): REQUISITI ORGANIZZATIVI (art. 3): FINANZIAMENTI ASSICURAZIONI (art. 4) RISORSE ECONOMICHE (art. 5) AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 8) RAPPORTI VOLONTARIATO - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: REGIONI (art. 10, 15) REGISTRI (art. 6) CONVENZIONI (art. 7) CONTROLLI (art.6; 11) OSSERVATORIO NAZIONALE (art. 12; 14) CENTRI SERVIZI (art. 15) CONDIZIONE DEI VOLONTARI TEMPI DI VITA E VOLONTARIATO (art. 17) INCOMPATIBILITA (art. 2)
41 41 Legge 266/1991 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO QUELLA PRESTATA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, TRAMITE L ORGANIZZAZIONE DI CUI IL VOLONTARIATO FA PARTE, SENZA FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA (art. 2 Legge 266/1991) CARATTERE ORGANIZZATO DELL ATTIVITA DI VOLONTARIATO QUINDI NON E REGOLAMENTATO L AGIRE VOLONTARIO E ALTRUISTICO DEI CITTADINI ASSENZA DI FINI DI LUCRO ASSENZA DI REDISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ASENZA DI RAPPORTO DI LAVORO FINE SOLIDARISTICO DELL ATTIVITA
42 42 Legge 266/1991 REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E CONSIDERATO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OGNI ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO... CHE SI AVVALGA IN MODO DETERMINANTE E PREVALENTE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI (art. 3 Legge 266/1991) ELEMENTI NECESSARI DELLO STATUTO ASSENZA DI FINI DI LUCRO DEMOCRATICITA DELLA STRUTTURA ELETTIVITA E GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE GRATUITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI OBBLIGO DI FORMAZIIONE DEL BILANCIO E MODALITA DI APPROVAZIONE
43 43 Legge 266/1991 FINANZIAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI CONTRIBUTI DI PRIVATI CONTRIBUTI PUBBLICI CONTRIBUTI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI TASSAZIONE ESENZIONI DEDUZIONI
44 44 Legge 266/1991 CONDIZIONE DEI VOLONTARI INCOMPATIBILITA DELLA QUALITA DI VOLONTARIO CON QUALSIASI FORMA DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO ( art 2 /c3) OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA FLESSIBILITA DI ORARIO DI LAVORO (art. 17)
45 45 Legge 266/1991 RAPPORTI VOLONTARIATO - SETTORE PUBBLICO ISCRIZIONE AI REGISTRI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PUBBLICI STRUMENTO PER FARE IL CENSIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONI CONTINUITA DELLE ATTIVITA RISPETTO DEI DIRITTI E DIGNITA DEGLI UTENTI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA QUALITA OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO CENTRI DI SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI FUNZIONI DI SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA
46 REGIONE LOMBARDIA - VOLONTARIATO Legge Regionale 22 / ATTIVITA DI VOLONTARIATO DEFINIZIONE (art. 2) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 3) FORMAZIONE (art. 6) SVILUPPO ED IMMAGINE SOCIALE» COMITATO (art. 10, 11)» CONFERENZA REGIONALE (art. 13) REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO art. 4 VOLONTARIATO E POLITICHE SOCIALI art. 5 RAPPORTI CON IL SETTORE PUBBLICO SOSTEGNI FINANZIARI (art. 7, 12) CONVENZIONI (art. 8) VIGILANZA (art. 9)
47 47 CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO GESTITI DIRETTAMENTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OFFRONO: STRUMENTI PER LA CRESCITA CULTURALE FORMAZIONE CONSULENZA AIUTO ALLA PROGETTAZIONE
48 ESTERNALIZZAZIONE (ingl. Outsourcing) 48 AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DELLA ORGANIZZAZIONE DI SINGOLE FUNZIONI O DI INTERI CICLI DI PRODUZIONE DI UNA ATTIVITA. RISPONDE AD ESIGENZE DI: CONTENIMENTO DEI COSTI USO PIU RAZIONALE DELLE RISORSE FLESSIBILITA ORGANIZZATIVA ALCUNE TIPOLOGIE: ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA AUTONOMA E DISTINTA DALL ENTE, MA CHE RIMANE FORMALMENTE PUBBLICA (AZIENDA, ISTITUZIONE, ENTE AUTONOMO ISTITUZIONE AUTONOMA, MA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE DI PARTNERS PRIVATI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN SOGGETTO PRIVATO DI UNA ATTIVITA O FUNZIONE DI PUBBLICO INTERESSE SISTSER
49 49 ESTERNALIZZAZIONE definizione TECNICA ORGANIZZATIVA IN BASE A CUI UN OPERATORE ECONOMICO (come la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ACQUISTA ATTIVITA PRODUTTIVE SUL MERCATO (QUINDI ALL ESTERNO) INVECE DI USARE MEZZI PROPRI
50 ESTERNALIZZAZIONE della PRODUZIONE di SERVIZI 50 ENTE PUBBLICO SOGGETTO ESTERNO TITOLARITA GIURIDICA RESPONSABILITA FINANZIARIA OBIETTIVI PUBBLICI RESPONSABILITA GESTIONALE della OFFERTA dei SERVIZI CONTRATTATI SERVIZIO RELAZIONE CONTRATTUALE ATTIVITA DI SERVIZIO PROBLEMATICHE PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI DA DEFINIRE: SOGGETTI DELL INTERVENTO FINALITA E METODI DI INTERVENTO OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI DURATA, PROROGHE, RINNOVI POSSIBILI MODIFICHE AMMISSIONI E DIMISSIONI DEGLI UTENTI PROGETTI INDIVIDUALI RELAZIONI PERIODICHE E FINALI STANDARD DEL SERVIZIO: NUMERO E COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI AMBIENTI, CONDIZIONI SANITARIE, REGIMI ASSICURATIVI COLLABORAZIONE FRA OPERATORI PUBBLICI E OPERATORI PRIVATI FORME DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIAMENTO VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO SUI RISULTATI E SULE AZIONI DI SERVIZIO MODALITA DI INTERVENTO SULLE INADEMPIENZE
51 51 APPALTO definizione UNA IMPRESA (O APPALTATORE) ASSUME, CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE E A PROPRIO RISCHIO, LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA O DI UN SERVIZIO SULLA BASE DI UN CORRISPETTIVO DI DENARO PAGATO DAL COMITTENTE (APPALTANTE)
52 APPALTI 52 APPALTO: CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO LA COSTRUZIONE DI UN OPERA LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO MODI PER SCEGLIERE IL CONTRAENTE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: APPALTO CONCORSO L APPALTATORE PRESENTA UNA OFFERTA ECONOMICA E UN PROGETTO ASTA PUBBLICA GARA CUI SONO AMMESSI COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER PARTECIPARVI LICITAZIONE PRIVATA GARA CHE AVVIENE TRA COLORO CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA INVITATO A PARTECIPARE IN RAPPORTO AI REQUISITI DI IDONEITA TECNICA FORNITI TRATTATIVA PRIVATA TRATTATIVA DIRETTA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI SENZA ALCUNA GARA. E MOLTO DISCREZIONALE: NON OFFRE GARANZIE DI IMPARZIALITA SISTSER
53 53 APPALTI DI SERVIZI: FASI BASSA REGOLAZIONE Anni 80 SVILUPPO RETE USL PRIMI PROCESSI DI RAFFORZAMENTO DI RUOLO DEI COMUNI REGOLAZIONE NON SPECIFICA CULTURA AMMINISTRATIVA DEGLI APPALTI D OPERA MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI ESPERIENZE OPERATIVE SVILUPPO DI PROFESSIONALITA REGOLAZIONE SPECIFICA RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
54 APPALTI: PROCEDURE 54 STUDIO DI FATTIBILITA PROGETTO DELIBERA A CONTRATTARE BANDO DI GARA RICHIESTA DI INVITO PRE-SELEZIONE LETTERA DI INVITO VALUTAZIONE DELL OFFERTA AGGIUDICAZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE SISTSER
55 55 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNI VIGILANZA SUI SOGGETTI EROGATORI DIVERSE MODALITA DI GESTIONE Unità organizzative di servizio: OFFERTA di SERVIZI a GESTIONE DIRETTA OFFERTA di SERVIZI tramite GESTIONE INDIRETTA: CONTRATTI DI APPALTO ACCREDITAMENTO CONCESSIONE
56 UNA REGOLA IMPORTANTE 56 Legge 328/2000 Art. 4. Selezione dei soggetti del terzo settore 1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi: a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti; b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; 2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalita' adottate per il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunita'; d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. 3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.
57 57 ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI: LE REGOLE I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni L autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione I comuni provvedono all accreditamento. e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell ambito della programmazione regionale e locale Legge n. 328/2000, art. 11
58 58 Definizione generale: L ACCREDITAMENTO è UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO IL QUALE L ENTE PUBBLICO CONSENTE AD UN SOGGETTO PRIVATO IN POSSESSO DI REQUISITI PREDETERMINATI DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA PROPRIA RETE DI FORNITORI DI UN SERVIZIO
59 59 Dal punto di vista operativo L ACCREDITAMENTO consiste nella verifica del possesso delle strutture pubbliche e private di requisiti professionali ed organizzativi relativamente a: STRUTTURA PROCESSI DI ASSISTENZA RISULTATI DI SERVIZIO
60 60 L OFFERTA tramite ACCREDITAMENTO SOCIALE avviene sulla base di: preliminare autorizzazione definizione di requisiti organizzativi e professionali di accreditamento tariffe riconosciute agli enti erogatori
61 STRUMENTI PER LA GESTIONE: LE DIFFERENZE FRA APPALTO E ACCREDITAMENTO STATO REQUISITI MINIMI 61 REGIONE REQUISITI ANALITICI APPALTO di SERVIZI ACCREDITAMENTO ENTE PUBBLICO ENTE PUBBLICO OBIETTIVI QUANTITA e QUALITA del SERVIZIO CAPITOLATO CONTRATTUALE RICERCA DI PUNTI DI INCONTRO FRA DOMANDA ED OFFERTA SULLA BASE di REQUISITI ORGANIZZATIVI STABILITI A LIVELLO STATALE E REGIONALE PROCEDURE di AGGIUDICAZIONE APPLICAZIONE del CONTRATTO ENTE GESTORE ENTE GESTORE
62 62 L'autorizzazione al funzionamento è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta di avviare legalmente la gestione ed erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini L'accreditamento è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta autorizzata al funzionamento di erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini con un livello di qualità definito dall' Ente accreditante II contratto è l'atto che impegna l'ente accreditante e la struttura accreditata, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini
63 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PUNTO DI INCONTRO FRA DUE FORZE 63 STATO REGIONI COMUNI Servizi sociali ASL Servizi sanitari AREA dei SOGGETTI AUTORIZZATI e ACCREDITATI CARTA dei SERVIZI TERZO SETTORE PRIVATI
64 64 TIPI DI ACCREDITAMENTO ACCREDITAMENTO SOCIALE: ATTIVITA TECNICO-AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO CUI I COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI VERIFICANO IL POSSESSO DI REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI ED ATTRIBUISCONO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E AGLI ENTI PRIVATI LA CAPACITA DI OFFRIRE PRESTAZIONI SOCIALI E SERVIZI SOCIALI FINANZIATI SUI PROPRI BILANCI SANITARIO E SOCIO-SANITARIO: ATTIVITA TECNICO-AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO CUI LE REGIONI, TRAMITE LE ASL, VERIFICANO IL POSSESSO DI REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI ED ATTRIBUISCONO AGLI ENTI PRIVATI LA CAPACITA DI OFFRIRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
65 65 ACCREDITAMENTO SANITARIO il processo delle 3A L accreditamento istituzionale è un processo tecnico ed amministrativo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche o private, ed i professionisti che ne facciano richiesta, acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale OBIETTIVI: RENDERE OMOGENEI I REQUISITI MINIMI ASSICURARE DETERMINATI STANDARD di OFFERTA FAVORIRE la LIBERA SCELTA dei CITTADINI REGOLARE la CRESCITA dei SOGGETTI EROGATORI AUTORIZZAZIONE: possesso di requisiti minimi ACCREDITAMENTO: presuppone l autorizzazione e il possesso di ulteriori requisiti e l accettazione di un sistema tariffario ACCORDI CONTRATTUALI: delimitazione quali quantitativa delle prestazioni compatibili con i livelli assistenziali programmati e con le risorse disponibili Fonte: Balma R., Clerico G., L accreditamento i sanità, in I servizi sanitari in Italia 2000, Il Mulino 2000, p. 237
66 66 ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 Saggi di studio e approfondimento in tema di appalti e accreditamento Paolo Ferrario, I servizi socio-sanitari e le politiche amministrative dell'accreditamento,, in Appunti sulle politiche sociali n. 5, 2002, a cura del Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati (Ancona) (per informazioni: Paolo Ferrario, "Dalla Legge 328/00 a oggi: gestione dei servizi sociali e contratti di appalto; gestione dei servizi sociali e accreditamento sociale" (secondo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n , pag. 1-5 Un monitoraggio continuo sull attuazione della Legge 328/2000 è contenuto sul sito a questo indirizzo:
67 LA CARTA DEI SERVIZI Che cosa è? 67 E un patto-contratto che l Ente stabilisce con i propri utenti attraverso un documento pubblico, sul quale sono descritti i servizi offerti e gli standard di qualità e quantità con cui si impegna a fornirli. In modo più analitico è: DOCUMENTO DI TRASPARENZA RIVOLTO AI CITTADINI / UTENTI DA UN ENTE PUBBLICO o PRIVATO CON IL QUALE ESSO: - ESPLICITA I SUOI ORIENTAMENTI - DICHIARA QUALI SONO LE PRESTAZIONI CHE SI IMPEGNA AD EROGARE - COME INTENDE OPERARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PRESTAZIONI PROMESSE TALE DOCUMENTO HA NOTEVOLI IMPLICAZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI, IN QUANTO ORIENTA IL FORNITORE A METTERE AL CENTRO LE ESIGENZE DELL UTENTE/OSPITE/CLIENTE
68 68 Per una analisi sull argomento, rimando a: LE POLITICHE SOCIALI PER LO SVILUPPO DELLA QUALITA In Paolo Ferrario, Marisa Bianchi, Luciana Quaia, La qualità nei servizi socio-sanitari, Carocci Faber 2002 (vai a Pagg Indice Le politiche sociali per lo sviluppo della qualità di Paolo Ferrario Capitolo 1: L orientamento alla qualità nella legislazione 1.1 Servizi socio-sanitari: il ciclo riformistico degli anni Il nuovo ordinamento dei comuni 1.3 Il nuovo ordinamento delle Aziende sanitarie locali 1.4 La riforma dei servizi sociali 1.5 Riforme amministrative e valutazione della qualità 1.6 Le politiche della comunicazione pubblica Capitolo 2: Politiche legislative per le Carte dei servizi 2.1 Fasi di sviluppo 2.2 Le regole quadro 2.3 Le regole di settore 2.4 Aspetti di metodo nella produzione delle Carte dei servizi 2.5 Processi di comunicazione e di pensiero nella produzione delle Carte Capitolo 3: Culture organizzative sulla qualità dei servizi socio-sanitari 3.1 La qualità del servizio 3.2 Amministrazione dei servizi, esternalizzazione e accreditamento 3.3 Il contributo teorico-pratico di Richard Normann 3.4 I gruppi di progettazione: il contributo di Henry Mintzberg
69 69 CARTA DEI SERVIZI DOCUMENTAZIONE SCRITTA, ORIENTATA ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA E RIVOLTA AL CITTADINO / UTENTE, CON CUI L ENTE ESPLICITA LE SUE FINALITA DICHIARA LE PRESTAZIONI CHE SI IMPEGNA AD EROGARE DICHIARA COME INTENDE OPERARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PRESTAZIONI PROMESSE SUA IMPLICAZIONE ORGANIZZATIVA: ORIENTA IL FORNITORE A METTERE AL CENTRO LE ESIGENZE DEL CLIENTE
70 70 L 328/2000: PROCESSI ISTITUZIONALI CHE SI CONNETTONO A POLITICHE DI SVILUPPO DELLA QUALITA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CARTE DEI SERVIZI SOCIALI PIANI DI ZONA negli AMBITI TERRITORIALI PROMOZIONE della GESTIONE ASSOCIATA
71 71 CARTE DEI SERVIZI: percorso legislativo UNA RADICE E RICONOSCIBILE NELLA Legge 241/1990 RILEVANZA GIURIDICA DI ASPETTI COME: TRASPARENZA PUBBLICITA PARTECIPAZIONE EFFICIENZA/EFFICACIA Dlgs 29/ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO art. 12 RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI art. 20 legge 20/ REGIONALIZZAZIONE CORTE DEI CONTI introdotta la CULTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DIRETTIVA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 27/1/1994 (v. scheda) DIRETTIVA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 11/10/1994 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO DPCM 19/5/ SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO
72 72 LA POLITICA DELLE CARTE DEI SERVIZI REGIONI a STATUTO ORDINARIO POTERI AMMINISTRATIVI delle REGIONI ULTERIORE RAFFORZAMENTO DEI POTERI AMMINISTRATIVI delle REGIONI RIFORMA della COSTITUZIONE aa RIFORMA SANITARIA POLITICHE REGIONALI SUI SERVIZI SOCIALI RIFORME AMMINISTRATIVE della SANITA RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI RIFORMA degli ENTI LOCALI RIFORMA delle COOPERATIVE SOCIALI RIFORMA del VOLONTARIATO ORGANIZZATO
73 IL MODELLO della CARTA DEI SERVIZI 73 STORIA: NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SANITA NEI SERVIZI SOCIALI (Legge 328/2000, art. 13) LINEE GUIDA CRITERI: ACCESSO FUNZIONAMENTO SERVIZI VALUTAZIONE ESTERNA TUTELA UTENTI AZIONE ORGANIZZATIVA ANALISI del SISTEMA DI OFFERTA PROCESSI DI LAVORO FATTORI di QUALITA INDICATORI di QUALITA COMUNICAZIONE ESTERNA QUALITA PERCEPITA
74 74 CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI metodologia: le carte devono individuare gli standard delle prestazioni di servizio a partire dalla identificazione dei fattori di qualità del servizio e dei rispettivi indicatori. Devono inoltre dotarsi di un sistema di controllo che permetta di rilevare gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi programmati e quelli realizzati FATTORI DI QUALITA ASPETTI RILEVANTI PER LA PERCEZIONE DELLA QUALITA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL UTENTE (es. tempestività, accessibilità, semplicità della fruizione del servizio, informazione, orientamento, accoglienza, cortesia, rispetto INDICATORI DI QUALITA VARIABILI QUANTITATIVE O PARAMETRI QUALITATIVI CHE REGISTRANO UN CERTO FENOMENO, RITENUTO INDICATIVO DI UN FATTORE DI QUALITA. PER OGNI FATTORE DI QUALITA POSSONO ESISTERE PIU INDICATORI. SI SUDDIVIDONO IN INDICATORI DI PROCESSO, DI STRUTTURA, DI ESITO STANDARD DI QUALITA VALORI ATTESI PER DETERMINATI INDICATORI. RAPPRESENTANO OBIETTIVI DI QUALITA CHE SI RIFERISCONO AL COMPLESSO DELLE PRESTAZIONI RESE QUALITA
75 75 LE POLITICHE DELLA CARTA DEI SERVIZI FASI AZIONI PREPARAZIONE ricerca internazionale: Carta di servizi pubblici Inghilterra Francia Belgio Carta europea contesto: rinnovamento della pubblica amministrazione REGOLE QUADRO 1994 Direttiva: Principi dell erogazione dei servizi pubblici PRINCIPI STRUMENTI TUTELA REGOLE DI SETTORE 1995 SCHEMA GENERALE CARTA SERVIZI SANITA QUADRI DI RIFERIMENTO INDICAZIONI METODOLOGICHE LINEE GUIDA SANITA ALTRI SCHEMI DI SETTORE: SCUOLA, PREVIDENZA, ELETTRICITA, GAS, POSTE SPERIMENTAZIONI E REALIZZAZIONI MONITORAGGIO PRESSO IL MINISTERO SANITA RICERCHE SAGGI DI DOCUMENTAZIONE SULLE ESPERIENZE FORMAZIONE SULL ARGOMENTO APPLICAZIONE DIFFUSA RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI ED ESTENSIONE PRESSO I COMUNI ED I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE SUO AGGANCIO ALL ACCREDTAMENTO SOCIALE Per una analisi delle politiche legislative nel quadro della pubblica amministrazione: Paolo Ferrario: Le politiche per lo sviluppo della qualità, in Ferrario P., Bianchi M., Quaia L., La qualità nei servizi socio-sanitari, Carocci Faber, 2002, p
76 76 MUTAMENTI NELLE POLITICHE LEGISLATIVE DA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI A CARTA DEI SERVIZI SOCIALI 2000-
77 77 LE DIVERSE RADICI DELLE CARTE DEI SERVIZI CARTA dei SERVIZI CARTA dei SERVIZI CARTA dei SERVIZI CARTA dei SERVIZI CARTA dei SERVIZI le CRESCENTI ESIGENZE DI IMMAGINE gli SVILUPPI ORGANIZZATIVO PROFESSIONALI REGOLE sulla TRASPARENZA REGOLE sulla CONCORRENZA AMMINISTRATA
78 78 PRINCIPI FONDAMENTALI SULL EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI EGUAGLIANZA NON UNIFORMITA DELLE PRESTAZIONI, MA DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI IMPARZIALITA DOVERE DI NEUTRALITA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTINUITA INTERRUZIONE DEI SERVIZI SOLO NEI CASI GIA PREFISSATI DIRITTO DI SCELTA POSSIBILITA PER L UTENTE DI SCEGLIERE IL SOGGETTO EROGATORE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVA, CON POSSIBILITA PER L UTENTE DI FORNIRE PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EFFICIENZA ED EFFICACIA MISURE IDONEE AL RAGGIONGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SECONDO PARAMETRI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA Fonte: DPCM 27/1/1994
79 79 CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI Direttiva Ciampi Cassese (D.P.C.M , in g.u n. 43) PRINCIPI FONDAMENTALI EGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI OBIETTIVITA, GIUSTIZIA E IMPARZIALITA CONTINUITA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DIRITTO DI SCELTA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI EFFICIENZA ED EFFICACIA STRUMENTI ADOZIONE E VALUTAZIONE DI STANDARD E DI QUALITA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMAZIONE DEGLI UTENTI VALUTAZIONE DELLA QUALITA DEI SERVIZI RIMBORSO IN CASO DI PRESTAZIONE INFERIORE AGLI STANDARD PUBBLICATI TUTELA PROCEDURE DI RECLAMO DA SPORGERE PRESSO L UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO COMITATO PERMANENTE PER L ATTUAZIONE DELLA CARTA SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA DIRETTIVA
80 80 SCHEMI DI RIFERIMENTO DELLE CARTE DEI SERVIZI (D.L n. 163, convertito con Legge n. 273) PREVEDE: EMANAZIONE DEGLI SCHEMI GENERALI DI RIFERIMENTO DELLE CARTE DEI SERVIZI MODIFICAZIONE NORMATIVA SULL UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (Art. 12 L. 29/1993) STABILENDO CHE IL RESPONSABILE ED IL PERSONALE DA LUI INDICATO POSSONO ASSUMERE AUTONOME INIZIATIVE PER: MIGLIORAMENTO SERVIZI PER IL PUBBLICO SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PROCEDURE INCREMENTO DELLE MODALITA DI ACCESSO INFORMALE VERIFICHE SULLE AUTONOME INIZIATIVE UTILI PER VALUTAZIONE CARRIERA E CONCORSI PUBBLICI (es. produttività)
81 81 LA CARTA DEI SERVIZI NELLE LINEE GUIDA N. 2/1995 DEL MINISTERO DELLA SANITA presentazione dell Ente e della sua mission informazione sulla strutture e sui servizi forniti standard di qualità, impegni, programmi meccanismi di tutela e di verifica
82 82 LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI NELLA LEGGE 328 / 2000 (art. 13) ADOZIONE DI UNO SCHEMA DI RIFERIMENTO OGNI ENTE EROGATORE ADOTTA UNA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI e ne dà ADEGUATA PUBBLICITA AGLI UTENTI NELLA CARTA SONO DEFINITI: I CRITERI PER L ACCESSO AI SERVIZI LE LORO MODALITA DI FUNZIONAMENTO LE CONDIZIONI PER FACILITARNE LE VALUTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI E DEI SOGGETTI CHE RAPPRESENTANO I LORO DIRITTI LE PROCEDURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI UTENTI LA CARTA DEI SERVIZI PREVEDE PER GLI UTENTI LA POSSIBILITA DI ATTIVARE RICORSI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI L ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI COSTITUISCE REQUISITO NECESSARIO AI FINI DELL ACCREDITAMENTO
83 83 MAPPA DEI VARI ASPETTI DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI ACCESSO MODALITA DI FUNZIONAMENTO VALUTAZIONE da parte degli UTENTI CARTA dei SERVIZI REQUISITO NECESSARIO per L ACCREDITAMENTO PROCEDURE per la TUTELA degli UTENTI QUESTO ASPETTO RIMANDA ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DOPO LA LEGGE 328
84 84 LA CARTA DEI SERVIZI NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 229/1999 (art. 3 septies e 8- quater) INDIVIDUAZIONE ALL INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI DI UNA SEZIONE DEDICATA AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIO- SANITARI IN RIFERIMENTO ALL ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE SI PARLA DI: ADOZIONE E UTILIZZAZIONE SISTEMATICA DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI, INCLUSA LA DIFFUSIONE DEGLI ESITI DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE
85 LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI negli STANDARD ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI dei CDD Centri Diurni per persone con REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI in cui siano: Disabilità ILLUSTRATI I SERVIZI OFFERTI DGR luglio 2004 INDICATO L AMMONTARE DELLA RETTA 85 ALLEGATO IL QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE PER OSPITI E FAMILIARI INDICATA LA POSSIBILITA DI VISITE GUIDATE PER GLI UTENTI POTENZIALI E LORO FAMILIARI DESCRITTE LE MODALITA DI ACCOGLIENZA PRESA IN CARICO DIMISSIONI DEFINITE LE MODALITA DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI RIPORTATO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI, DELLE FAMIGLIE, DEGLI OPERATORI
86 86 EVOLUZIONE LEGISLATIVA ed ORGANIZZATIVA DELLA CARTA DEI SERVIZI DA STRUMENTO PER LA VISIBILITA DEI VARI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A STRUMENTO AMMINISTRATIVO PER IL GOVERNO DEI SERVIZI ALLA PERSONA: PER L ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIAO-SANITARI PER L ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
87 87 LA CARTA DEI SERVIZI E LE SUE CONNESSIONI CONNESSIONI CON L ORGANIZZAZIONE INTERNA ENTE UNITA OPERATIVE CARTA DEI SERVIZI CONNESSIONI CON L AMBIENTE SOCIALE: BISOGNI, DOMANDA CONNESSIONI CON LA RETE ESTERNA DEGLI ENTI
88 88 TIPI DI CARTE DEI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO- SANITARIO CARTE DEI SERVIZI NELLA SANITA DATA LA COMPLESSITA DI QUESTE ORGANIZZAZIONI TENDONO AD ESSERE DELLE GUIDE AI SERVIZI TENDENZA A PRODURRE CARTE RIGUARDANTI SINGOLI PROCESSI DI PRODUZIONE (ES. CURE PALLLIATIVE; REPARTI OSPEDALIERI CARTE DEI SERVIZI NELLE RSA PER ANZIANI PER RISPETTARE GLI STANDARD REGIONALI QUALI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA QUALITA CARTE DEI SERVIZI NEI COMUNI DECISIONI COLLEGATE A SCELTE LOCALI DI TIPO POLITICO O PROFESSIONALE CARTE DEI SERVIZI COLLEGATE AI PROCESSI ATTUATIVI DELLA LEGGE 328/2000 PRODOTTE DA COOPERATIVE SOCIALI O ALTRI SOGGETTI PRIVATI PRODOTTE DA COMUNI
89 89 Forse si può riconoscere l esistenza di PIU VOCAZIONI relativamente alle politiche di sviluppo delle CARTE DEI SERVIZI: ADEMPIMENTO BUROCRATICO PER LE AZIONI AMMINISTRATIVE (es. accreditamento GUIDA DEI SERVIZI = RUBRICA TELEFONICA SPECIALIZZATA CONTRATTO CON L UTENZA DIRETTA ED INDIRETTA = RICOGNIZIONE CONTINUA SUL SISTEMA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI CULTURALI DELL ORGANIZZAZIONE
Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.14: I SOGGETTI DI TERZO SETTORE : differenze istituzionali 28 aprile 2011
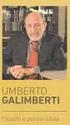 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.14: I SOGGETTI DI TERZO SETTORE : differenze istituzionali 28 aprile 2011 2 TERZO SETTORE COMPLESSO DI ISTITUZIONI CHE, PONENDOSI ALL INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO,
1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.14: I SOGGETTI DI TERZO SETTORE : differenze istituzionali 28 aprile 2011 2 TERZO SETTORE COMPLESSO DI ISTITUZIONI CHE, PONENDOSI ALL INTERNO DEL SISTEMA ECONOMICO,
SISTEMA dei SERVIZI SOCIO-SANITARI: RELAZIONI INTER - ISTITUZIONALI
 SOCIOEDUCATIVI: APPALTI E ACCREDITAMENTI, 21 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.12: LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI: APPALTI E ACCREDITAMENTI 21 aprile 2011 SISTEMA
SOCIOEDUCATIVI: APPALTI E ACCREDITAMENTI, 21 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.12: LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI: APPALTI E ACCREDITAMENTI 21 aprile 2011 SISTEMA
UNITA DIDATTICA DEDICATA ALLA: RIFORMA del TERZO SETTORE,
 1 Incontri di formazione: LEGISLAZIONE SOCIALE E SISTEMA DEI SERVIZI NELLA FASE Cooperativa sociale PROGETTO SOCIALE (vai al sito), Cantù, 7 luglio; 4 ottobre 2016 UNITA DIDATTICA DEDICATA ALLA: RIFORMA
1 Incontri di formazione: LEGISLAZIONE SOCIALE E SISTEMA DEI SERVIZI NELLA FASE Cooperativa sociale PROGETTO SOCIALE (vai al sito), Cantù, 7 luglio; 4 ottobre 2016 UNITA DIDATTICA DEDICATA ALLA: RIFORMA
LE DIVERSE RADICI DELLE CARTE DEI SERVIZI
 comunicazione e di gestione dei servizi alla persona, 21 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.13: Le CARTE DEI SERVIZI SOCIALI come strumenti di comunicazione e di gestione dei servizi alla
comunicazione e di gestione dei servizi alla persona, 21 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.13: Le CARTE DEI SERVIZI SOCIALI come strumenti di comunicazione e di gestione dei servizi alla
Mappa cognitiva: i soggetti del terzo settore nel quadro dei servizi alla persona
 1 Soggetti del TERZO SETTORE Una ricognizione sulle politiche legislative a cura di 2 dicembre 2011 Mappa cognitiva: i soggetti del terzo settore nel quadro dei servizi alla persona periodizzazione delle
1 Soggetti del TERZO SETTORE Una ricognizione sulle politiche legislative a cura di 2 dicembre 2011 Mappa cognitiva: i soggetti del terzo settore nel quadro dei servizi alla persona periodizzazione delle
POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI ed EDUCATIVI E SISTEMA DEI COMUNI ITALIANI
 1 DISPENSA N. 11 6 novembre 2013 POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI ed EDUCATIVI E SISTEMA DEI COMUNI ITALIANI Definizione Periodizzazione I flussi di finanziamento Differenze fra la riforma sanitaria e quella
1 DISPENSA N. 11 6 novembre 2013 POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI ed EDUCATIVI E SISTEMA DEI COMUNI ITALIANI Definizione Periodizzazione I flussi di finanziamento Differenze fra la riforma sanitaria e quella
A chi potrei donare?
 Donazioni e lasciti nei confronti associazioni e Onlus Aspetti giuridici A chi potrei donare? Modena, 30 settembre 2016 1 Contenuti I comitati Le associazioni Le fondazioni Gli enti non commerciali Le
Donazioni e lasciti nei confronti associazioni e Onlus Aspetti giuridici A chi potrei donare? Modena, 30 settembre 2016 1 Contenuti I comitati Le associazioni Le fondazioni Gli enti non commerciali Le
Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a
 1 Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo 2009 Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a cura di Paolo Ferrario Questa dispensa si struttura
1 Dispensa n. 2 Argomenti trattati nelle Lezioni del 10 e 12 Marzo 2009 Il sistema dei servizi alla persona e le grandi riforme dagli anni 80 a oggi a cura di Paolo Ferrario Questa dispensa si struttura
DISPENSA N e 20 Novembre 2012
 1 DISPENSA N. 12 15 e 20 Novembre 2012 POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI ed EDUCATIVI E SISTEMA DEI COMUNI ITALIANI Definizione Periodizzazione Differenze fra la riforma sanitaria e quella dei servizi sociali
1 DISPENSA N. 12 15 e 20 Novembre 2012 POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI ed EDUCATIVI E SISTEMA DEI COMUNI ITALIANI Definizione Periodizzazione Differenze fra la riforma sanitaria e quella dei servizi sociali
La riforma dell impresa sociale. Caratteristiche, motivazioni e modelli organizzativi. Il modello cooperativo come Impresa sociale
 La riforma dell impresa sociale. Caratteristiche, motivazioni e modelli organizzativi. Il modello cooperativo come Impresa sociale Alessandro Ficicchia Dottore Commercialista - Componente della Commissione
La riforma dell impresa sociale. Caratteristiche, motivazioni e modelli organizzativi. Il modello cooperativo come Impresa sociale Alessandro Ficicchia Dottore Commercialista - Componente della Commissione
Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.10: LE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI ALLA LUCE DELLA L. 328/2000, 12 e 14 aprile 2011
 DELLA L. 328/2000, 12 e 14 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.10: LE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI ALLA LUCE DELLA L. 328/2000, 12 e 14 aprile 2011 DELLA L. 328/2000, 12
DELLA L. 328/2000, 12 e 14 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.10: LE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI ALLA LUCE DELLA L. 328/2000, 12 e 14 aprile 2011 DELLA L. 328/2000, 12
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO
 COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE (PROVINCIA DI BIELLA ) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.06.2013 2 ART. 1 FONDAMENTO Il presente Regolamento
COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE (PROVINCIA DI BIELLA ) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.06.2013 2 ART. 1 FONDAMENTO Il presente Regolamento
LA LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (LR 328/2000)alla luce della successiva RIFORMA COSTITUZIONALE (LC N. 3/2001)
 1 DISPENSA N.5 25 ottobre 2013 Esercitazione applicativa: LA LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (LR 328/2000)alla luce della successiva RIFORMA COSTITUZIONALE (LC N. 3/2001) 2 Linee guida per lo studio
1 DISPENSA N.5 25 ottobre 2013 Esercitazione applicativa: LA LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI (LR 328/2000)alla luce della successiva RIFORMA COSTITUZIONALE (LC N. 3/2001) 2 Linee guida per lo studio
Maurizio Ampollini. La riforma del Terzo Settore. Caponago, 18 novembre 2017
 Maurizio Ampollini La riforma del Terzo Settore Caponago, 18 novembre 2017 Legge 6 giugno 2016 n. 106 (GU 18 giugno 2016 n.141): Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell impresa sociale
Maurizio Ampollini La riforma del Terzo Settore Caponago, 18 novembre 2017 Legge 6 giugno 2016 n. 106 (GU 18 giugno 2016 n.141): Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell impresa sociale
Costituzione e successivi adempimenti Venerdì 03 Aprile :47
 L art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove (con la
L art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove (con la
IPrincipi dei Probi Pionieri:
 IPrincipi dei Probi Pionieri: 1. adesione volontaria dei soci; 2. libera elezione, da parte di tutti i soci, degli organi direttivi ed amministrativi della società cooperativa; 3. pratica del "ristorno",
IPrincipi dei Probi Pionieri: 1. adesione volontaria dei soci; 2. libera elezione, da parte di tutti i soci, degli organi direttivi ed amministrativi della società cooperativa; 3. pratica del "ristorno",
Progettare i piani di zona: metodologie e strumenti
 Regione Siciliana CORSO FAD CEFPAS Progettare i piani di zona: metodologie e strumenti Modulo 2: La progettazione dei piani di zona Lezione n. 2 I soggetti, le regole ed i luoghi della concertazione I
Regione Siciliana CORSO FAD CEFPAS Progettare i piani di zona: metodologie e strumenti Modulo 2: La progettazione dei piani di zona Lezione n. 2 I soggetti, le regole ed i luoghi della concertazione I
Come creare una società cooperativa Giovedì 01 Dicembre :57
 L art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. Una società
L art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. Una società
Codice del Terzo settore Misure fiscali e sostegno economico
 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA PRIMAVERA DEL NON PROFIT Riforma del terzo settore Codice del Terzo settore Misure fiscali e sostegno economico Patrizia Clementi 31 Marzo 2015 - Auditorium
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA PRIMAVERA DEL NON PROFIT Riforma del terzo settore Codice del Terzo settore Misure fiscali e sostegno economico Patrizia Clementi 31 Marzo 2015 - Auditorium
LE COOPERATIVE. Possiamo classificare le cooperative anche in base alla loro attività così possiamo avere:
 LE COOPERATIVE La cooperativa è una forma di società che ha uno scopo mutualistico, cioè è costituita per arrecare un reciproco vantaggio per i soci Secondo il codice civile (art. 2511) per costituire
LE COOPERATIVE La cooperativa è una forma di società che ha uno scopo mutualistico, cioè è costituita per arrecare un reciproco vantaggio per i soci Secondo il codice civile (art. 2511) per costituire
Profili generali della riforma del Terzo settore. Brescia, 15 novembre 2017 Luca Gori
 Profili generali della riforma del Terzo settore Brescia, 15 novembre 2017 Luca Gori Iter della riforma Attuazione tramite D.M. (generalmente entro il 3 agosto 2018) Consultazione pubblica del Governo
Profili generali della riforma del Terzo settore Brescia, 15 novembre 2017 Luca Gori Iter della riforma Attuazione tramite D.M. (generalmente entro il 3 agosto 2018) Consultazione pubblica del Governo
REPUBBLICA DI SAN MARINO
 REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO, LA COOPERAZIONE E LE POSTE PROGETTO DI LEGGE NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO Articolato Art. 1 Nozione e finalità 1. Le cooperative
REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO, LA COOPERAZIONE E LE POSTE PROGETTO DI LEGGE NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO Articolato Art. 1 Nozione e finalità 1. Le cooperative
ALLEGATO 3) Legge 8 novembre 1991, n 381: "Disciplina delle cooperative sociali"
 ALLEGATO 3) Legge 8 novembre 1991, n 381: "Disciplina delle cooperative sociali" Articolo 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla
ALLEGATO 3) Legge 8 novembre 1991, n 381: "Disciplina delle cooperative sociali" Articolo 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla
Le società cooperative: disciplina normativa e caratteri
 Le società cooperative: disciplina normativa e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Secondo il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per
Le società cooperative: disciplina normativa e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Secondo il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per
Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34
 Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato
Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283)
 LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO n agosto 1991
 LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO n. 266 11 agosto 1991 LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO LR 38/94 Altre leggi di settore Legge 266/91, lo Stato Il Legislatore: Prende atto dell esistenza del Volontariato Riconosce
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO n. 266 11 agosto 1991 LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO LR 38/94 Altre leggi di settore Legge 266/91, lo Stato Il Legislatore: Prende atto dell esistenza del Volontariato Riconosce
Il D.Lgs 50/2016. Il D.Lgs 50/2016. Le Cooperative Sociali e il modello convenzionale pubblico
 Le Cooperative Sociali e il modello convenzionale pubblico 1 L 381/1991 Art. 5 Convenzioni 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in
Le Cooperative Sociali e il modello convenzionale pubblico 1 L 381/1991 Art. 5 Convenzioni 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in
POLITICHE SANITARIE e SISTEMA DELLE ASL / AZIENDE SANITARIE LOCALI
 1 DISPENSA N. 10 5 novembre 2013 POLITICHE SANITARIE e SISTEMA DELLE ASL / AZIENDE SANITARIE LOCALI Le politiche sanitarie Periodizzazione La regolazione della sanità dal 2001 I diversi sistemi di protezione
1 DISPENSA N. 10 5 novembre 2013 POLITICHE SANITARIE e SISTEMA DELLE ASL / AZIENDE SANITARIE LOCALI Le politiche sanitarie Periodizzazione La regolazione della sanità dal 2001 I diversi sistemi di protezione
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA LIANA FANI
 ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA LIANA FANI E quell insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative,
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA LIANA FANI E quell insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative,
INDICE SOMMARIO. Introduzione... Pag.
 INDICE SOMMARIO Introduzione... Pag. V Capitolo Primo EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA, FORME GIURIDICHE E CARATTERI DEFINENTI LE DIVERSE TIPOLOGIE NON PROFIT 1. Definizione, fattori costitutivi e ruolo...
INDICE SOMMARIO Introduzione... Pag. V Capitolo Primo EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA, FORME GIURIDICHE E CARATTERI DEFINENTI LE DIVERSE TIPOLOGIE NON PROFIT 1. Definizione, fattori costitutivi e ruolo...
Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21
 Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" Art
Legge Regionale Puglia 1 settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" Art
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - Progest
 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - Progest Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali Corso: LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA Anno accademico 2007 2008
1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - Progest Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali Corso: LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA Anno accademico 2007 2008
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
 Legge 381/1991 Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali. Art.1. Definizione. 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
Legge 381/1991 Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali. Art.1. Definizione. 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
Dalla Legge 328/2000 ai Piani di Zona: impegno e ruolo del Sindacato
 XXII ed. corso di formazione per quadri UILP e volontari A.D.A. «Diritti di cittadinanza e giustizia sociale per un Sindacato più forte» UILP PUGLIA ADA BARI Montesilvano (PE) 08/09/2016 Silvana Roseto
XXII ed. corso di formazione per quadri UILP e volontari A.D.A. «Diritti di cittadinanza e giustizia sociale per un Sindacato più forte» UILP PUGLIA ADA BARI Montesilvano (PE) 08/09/2016 Silvana Roseto
Paolo Ferrario, Dispensa didattica su: La Mappa/Rete delle istituzioni e analisi sistematica dei soggetti di Terzo settore 7 febbraio 2011
 settore 1/17 Paolo Ferrario, Dispensa didattica su: La Mappa/Rete delle istituzioni e analisi sistematica dei soggetti di Terzo settore 7 febbraio 2011 RIASSUNTO PER PUNTI DEI TEMI TRATTATI NELLE PRECEDENTI
settore 1/17 Paolo Ferrario, Dispensa didattica su: La Mappa/Rete delle istituzioni e analisi sistematica dei soggetti di Terzo settore 7 febbraio 2011 RIASSUNTO PER PUNTI DEI TEMI TRATTATI NELLE PRECEDENTI
STATUTO EDIZIONE 2008/2009
 STATUTO EDIZIONE 2008/2009 6 Lo statuto è la legge della cooperativa e rappresenta una sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi
STATUTO EDIZIONE 2008/2009 6 Lo statuto è la legge della cooperativa e rappresenta una sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi
imprese sociali. La pluralità dei modelli normativi di impresa sociale nella riforma del Terzo settore.
 Dall impresa sociale imprese sociali. alle La pluralità dei modelli normativi di impresa sociale nella riforma del Terzo settore. Luca Gori Scuola Superiore Sant Anna Pisa Trento, 25-26 maggio Le domande
Dall impresa sociale imprese sociali. alle La pluralità dei modelli normativi di impresa sociale nella riforma del Terzo settore. Luca Gori Scuola Superiore Sant Anna Pisa Trento, 25-26 maggio Le domande
- la s.r.l.c.r. può essere solamente costituita da persone fisiche; non è quindi possibile che i soci della s.r.l.c.r. siano persone giuridiche;
 CIRCOLARE N. 010 DEL 31/08/2012 OGGETTO: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO Premessa L' art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese",
CIRCOLARE N. 010 DEL 31/08/2012 OGGETTO: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO Premessa L' art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese",
Associazione i di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, giuridicamente
 CONFCOOPERATIVE Associazione i di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, giuridicamente riconosciuta; Presente in tutte le Regioni e Province italiane; Conta circa 20.000 cooperative, circa 3
CONFCOOPERATIVE Associazione i di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, giuridicamente riconosciuta; Presente in tutte le Regioni e Province italiane; Conta circa 20.000 cooperative, circa 3
CARTA DEI VALORI E DEI SERVIZI DA SEMPRE AL FIANCO DELLE COOPERATIVE E DEI COOPERATORI
 CARTA DEI VALORI E DEI SERVIZI DA SEMPRE AL FIANCO DELLE COOPERATIVE E DEI COOPERATORI Cooperare significa scegliere di operare insieme, unire sforzi, lavoro, prodotti e risparmi nel tentativo di raggiungere
CARTA DEI VALORI E DEI SERVIZI DA SEMPRE AL FIANCO DELLE COOPERATIVE E DEI COOPERATORI Cooperare significa scegliere di operare insieme, unire sforzi, lavoro, prodotti e risparmi nel tentativo di raggiungere
DOSSIER DIDATTICO N. 5, 19 giugno 2008:
 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Progest Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali Corso: LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA7 Anno accademico 27 28 Lezioni
1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Progest Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali Corso: LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA7 Anno accademico 27 28 Lezioni
FORMA GIURIDICA APPROPRIATA
 FORMA GIURIDICA APPROPRIATA Prima di avviare un impresa è necessario individuare la forma giuridica che meglio coincide con le proprie necessità e caratteristiche. Esploriamo le principali forme d impresa.
FORMA GIURIDICA APPROPRIATA Prima di avviare un impresa è necessario individuare la forma giuridica che meglio coincide con le proprie necessità e caratteristiche. Esploriamo le principali forme d impresa.
LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI
 LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Dott. Romano MOSCONI Diretta 19 ottobre 2009 ART. 2511, CODICE CIVILE Articolo 2511 Codice Civile Società cooperative Le cooperative sono società a capitale variabile
LO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Dott. Romano MOSCONI Diretta 19 ottobre 2009 ART. 2511, CODICE CIVILE Articolo 2511 Codice Civile Società cooperative Le cooperative sono società a capitale variabile
SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
 SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEGGERLA, CAPIRLA, APPLICARLA
 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEGGERLA, CAPIRLA, APPLICARLA PARTE GIURIDICA PAOLO DANESI RESTA VIGENTE IL CODICE CIVILE CHE ARTICOLA GLI ENTI NON LUCRATIVI DEL LIBRO PRIMO IN: ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEGGERLA, CAPIRLA, APPLICARLA PARTE GIURIDICA PAOLO DANESI RESTA VIGENTE IL CODICE CIVILE CHE ARTICOLA GLI ENTI NON LUCRATIVI DEL LIBRO PRIMO IN: ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
PERSONE GIURIDICHE e ENTI
 PERSONE GIURIDICHE e ENTI Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone
PERSONE GIURIDICHE e ENTI Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone
PARTE I L INQUADRAMENTO
 INDICE Introduzione XVII PARTE I L INQUADRAMENTO SEZIONE I L inquadramento generale La Riforma del Terzo Settore nella sua evoluzione storica, normativa ed economica (artt. 1-3) 3 1. Introduzione 3 2.
INDICE Introduzione XVII PARTE I L INQUADRAMENTO SEZIONE I L inquadramento generale La Riforma del Terzo Settore nella sua evoluzione storica, normativa ed economica (artt. 1-3) 3 1. Introduzione 3 2.
COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24. Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 1
 LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24 Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 1 Art. 1 2 (Finalità della legge) 1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere
LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24 Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 1 Art. 1 2 (Finalità della legge) 1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere
SOCIALI, EDUCATIVI, SANITARI
 1 DISPENSA N. 4 26 ottobre 2012 Linee guida per la costruzione di una propria documentazione professionale in tema di POLITICHE LEGISLATIVE applicate ai SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, SANITARI PERIODIZZAZIONI
1 DISPENSA N. 4 26 ottobre 2012 Linee guida per la costruzione di una propria documentazione professionale in tema di POLITICHE LEGISLATIVE applicate ai SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, SANITARI PERIODIZZAZIONI
Relazione della I Commissione permanente
 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 30 gennaio 2017) Relatore di maggioranza:
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 30 gennaio 2017) Relatore di maggioranza:
Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano
 569 Indice generale Presentazione... pag. 7 Capitolo I Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 1. Nozione giuridica di società e requisiti del contratto di società...» 9 2.
569 Indice generale Presentazione... pag. 7 Capitolo I Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 1. Nozione giuridica di società e requisiti del contratto di società...» 9 2.
LE DIFFERENTI DECLINAZIONI OPERATIVO - STRUTTURALI : DALLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE STEFANIA AVERNI
 LE DIFFERENTI DECLINAZIONI OPERATIVO - STRUTTURALI : DALLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE STEFANIA AVERNI DOTTORE COMMERCIALISTA MEMBRO DELLA COMMISSIONE ENTI NO PROFIT Roma
LE DIFFERENTI DECLINAZIONI OPERATIVO - STRUTTURALI : DALLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE STEFANIA AVERNI DOTTORE COMMERCIALISTA MEMBRO DELLA COMMISSIONE ENTI NO PROFIT Roma
Il Consultorio Familiare come ente di Terzo Settore. Don Lorenzo Simonelli
 Il Consultorio Familiare come ente di Terzo Settore Don Lorenzo Simonelli 1 classificazione: Ente gestore e attività di Consultorio familiare Enti civili Prestazioni gratuite, senza contributi pubblici
Il Consultorio Familiare come ente di Terzo Settore Don Lorenzo Simonelli 1 classificazione: Ente gestore e attività di Consultorio familiare Enti civili Prestazioni gratuite, senza contributi pubblici
Regione Toscana Consiglio regionale
 Regione Toscana Consiglio regionale Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007. Art. 1 - Principi 1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo
Regione Toscana Consiglio regionale Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007. Art. 1 - Principi 1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo
Le Società Cooperative. di Mario Frascarelli
 Le Società Cooperative di Mario Frascarelli Capitolo 1 - L essenza delle cooperative 1.1 Lo scopo mutualistico... 17 1.2 La mutualità esterna... 23 1.3 I segni distintivi... 24 1.4 La carta dei valori
Le Società Cooperative di Mario Frascarelli Capitolo 1 - L essenza delle cooperative 1.1 Lo scopo mutualistico... 17 1.2 La mutualità esterna... 23 1.3 I segni distintivi... 24 1.4 La carta dei valori
DISPENSA N novembre 2012
 1 DISPENSA N. 11 8 novembre 2012 POLITICHE SANITARIE E SISTEMA DELLA ASL /AZIENDE SANITARIE LOCALI Politiche sociali e politiche dei servizi Le politiche sanitarie Periodizzazione La regolazione della
1 DISPENSA N. 11 8 novembre 2012 POLITICHE SANITARIE E SISTEMA DELLA ASL /AZIENDE SANITARIE LOCALI Politiche sociali e politiche dei servizi Le politiche sanitarie Periodizzazione La regolazione della
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE LIGURIA
 LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20-02-2007 REGIONE LIGURIA NORME PER L ACCOGLIENZA E L INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20-02-2007 REGIONE LIGURIA NORME PER L ACCOGLIENZA E L INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Gallera, Rolfi e D. Maroni. Vita indipendente. PRESENTATO IL 22/07/2014
 REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5679 PROGETTO DI LEGGE N. 0183 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Gallera, Rolfi e D. Maroni Vita indipendente. PRESENTATO IL 22/07/2014 ASSEGNATO
REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5679 PROGETTO DI LEGGE N. 0183 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Gallera, Rolfi e D. Maroni Vita indipendente. PRESENTATO IL 22/07/2014 ASSEGNATO
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 1 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016 a cura di FP CGIL Approvata il 25 maggio 2016 la Legge delega per la Riforma del Terzo Settore che detta i principi fondamentali
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 1 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016 a cura di FP CGIL Approvata il 25 maggio 2016 la Legge delega per la Riforma del Terzo Settore che detta i principi fondamentali
INDICE PREMESSA 1. LA COOPERATIVA SOCIALE
 INDICE PREMESSA... 9 1. LA COOPERATIVA SOCIALE... 11 1. I presupposti legislativi e contrattuali. La L. 381/1991... 11 2. Modalità di costituzione e adempimenti conseguenti... 12 3. L atto costitutivo,
INDICE PREMESSA... 9 1. LA COOPERATIVA SOCIALE... 11 1. I presupposti legislativi e contrattuali. La L. 381/1991... 11 2. Modalità di costituzione e adempimenti conseguenti... 12 3. L atto costitutivo,
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LO STATO DELL ARTE
 1 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LO STATO DELL ARTE Dott. Davide Barberis - commercialista 2 3 D.LGS 117/ obiettivi a breve fornire un perimetro normativo capace di individuare gli enti del Terzo settore
1 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LO STATO DELL ARTE Dott. Davide Barberis - commercialista 2 3 D.LGS 117/ obiettivi a breve fornire un perimetro normativo capace di individuare gli enti del Terzo settore
Riforma del III Settore e sua attuazione. Avv. Luca Degani
 Riforma del III Settore e sua attuazione Avv. Luca Degani Il Consiglio dei Ministri in data 28.06.2017 ha adottato 3 provvedimenti (D. Lgs.) attuativi della delega disposta dalla legge 6 giugno 2016, n.
Riforma del III Settore e sua attuazione Avv. Luca Degani Il Consiglio dei Ministri in data 28.06.2017 ha adottato 3 provvedimenti (D. Lgs.) attuativi della delega disposta dalla legge 6 giugno 2016, n.
Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.
 Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012
 Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell
Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell
Si aggiunga come primo riconoscimento:
 PROPOSTA DI EMENDAMENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO TRATTE DAL DOCUMENTO "RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
PROPOSTA DI EMENDAMENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO TRATTE DAL DOCUMENTO "RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
 ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEFINIZIONE Ai sensi dell art. 2 della legge 7.12.2000, n. 383 si considerano associazioni di promozione sociale: - le associazioni riconosciute, - le associazioni non
ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEFINIZIONE Ai sensi dell art. 2 della legge 7.12.2000, n. 383 si considerano associazioni di promozione sociale: - le associazioni riconosciute, - le associazioni non
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D13/2010
 Comune di Ravenna Area: POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI Servizio Proponente: U.O. PIANIFICAZIONE SOCIO SANITARIA Dirigente Responsabile: DOTT.SSA NOEMIA PIOLANTI Cod. punto
Comune di Ravenna Area: POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI, SPORT E RAPPORTI INTERNAZIONALI Servizio Proponente: U.O. PIANIFICAZIONE SOCIO SANITARIA Dirigente Responsabile: DOTT.SSA NOEMIA PIOLANTI Cod. punto
12. CHE FINALITA HA LA LEGGE 6 /2004?
 1. A NORMA DI QUANTO DISPONE L'ART. 4 DELLA LEGGE N. 328/2000, A CHI COMPETE, IN MERITO AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI, LA SPESA PER LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI? 1)
1. A NORMA DI QUANTO DISPONE L'ART. 4 DELLA LEGGE N. 328/2000, A CHI COMPETE, IN MERITO AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI, LA SPESA PER LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI? 1)
Il cantiere aperto dell articolata Riforma del Terzo Settore
 Il cantiere aperto dell articolata Riforma del Terzo Settore Martinengo - 25 Novembre 2017 Roberto Russo Università ecampus Il "meccanismo" in sintesi La Legge di delega Decreti legislativi delegati Decreti
Il cantiere aperto dell articolata Riforma del Terzo Settore Martinengo - 25 Novembre 2017 Roberto Russo Università ecampus Il "meccanismo" in sintesi La Legge di delega Decreti legislativi delegati Decreti
Lezione Strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale periferico a.a. 2012/13
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere e Filosofia Lezione Strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale periferico a.a. 2012/13 Prof.ssa Claudia M. Golinelli Categorie
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Lettere e Filosofia Lezione Strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale periferico a.a. 2012/13 Prof.ssa Claudia M. Golinelli Categorie
SOMMARIO. Prefazione... Nota sull autore...
 Sommario SOMMARIO Prefazione... Nota sull autore... XI XV Capitolo 1 - Principi generali e aspetti societari 1. Premessa... 1 1.1 Cooperative di utenza... 1 1.2 Cooperative di lavoro... 1 1.3 Tipologia
Sommario SOMMARIO Prefazione... Nota sull autore... XI XV Capitolo 1 - Principi generali e aspetti societari 1. Premessa... 1 1.1 Cooperative di utenza... 1 1.2 Cooperative di lavoro... 1 1.3 Tipologia
Il Codice del Terzo settore
 STUDIO FERRERI - DOTTORI COMMERCIALISTI Il Codice del Terzo settore Roma, 17 ottobre 2017 Pagina 1 di 27 La riforma del Terzo settore Normativa di riferimento Legge 6 giugno 2016, n. 106 - delega al governo
STUDIO FERRERI - DOTTORI COMMERCIALISTI Il Codice del Terzo settore Roma, 17 ottobre 2017 Pagina 1 di 27 La riforma del Terzo settore Normativa di riferimento Legge 6 giugno 2016, n. 106 - delega al governo
SINTESI DELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di DANIELE CURRI responsabile dipartimento fiscale di Unpli Piemonte.
 SINTESI DELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di DANIELE CURRI responsabile dipartimento fiscale di Unpli Piemonte. È stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, la legge delega
SINTESI DELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di DANIELE CURRI responsabile dipartimento fiscale di Unpli Piemonte. È stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, la legge delega
Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
 Allegato alla Delib.G.R. n. 58/4 del 27.11.2015 Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA per l erogazione
Allegato alla Delib.G.R. n. 58/4 del 27.11.2015 Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA per l erogazione
LINEE GUIDA PER L IMPLEMENTAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DEI SERVIZI SOCIALI NELL AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
 LINEE GUIDA PER L IMPLEMENTAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DEI SERVIZI SOCIALI NELL AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE PREMESSA La Regione Lombardia ha definito tra gli obiettivi
LINEE GUIDA PER L IMPLEMENTAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DEI SERVIZI SOCIALI NELL AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE PREMESSA La Regione Lombardia ha definito tra gli obiettivi
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B
 XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 20 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2595) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 maggio 2005
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 20 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2595) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 maggio 2005
ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali /
 La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel Tutti i venerdì dal 25 settembre al 29 gennaio 2016 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 /
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel Tutti i venerdì dal 25 settembre al 29 gennaio 2016 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 /
LABORATORIO PERMANENTE DELLA FORMAZIONE PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
 PROTEZIONE CIVILE LABORATORIO PERMANENTE DELLA FORMAZIONE PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Marzo 2005 Febbraio 2006 UNITA FORMAZIONE,
PROTEZIONE CIVILE LABORATORIO PERMANENTE DELLA FORMAZIONE PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Marzo 2005 Febbraio 2006 UNITA FORMAZIONE,
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO
 Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (BUR n. 69/2017) INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto,
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (BUR n. 69/2017) INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto,
C O M U N E D I C A O R L E Provincia di Venezia
 C O M U N E D I C A O R L E Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEL VOLONTARIATO E DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale
C O M U N E D I C A O R L E Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEL VOLONTARIATO E DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale
PROTOCOLLO D INTESA. Tra
 Provincia autonoma di Trento Assessorato alla salute e politiche sociali PROTOCOLLO D INTESA Tra l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), con sede legale a Roma
Provincia autonoma di Trento Assessorato alla salute e politiche sociali PROTOCOLLO D INTESA Tra l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), con sede legale a Roma
Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)
 LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U.R. 20 novembre 2008, n. 108 ) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U.R. 20 novembre 2008, n. 108 ) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro
SOMMARIO CAPITOLO 1 Il diritto alla salute CAPITOLO 2 Il Servizio Sanitario Nazionale e i Servizi Sanitari Regionali
 SOMMARIO CAPITOLO 1 Il diritto alla salute 1. Il diritto alla salute nella Costituzione 2. Il diritto ad essere curati 2.1. La legge istitutiva del Servizio Sanitario nazionale (legge 23.12.1978, n. 833)
SOMMARIO CAPITOLO 1 Il diritto alla salute 1. Il diritto alla salute nella Costituzione 2. Il diritto ad essere curati 2.1. La legge istitutiva del Servizio Sanitario nazionale (legge 23.12.1978, n. 833)
ACCORDO INTERCONFEDERALE. tra. A.N.Fo.P. Associazione Nazionale Formatori Professionisti;
 Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei lavoratori e dei collaboratori delle piccole e medie imprese denominato FondoForma ACCORDO INTERCONFEDERALE tra UNFI Unione Nazionale
Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei lavoratori e dei collaboratori delle piccole e medie imprese denominato FondoForma ACCORDO INTERCONFEDERALE tra UNFI Unione Nazionale
LE COOPERATIVE I PROBI PIONIERI DI ROCHDALE 1844
 LE COOPERATIVE I PROBI PIONIERI DI ROCHDALE 1844 LE COOPERATIVE PRINCIPI FONDAMENTALI ART 45 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
LE COOPERATIVE I PROBI PIONIERI DI ROCHDALE 1844 LE COOPERATIVE PRINCIPI FONDAMENTALI ART 45 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40
 Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale B. U. REGIONE BASILICATA N. 51bis del 16 novembre 2009 Testo aggiornato e coordinato con la L.R. 4 agosto 2011,
Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale B. U. REGIONE BASILICATA N. 51bis del 16 novembre 2009 Testo aggiornato e coordinato con la L.R. 4 agosto 2011,
COSA CAMBIA PER AIdel22?
 La Riforma del Terzo Settore, che direttamente investe la struttura di AIdel22, diventata a partire dall Assemblea dei Soci seguita al convegno Ente del Terzo Settore. dott.ssa Raffaella Cungi, avvocato
La Riforma del Terzo Settore, che direttamente investe la struttura di AIdel22, diventata a partire dall Assemblea dei Soci seguita al convegno Ente del Terzo Settore. dott.ssa Raffaella Cungi, avvocato
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLE IMPRESE COOPERATIVE.
 ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLE IMPRESE COOPERATIVE. 6 giugno 2001 A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLE IMPRESE COOPERATIVE. 6 giugno 2001 A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e
Stato dei lavori del nuovo sistema di autorizzazione/accreditamento. 13 aprile 2018
 Stato dei lavori del nuovo sistema di autorizzazione/accreditamento 13 aprile 2018 1 Il nuovo Sistema provinciale di qualità dei servizi socio-assistenziali 2 . La l.p. 13/2007 promuove il miglioramento
Stato dei lavori del nuovo sistema di autorizzazione/accreditamento 13 aprile 2018 1 Il nuovo Sistema provinciale di qualità dei servizi socio-assistenziali 2 . La l.p. 13/2007 promuove il miglioramento
dott.ssa Valeria Albertini dott.ssa Elisabetta Ambrogetti
 INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI La Riforma del terzo settore dott.ssa Valeria Albertini dott.ssa Elisabetta Ambrogetti Borgo Valsugana, 23/02/2018 Il Percorso Legge delega 106/2016 Sulla base di tale legge
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI La Riforma del terzo settore dott.ssa Valeria Albertini dott.ssa Elisabetta Ambrogetti Borgo Valsugana, 23/02/2018 Il Percorso Legge delega 106/2016 Sulla base di tale legge
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
 L.R. 21 marzo 2007, n. 12. Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza (B.U. 28 marzo 2007, n. 7) Art. 1. (Principi) 1. La Regione
L.R. 21 marzo 2007, n. 12. Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza (B.U. 28 marzo 2007, n. 7) Art. 1. (Principi) 1. La Regione
INDICE-SOMMARIO STEFANIA PEDRABISSI FONTI LEGISLATIVE E RIPARTIZIONE DI COMPETENZE
 INDICE-SOMMARIO Prefazione di Cesare Miriello... pag. XIII Introduzione di Carlo Bottari...» XVII STEFANIA PEDRABISSI FONTI LEGISLATIVE E RIPARTIZIONE DI COMPETENZE 1. Premessa... pag. 1 1.1. Il diritto
INDICE-SOMMARIO Prefazione di Cesare Miriello... pag. XIII Introduzione di Carlo Bottari...» XVII STEFANIA PEDRABISSI FONTI LEGISLATIVE E RIPARTIZIONE DI COMPETENZE 1. Premessa... pag. 1 1.1. Il diritto
Q u a l e f o r m a g i u r i d i c a p e r l a n u o v a i m p r e s a?
 Impresa individuale Società di persone Società di capitali 1 IMPRESA INDIVIDUALE Normativa di riferimento: Artt. 2082, 2195, 2196 c.c Per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti
Impresa individuale Società di persone Società di capitali 1 IMPRESA INDIVIDUALE Normativa di riferimento: Artt. 2082, 2195, 2196 c.c Per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti
