4 Le relazioni grammaticali
|
|
|
- Silvana Rubino
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Le relazioni grammaticali (1) Le relazioni grammaticali: insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (soggetto, oggetto, oggetto indiretto) rispetto al verbo della frase. Tali elementi, che vanno sotto il nome di argomenti verbali, possono essere: A = soggetto (ovvero, uno dei due argomenti, corrispondente tipicamente all entità che compie l azione) di un verbo transitivo O (o, in alcune notazioni, P) = oggetto (ovvero, l altro argomento, corrispondente tipicamente all entità che subisce l azione) di un verbo transitivo S = soggetto (ovvero, l unico argomento) di un verbo intransitivo (2) I criteri tradizionali per distinguere le relazioni grammaticali (Comrie 1983: 151-4; Dixon 1994: 8-11: Croft 2001: 148-9): Elementi che sono trattati allo stesso modo dal punto di vista grammaticale (ad esempio, elementi che prendono la stessa marca di caso, determinano o meno l accordo verbale, possono o meno essere omessi nelle frasi coordinate, si trovano nella stessa posizione all interno della frase) sono coinvolti nella stessa relazione grammaticale (tabella 1). Questi criterio, però, non consente di definire gli stessi insiemi di elementi (ovvero, gli stessi rggruppamenti di A, S, ed O) da una lingua all altra, e da un contesto all altro nell ambito della stessa lingua ((3)-(8)). A+S: marche di caso in inglese (3) (a) She lei-nom slept dormiva (Lei) dormiva (b) *Her slept lei-acc dormiva (Lei dormiva (c) She saw lei-nom ho.visto Lei l ha vista her lei-acc A+S: marche di caso in latino (4) (a) Poet-a poeta-nom ven-it venire-3sg Il poeta viene 1
2 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Frasi intransitive (S) Codifica Accordo verbale: I gatti dormono Posizione preverbale: Il gatto dorme/ *Dorme il gatto Distribuzione: Omissione con i verbi non finiti: Ha consigliato allo studente i di ø i andare all estero Omissione con l imperativo: ø i Vai via! Omissione nelle costruzioni cordinate: La ragazza i è uscita ed ø i è andata in dipartimento Frasi transitive (A) I gatti non mangiano la verdura Il gatto mangia il pesce Ha consigliato allo studente i di ø i leggere questo libro *Ha comprato la casa j per rivendere ø j ø i Mangia la minestra! La ragazza i è uscita e ø i ha comprato un libro *Ha sfogliato il libro j e ha comprato ø j Tabella 1: Criteri per identificare la categoria di soggetto (A+S) in italiano (adattato da Croft 2001: 148) (b) Puell-a poet-am Fanciulla-NOM poeta-acc La fanciulla ascolta il poeta aud-it ascoltare-3sg (5) A+S: il passivo: (a) Il gatto mangia il pesce (b) Il pesce è mangiato dal gatto (c) * Il gatto è mangiato dal pesce (d) Il gatto dorme (e) Il gatto è dormito 2
3 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Lingue ergative: Yuwalaraay (australiano) (6) (a) duyu-gu serpente-erg nama quello dayn-ø uomo-ass yi-i mordere-nonfut Il serpente [A] ha morso l uomo [O] (b) wa:l NEG nama quello yinar-ø donna-ass banaga-ni correre-nonfut La donna non ha corso (Croft 2003: 144) Lingue ergative: Dyirbal (australiano) (7) (a) nguma-ø padre myianda-nyu ridere-nonfut Il padre [S] ha riso (b) nguma-ø padre-ass yabu-nggu madre-erg bura-n vedere-nonfut La madre [A] ha visto il padre [O] (Dixon 1994: 160-1) Lingue attive: Lakhota (amerindiano; USA) (8) (a) ó-ma-ya-kiye LOC-1PAT-2AG-aiutare Tu [A] hai aiutato me [O] (b) wa-pu 1AG-venire Io [S] sto venendo (b) ma-khuže 1PAT-malato Io [S] sono malato (Croft 2001: 162) A O S Tabella 2: Lingue nominative (adattato da Dixon 1994: 72) (9) Le relazioni grammaticali in prospettiva interlinguistica: i criteri di definizione di relazioni grammaticali di soggetto e oggetto forniscono risultati contrastanti se applicati da una lingua all altra, ovvero gli stessi criteri, in diverse lingue, identificano diversi raggruppamenti dei tre argomenti A, O ed S 3
4 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a A O S Tabella 3: Lingue ergative (adattato da Dixon 1994: 72) A O S (AG) S (PAT) Tabella 4: Lingue attive (adattato da Dixon 1994: 72) Si può allora parlare di relazioni grammaticali (soggetto, oggetto) universali, ovvero si può dire che tutte le lingue hanno un soggetto e un oggetto, e se sì, come definire queste relazioni? Oppure si deve dire che le relazioni grammaticali non sono universali, ma specifiche di singole lingue? Nel caso in cui si concluda che le relazioni grammaticali non sono universali, esistono dei principi universali cui tutte le lingue si conformano nel codificare i tre argomenti A, O ed S? (10) La distribuzione interlinguistica delle relazioni grammaticali (Comrie 1983: cap. 5, Dixon 1994): Singole lingue non presentano un solo sistema di organizzazione di A, O ed S (ad esempio, nominativo o ergativo), ma il sistema di organizzazione varia a seconda della costruzione che viene presa in considerazione (cosiddetti fenomeni di scissione). Ad esempio, ci sono lingue in cui le marche di caso funzionano in maniera ergativa per i nomi, nominativa per i pronomi di 1 e 2 persona, e tripartita per i pronomi di terza persona (tabelle (5) e (6)). Talvolta i sistemi di caso funzionano in maniera ergativa al perfetto, ma nominativa al presente ((11)). In alcune lingue il sistema di caso funziona in maniera ergativa, ma la possibilit a di omettere argomenti in frasi coordinate funziona in maniera nominativa ((12)). Di conseguenza, anche nell ambito di singole lingue, le relazioni grammaticali non possono essere definite indipendentemente dalle singole costruzioni in cui occorrono. Sistemi di caso nominativi al presente ed ergativi al perfetto: georgiano (caucasico; Geogia) 4
5 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a A ø -nggu -Ngu -nggu S ø ø ø ø O -na ø ø ø pronomi di 1 e 2 persona pronomi di 3 persona nomi propri nomi comuni Tabella 5: Organizzazione degli argomenti verbali in dyirbal (australiano) (Dixon 1994: 86) A ø habũ nasalizzazione S ø habu ø O -a haa ø pronomi di 1 e 2 persona pronomi di 3 persona nomi propri, nomi comuni Tabella 6: Organizzazione degli argomenti verbali in cashinawa (amerindiano, Peru) (Dixon 1994: 86) (11) (a) Student-i midis studente-caso va Lo studente va (b) Student-i ceril-s studente-caso lettera-caso Lo studente scrive la lettera (c) Student-i mivida studente-caso andò Lo studente andò (d) Student-ma ceril-i studente-caso lettera-caso Lo studente scrisse la lettera cers scrive dacera scrisse Ergatività morfologica e accusatività sintattica: tongano (austronesiano; Tonga) (12) (a) na e PAST lea parlare a ASS etalavou giovane Il giovane ha parlato (b) na e PAST ma u ricevere e ERG siale Charlie Charlie ha ricevuto il regalo a ASS e DEF me a ofa regalo 5
6 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a (c) oku PRES lava possibile a ASS mele Mary o TMP Mary può ø [S] entrare in casa sua hū entrare ki in hono sua (d) * oku PRES lava possibile a ASS e DEF fefine donna o TMP taa i colpire e ERG Charlie può colpire la donna ø [O] (Croft 2001: 150) fale casa siale Charlie Ergatività sintattica: dyirbal (australiano) (13) (a) nguma padre:ass banaga-ngu tornare-nonfut yabu-nggu madre-erg bura-n vedere-nonfut Il padre i [S] è tornato e la madre [A] ha visto ø i [O] (b) nguma padre:ass abu-nggu madre-erg bura-n vedere-nonfut banaga-ngu tornare-nonfut La madre [A] ha visto il padre [O] ed ø i [S] è tornato (Dixon 1994: 12) (14) Le lingue del mondo raggruppano gli argomenti verbali in maniera diversa a seconda delle varie costruzioni. Tuttavia i sistemi di raggruppamento degli argomenti verbali nelle lingue del mondo manifestano delle caratteristiche ricorrenti (Comrie 1983: cap. 5, cap. 6, Dixon 1994: cap. 5): I fenomeni di scissione avvengono normalmente sempre secondo le stesse modalità (ad esempio quelle illustrate nelle tabelle 5 e 6 e in (11)-(12)) da una lingua all altra. Indipendentemente dal sistema di raggruppamento degli argomenti verbali usato nelle singole lingue, A ed O sono sempre espressi in modo distinto (Comrie 1983: 176-7). Nelle lingue a morfologia ergativa, l assolutivo (S + O) è non marcato rispetto all ergativo (A); nelle lingue a morfologia nominativa, il nominativo (A+S) è non marcato rispetto all accusativo (O). (15) Alcune possibili spiegazioni per i fenomeni in (14) ((Dixon 1979 e 1994, Comrie 1978 and 1989, Du Bois 1985, Song 2001)): A e O sono indicati diversamente perchè cooccorrono nelle frasi transitive, e devono essere distinti; S è indicato o come A o come O, e non è normalmente indicato da morfemi espliciti, perchè occorre isolatamente, e quindi non deve essere distinto da altri argomenti. Esistono dei criteri che conducono i parlanti ad associare diversi tipi di argomenti, ad esempio A ed S (sistemi nominaativi), perchè sono argomenti topicali, S ed O (sistemi ergativi), perchè sono gli argomenti corrispondenti all informazione nuova, O e gli argomenti S dei verbi intransitivi meno agentivi (sistemi attivi), perchè si tratta di argomenti meno agentivi 6
7 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Ma i morfemi usati per indicare A, S, ed O tipicamente derivano da processi diacronici di reinterpretazione di morfemi preesistenti. Ad esempio: I morfemi di accusativo possono avere origine da verbi che significano prendere in costruzioni del tipo Prendere X e Verbo Transitivo (X), in cui il verbo prendere descrive un evento preliminare ed accessorio rispetto all evento descritto dall altro verbo ( Prendere X e Verbo Transitivo X > ACC X Verbo Transitivo : (16)), oppure dai morfemi usati per il possessore in costruzioni nominalizzate del tipo X è occupato con il fare di Y, che vengono rianalizzate come X sta facendo ACC Y ((17)). I morfemi di ergativo possono avere origine dai morfemi usati per indicare l agente in costruzioni passive che vengono renterpretate come attive ( X è fatto da Y > Y ERG fa Y : (18)-(19)), dai morfemi usati per il possessore in costruzioni nominalizzate ( Ad X sarà il fare di Y > X ERG farà Y : (20)), o da morfemi direzionali usati su un agente per indicare un movimento di tale agente in direzione del parlante o dell interlocutore ( X DIR mi segue > X ERG mi segue : (21)). Il fatto che O e gli argomenti S dei verbi intransitivi meno agentivi siano indicati allo stesso modo può avere origine dal fatto che la costruzione intransitiva è il risultato di una rianalisi di una corrispondente costruzione attiva con un agente di terza persona non espresso ( (Questo) mi brucia > Sono bruciato : (22)). Quindi si pu o ipotizzare che ciò che spiega il modo in cui A, S, ed O sono indicati (ovvero, l esistenza di sistemi nomnativi, ergativi ed attivi) sono in realtà questi processi di reinterpretazione, piuttosto che la necessità di distinguere certi argomenti da altri, o il fatto che i parlanti associno certi tipi di argomenti. Twi (nigero-congolese; Ghana) (16) (a) a de kannea ni ahuhuru ma asase aivu sole OBJ luce e calore dare terra Il sole dà luce e calore alla terra (Lord 1993: 66) (b) o-de lui-obj afoa spada ce mettere boha-m fodero-dentro Mise la spada nel fodero (Lord 1993: 66) (c) OkOm fame de prendere me me La fame mi prende (Lord 1993: 70) [da una descrizione più antica della lingua] Wayana (caribico; Suriname) 7
8 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a (17) 1-pakoro-n 1-casa-POSS iri-ø fare-nomlz p@k occupato.con wai 1.essere Mi sto costruendo la casa (let. sono occupato con la costruzione della mia casa ) (Gildea 1998: 201) Hindi (indo-europeo; India) (18) laṙk-e=ne ragazzo-obl-erg bacch-e=ko bambino-obl-acc mār-a colpire-perf.m.sg hai be.aux Il ragazzo ha colpito il bambino (Verbeke and De Cuypere 2009: 5) Sanscrito (indoeuropeo; India) (19) devadatt-ena Devadatta-INSTR kaṫa-ḣ tappeto-nom kṙ-taḣ fare-nom.past.ptcpl Il tappeto è fartto da Devadatta (Verbeke and De Cuypere 2009: 3) Carinã (caribico; Venezuela) (20) (a) 1-woona-r1-ma 1-coltivare-NOMLZ-3.essere Io coltiverò (Gildea 1998: 169) (b) 1-aaro-r1-ma 1-prendere-NOMLZ-3.essere (Qualcuno) mi prenderà (Gildea 1998: 169) (c) a-eena-r1-ma 1- wa 2-avere-NOMLZ-3.essere 1-DAT Io ti avrò (let. A me sarà il tuo avere (Gildea 1998: 170) Nez Perce (penutiano; USA) (21) (a) áw ora i-q inum-1m-a 3NOM-guardare-CSL-PAST w inš uomo Ora l uomo guardò da questa parte (Rude 1991: 41) (b) áw-naš ora-1sg i-q inun-a 3NOM-guardare-PAST w inš-n1m uomo-erg Ora l uomo guardò me (Rude 1991: 41) (c) áw-naš x ora-1sg w1saat-n1m i-twána-m-aš vecchio-erg 3NOM-seguire-CSL-IMPFV Ora il vecchio mi sta seguendo (Rude 1991: 41) Galela (austronesiano; Indonesia) 8
9 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a (22) (a) ni-kiolo 2SG-addormentato Tu sei addormentato (galela moderno: (Holton 2008: 261)) (b) wo-ni-doto 3M.SG-2SG-insegnare Lui ti insegna (galela moderno: (Holton 2008: 261)) (c) i-mi-tosa 3SG.NONHUM-3F.SG-arrabbiato Lei è arrabbiata (galela del XIX secolo: (Holton 2008: 272)) (d) mi-pereki 3F.SG-old Lei è vecchia (galela del XIX ecolo: (Holton 2008: 272)) Letture: Comrie 1983: cap. 5 e 6, Croft 1990: , Croft 2003: , , , Bickel 2011 Abbreviazioni ACC accusativo NOM nominativo NOMLZ nominalizzazione AG agente ASS assolutivo AUX ausiliare CSL cislocativo DAT dativo DEF definito ERG ergativo F femminile IMPFV imperfettivo INSTR strumentale LOC locativo M maschile NONFUT non futuro NONHUM non umano OBJ oggetto OBL obliquo PAST passato PAT paziente PERF perfetto POSS possessore PRES presente PTCPL participio SG singolare NEG negazione TMP tempo 9
10 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a Riferimenti bibliografici Bickel, B. (2011). Grammatical Relations Typology. In J. J. Song (Ed.), Handbook of Linguistic Typology, pp Oxford: Oxford University Press. Comrie, B. (1978). Ergativity. In W. P. Lehmann (Ed.), Syntactic typology, pp Austin: University of Texas Press. Comrie, B. (1983). Universali del linguaggio e tipologia linguistica. Bologna: Il Mulino. Comrie, B. (1989). Language universals and linguistic typology. 2nd edition. Oxford: Basil Blackwell. Croft, W. (1990). Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press. Croft, W. (2001). Radical Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press. Croft, W. (2003). Typology and universals. 2nd edition. Cambridge: University Press. Dixon, R. M. W. (1979). Ergativity. Language 55, Dixon, R. M. W. (1994). Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge Du Bois, J. A. (1985). Competing motivations. In J. Haiman (Ed.), Iconicity in syntax, pp Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. Gildea, S. (1998). On reconstructing grammar : Comparative Cariban morphosyntax. Oxford: Oxford University Press. Holton, G. (2008). The rise and fall of semantic alignment in Northern Halmahera, Indonesia. In M. Donohue and S. Wichmann (Eds.), The typology of semantic alignment, pp Oxford: Oxford University Press. Lord, C. (1993). Historical change in serial verb constructions. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. Rude, N. (1991). On the Origin of the Nez Perce Ergative NP Suffix. International Journal of American Linguistics 57, Song, J. J. (2001). Linguistic typology: morphology and syntax. Harlow, Essex: Longman. Verbeke, S. and L. De Cuypere (2009). The rise of ergativity in Hindi: Assessing the role of grammaticalization. Folia Linguistica Historica 30,
4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle relazioni grammaticali:
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 4 Le relazioni grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle relazioni grammaticali:
4 Le categorie grammaticali: criteri di definizione e problemi
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 4 Le categorie grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle categorie (o relazioni)
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 4 Le categorie grammaticali: criteri di definizione e problemi 4.1 Introduzione (1) La classificazione tradizionale delle categorie (o relazioni)
4 Le relazioni grammaticali
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 4 Le relazioni grammaticali (1) Le relazioni grammaticali: categorie, o insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (ad esempio,
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 4 Le relazioni grammaticali (1) Le relazioni grammaticali: categorie, o insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (ad esempio,
4 Le relazioni grammaticali
 4 Le relazioni grammaticali Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2015-16 (1) Le relazioni grammaticali: categorie, o insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (ad esempio,
4 Le relazioni grammaticali Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2015-16 (1) Le relazioni grammaticali: categorie, o insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (ad esempio,
4 Le relazioni grammaticali
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2010-11 1 4 Le relazioni grammaticali 4.1 Introduzione (1) Le relazioni grammaticali: insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (soggetto,
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2010-11 1 4 Le relazioni grammaticali 4.1 Introduzione (1) Le relazioni grammaticali: insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (soggetto,
6 Le relazioni grammaticali
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 6 Le relazioni grammaticali (1) Relazioni grammaticali: classe di elementi che si trovano tutti nella stessa relazione rispetto al verbo della frase e alla
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 6 Le relazioni grammaticali (1) Relazioni grammaticali: classe di elementi che si trovano tutti nella stessa relazione rispetto al verbo della frase e alla
Un ulteriore fenomeno (che non si vede in (2), ma cfr. (5)):
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2011-12 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
4 Le relazioni grammaticali
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 4 Le relazioni grammaticali (1) Le relazioni grammaticali: insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (soggetto, oggetto, oggetto
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 4 Le relazioni grammaticali (1) Le relazioni grammaticali: insiemi di elementi che si trovano tutti nello stesso rapporto (soggetto, oggetto, oggetto
nerede? dove? Dove sono le mie due valigie? (Moravcsik 2006: xii) (b) Iki due
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2012-13 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 11 (solo per quanto riguarda gli
nerede? dove? Dove sono le mie due valigie? (Moravcsik 2006: xii) (b) Iki due valigia-mia? Dove sono le mie due valigie? (Moravcsik 2006: xii)
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda gli
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda gli
2 Sintassi. Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
5 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 5 Motivazioni funzionali [Materiale di riferimento per questa parte: Croft 1990: capp. 3 (traduzione italiana in Cristofaro and Ramat 1999: cap.1) e 4; Cristofaro
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota generale: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica Generale A - a.a 2016-17 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo
(2) Perchè non ordini un pesce verde e un insalata alla piastra? (Manuel Vasquez Montalban, I mari del sud, Feltrinelli 1994, 161)
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 2 Sintassi [Manuali di riferimento per questa parte: Matthews 1981 o, in traduzione italiana, Matthews 1982: capp. 1, 4, 6, 11 (solo per quanto riguarda
5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2014-15 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio
 1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
1 Introduzione: Perché lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2013-14 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a 2013-14 1 5 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi
(1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile identificare nella lingua, e sulla base di quali fenomeni.
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è Tolai (austronesia; Papua Nuova Guinea) (2) (a) A tutana uomo i
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2015-16 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è Tolai (austronesia; Papua Nuova Guinea) (2) (a) A tutana uomo i
persona categorie del verbo (6) carattere non pro-drop (6) carattere non pro-drop lingue slave 09/05/2017
 categorie del verbo persona persona tempo aspetto modo diatesi (io) (tu) (egli) (noi) (voi) (essi) italiano scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scrivono (6) carattere non pro-drop (6) carattere non
categorie del verbo persona persona tempo aspetto modo diatesi (io) (tu) (egli) (noi) (voi) (essi) italiano scrivo scrivi scrive scriviamo scrivete scrivono (6) carattere non pro-drop (6) carattere non
1 Introduzione: la comparazione interlinguistica
 1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio tipologico-funzionalista allo studio del linguaggio,
1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio tipologico-funzionalista allo studio del linguaggio,
1 Introduzione: Perchè lo studio del linguaggio
 1 Introduzione: Perchè lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
1 Introduzione: Perchè lo studio del linguaggio Nota: Questi primi materiali hanno carattere orientativo, e i testi indicati nella sezione Riferimenti bibliografici non sono pertanto strettamente necessari
2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2015-16 1 2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso Manuali di riferimento per questa parte: Blake 2001: cap. 6 (con particolare riferimento
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2015-16 1 2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso Manuali di riferimento per questa parte: Blake 2001: cap. 6 (con particolare riferimento
Esercizi - 1. Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2016-17 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile identificare nella lingua, e
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2016-17 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile identificare nella lingua, e
6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica
 6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi (nonchè avverbi, adposizioni ecc.) (2) I criteri tradizionali
6 Le parti del discorso: una prospettiva interlinguistica (1) La classificazione tradizionale delle parti del discorso: nomi, verbi, aggettivi (nonchè avverbi, adposizioni ecc.) (2) I criteri tradizionali
2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2016-17 1 2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso Manuali di riferimento per questa parte: Blake 2001: cap. 6 (con particolare riferimento
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2016-17 1 2 Lo sviluppo delle categorie grammaticali: adposizioni e marche di caso Manuali di riferimento per questa parte: Blake 2001: cap. 6 (con particolare riferimento
1 La comparazione interlinguistica
 1 La comparazione interlinguistica Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2011-12 Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio tipologico-funzionalista
1 La comparazione interlinguistica Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2011-12 Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio tipologico-funzionalista
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile Taba (austronesiano; Indonesia)
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2018-19 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile Taba (austronesiano; Indonesia)
Lingue e linguaggio a.a. 2013/14
 Corso di laurea magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze linguistiche Semiotica Lingue e linguaggio a.a. 2013/14 Prof. Nicola Grandi nicola.grandi@unibo.it www.grandionline.net/nicola/lingue_e_linguaggio
Corso di laurea magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze linguistiche Semiotica Lingue e linguaggio a.a. 2013/14 Prof. Nicola Grandi nicola.grandi@unibo.it www.grandionline.net/nicola/lingue_e_linguaggio
3 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente e motivata
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente e motivata
Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s)
 Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s) Il mutamento linguistico (Modulo I: 18 ore) Mutamento morfologico: aspetti della grammaticalizzazione (Modulo II: 36 ore) Programma 2010/2011 I. All interno
Prof.ssa Paola Cotticelli Linguistica Storica (s) Il mutamento linguistico (Modulo I: 18 ore) Mutamento morfologico: aspetti della grammaticalizzazione (Modulo II: 36 ore) Programma 2010/2011 I. All interno
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2016-17 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile Taba (austronesia; Indonesia)
Sonia Cristofaro - Glottologia A/ Linguistica generale A - a.a 2016-17 1 Esercizi - 1 (1) Osservando le frasi in (2), si individui quali relazioni grammaticali è possibile Taba (austronesia; Indonesia)
1 Introduzione: l analisi del linguaggio
 1 Introduzione: l analisi del linguaggio Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2011-12 Obiettivi: Il corso e volto a illustrare le modalità e i principi generali che governano l organizzazione grammaticale
1 Introduzione: l analisi del linguaggio Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2011-12 Obiettivi: Il corso e volto a illustrare le modalità e i principi generali che governano l organizzazione grammaticale
Tipi di verbo. Marco Svolacchia
 Tipi di verbo Marco Svolacchia In questa sezione si mostra come la categoria di intransitività sia insufficiente a rendere conto dei fenomeni che riguardano i verbi non transitivi e che è necessario distinguere
Tipi di verbo Marco Svolacchia In questa sezione si mostra come la categoria di intransitività sia insufficiente a rendere conto dei fenomeni che riguardano i verbi non transitivi e che è necessario distinguere
(1) Si identifichino i costituenti all interno delle frasi che seguono, motivando la risposta:
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 Esercizi - 1 (1) Si identifichino i costituenti all interno delle frasi che seguono, motivando la risposta: (a) Abbiamo deciso di dipingere la sala da pranzo
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2009-10 1 Esercizi - 1 (1) Si identifichino i costituenti all interno delle frasi che seguono, motivando la risposta: (a) Abbiamo deciso di dipingere la sala da pranzo
3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto (1) Alcuni tipi di nozioni di tempo e aspetto (Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: 125-;
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2007-8 1 3 L origine delle categorie grammaticali: ancora tempo e aspetto (1) Alcuni tipi di nozioni di tempo e aspetto (Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: 125-;
2 Universali linguistici
 2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra che, pur nella loro diversità strutturale, (molte di) tali lingue hanno delle proprierà in comune.
2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra che, pur nella loro diversità strutturale, (molte di) tali lingue hanno delle proprierà in comune.
1 Introduzione: la comparazione interlinguistica
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 1 Introduzione: la comparazione interlinguistica Obiettivi del corso: Il corso è volto a delineare i metodi e i principali risultati dell approccio
3 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2009-10 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente
1 Introduzione: l analisi del linguaggio
 1 Introduzione: l analisi del linguaggio Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2009-10 Obiettivi: Il corso e volto a illustrare le modalit e i principi generali che governano l organizzazione grammaticale
1 Introduzione: l analisi del linguaggio Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2009-10 Obiettivi: Il corso e volto a illustrare le modalit e i principi generali che governano l organizzazione grammaticale
3 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 3 Motivazioni funzionali 3.1 Introduzione (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 3 Motivazioni funzionali 3.1 Introduzione (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente
2 Universali linguistici
 2 Universali linguistici Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2015-16 (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale, (molte
2 Universali linguistici Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2015-16 (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale, (molte
3 Motivazioni funzionali
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2014-15 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2014-15 1 3 Motivazioni funzionali (1) Il concetto di motivazione funzionale: la struttura delle espressioni linguistiche è almeno parzialmente dipendente
9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto
 Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2008-9 1 9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto [Manuali di riferimento per questa parte: Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: capp. 5 e 6 (le parti
Sonia Cristofaro - Glottologia B - a.a 2008-9 1 9 L origine delle categorie grammaticali: tempo e aspetto [Manuali di riferimento per questa parte: Bybee, Perkins, and Pagliuca 1994: capp. 5 e 6 (le parti
5 L ordine delle parole
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 5 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr.
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2016-17 1 5 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr.
2 Universali linguistici
 Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale, (molte
Sonia Cristofaro - Language typology - a.a 2017-18 1 2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale, (molte
mí 1SG ART nù acqua interno ART
 Sonia Cristofaro - Glottologia a.a. 2011-12 1 Esercizi - 4 (1) Sapendo che le lingue in (2)-(4) appartengono tutte alla stessa famiglia, e i verbi negli esempi (2) e (3) sono connessi con il morfema kè
Sonia Cristofaro - Glottologia a.a. 2011-12 1 Esercizi - 4 (1) Sapendo che le lingue in (2)-(4) appartengono tutte alla stessa famiglia, e i verbi negli esempi (2) e (3) sono connessi con il morfema kè
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -2 (1) In Burushaski (isolato; Pakistan), nelle frasi al passato i nomi e i pronomi singolari che occorrono come A presentano la marca
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -2 (1) In Burushaski (isolato; Pakistan), nelle frasi al passato i nomi e i pronomi singolari che occorrono come A presentano la marca
DIATESI ATTIVA E PASSIVA IL SOGGETTO È SEMPRE L AGENTE?
 DIATESI ATTIVA E PASSIVA IL SOGGETTO È SEMPRE L AGENTE? SOGGETTO E AGENTE Abbiamo sempre studiato che «soggetto» è chi compie l azione del verbo, ma in realtà questa è la funzione dell agente. IL LUPO
DIATESI ATTIVA E PASSIVA IL SOGGETTO È SEMPRE L AGENTE? SOGGETTO E AGENTE Abbiamo sempre studiato che «soggetto» è chi compie l azione del verbo, ma in realtà questa è la funzione dell agente. IL LUPO
6 L ordine delle parole
 6 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr. file n. 1), ad esempio vari ordini di soggetto, oggetto
6 L ordine delle parole (1) Il punto di partenza: Le lingue del mondo presentano ordini delle parole diversi all interno di varie costruzioni (cfr. file n. 1), ad esempio vari ordini di soggetto, oggetto
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -1 (1) Le frasi in (2)-(6) illustrano i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo per cio che riguarda l accordo verbale. A partire
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2012-13 1 Esercizi -1 (1) Le frasi in (2)-(6) illustrano i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo per cio che riguarda l accordo verbale. A partire
Sommario. Premessa XIII
 Sommario Premessa XIII Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 1 1.1 Vocali 3 1.2 Consonanti 6 1.3 Aspirazione 8 1.4 Il sistema di accentazione 10 1.5 Proclitiche ed enclitiche. Appositive e ortotoniche 12
Sommario Premessa XIII Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 1 1.1 Vocali 3 1.2 Consonanti 6 1.3 Aspirazione 8 1.4 Il sistema di accentazione 10 1.5 Proclitiche ed enclitiche. Appositive e ortotoniche 12
5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
Sonia Cristofaro - Glottologia A - a.a 2014-15 1 5 L evoluzione delle lingue: livelli del mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte (solo in riferimento agli arrgomenti trattati):
2 Universali linguistici
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2014-15 1 2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale,
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2014-15 1 2 Universali linguistici (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra, pur nel loro diversità strutturale,
La tipologia e gli universali
 La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
La tipologia e gli universali La tipologia studia la variazione interlinguistica; la ricerca sugli universali si occupa di ciò che è comune a tutte le lingue, cioè delle proprietà rispetto alle quali non
NUOVI ITINERARI. Sommario. Premessa
 NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
NUOVI ITINERARI V Sommario Premessa XI Prima unità Cap. 1 Alfabeto e sistema fonetico 3 1.1 Vocali 5 1.2 Consonanti 8 1.3 Aspirazione 10 1.4 Il sistema di accentazione 12 1.5 Proclitiche ed enclitiche.
2 Universali linguistici
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2011-12 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2011-12 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa. Usa il linguaggio verbale sì no. Usa il corpo per esprimere le sue emozioni sì no
 Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Traccia di analisi della competenza linguistica e comunicativa a cura di Francesco De Renzo (Facoltà di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma) Comunicazione Interazione In che modo comunica e interagisce:
Classificazione dei vrebi in base alla valenza: - avalenti o zerovalenti > nessun argomento es. piove, nevica
 I verbi Valenza verbale: indica il numero di elementi che devono obbligatoriamente accompagnare il verbo. Questi gruppi nominali sono detti argomenti. Gli altri elementi non obbligatori che occorrono in
I verbi Valenza verbale: indica il numero di elementi che devono obbligatoriamente accompagnare il verbo. Questi gruppi nominali sono detti argomenti. Gli altri elementi non obbligatori che occorrono in
Singolare Plurale. Even (ugro-finnico, Russia centrale): declinazione del nome ǰuu casa
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 Esercizi - 1 (1) La tabella che segue riporta alcune forme di caso per i due sostantivi pesce e donna in kayardild (australiano). Cosa si può dire circa tali
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2013-14 1 Esercizi - 1 (1) La tabella che segue riporta alcune forme di caso per i due sostantivi pesce e donna in kayardild (australiano). Cosa si può dire circa tali
+,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''.
 +,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''. 0 ( 1, +, ''3!/(. ' - ''0 0 04 01 ' / 5 02 /0+ / 330! / 3 54 / 5 4 ( / ( 40 (40 ( 44 ( ' 44 ( 3 644 ( ' 41 ( 41, ' / 42, ' 42, ' ( 4+ ( 4 4 4 1 10,-!14! 7 12! 1+!
+,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''. 0 ( 1, +, ''3!/(. ' - ''0 0 04 01 ' / 5 02 /0+ / 330! / 3 54 / 5 4 ( / ( 40 (40 ( 44 ( ' 44 ( 3 644 ( ' 41 ( 41, ' / 42, ' 42, ' ( 4+ ( 4 4 4 1 10,-!14! 7 12! 1+!
TRANSITIVI: 1. INTRANSITIVI 1: è arrivato. si è ammalato è affondato. 2. INTRANSITIVI 2: ha telefonato PSEUDORIFLESSIVI: ERGATIVI:
 TRANSITIVITÀ 1. INTRANSITIVI 1: è arrivato PSEUDORIFLESSIVI: ERGATIVI: PASSIVI: si è ammalato è affondato è stato promosso 2. INTRANSITIVI 2: ha telefonato TRANSITIVI: ha visto ALTRE LINGUE? 1. Er ist
TRANSITIVITÀ 1. INTRANSITIVI 1: è arrivato PSEUDORIFLESSIVI: ERGATIVI: PASSIVI: si è ammalato è affondato è stato promosso 2. INTRANSITIVI 2: ha telefonato TRANSITIVI: ha visto ALTRE LINGUE? 1. Er ist
Linguistica generale. a.a Federica Da Milano
 Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
Linguistica generale a.a.2014-2015 Federica Da Milano La sintassi: frasi e enunciati La frase intesa come modulo di un testo è chiamata enunciato, per differenziarla dalla frase intesa come costruzione
SINTASSI E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2. Francesca Forza - Nozioni Generali di Sintassi
 SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2 Perché la sintassi? 2 Il significato di una frase (e quindi più in generale la semantica) non dipende solo dalle sue componenti (il lessico) ma anche
SINTASSI 1 E L E M E N T I I N T R O D U T T I V I 2 Perché la sintassi? 2 Il significato di una frase (e quindi più in generale la semantica) non dipende solo dalle sue componenti (il lessico) ma anche
Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente, beneficiario, strumento, ecc.
 Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Both English and Dyirbal have different syntactic means of encoding the same semantic roles (p. 114) Funzioni fondamentali della frase (soggetto, oggetto diretto, ecc.) Ruoli tematici: agente, paziente,
Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia
 Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A. 2015 / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. La classificazione tipologica delle lingue La classificazione
Corso di laurea in Comunicazione Interculturale A. A. 2015 / 2016 Linguistica Generale Prof. Giorgio Francesco Arcodia (giorgio.arcodia@unimib.it) 1. La classificazione tipologica delle lingue La classificazione
2 Universali linguistici
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2007-8 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
Esercizi-2. Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2013-14 1 Esercizi-2 (1) In swahili, un elevato numero di nomi forma il singolare e il plurale aggiungendo alla radice della parola, rispettivamente, i due prefissi
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a. 2013-14 1 Esercizi-2 (1) In swahili, un elevato numero di nomi forma il singolare e il plurale aggiungendo alla radice della parola, rispettivamente, i due prefissi
Il programma profondo dello studente L interlingua (1 parte)
 L apprendimento dell italiano L2 Il programma profondo dello studente L interlingua (1 parte) Giuseppe Faso Analisi di brani (1): Li Li, cinese, in Italia da due mesi Una bambino e e lui papà vado a lago
L apprendimento dell italiano L2 Il programma profondo dello studente L interlingua (1 parte) Giuseppe Faso Analisi di brani (1): Li Li, cinese, in Italia da due mesi Una bambino e e lui papà vado a lago
IL MODELLO DEI GRUPPI SINTATTICI E L ANALISI MORFOSINTATTICA
 Le Botteghe dell Insegnare ITALIANO -LINGUA Seminario 6 novembre 2015 Insegnare lingua italiana nella scuola media. Esperienze degli specializzandi PAS A043 IL MODELLO DEI GRUPPI SINTATTICI E L ANALISI
Le Botteghe dell Insegnare ITALIANO -LINGUA Seminario 6 novembre 2015 Insegnare lingua italiana nella scuola media. Esperienze degli specializzandi PAS A043 IL MODELLO DEI GRUPPI SINTATTICI E L ANALISI
+,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''.
 +,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''. 0 ( 1, +, ''3!/(. ' - ''0 0 04 01 ' / 5 02 /0+ / 330! / 3 54 / 5 4 ( / ( 40 (40 ( 44 ( ' 44 ( 3 644 ( ' 41 ( 41, ' / 42, ' 42, ' ( 4+ ( 4 4 4 1 10,-!14! 7 12! 1+!
+,-! (. / /,- / 0,- / 1,- / ' 2 +. ''. 0 ( 1, +, ''3!/(. ' - ''0 0 04 01 ' / 5 02 /0+ / 330! / 3 54 / 5 4 ( / ( 40 (40 ( 44 ( ' 44 ( 3 644 ( ' 41 ( 41, ' / 42, ' 42, ' ( 4+ ( 4 4 4 1 10,-!14! 7 12! 1+!
Argomento La frase Frase e non frase (fase 1)
 Argomento La frase Frase e non frase (fase 1) Attività Cos è una frase? Destinatari: secondaria di I grado - classe prima Obiettivo di riflessione: individuare le caratteristiche della frase Durata: 1
Argomento La frase Frase e non frase (fase 1) Attività Cos è una frase? Destinatari: secondaria di I grado - classe prima Obiettivo di riflessione: individuare le caratteristiche della frase Durata: 1
5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico
 Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2010-11 1 5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte: Per il mutamento linguistico in generale: Lazzeroni
Sonia Cristofaro - Glottologia - a.a 2010-11 1 5 L evoluzione delle lingue: tipi di mutamento linguistico [Materiali di riferimento per questa parte: Per il mutamento linguistico in generale: Lazzeroni
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA?
 La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
La padronanza linguistica, Academia Universa Press 2011 PARTE PRIMA FARE GRAMMATICA 1. INSEGNARE ANCORA LA GRAMMATICA? 2. LA TRADIZIONE Analisi grammaticale Analisi logica Analisi del periodo Analisi testuale
Il verbo: imparare le forme
 Scuola primaria Scuola secondaria I grado Scuola secondaria II grado Il verbo: imparare le forme www.insegnaregramma2ca.it Il tipico compitino di verbi saranno sta( mangia( mangiassimo mangerete avemmo
Scuola primaria Scuola secondaria I grado Scuola secondaria II grado Il verbo: imparare le forme www.insegnaregramma2ca.it Il tipico compitino di verbi saranno sta( mangia( mangiassimo mangerete avemmo
3. Dalla linearità alla struttura La dipendenza dalla struttura La ricorsività 31
 Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
Indice Parte I Fare grammatica 9 1. Insegnare ancora la grammatica? 9 2. La tradizione 15 2.1. Analisi grammaticale 16 2.2. Analisi logica 19 2.3. Analisi del periodo 22 2.4. Analisi testuale 24 2.5. Verso
2 LE PARTI DEL DISCORSO Le nove parti del discorso Caratteristiche delle parti del discorso 48 ESERCIZI 50 INDICE
 1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
1 FONOLOGIA E ORTOGRAFIA SUONI, LETTERE E ORTOGRAFIA 2 A COLPO D OCCHIO - PERCORSO DI STUDIO 2 QUIZ PER COMINCIARE 4 1. I suoni e le lettere 5 1. L alfabeto italiano 5 2. Le sette vocali 6 3. Dittonghi,
Istituzioni di linguistica. a.a Federica Da Milano
 Istituzioni di linguistica a.a.2015-2016 Federica Da Milano La flessione Le parole che troviamo in un enunciato sono forme flesse di parola, cioè forme che esprimono, oltre ad un significato lessicale,
Istituzioni di linguistica a.a.2015-2016 Federica Da Milano La flessione Le parole che troviamo in un enunciato sono forme flesse di parola, cioè forme che esprimono, oltre ad un significato lessicale,
Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia
 Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia Il verbo Che cos'è il verbo? Il verbo è la parte variabile del discorso con la quale si esprimono, collocandoli nel tempo, un'azione,
Presentazione di: Condes Angel Grace Colella Ludovica Conte Flaminia Il verbo Che cos'è il verbo? Il verbo è la parte variabile del discorso con la quale si esprimono, collocandoli nel tempo, un'azione,
2 Universali linguistici
 Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2010-11 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
Sonia Cristofaro - Linguistica tipologica - a.a. 2010-11 1 2 Universali linguistici 2.1 Universali assoluti e implicazionali (1) Gli universali linguistici: l analisi empirica delle lingue del mondo mostra,
INDICE PREFAZIONE. Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE. Capitolo 2 STATO DETERMINATO E INDETERMINATO. Capitolo 3 I GENERI MASCHILE E FEMMINILE
 INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
INDICE PREFAZIONE XIII Capitolo 1 INFORMAZIONI DI BASE 1.1 Le lettere dell alfabeto e la loro traslitterazione 1 1.2 Le vocali 2 1.3 I segni ortografici 3 1.4 Il sostegno della hamza 4 1.5 Le caratteristiche
a. s CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
a. s. 2015-2016 CLASSE I B Insegnante A. Pruneddu Disciplina Latino PROGRAMMA SVOLTO Segni e suoni L alfabeto: confronto italiano - latino Vocali e dittonghi Come si legge il latino La quantità della penultima
LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE
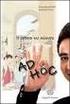 Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
Gian Biagio Conte LATINO A COLORI MATERIALI PER IL DOCENTE a cura di Laura Perrotta 2009 by Mondadori Education S.p.A., Milano Tutti i diritti riservati Progettazione e redazione Impaginazione Rilettura
IL PREDICATO NOMINALE. Daniela Notarbartolo
 IL PREDICATO NOMINALE Daniela Notarbartolo Definizione? Le definizioni dovrebbero essere univoche e permettere di distinguere i fenomeni in modo certo. Invece tutte le definizioni di predicato nominale
IL PREDICATO NOMINALE Daniela Notarbartolo Definizione? Le definizioni dovrebbero essere univoche e permettere di distinguere i fenomeni in modo certo. Invece tutte le definizioni di predicato nominale
La grammatica e l analisi degli elementi di una frase
 La grammatica e l analisi degli elementi di una frase La distinzione in categorie grammaticali è molto antica. Risale addirittura al II secolo a.c., quando il grammatico greco Dionisio Trace ne segnò le
La grammatica e l analisi degli elementi di una frase La distinzione in categorie grammaticali è molto antica. Risale addirittura al II secolo a.c., quando il grammatico greco Dionisio Trace ne segnò le
PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO. a. s CLASSE: I A. Insegnante: Daniela Saracco. Disciplina: Latino
 PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO a. s. 2017-2018 CLASSE: I A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO 1. Segni e suoni 1.1. Vocali e dittonghi 1.2. Come si legge il latino
PROGRAMMA SVOLTO E INDICAZIONI LAVORO ESTIVO a. s. 2017-2018 CLASSE: I A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO 1. Segni e suoni 1.1. Vocali e dittonghi 1.2. Come si legge il latino
che cosa sai fare Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5
 Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
Percorso 1 La fonortografia mappa del percorso 2 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua parlata 4 Prova a misurare la tua consapevolezza sulla lingua scritta 5 Come si parla e come si scrive
(3) In greco antico, il paradigma plurale degli aggettivi presenta le seguenti desinenze a seconda del caso e del genere:
 Esercizi (1) La lista che segue, VSO & AuxV non VSO & AuxV non VSO & VAux illustra i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo in relazione all ordine di verbo (V) e ausiliare (Aux) (i simboli
Esercizi (1) La lista che segue, VSO & AuxV non VSO & AuxV non VSO & VAux illustra i tipi linguistici attestati nelle lingue del mondo in relazione all ordine di verbo (V) e ausiliare (Aux) (i simboli
a. s CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino
 a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
a. s. 2015-2016 CLASSE: 1A Insegnante: Daniela Saracco Disciplina: Latino PROGRAMMA SVOLTO Testi adottati: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio Testi consigliati Nicola Flocchini, Piera
LESSON NUMBER 24: QUESTIONS LEZIONE NUMERO 24: DOMANDE
 Visitaci su: http://englishclass.altervista.org/ LESSON NUMBER 24: QUESTIONS LEZIONE NUMERO 24: DOMANDE In inglese i pronomi/aggettivi e gli avverbi interrogativi iniziano quasi sempre per WH. Una domanda
Visitaci su: http://englishclass.altervista.org/ LESSON NUMBER 24: QUESTIONS LEZIONE NUMERO 24: DOMANDE In inglese i pronomi/aggettivi e gli avverbi interrogativi iniziano quasi sempre per WH. Una domanda
