Un pò di storia sui satelliti meteo. Scritto da coadmin - Ultimo aggiornamento Domenica 14 Febbraio :57
|
|
|
- Letizia Leo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Un pò di storia e in fondo all'articolo, gli aggiornamenti di tutti i satelliti meteorologici operativi, polari e geostazionari, quelli in orbita e quelli futuri. I satelliti Meteorologici fanno parte della famiglia dei satelliti denominati artificiali e con questo termine va inteso qualsiasi oggetto posto dall'uomo in un orbita attorno alla Terra o attorno ad un altro corpo celeste. Va precisato che un satellite artificiale può venire posto in un'orbita terrestre in tre modi diversi o lungo l'equatore (orbita "Equatoriale o Sincrona") oppure passante per i poli (orbita "Polare") od ancora su un'orbita inclinata rispetto l'equatore, comunque tutti ad una altezza non inferiore ai 130 Km e per potersi mantenere in orbita deve essere data al satellite una velocità orbitale sufficiente a contrastare la forza di gravità Terrestre altrimenti verrebbe attratto rapidamente verso Terra. Attualmente, attività quotidiane come telefonare, vedere la TV o ascoltare la radio hanno spesso relazioni dirette o indirette con l'uso dei satelliti artificiali e il loro numero in orbita attualmente attivi raggiunge quasi il migliaio e tutti girano su orbite predeterminate e perfettamente controllate da Centri di Controllo CDA che provvedono alla loro correzione ogni qualvolta se ne presenta la necessità.ma ora andremo a vedere da vicino la categoria di satelliti artificiali chiamati "Meteorologici" e di grande aiuto per le previsioni del tempo. 1 / 10
2 Sebbene molti sappiano già della loro presenza nello spazio non fosse altro che per le loro immagini mostrate spesso in TV durante le previsioni del tempo, sono pochi però quelli che ne conoscono la loro storia e subito va detto che le loro immagini non sono soltanto belle a vedersi ma contengono numerosissime informazioni che se interpretate correttamente ed integrate con altri dati (come ad esempio la pressione atmosferica, la temperature al suolo ed in quota, ecc.), divengono utilissime per fare previsioni del tempo a breve e media scadenza e inoltre possono essere un'importante fonte di studio riguardante l'agricoltura e la climatologia. Quindi vediamone un po' la loro storia. In sintesi possiamo dire che si tratta di satelliti artificiali che dallo spazio inviano quotidianamente a terra immagini della situazione Meteorologica e Climatologica in atto sul nostro pianeta. Il primo satellite artificiale meteorologico fu lanciato in orbita dalla NASA il 1 Aprile del 1960 e si chiamava TIROS 1 da non confondere con il primo satellite artificiale che fu lo Sputnik 1, lanciato dall'unione Sovietica il 4 ottobre del 1957 e rimase in orbita per soli 92 giorni. Le immagini Meteo inviate dal TIROS 1, ancora poco dettagliate, venivano registrate a bordo e poi inviate a terra su comando da parte dei tecnici addetti ai centri di controllo CDA della NASA. Al TIROS 1 seguirono in graduale successione altri satelliti simili fino al 1964, quando questa prima serie sperimentale di satelliti Meteorologici venne sostituita poi da una nuova serie di satelliti operativi molto più sofisticata il cui nome era Nimbus. Il Nimbus rispetto ai satelliti TIROS era in grado di fornire immagini molto più nitide e dettagliate sotto forma di fotografie e le immagini erano riprese in sequenza e trasmesse in tempo reale lungo le sue orbite e non più registrate a bordo e quindi a disposizione di chiunque si attrezzasse con apposite apparecchiature di ricezione. Va anche detto che nel periodo ai Nimbus venne affiancata una nuova serie di satelliti meteorologici USA chiamati ESSA con caratteristiche simili. Alla fine degli anni 60 gli studiosi di scienza e Meteorologia si resero sempre più conto dell importanza di questi satelliti non solo per rilevare i corpi nuvolosi, ma anche per ottenere altri tipi di informazioni relative al suolo terrestre, così agli inizi degli anni 70, tenendo presente l'esperienza fatta nei dieci anni precedenti, venne approntata una nuova serie di satelliti ancora più sofisticata delle precedenti e cioè capaci di riprendere immagini oltre che nello spettro del visibile anche nello spettro dell'infrarosso. 2 / 10
3 Il primo satellite di questa serie fu lanciato il 23 Gennaio del 1970 e gli venne dato il nome provvisorio di ITOS 1 poi a quelli successivi venne dato il nome di NOAA, nome tutt'ora impiegato per tutti i satelliti meteorologici americani in orbite polari che seguirono, ultimo dei quali e forse definitivamente, è il NOAA 19 lanciato il 6 Febbraio del Satelliti meteorologici: aggiornamento al 14 Gennaio GEO: SATELLITE GEOSTAZIONARIO Nome satellite data lancio Posizione Europa 3 / 10
4 Meteosat GEO 57.5 E Meteosat 8 (MSG-1) GEO 9.5 E Meteosat 9 (MSG-2) GEO 0.0 MSG GEO 3.4 W MSG GEO Metop-A orbita polare Metop-B orbita polare Metop-C 2017 orbita polare Metop-SG A1,A2,A orbita polare Metop-SG B1,B2,B orbita polare Jason orbita polare Jason orbita polare 4 / 10
5 Sentinel-3A, 3B 2013, 2015 orbita polare U.S.A. Goes GEO 60 W Goes GEO 75 W Goes GEO W Goes GEO 135 W Goes-R e S GEO Noaa orbita polare Noaa orbita polare Noaa orbita polare 5 / 10
6 Noaa orbita polare Noaa orbita polare Suomi NPP orbita polare JPSS-1 e orbita polare DMSP 19, orbita polare Russia Electro-L N GEO 76 E Electro-L N GEO 14.5 W Electro-L N GEO 166 E Meteor-M N orbita polare Meteor-M N orbita polare 6 / 10
7 Meteor-M N orbita polare Cina Fengyun-2C(FY-2C) GEO E FY-2D GEO 86.5 E FY-2E GEO 105 E FY-2F GEO 112 E FY-2G e -2H GEO FY-4A a-4c GEO FY-1D orbita polare FY-3A orbita polare 7 / 10
8 FY-3B orbita polare FY-3Ca -3G orbita polare FY-3 RM1 e RM orbita polare Giappone MTSAT-1R GEO 140 E MTSAT GEO 145 E Himawari 8 e GEO India KALPANA GEO 74 E 8 / 10
9 INSAT-3A GEO 93.5 E INSAT-3D GEO Oceansat orbita polare Oceansat orbita polare SARAL-Altika 2012 orbita polare Megha-Tropiques orbita polare Corea del Sud COMS GEO E GEO-KOMPSAT GEO 9 / 10
10 10 / 10
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi
 Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
Telerilevamento: una panoramica sui sistemi Il telerilevamento: cos è? Il telerilevamento è la scienza (o l arte) di ottenere informazioni riguardanti un oggetto, un area o un fenomeno utilizzando dati
"Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità"
 www.k-sport.it "Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità" Mirko Marcolini Il carico esterno Cos è Ogni grandezza fisica viene definita mediante il metodo che si usa per misurarla.
www.k-sport.it "Match analysis, GPS, potenza metabolica: le bugie della verità" Mirko Marcolini Il carico esterno Cos è Ogni grandezza fisica viene definita mediante il metodo che si usa per misurarla.
ESPLORAZIONI SPAZIALI
 ESPLORAZIONI SPAZIALI Astronautica = la scienza della navigazione spaziale Si avvale di altre discipline, quali la fisica, l'astronomia, la matematica, la chimica, la biologia, la medicina, l'elettronica
ESPLORAZIONI SPAZIALI Astronautica = la scienza della navigazione spaziale Si avvale di altre discipline, quali la fisica, l'astronomia, la matematica, la chimica, la biologia, la medicina, l'elettronica
Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio
 www.k-sport.it Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio Una mela cade dall albero. Qualcuno ci vede un frutto andato a male. Qualcun altro la legge di gravità. Mirko Marcolini 1 Cos è Ogni grandezza
www.k-sport.it Tecnologia e rilievo del carico esterno nel calcio Una mela cade dall albero. Qualcuno ci vede un frutto andato a male. Qualcun altro la legge di gravità. Mirko Marcolini 1 Cos è Ogni grandezza
I satelliti meteorologici
 I satelliti meteorologici Nella meteorologia moderna i satelliti svolgono ormai un ruolo fondamentale: grazie a questi occhi in orbita attorno al nostro pianeta possiamo monitorare in tempo reale l evoluzione
I satelliti meteorologici Nella meteorologia moderna i satelliti svolgono ormai un ruolo fondamentale: grazie a questi occhi in orbita attorno al nostro pianeta possiamo monitorare in tempo reale l evoluzione
I satelliti meteorologici. 24/02/2010 Prof.ssa Maria Fichera Appunti dalle lezioni. aria fichera
 I satelliti meteorologici 1 I satelliti meteorologici sono un potentissimo strumento per la meteorologia, climatologia e fisica dell'atmosfera. 2 Sono dotati di un radiometro che misura la radiazione solare
I satelliti meteorologici 1 I satelliti meteorologici sono un potentissimo strumento per la meteorologia, climatologia e fisica dell'atmosfera. 2 Sono dotati di un radiometro che misura la radiazione solare
I satelliti. Com è fatto un satellite
 I satelliti Intorno alla Terra ruotano numerosi satelliti artificiali, messi in orbita nel corso degli ultimi decenni per gli scopi più diversi, sia in ambito militare sia civile. I satelliti sono ormai
I satelliti Intorno alla Terra ruotano numerosi satelliti artificiali, messi in orbita nel corso degli ultimi decenni per gli scopi più diversi, sia in ambito militare sia civile. I satelliti sono ormai
Introduzione al TELERILEVAMENTO. (Remote Sensing) Docente: Andrea Piemonte
 Introduzione al TELERILEVAMENTO (Remote Sensing) Slide 1 COS È È una disciplina del rilevamento che ha come scopo la produzione di mappe tematiche o comunque l estrazione di un certo tipo di informazioni
Introduzione al TELERILEVAMENTO (Remote Sensing) Slide 1 COS È È una disciplina del rilevamento che ha come scopo la produzione di mappe tematiche o comunque l estrazione di un certo tipo di informazioni
INIZIO ATTIVITA RADIOANTISTICA 1978
 INIZIO ATTIVITA RADIOANTISTICA 1978 In quei primi anni di attivita radio ho rivolto la mia attenzione ad ascoltare principalmente segnali radio diversi dalla solita fonia. RTTY.AGENZIE DI STAMPA.CW.WEFAX
INIZIO ATTIVITA RADIOANTISTICA 1978 In quei primi anni di attivita radio ho rivolto la mia attenzione ad ascoltare principalmente segnali radio diversi dalla solita fonia. RTTY.AGENZIE DI STAMPA.CW.WEFAX
SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE
 SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE «Tecniche di interferometria satellitare per l individuazione di aree con dissesti non cartografati» Bologna
SEMINARIO TECNICO SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOBILE DELLA INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE «Tecniche di interferometria satellitare per l individuazione di aree con dissesti non cartografati» Bologna
Breve lezione di Astronomia. Sistema Solare con le sue relative dimensioni
 Breve lezione di Astronomia Sistema Solare con le sue relative dimensioni Elenco dei pianeti dall interno verso l esterno del sistema solare Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
Breve lezione di Astronomia Sistema Solare con le sue relative dimensioni Elenco dei pianeti dall interno verso l esterno del sistema solare Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
Il sistema di navigazione GNSS Global Navigation Satellite Systems
 Il sistema di navigazione GNSS Global Navigation Satellite Systems Raggruppa i sistemi satellitari GPS (Stati Uniti), GLONASS (Fed. Russa) e GALILEO (Comunità Europea, in corso di realizzazione) Ha lo
Il sistema di navigazione GNSS Global Navigation Satellite Systems Raggruppa i sistemi satellitari GPS (Stati Uniti), GLONASS (Fed. Russa) e GALILEO (Comunità Europea, in corso di realizzazione) Ha lo
AFAM - Remanzacco. Serata osservativa del 15 settembre
 AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 15 settembre Cielo del 15 settembre a Remanzacco Nettuno Plutone Saturno Urano Albireo Nebulosa M 57 P Cygni Galassia M 81 Ammasso M 13 Stella Polare La Luna sorge
AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 15 settembre Cielo del 15 settembre a Remanzacco Nettuno Plutone Saturno Urano Albireo Nebulosa M 57 P Cygni Galassia M 81 Ammasso M 13 Stella Polare La Luna sorge
Problemi di Fisica. La Gravitazione
 Problemi di Fisica La Gravitazione Calcolare la forza che agisce sulla Luna per effetto dell interazione gravitazionale con la erra e il Sole. I dati sono: massa Sole M S =1,9810 30 kg; massa erra M =5,9810
Problemi di Fisica La Gravitazione Calcolare la forza che agisce sulla Luna per effetto dell interazione gravitazionale con la erra e il Sole. I dati sono: massa Sole M S =1,9810 30 kg; massa erra M =5,9810
Daniele Izzo Meteorologo Centro Epson Meteo
 Le previsioni del tempo Daniele Izzo Meteorologo Centro Epson Meteo daniele.izzo@meteo.expert Le previsioni del tempo L approccio scientifico è indispensabile per poter prevedere tutti i fenomeni meteorologici:
Le previsioni del tempo Daniele Izzo Meteorologo Centro Epson Meteo daniele.izzo@meteo.expert Le previsioni del tempo L approccio scientifico è indispensabile per poter prevedere tutti i fenomeni meteorologici:
Il radar in meteorologia Dove è piovuto, sta piovendo e pioverà a breve?
 Il radar in meteorologia Dove è piovuto, sta piovendo e pioverà a breve? IL RADAR METEOROLOGICO Il radar del Macaion Si trova sul comune di Fondo (TN), sul monte Macaion, ad una quota di circa 1870 m.
Il radar in meteorologia Dove è piovuto, sta piovendo e pioverà a breve? IL RADAR METEOROLOGICO Il radar del Macaion Si trova sul comune di Fondo (TN), sul monte Macaion, ad una quota di circa 1870 m.
AMSAT-Italia SPAZIO E RADIOAMATORI. Fabio Azzarello IW8QKU. AMSAT-Italia Convegno Spazio e Radioamatori - Roma 02/12/2006
 AMSAT-Italia SPAZIO E RADIOAMATORI Fabio Azzarello IW8QKU AMSAT-Italia Convegno Spazio e Radioamatori - Roma 02/12/ Propagazione onde corte onde ultracorte microonde lunga distanza variazioni giorno/notte
AMSAT-Italia SPAZIO E RADIOAMATORI Fabio Azzarello IW8QKU AMSAT-Italia Convegno Spazio e Radioamatori - Roma 02/12/ Propagazione onde corte onde ultracorte microonde lunga distanza variazioni giorno/notte
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - BARI
 PAG. 1 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - BARI ORBITE E PARAMETRI ORBITALI Parametri Orbitali Sei sono i parametri orbitali che consentono di individuare univocamente la posizione
PAG. 1 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - BARI ORBITE E PARAMETRI ORBITALI Parametri Orbitali Sei sono i parametri orbitali che consentono di individuare univocamente la posizione
La nostra compagna di viaggio: la Luna. Enrico Degiuli Classe Terza
 La nostra compagna di viaggio: la Luna Enrico Degiuli Classe Terza La Luna, caratteristiche fisiche I pianeti a volte hanno dei corpi celesti più piccoli che orbitano attorno a loro, questi corpi sono
La nostra compagna di viaggio: la Luna Enrico Degiuli Classe Terza La Luna, caratteristiche fisiche I pianeti a volte hanno dei corpi celesti più piccoli che orbitano attorno a loro, questi corpi sono
Come nasce il bollettino meteo?
 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Agentur für Bevölkerungsschutz Landeswetterdienst PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Agenzia per la protezione civile Servizio Meteo Provinciale Come nasce il
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Agentur für Bevölkerungsschutz Landeswetterdienst PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Agenzia per la protezione civile Servizio Meteo Provinciale Come nasce il
FACCIA A FACCIA A. Propedeutica chinesiologica. Corsi A & B P9 FACCIA B. 3. GARMIN Forerunner ed Edge. 1. Fotocellule (OptoJump tempi & velocità);
 Propedeutica chinesiologica Corsi A & B P9 FACCIA A 1. Fotocellule (OptoJump tempi & velocità); 2. cinematica video (DartFish spazi, tempi & velocità); 3. sistemi GPS (Forerunner ed Edge spazi, tempi &
Propedeutica chinesiologica Corsi A & B P9 FACCIA A 1. Fotocellule (OptoJump tempi & velocità); 2. cinematica video (DartFish spazi, tempi & velocità); 3. sistemi GPS (Forerunner ed Edge spazi, tempi &
La nostra compagna di viaggio: la Luna. Enrico Degiuli Classe Terza
 La nostra compagna di viaggio: la Luna Enrico Degiuli Classe Terza La Luna, caratteristiche fisiche I pianeti a volte hanno dei corpi celesti più piccoli che orbitano attorno a loro, questi corpi sono
La nostra compagna di viaggio: la Luna Enrico Degiuli Classe Terza La Luna, caratteristiche fisiche I pianeti a volte hanno dei corpi celesti più piccoli che orbitano attorno a loro, questi corpi sono
LA PREVISIONE METEOROLOGICA
 LA PREVISIONE METEOROLOGICA Bernardo GOZZINI Consorzio Consorzio LaMMA LaMMA Seminario RISCHIO ALLUVIONI IN TOSCANA: PRECIPITAZIONI ED EFFETTI AL SUOLO Firenze, 22 aprile 2015 16 giugno 1996 12 aprile
LA PREVISIONE METEOROLOGICA Bernardo GOZZINI Consorzio Consorzio LaMMA LaMMA Seminario RISCHIO ALLUVIONI IN TOSCANA: PRECIPITAZIONI ED EFFETTI AL SUOLO Firenze, 22 aprile 2015 16 giugno 1996 12 aprile
Ricezione immagini meteo da satelliti NOAA. Juri Gherrdi - IZ4OSG - AMSAT - Università Tor Vergata
 Ricezione immagini meteo da satelliti NOAA NOAAA (National Oceanic and Atmospheric Administrator L ente statunitense civile per la meteorologia e l oceanografia Definizione satellite meteorologico Un satellite
Ricezione immagini meteo da satelliti NOAA NOAAA (National Oceanic and Atmospheric Administrator L ente statunitense civile per la meteorologia e l oceanografia Definizione satellite meteorologico Un satellite
GIOVE e l osservazione in banda radio
 GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
GIOVE e l osservazione in banda radio CARATTERISTICHE DI GIOVE Diametro: 142.800 km Massa: 1,9 x 10^27 kg Densità: 1,3 kg/dm³ Distanza Minima dal Sole: 741.000.000 km Distanza Massima dal Sole: 817.000.000
Materiale didattico per il corso:
 Materiale didattico per il corso: 059AR - TELERILEVAMENTO PER LO STUDIO DEL TERRITORIO - REMOTE SENSING FOR TERRITORIAL STUDY Docente: Andrea Favretto afavretto@units.it Parte terza Telerilevamento come
Materiale didattico per il corso: 059AR - TELERILEVAMENTO PER LO STUDIO DEL TERRITORIO - REMOTE SENSING FOR TERRITORIAL STUDY Docente: Andrea Favretto afavretto@units.it Parte terza Telerilevamento come
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
 SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
SICAM Sistema Centrale di Automazione dei Servizi Metereologici
 Sistema Centrale di Automazione dei Servizi Metereologici Il SIstema Centrale di Automazione dei servizi Meteorologici (SICAM) è un sistema informatico progettato e sviluppato da VITROCISET per la gestione
Sistema Centrale di Automazione dei Servizi Metereologici Il SIstema Centrale di Automazione dei servizi Meteorologici (SICAM) è un sistema informatico progettato e sviluppato da VITROCISET per la gestione
La storia del telerilevamento in Italia e in Europa. Osservazione della Terra con tecnologia Grid e SOA da ESA. Un report dalla Conferenza ESRI 2009
 La storia del telerilevamento in Italia e in Europa Osservazione della Terra con tecnologia Grid e SOA da ESA Un report dalla Conferenza ESRI 2009 Il Corpo Forestale presenta il progetto TARGET-STARS L'International
La storia del telerilevamento in Italia e in Europa Osservazione della Terra con tecnologia Grid e SOA da ESA Un report dalla Conferenza ESRI 2009 Il Corpo Forestale presenta il progetto TARGET-STARS L'International
IL MOTO di ROTAZIONE. CONSEGUENZE del MOTO di ROTAZIONE
 IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
AFAM - Remanzacco. Serata osservativa dell 11 ottobre
 AFAM - Remanzacco Serata osservativa dell 11 ottobre Cielo del 15 settembre a Remanzacco Nettuno Saturno Urano Albireo Nebulosa M 57 P Cygni Galassia M 81 Ammasso M 13 Stella Polare La Luna sorge alle
AFAM - Remanzacco Serata osservativa dell 11 ottobre Cielo del 15 settembre a Remanzacco Nettuno Saturno Urano Albireo Nebulosa M 57 P Cygni Galassia M 81 Ammasso M 13 Stella Polare La Luna sorge alle
sistema composto da: 1. Sezione orbitante (satelliti) 2. Sezione terrestre (antenna e ricevitore) 3. Sezione di controllo (stazioni a terra)
 IL GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) SISTEMA GLOBALE DI RILEVAMENTO DELLA POSIZIONE NAVSTAR GPS NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System sistema di posizionamento e navigazione satellitare
IL GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) SISTEMA GLOBALE DI RILEVAMENTO DELLA POSIZIONE NAVSTAR GPS NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System sistema di posizionamento e navigazione satellitare
La relatività generale. Lezioni d'autore
 La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
La relatività generale Lezioni d'autore Il GPS (RaiScienze) VIDEO Einstein e la teoria della relativita (History Channel) VIDEO Einstein: dimostrazione della teoria generale della gravità (History Channel))
Relazione breve su dati di illuminazione e impermeabilizzazione
 AS / Lt-Agro, creazione: 2008-02-14 modifiche: 09.58 / 2008-03-05, Pagina 1 di 9 Relazione breve su dati di illuminazione e impermeabilizzazione Progetto Lights Andrea Spisni (aspisni@arpa.emr.it) Lab.
AS / Lt-Agro, creazione: 2008-02-14 modifiche: 09.58 / 2008-03-05, Pagina 1 di 9 Relazione breve su dati di illuminazione e impermeabilizzazione Progetto Lights Andrea Spisni (aspisni@arpa.emr.it) Lab.
Leader mondiale nei satelliti meteorologici geostazionari, dalla provata esperienza
 THALES ALENIA SPACE UNA GAMMA COMPLETA DI TECNOLOGIE PER L OSSERVAZIONE DELLA TERRA Leader mondiale nei satelliti meteorologici geostazionari, dalla provata esperienza nelle missioni di osservazione della
THALES ALENIA SPACE UNA GAMMA COMPLETA DI TECNOLOGIE PER L OSSERVAZIONE DELLA TERRA Leader mondiale nei satelliti meteorologici geostazionari, dalla provata esperienza nelle missioni di osservazione della
L esplorazione dello spazio. Enrico Degiuli Classe Terza
 L esplorazione dello spazio Enrico Degiuli Classe Terza Lo Sputnik 1, il primo satellite Lo Sputnik 1 è stato il primo satellite artificiale (sputnik significa satellite). E stato messo in orbita dall
L esplorazione dello spazio Enrico Degiuli Classe Terza Lo Sputnik 1, il primo satellite Lo Sputnik 1 è stato il primo satellite artificiale (sputnik significa satellite). E stato messo in orbita dall
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani : - Azione1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave nelle
 Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani : - Azione1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave nelle scienze PON C1-Codice: C-1-FSE-2013-2614 - Lezioni di astronomia
Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani : - Azione1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave nelle scienze PON C1-Codice: C-1-FSE-2013-2614 - Lezioni di astronomia
Abbiamo parlato del Sole, della Luna e di un po di altre cosette, qua e là, che fanno parte del Sistema Solare.
 Ciao! Abbiamo parlato del Sole, della Luna e di un po di altre cosette, qua e là, che fanno parte del Sistema Solare. Ti ricordi della cipolla??? Bene, stavolta partiamo dall interno. C è il Sole, poi
Ciao! Abbiamo parlato del Sole, della Luna e di un po di altre cosette, qua e là, che fanno parte del Sistema Solare. Ti ricordi della cipolla??? Bene, stavolta partiamo dall interno. C è il Sole, poi
La missione Planck. Francesco Piacentini. il lancio e le fasi della missione. 14 Maggio 2009 lancio di Planck. Francesco Piacentini.
 La missione Planck il lancio e le fasi della missione Page 1 Il lancio di Planck Planck viene lanciato dallo spazioporto di Kourou (Guiana Francese) 14 maggio 2009, 13:12 UTC (15:12 CET) + 55 minuti di
La missione Planck il lancio e le fasi della missione Page 1 Il lancio di Planck Planck viene lanciato dallo spazioporto di Kourou (Guiana Francese) 14 maggio 2009, 13:12 UTC (15:12 CET) + 55 minuti di
AFAM - Remanzacco. Serata osservativa del 19 novembre
 AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 19 novembre Cielo del 19 novembre a Remanzacco Galassie M 31 - M 32 Urano Nettuno Miram Phi Tauri Nebulosa M 76 Stella Polare Ammasso M 15 Doppio Ammasso del Perseo
AFAM - Remanzacco Serata osservativa del 19 novembre Cielo del 19 novembre a Remanzacco Galassie M 31 - M 32 Urano Nettuno Miram Phi Tauri Nebulosa M 76 Stella Polare Ammasso M 15 Doppio Ammasso del Perseo
L inquinamento luminoso visto da satellite
 L inquinamento luminoso visto da satellite Prof. Gabriele Moser Università degli Studi di Genova Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) gabriele.moser@unige.it
L inquinamento luminoso visto da satellite Prof. Gabriele Moser Università degli Studi di Genova Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) gabriele.moser@unige.it
LA MATEMATICA DELLE MISSIONI SPAZIALI. Daniele Serra - Università di Pisa
 LA MATEMATICA DELLE MISSIONI SPAZIALI Daniele Serra - Università di Pisa XIII Settimana Matematica - 9 Febbraio 2017 La mathematica è l'alfabeto in cui Dio à scritto l'universo. Galileo Galilei MISSIONI
LA MATEMATICA DELLE MISSIONI SPAZIALI Daniele Serra - Università di Pisa XIII Settimana Matematica - 9 Febbraio 2017 La mathematica è l'alfabeto in cui Dio à scritto l'universo. Galileo Galilei MISSIONI
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE. 9.1 Introduzione.
 CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
CAPITOLO 9: LA GRAVITAZIONE 9.1 Introduzione. Un altro tipo di forza piuttosto importante è la forza gravitazionale. Innanzitutto, è risaputo che nel nostro sistema di pianeti chiamato sistema solare il
Eventi estremi: come mai sempre più frequenti e cosa fare per limitarne i danni
 Eventi estremi: come mai sempre più frequenti e cosa fare per limitarne i danni MARTEDì 03 APRILE Luca Maffezzoni 1) Trattato di HADLEY riguardante la circolazione atmosferica globale e moto dei venti
Eventi estremi: come mai sempre più frequenti e cosa fare per limitarne i danni MARTEDì 03 APRILE Luca Maffezzoni 1) Trattato di HADLEY riguardante la circolazione atmosferica globale e moto dei venti
IL GPS sistema di satelliti segmento di terra segnali elettromagnetici ricevitori
 IL GPS Il GPS Global Positioning System è costituito da un sistema di satelliti orbitanti all altezza di circa 20.000 km, controllati da un segmento di terra che ne determina con precisione le orbite.
IL GPS Il GPS Global Positioning System è costituito da un sistema di satelliti orbitanti all altezza di circa 20.000 km, controllati da un segmento di terra che ne determina con precisione le orbite.
Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più
 Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più completa. I dati forniti permettevano di arrivare alla soluzione
Tra le soluzioni pervenute pubblichiamo, con le dovute correzioni e precisazioni, quella inviata da Raffaele Campanile, perché ritenuta la più completa. I dati forniti permettevano di arrivare alla soluzione
6 Agosto 1945 ore 8:15 viene lanciata la bomba atomica su Hiroshima
 6 Agosto 1945 ore 8:15 viene lanciata la bomba atomica su Hiroshima 9 Agosto 1945 ore 11:01 viene lanciata la bomba atomica su Nagasaki Little Boy, la bomba lanciata su Hiroshima9,10) Peso 3200 kg Potenza
6 Agosto 1945 ore 8:15 viene lanciata la bomba atomica su Hiroshima 9 Agosto 1945 ore 11:01 viene lanciata la bomba atomica su Nagasaki Little Boy, la bomba lanciata su Hiroshima9,10) Peso 3200 kg Potenza
UNITÀ DIDATTICA 11 LE COORDINATE GEOGRAFICHE
 UNITÀ DIDATTICA 11 LE COORDINATE GEOGRAFICHE 11.1 Il reticolato geografico La forma della Terra si discosta poco da quella di una sfera. Sulla superficie terrestre, considerata come sferica, è possibile
UNITÀ DIDATTICA 11 LE COORDINATE GEOGRAFICHE 11.1 Il reticolato geografico La forma della Terra si discosta poco da quella di una sfera. Sulla superficie terrestre, considerata come sferica, è possibile
METEOROLOGIA SINOTTICA
 DEFINIZIONE COMPOSIZIONE TEMPERATURA PRESSIONE DENSITÀ RELAZIONE PRESSIONE - QUOTA - TEMPERATURA SUPERFICI ISOBARICHE ATMOSFERA STANDARD ICAO SISTEMI BARICI AL SUOLO tra 0 e 100 km COMPOSIZIONE DELL ATMOSFERA
DEFINIZIONE COMPOSIZIONE TEMPERATURA PRESSIONE DENSITÀ RELAZIONE PRESSIONE - QUOTA - TEMPERATURA SUPERFICI ISOBARICHE ATMOSFERA STANDARD ICAO SISTEMI BARICI AL SUOLO tra 0 e 100 km COMPOSIZIONE DELL ATMOSFERA
Introduzione INTRODUZIONE
 Introduzione INTRODUZIONE La comunicazione satellitare è nata sostanzialmente per sopperire alle difficoltà caratteristiche delle comunicazioni terrestri (cavi, radiofrequenze, ecc). Il sistema satellitare,
Introduzione INTRODUZIONE La comunicazione satellitare è nata sostanzialmente per sopperire alle difficoltà caratteristiche delle comunicazioni terrestri (cavi, radiofrequenze, ecc). Il sistema satellitare,
Glossario Meteo. Lettera S - Da Saccatura a Subsidenza
 Saccatura Si forma da un prolungamento di una bassa pressione con circolazione di sistemi frontali. Porta di solito brutto tempo con venti forti e precipitazioni intense a causa dello scontro di masse
Saccatura Si forma da un prolungamento di una bassa pressione con circolazione di sistemi frontali. Porta di solito brutto tempo con venti forti e precipitazioni intense a causa dello scontro di masse
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania. Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
PLUTONE. Labardi-Tofani 5 L NONO PIANETA O NANO PIANETA?
 PLUTONE Labardi-Tofani 5 L NONO PIANETA O NANO PIANETA? Plutone è un pianeta nano orbitante nelle regioni periferiche del sistema solare, con un'orbita eccentrica a cavallo dell'orbita di Nettuno fu scoperto
PLUTONE Labardi-Tofani 5 L NONO PIANETA O NANO PIANETA? Plutone è un pianeta nano orbitante nelle regioni periferiche del sistema solare, con un'orbita eccentrica a cavallo dell'orbita di Nettuno fu scoperto
 luna http://www.comuni-italiani.it/soleluna/comune/017029/ selene La Luna è tra le protagoniste della mitologia e della letteratura, nonché di riti e credenze popolari. sistema biplanetario. luna 1.738
luna http://www.comuni-italiani.it/soleluna/comune/017029/ selene La Luna è tra le protagoniste della mitologia e della letteratura, nonché di riti e credenze popolari. sistema biplanetario. luna 1.738
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
Progetto adriamet meteorologia per la nautica in Adriatico Card informativa Partner di progetto
 Progetto adriamet meteorologia per la nautica in Adriatico Card informativa Partner di progetto Progetto cofinanziato dall Unione Europea Programma INTERREG IIIA, transfrontaliero Adriatico www.adriamet.info
Progetto adriamet meteorologia per la nautica in Adriatico Card informativa Partner di progetto Progetto cofinanziato dall Unione Europea Programma INTERREG IIIA, transfrontaliero Adriatico www.adriamet.info
Serata su GPS. Luca Delucchi. 7 Giugno 2013, Trento. Fondazione Edmund Mach - GIS & Remote Sensing Unit.
 Serata su GPS Fondazione Edmund Mach - GIS & Remote Sensing Unit http://gis.cri.fmach.it 1 Cos è e come funziona Storia 2 Datalogger GPS Cellulari 3 Waypoints Tracce Rotte TracBack Bussola elettronica
Serata su GPS Fondazione Edmund Mach - GIS & Remote Sensing Unit http://gis.cri.fmach.it 1 Cos è e come funziona Storia 2 Datalogger GPS Cellulari 3 Waypoints Tracce Rotte TracBack Bussola elettronica
Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera
 Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera TRAPPIST-1 ed i 7 pianeti Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta simile alla
Alla ricerca di un altra Terra! Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera TRAPPIST-1 ed i 7 pianeti Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta simile alla
3. Quale lavoro bisogna compiere per fermare un auto di 1000 kg che si muove a 180 km/h?
 Forze e Attrito 1. Un corpo del peso di 100N disposto su un piano inclinato di 30 si mette in movimento quando si applica ad esso una forza diretta orizzontalmente di 20N. Si determini il coefficiente
Forze e Attrito 1. Un corpo del peso di 100N disposto su un piano inclinato di 30 si mette in movimento quando si applica ad esso una forza diretta orizzontalmente di 20N. Si determini il coefficiente
Esperimentazioni di Fisica 1 L accelerazione di gravità
 Esperimentazioni di Fisica 1 L accelerazione di gravità Università Roma Tre - Dipartimento di Matematica e Fisica 21 maggio 2016 Misurazione dell accelerazione di gravità L accelerazione di gravità Un
Esperimentazioni di Fisica 1 L accelerazione di gravità Università Roma Tre - Dipartimento di Matematica e Fisica 21 maggio 2016 Misurazione dell accelerazione di gravità L accelerazione di gravità Un
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Dati caratteristici. La Luna ed i suoi movimenti
 La Luna ed i suoi movimenti Dati caratteristici Raggio medio: 1738 km Volume: 22 109 km 3 Massa: 7,35 1022 kg Densità: 3,34 g/cm 3 Dato che ha una massa che è circa 1/81 di quella della Terra, la sua gravità
La Luna ed i suoi movimenti Dati caratteristici Raggio medio: 1738 km Volume: 22 109 km 3 Massa: 7,35 1022 kg Densità: 3,34 g/cm 3 Dato che ha una massa che è circa 1/81 di quella della Terra, la sua gravità
TOPOGRAFIA E GPS. Edizione n /19
 TOPOGRAFIA E GPS Edizione n. 03-2018/19 Corso specialistico per Volontari di Protezione Civile, conforme alla D.G.R. n. XI/1190 del 28-01-2019, Codice A2-10 Organizzazione: Settore formazione del CCV-Bg
TOPOGRAFIA E GPS Edizione n. 03-2018/19 Corso specialistico per Volontari di Protezione Civile, conforme alla D.G.R. n. XI/1190 del 28-01-2019, Codice A2-10 Organizzazione: Settore formazione del CCV-Bg
5 CORSO DI ASTRONOMIA
 5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
5 CORSO DI ASTRONOMIA Evoluzione dell Universo e Pianeti Extrasolari 13 febbraio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Parte Prima La Teoria
Il movimento. Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani
 Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Il movimento Il fenomeno del movimento è estremamente vario; gli oggetti e gli esseri viventi si muovono nei modi più svariati complicati e strani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GIOSTRA 11 MOTO ARMONICO LINK 12
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto Roberto Barbiero
 Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Il forte temporale osservato a Besenello nella giornata del 26 agosto 2004 Roberto Barbiero Descrizione meteorologica della giornata del 26 agosto 2004 L analisi generale delle condizioni meteorologiche
Esercizi di dinamica
 Esercizi di dinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2003-2004 M F1, m v0 α F2, M α F3 Esercizio 1 Un blocco di massa M = 1.20 kg (figura F1) si trova in equilibrio appoggiato su una molla
Esercizi di dinamica Esercitazioni di Fisica LA per ingegneri - A.A. 2003-2004 M F1, m v0 α F2, M α F3 Esercizio 1 Un blocco di massa M = 1.20 kg (figura F1) si trova in equilibrio appoggiato su una molla
29/10/2017. luminescenza.
 Orientarsi significa determinare la propria posizione rispetto a dei punti di riferimento. In passato il riferimento era il punto da cui sorge il sole (dal latino oriri, sorgere). Per orientarsi la prima
Orientarsi significa determinare la propria posizione rispetto a dei punti di riferimento. In passato il riferimento era il punto da cui sorge il sole (dal latino oriri, sorgere). Per orientarsi la prima
Quadrantidi Giuseppe Allocca, Lorenzo Barbieri, Fabio Balboni, Gaetano Brando, Daniele Cifiello
 Quadrantidi 2016 Giuseppe Allocca, Lorenzo Barbieri, Fabio Balboni, Gaetano Brando, Daniele Cifiello Associazione Astrofili Bolognesi Sezione di Ricerca Meteore/RAMBO www.ramboms.com March 14, 2016 Introduzione
Quadrantidi 2016 Giuseppe Allocca, Lorenzo Barbieri, Fabio Balboni, Gaetano Brando, Daniele Cifiello Associazione Astrofili Bolognesi Sezione di Ricerca Meteore/RAMBO www.ramboms.com March 14, 2016 Introduzione
ANOMALIA DI BOUGUER (4.1.1) dove G è la costante di gravitazione universale, pari a m3kg-1s-2. (4.1.2)
 ANOMALIA DI BOUGUER La gravità è, tra tutte le forze della natura, quella cui siamo maggiormente soggetti; essa influenza quotidianamente la nostra esistenza. Anche all interno dell universo l'attrazione
ANOMALIA DI BOUGUER La gravità è, tra tutte le forze della natura, quella cui siamo maggiormente soggetti; essa influenza quotidianamente la nostra esistenza. Anche all interno dell universo l'attrazione
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
 SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Il Sistema Solare TERRA MARTE E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo quarto pianeta
Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle.
 1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
Moti della Terra. Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari
 Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
Agenzia Spaziale Italiana. Evoluzioni e Prospettive
 Agenzia Spaziale Italiana Evoluzioni e Prospettive 2010-2020 1 Il Documento di Visione Strategica (2010-2020) Il DVS pubblicato dall ASI nel 2010 definisce: I pilastri del piano strategico Gli elementi
Agenzia Spaziale Italiana Evoluzioni e Prospettive 2010-2020 1 Il Documento di Visione Strategica (2010-2020) Il DVS pubblicato dall ASI nel 2010 definisce: I pilastri del piano strategico Gli elementi
Il Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia nel sistema regionale di Protezione Civile
 Il Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia nel sistema regionale di Protezione Civile Mauro Valentini «Le attività di ARPA in materia di sicurezza e gestione dei rischi per l ambiente» Servizio Meteorologico
Il Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia nel sistema regionale di Protezione Civile Mauro Valentini «Le attività di ARPA in materia di sicurezza e gestione dei rischi per l ambiente» Servizio Meteorologico
15 - il tempo meteorologico
 15. Il tempo meteorologico Se vogliamo descrivere a un amico lontano che tempo fa oggi, diciamo, per esempio, che la giornata è variabile, con sole e nubi che si alternano, oppure che è fredda e piovosa
15. Il tempo meteorologico Se vogliamo descrivere a un amico lontano che tempo fa oggi, diciamo, per esempio, che la giornata è variabile, con sole e nubi che si alternano, oppure che è fredda e piovosa
METEOROLOGIA: CONFERENZA DEI PREVISORI E VISITA ALLA SEDE DELL OSMER DI PALMANOVA
 Incontri di METEOROLOGIA: CONFERENZA DEI PREVISORI E VISITA ALLA SEDE DELL OSMER DI PALMANOVA di Emma Pinosio, Federico Liani e Tommaso Marioni - classe 1G A maggio, in occasione della Settimana dell'arte
Incontri di METEOROLOGIA: CONFERENZA DEI PREVISORI E VISITA ALLA SEDE DELL OSMER DI PALMANOVA di Emma Pinosio, Federico Liani e Tommaso Marioni - classe 1G A maggio, in occasione della Settimana dell'arte
RAPPORTO TECNICO DELL ATTIVITA ESPLOSIVA DEL 12 GENNAIO 2011 OSSERVAZIONE E SIMULAZIONE DELL EMISSIONE DI CENERE
 Prot. int. n UFVG2011/08 RAPPORTO TECNICO DELL ATTIVITA ESPLOSIVA DEL 12 GENNAIO 2011 OSSERVAZIONE E SIMULAZIONE DELL EMISSIONE DI CENERE Mauro Coltelli, Michele Prestifilippo, Simona Scollo, Gaetano Spata
Prot. int. n UFVG2011/08 RAPPORTO TECNICO DELL ATTIVITA ESPLOSIVA DEL 12 GENNAIO 2011 OSSERVAZIONE E SIMULAZIONE DELL EMISSIONE DI CENERE Mauro Coltelli, Michele Prestifilippo, Simona Scollo, Gaetano Spata
1. L ambiente celeste
 1. L ambiente celeste Arecibo (Puerto Rico, Antille), 12 ottobre 1992: cinquecentesimo anniversario della scoperta dell America. Il potente radiotelescopio, la cui parabola riveste un ampia cavità naturale,
1. L ambiente celeste Arecibo (Puerto Rico, Antille), 12 ottobre 1992: cinquecentesimo anniversario della scoperta dell America. Il potente radiotelescopio, la cui parabola riveste un ampia cavità naturale,
Astronomia Osservazione del cielo
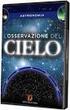 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
QUEI SEGNALI PROVENGONO DALLE ASTRONAVI SU SATURNO
 RISPOSTA DELL'ARCANGELO MICHELE RIGUARDO L'ARTICOLO SOTTOSTANTE: Nel 1532 l'incontro fra la Germania e la Svizzera protestante, che ultimamente adattarono il loro credo in alcune loro riforme della chiesa,
RISPOSTA DELL'ARCANGELO MICHELE RIGUARDO L'ARTICOLO SOTTOSTANTE: Nel 1532 l'incontro fra la Germania e la Svizzera protestante, che ultimamente adattarono il loro credo in alcune loro riforme della chiesa,
Sistema Solare come riconoscere pianeti e fenomeni celesti
 Sistema Solare come riconoscere pianeti e fenomeni celesti LE ORBITE Venere e Mercurio hanno orbite interne a quella terrestre Sono visibili solamente al tramonto o all alba alba durante le elongazioni
Sistema Solare come riconoscere pianeti e fenomeni celesti LE ORBITE Venere e Mercurio hanno orbite interne a quella terrestre Sono visibili solamente al tramonto o all alba alba durante le elongazioni
WLTP. Informazioni riguardo la nuova procedura di test sui consumi e sulle emissioni
 Informazioni riguardo la nuova procedura di test sui consumi e sulle emissioni Sulla base delle disposizioni ambientali più severe e dello sviluppo di nuove tecnologie di propulsione e mobilità, cambiano
Informazioni riguardo la nuova procedura di test sui consumi e sulle emissioni Sulla base delle disposizioni ambientali più severe e dello sviluppo di nuove tecnologie di propulsione e mobilità, cambiano
CULTURE E FORMATI DELLA TV E DELLA RADIO / Enrico Menduni / / A
 CULTURE E FORMATI DELLA TV E DELLA RADIO / Enrico Menduni / 15.3.18 / A Reti telefoniche e televisione Le linee telefoniche sono servite a trasportare il segnale radiofonico e televisivo, come mostra questa
CULTURE E FORMATI DELLA TV E DELLA RADIO / Enrico Menduni / 15.3.18 / A Reti telefoniche e televisione Le linee telefoniche sono servite a trasportare il segnale radiofonico e televisivo, come mostra questa
Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane.
 Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018
 4/12/2018 Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018 Figura 1. Copertura parzialmente divelta. Pellizzano 24 ottobre 2018. Il 24 ottobre forti venti settentrionali hanno interessato le Alpi.
4/12/2018 Vento forte e temperature massime elevate 24 ottobre 2018 Figura 1. Copertura parzialmente divelta. Pellizzano 24 ottobre 2018. Il 24 ottobre forti venti settentrionali hanno interessato le Alpi.
L a S c u o l a C o p e r n i c u s
 L a S c u o l a C o p e r n i c u s 2 0 1 8 I l T e l e r i l e v a m e n t o p e r l A g r i c o l t u r a 4. 0 Esempio pratico nell uso dei dati satellitari gratuiti Sentinel per l agricoltura con il
L a S c u o l a C o p e r n i c u s 2 0 1 8 I l T e l e r i l e v a m e n t o p e r l A g r i c o l t u r a 4. 0 Esempio pratico nell uso dei dati satellitari gratuiti Sentinel per l agricoltura con il
DEFINIZIONE DELLO SPAZIO
 DEFINIZIONE DELLO SPAZIO LIBERARE DEGLI OGGETTI DALL ATTRAZIONE TERRESTRE PONENDOLI SIA SU UN ORBITA ELLITTICA INTORNO ALLA TERRA SIA SU UN ORBITA ELLITTICA INTORNO AL SOLE QUINDI DUE SFACCETTATURE: BALISTICA,CHE
DEFINIZIONE DELLO SPAZIO LIBERARE DEGLI OGGETTI DALL ATTRAZIONE TERRESTRE PONENDOLI SIA SU UN ORBITA ELLITTICA INTORNO ALLA TERRA SIA SU UN ORBITA ELLITTICA INTORNO AL SOLE QUINDI DUE SFACCETTATURE: BALISTICA,CHE
Wireless Fidelity. Introduzione a WI-FI (WIreless FIdelity). Cos è WI-FI. Come funziona WI-FI. INFORMATICA Le reti
 Introduzione a WI-FI (WIreless FIdelity). Cos è WI-FI. Come funziona WI-FI. Cosa si fa e cosa si potrà fare con WI-FI. La sicurezza nel WI-FI. L importanza di WI-FI. Introduzione a WI-FI (WIreless FIdelity)
Introduzione a WI-FI (WIreless FIdelity). Cos è WI-FI. Come funziona WI-FI. Cosa si fa e cosa si potrà fare con WI-FI. La sicurezza nel WI-FI. L importanza di WI-FI. Introduzione a WI-FI (WIreless FIdelity)
Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI SS SISTEMI SPAZIALI
 Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI SS SISTEMI SPAZIALI PROBLEMI INGEGNERIA SPAZIALE 2 Dinamicai Meccanica del volo spaziale Sistemi di propulsione Rientro atmosferico Strutture Controllo
Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI SS SISTEMI SPAZIALI PROBLEMI INGEGNERIA SPAZIALE 2 Dinamicai Meccanica del volo spaziale Sistemi di propulsione Rientro atmosferico Strutture Controllo
Energia solare. Prof.ssa Matilde Pietrafesa
 Prof.ssa Matilde Pietrafesa Università Mediterranea Reggio Calabria Dipartimento DIIES dell Informazione, delle Infrastrutture e dell Energia Sostenibile Energia solare 05/04/2016 1 Temperatura del Sole
Prof.ssa Matilde Pietrafesa Università Mediterranea Reggio Calabria Dipartimento DIIES dell Informazione, delle Infrastrutture e dell Energia Sostenibile Energia solare 05/04/2016 1 Temperatura del Sole
Le leggi di Keplero modello geocentrico modello eliocentrico
 Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
Le leggi di Keplero Fino al 1600 si credeva che: la Terra fosse al centro dell'universo, con il Sole e i pianeti orbitanti attorno (modello geocentrico) (Esempio: modello aristotetelico-tolemaico); i corpi
PREREQUISITI ASPETTI TEORICI
 .- 1 - PREREQUISITI ASPETTI TEORICI LA SFERA CELESTE ED I SUOI ELEMENTI VOLTA E SFERA CELESTE LE PRINCIPALI COORDINATE ASTRONOMICHE COORDINATE ORIZZONTALI E COORDINATE EQUATORIALI pag. 2 pag. 3 CORRISPONDENZA
.- 1 - PREREQUISITI ASPETTI TEORICI LA SFERA CELESTE ED I SUOI ELEMENTI VOLTA E SFERA CELESTE LE PRINCIPALI COORDINATE ASTRONOMICHE COORDINATE ORIZZONTALI E COORDINATE EQUATORIALI pag. 2 pag. 3 CORRISPONDENZA
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
 ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2014-836 del 03/12/2014 Oggetto Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2014-836 del 03/12/2014 Oggetto Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento
2. IL GLOBO TERRESTRE VISTO DALLO SPAZIO
 2. IL GLOBO TERRESTRE VISTO DALLO SPAZIO 2004 EUMETSAT SOTTO LO SGUARDO DEI SATELLITI 1 VISTE GEOSTAZIONARIE DELLA TERRA La maggior parte dei satelliti meteorologici sono posizionati su un orbita geostazionaria
2. IL GLOBO TERRESTRE VISTO DALLO SPAZIO 2004 EUMETSAT SOTTO LO SGUARDO DEI SATELLITI 1 VISTE GEOSTAZIONARIE DELLA TERRA La maggior parte dei satelliti meteorologici sono posizionati su un orbita geostazionaria
L illuminazione della Terra
 L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
Ciao! Ma ricorda la cosa più importante:
 Ciao! La volta scorsa abbiamo parlato della radiazione che ci arriva dalla nostra galassia e a come possiamo raccoglierla per studiarla con sensori diversi che permettono di vedere aspetti diversi dello
Ciao! La volta scorsa abbiamo parlato della radiazione che ci arriva dalla nostra galassia e a come possiamo raccoglierla per studiarla con sensori diversi che permettono di vedere aspetti diversi dello
