15.5 RISULTATI ANALITICI CAMPAGNA DI SETTEMBRE 2003
|
|
|
- Aureliano Danieli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Fig. 33 pozzi campionati nella campagna di settembre
2 15.5 RISULTATI ANALITICI CAMPAGNA DI SETTEMBRE 2003 Il laboratorio CSA (Centro Studi Ambientali) di Rimini ha effettuato le analisi degli organici secondo la metodica di pretrattamento ed analisi qui illustrata. Si deve premettere che i metodi di pretrattamento sono basati sulla separazione dell analita dalla matrice per volatilizzazione. Esistono diversi tipi di pretrattamento: i metodi EPA sono basati sulla tecnica dello spazio di testa (5021), distillazione sottovuoto (5032) e purge and trap (5035 e 5030b). Il metodo IRSA 23a prevede invece l estrazione degli analiti in n-pentano. Esiste infine un metodo ISO per il pretrattamento dei composti organici (ISO 14507). Il laboratorio CSA di Rimini utilizza, per le acque, il metodo, chiamato di autocampionamento purge and trap (EPA 5030b, 1996), il quale prevede che un quantitativo definito di campione (5-25 ml) venga prelevato da un vial del volume di 40 ml e alloggiato in uno sparger vial alloggiato nell unità purge and trap Nello sparger vial, tramite un flusso costante di gas inerte (generalmente viene utilizzato elio), si estraggono i composti volatili contenuti nel campione d acqua, i quali vengono fissati tramite adsorbimento in una trappola adsorbente. Le sostanze adsorbite vengono rilasciate mediante desorbimento termico ed analizzate in un gascromatografo (colonna capillare da 60 m, diametro interno 0.25 mm, 1.5 µm di film di fase stazionaria tipo VOCOL) accoppiato ad uno spettrometro di massa a trappola ionica con modalità di acquisizione in SCAN da 35 a 350 m/z (metodo EPA 8260b, 1996). La quantificazione degli analiti viene effettuata mediante tecnica dello standard interno. CSA effettua inoltre un controllo di qualità tramite calibrazione, un controllo della funzionalità strumentale e un controllo del metodo. La calibrazione prevede la costruzione della retta di taratura degli analiti mediante l analisi di soluzioni acquose standard a cinque livelli di concentrazione a tenore costante di standard interno (Fluorobenzene, Clorobenzene-d5, 1,4- diclorobenzene-d4). Il controllo della funzionalità strumentale avviene attraverso tre controlli: analisi tuning standard, per la buona funzionalità dello spettrometro di massa; analisi di funzionalità del sistema cromatografico, per verificare la buona funzionalità del sistema purge and trap gascromatografo; controllo della taratura attraverso il controllo della retta di taratura di soluzioni acquose di 1,1 dicloroetene, cloroformio, 1,2 dicloropropano e toluene. Infine il controllo del metodo prevede l analisi del bianco (method blank), il controllo dei recuperi dei surrogati (bromodifluorometano, 1,2 diclorometano-d4, toluene-d8 e bromofluorobenzene) nei campioni e la verifica dei campioni doppi spike matrice ovvero aliquote di campione a cui sono aggiunte quantità note di analiti per documentare l effetto della matrice sul metodo (per ulteriori informazioni vedi anche ( In Tabella 9 sono mostrate le concentrazioni degli organici ottenute. Le concentrazioni di CVM rilevate risultano essere di gran lunga superiori non solo al limite stabilito dalla legge (0.5 µg/l) ma anche rispetto ai riscontri analitici di ARPA ed EST dei precedenti campionamenti; tali differenze, in alcuni casi, arrivano ai 2 ordini di grandezza. Il superamento della concentrazione limite accettabile del DM 471/99 risulta in 8 pozzi privati e 2 pubblici a Pontelagoscuro e nei 2 piezometri ARPA di Pontelagoscuro. Per effettuare un confronto fra le concentrazioni ottenute, in Tab. 10 è mostrato il dato CSA accanto al massimo dato ARPA ed EST, relativamente al CVM; laddove il confronto manca è perché quel punto non era mai stato campionato in precedenza. Su un totale di 35 punti campionati, pertanto, 16 non erano mai stati campionati né da ARPA né da EST. Nella Figure sono mostrate le concentrazioni rilevate da CSA rispetto a quanto rilevato da ARPA ed EST per Campo sportivo ed Orto Anziani. 87
3 Tab. 9 : risultati analitici sugli organici 88
4 Tab. 10 I dati sono relativi alle concentrazioni di CVM in µg/l. 89
5 CVM Orto Aziani Pontelagoscuro concentrazioni ppb /07/ /11/01 11/26/ /03/02 6/27/2002 7/24/ /21/ /11/02 2/13/ /03/ /03/03 6/10/2003 6/19/2003 7/9/ /07/03 9/23/ /22/2003 giorni campionamento Arpa Est "arpa piezometro" CSA pozzo CSA piezom.. CVM Campo sportivo Pontelagoscuro concentrazioni in ppb /07/ /11/01 11/26/ /03/02 6/27/2002 giorni campionamento 7/24/ /21/ /11/02 2/13/ /03/ /03/03 6/10/2003 7/9/ /07/03 9/23/ /10/20003 Arpa Est "Arpa piezometro" CSA pozzo CSA piezom Fig.re n 34-35: confronto fra analisi CSA e precedenti analisi ARPA/EST. 90
6 Stante la estrema severità della contaminazione rilevata, con concentrazioni analoghe a quelle rilevate all interno degli stabilimenti petrolchimici, è stato immediatamente deciso un campionamento contemporaneo fra ARPA e CSA, con le medesime modalità di prelievo, sui 3 pozzi privati che erano risultati più contaminati. Tale campionamento si è tenuto in data 22 ottobre In Tabella 11 sono mostrati i confronti fra le concentrazioni rilevate da CSA ed ARPA ed il valore del rapporto di concentrazione; addirittura in questo secondo campionamento il valore massimo rilevato da CSA aumenta nel pozzo di via Aminta 69 passando da 6632 ppb a 8589 ppb. Tab. 11 : risultati analitici del campionamento contemporaneo con ARPA Pertanto vengono considerate valide le concentrazioni rilevate in Settembre e vengono ora commentati i risultati ottenuti. Fra i superamenti del valore limite la concentrazione minima rilevata, pari a 74.2 ppb, è stata riscontrata nel piezometro del campo sportivo (n. campione 3), mentre la concentrazione massima, pari a 6632 ppb (8589 ppb in Ottobre) è stata rilevata in un pozzo privato di via Aminta (n. campione 17). Altissime concentrazioni sono state rilevate anche in via Zanaboni (3157 ppb, n. campione 9) e in via Della Pace (2777 ppb, n. campione 1). Di estremo rilievo è notare che, a differenza di quanto accade all interno degli stabilimenti petrolchimici, tali elevatissime concentrazioni di CVM non sono associate ad analoghe degli altri clorurati. Come superamenti del limite si rileva solo tetracloroetilene nei piezometri del campo sportivo di via Venezia (25.4 ppb), dell orto degli anziani (30.4), e nel piezometro superficiale di via Migliari (70.4). Spesso i possibili precursori o metaboliti sono di fatto assenti, in quanto inferiori al limite di rilevabilità. In Fig. 36 è mostrata una semplice interpolazione dei valori analitici rilevati di CVM, effettuata con il software Surfer 7.0, con impiego, come algoritmo di interpolazione, del kriging basato su un variogramma lineare di default. Vanno bene messi in evidenza i limiti di una tale interpolazione: i pozzi campionati, pur attingendo al primo acquifero in pressione, hanno profondità dei tratti filtrati e caratteristiche di completamento sconosciute ed, inoltre, hanno regimi di utilizzo e portate degli impianti di sollevamento affatto diversi. La restituzione, comunque, è sufficiente per delineare l area contaminata ed individuare il sito destinato ad essere oggetto del piano di investigazione. La contaminazione è di fatto legata all area di Pontelagoscuro Nuovo, con esclusione di via Vallelunga e della parte di Pontelagoscuro Vecchio. Si individua una forma allungata nella direzione di deflusso della falda con una distribuzione comunque irregolare dei picchi di concentrazione; ad esempio le concentrazioni massime (6632 e 2777 ppb) si riscontrano in due zone non particolarmente vicine (via Aminta e via Zanaboni), tra le quali i valori di CVM risultano inferiori. Tale risultanza è anche legata alla eterogeneità nella distribuzione della profondità dei pozzi. Comunque viene per la prima volta individuato il plume di contaminazione. 91
7 Fig. 36 : interpolazione dei risultati analitici rilevati di CVM 92
8 SEZIONE D - PIANO DI INVESTIGAZIONE 16. PROGETTAZIONE DEL PIANO DI INVESTIGAZIONE Sulla base dei risultati della campagna di settembre 2003, si è proceduto alla pianificazione dell investigazione, quindi alla formulazione del piano di investigazione con l obiettivo di definire con una caratterizzazione orizzontale e verticale l estensione del plume ed individuare il focolaio della contaminazione. Tale fase è detta acchiappa-plume (plumebuster). Il piano di investigazione, di fatto, è la prima fase vera e propria di caratterizzazione del plume. Abbiamo adottato uno schema concettuale di investigazione in 3 step successivi, in cui il primo step ha per obiettivo la definizione dei contorni del plume, il secondo la definizione della distribuzione della concentrazione lungo l asse longitudinale e trasversale ed il terzo la individuazione delle zone di frangia e del focolaio. Per rendere più comprensibile lo schema concettuale che è stato seguito nella formulazione del piano d investigazione consideriamo quanto riportato in Figura 37 che mostra un possibile modello concettuale del plume. L area rossa è la parte più contaminata, mentre le concentrazioni della sostanza inquinante diminuiscono passando ai colori arancio e giallo; la freccia in basso indica la direzione media del flusso di falda. I punti segnati sono i siti nei quali effettuare i sondaggi con prelievo ed analisi di campioni a differenti profondità entro l acquifero. GP3 GP12 GP14 GP10 GP16 GP1 GP5 GP6 GP7 GP8 GP4 GP11 GP13 GP9 GP15 GP2 I II III IV DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO DI FALDA Fig. n 37: schema concettuale del piano di investigazione. Nello step 1 vengono effettuati i sondaggi (indicati con GP, GroundProbing) 1,2,3,4 per confermare i limiti del plume sulla base della fotografia esistente basata sui pozzi campionati in Settembre 2003; viene effettuato anche il sondaggio GP7 al centro della massa contaminata. Come limite del pennacchio si intende quello delimitato dall isocona della concentrazione limite accettabile. Facendo riferimento alla figura 37 si individuano 4 punti: GP1- punto di monte o bianco: punto a monte del quale non si estende il plume; GP2- border line di destra: punto alla destra del quale non si estende il plume; GP3- border line di sinistra: punto alla sinistra del quale non si estende il plume; GP4- punto di valle: punto a valle del quale non si estende il plume. GP7- punto di centro: baricentro del plume. 93
9 Nello step 2 i sondaggi GP 5,6,8 evidenziano la struttura dell asse longitudinale del pennacchio, mentre il 9 ed il 10 identificano il transetto trasversale centrale. Nello step 3 i sondaggi rimanenti (11,12,13,14,15,16) definiscono le zone di frangia Ogni step è stato preceduto da uno studio a tavolino dei risultati ottenuti dal campionamento precedente. Ogni punto sondaggio risponde infatti ad un preciso quesito, confermando o annullando i fondamenti del modello concettuale precedentemente ipotizzato. Se il modello è confermato la sorgente è localizzata fra GP1 e GP5. Lungo i transetti indicati con i numeri romani da I a IV si determina il flusso di massa del pennacchio (control planes). Ovviamente questo modello può essere smentito in corso d opera. Ecco perché riteniamo che il modo migliore di applicare il piano di investigazione sia procedere a step; ogni fase suggerisce il modo idoneo di applicare la fase successiva. Ad esempio nel caso in cui, nel punto centrale GP7, non venga rilevata la presenza di alcun contaminante, allora il nuovo modello concettuale del pennacchio potrebbe assumere una configurazione simile a quella mostrata in Fig. 38, con il GP3 che prenderebbe il posto del precedente GP1, diventando il nuovo punto di monte, ed il GP4, che nell ipotesi precedente era il punto di valle, che diverrebbe il GP2 ovvero il nuovo border-line di destra (secondo la direzione di flusso). Ovviamente i gradi di libertà di cui disponiamo sono vincolati dalle risultanze della campagna di Settembre 2003, che ha già dato un idea grossolana di come è distribuito il plume. GP3 GP12 GP14 GP10 GP16 GP1 GP5 GP6 GP7 GP8 GP4 GP11 GP13 GP9 GP15 GP2 I II III IV DIREZIONE MEDIA DEL FLUSSO DI FALDA Fig. n 38 : Ipotesi alternativa di modello concettuale da definire in corso d opera. Come informazioni essenziali di supporto per la formulazione del piano di investigazione sono state inoltre acquisite o determinate: piezometria dell acquifero in pressione tramite l effettuazione di una campagna piezometrica sull area del plume, compreso un intorno significativo, in corrispondenza di alcuni step di indagine per verificare la variabilità eventuale del sistema di flusso; distribuzione delle isopache dell acquifero in pressione e delle isobate dal p.c. del tetto e del letto dell acquifero ottenute sulla base delle stratigrafie disponibili, al fine di guidare la corretta profondità di perforazione dei sondaggi e di prelievo dei campioni d acqua. Base di partenza per la attuazione del piano di investigazione è stata, ovviamente, la distribuzione della concentrazione rilevata nella campagna di Settembre L investigazione si è svolta in un lasso di tempo compreso fra Ottobre 2003 e Gennaio
10 16.1 CONFIGURAZIONE IDRODINAMICA DELL ACQUIFERO IN PRESSIONE DURANTE LA FASE DI CARATTERIZZAZIONE Si è ritenuto importante verificare eventuali variazioni nella morfologia della superficie piezometrica rispetto alla struttura osservata nelle piezometrie di dicembre 2002 e giugno Sono state pertanto effettuate 2 ulteriori campagne piezometriche, di cui la prima il Ottobre 2003 (effettuata la settimana precedente l inizio della fase di investigazione) e la seconda il Novembre 2003, fra il primo ed il secondo step della investigazione. La campagna di Ottobre ha visto la misura di 8 pozzi privati nell area di Pontelagoscuro e 5 piezometri (Campo Sportivo, Orto degli Anziani e 3 all interno dell area Solvay). A tale piezometria sono stati aggiunti i livelli piezometrici misurati in 23 pozzi, presenti in golena, del campo di prelievo ACOSEA, anch esso in condizioni statiche, ovvero con i pozzi non in pompaggio (vedi cap.11.2). La campagna di Novembre è ristretta all area di Pontelagoscuro Nuova. Tale campagna ha visto la misura di 4 pozzi privati e 2 piezometri (Campo Sportivo e Orto Anziani). In Fig. 39 vengono mostrate le 4 piezometrie disponibili a confronto relativamente alla zona di Pontelagoscuro. In Tab.10 sono riportati i dati piezometrici di tutte le piezometrie effettuate, relative a 5 pozzi dell area di Pontelagoscuro. Si noti come, al di là delle variazioni di livello, le relazioni fra i livelli rimangano sostanzialmente costanti, confermando una sostanziale uniformità del flusso di falda (con eccezione della magra estrema del Giugno 2003). Si noti anche come nel Novembre 2003 la falda sta risalendo rispetto ad Ottobre ma rimane ancora lontana dai livelli della piena estrema di Dicembre Il plume, pertanto, è stato investigato in condizioni idrologiche medie. Anche se il livello piezometrico medio misurato in Novembre (2,5 m l.m.m.) è risultato essere superiore a quello rilevato nella campagna precedentemente eseguita, si conferma sempre come il flusso sia diretto dal fiume Po verso Sud. Si noti anche come il gradiente idraulico e la direzione media di flusso rimangono sostanzialmente stazionari in quasi tutto l anno; il Po alimenta la falda, quest ultima si muove dal quadrante NW verso quello SE. Quando il Po è più alto il gradiente aumenta e la direzione di flusso tende a disporsi più subparallela al Po. In Giugno 2003, in condizioni eccezionali di magra, il flusso si inverte ma con gradiente assai basso. sigla pozzo dicembre-02 giugno-03 ottobre-03 novembre-03 livello in m.s.l.m. livello in m.s.l.m. livello in m.s.l.m. livello in m.s.l.m , GRADIENTE 2.0X X X X10-3 AZIMUTH NW-SE SSW-NNE NNW-SSE NNW-SSE Tabella 10 : livelli piezometrici, gradiente idraulico medio e direzione media di deflusso di falda a confronto fra 4 piezometrie 95
11 il Logo C. Milzona Botte Possessione Palazzo Possessione Cascina F.S. Stazione livello in s.l.m livello in s.l PONTELAGOSCUR NUOVO 21 F.S PONTELAGOSCUR O NUOVO 21 F.S Piezometria di dicembre 2002 Piezometria di giugno A 34 35A 36A 32A 14A 31A 11A 29 21A 12A 30 8A1A16A 9 9N Pontelagoscuro 5 9 9N m.s.l.m.m N m.s.l.m.m N PONTELAGOSCURO NUOVO PONTELAGOSCURO NUOVO 21 F.S. Stazione 0.7 DIAM PNP Piezometria di ottobre 2003 Piezometria di novembre 2003 Fig. 39 : piezometrie della zona di Pontelagoscuro tra dicembre 2002 e novembre 2003 (quote s.l.m.) 96
12 16.2 ISOBATE DEL TETTO E DEL LETTO DELL ACQUIFERO IN PRESSIONE Per l importanza del litosoma acquifero in esame e per una migliore definizione delle sue caratteristiche geometriche, ne sono state ricostruite le superfici del letto e del tetto a partire dal piano-campagna relativamente all area del plume. Tale elaborazione è essenziale per guidare la perforazione dei sondaggi di investigazione e quindi conoscere a priori quali fossero le profondità ottimali di campionamento dell acqua di falda all interno delle sabbie Würmiane. In Fig. 40 è mostrata la distribuzione delle isobate del tetto dell acquifero da p.c. nella zona indagata; la distribuzione delle isoipse del letto è mostrata in fig. 14. Sono stati eseguiti due profili stratigrafici, le cui tracce sono in Fig.41 uno longitudinalmente all asse presunto del plume (Fig. 42/A) ed uno trasversalmente a questo (Fig.n 42/B). Sono state utilizzate 19 stratigrafie disponibili e archiviate, alcune superficiali (10 m da p.c.), la maggior parte profonde (30 70 m da p.c.). Tali profili mettono in evidenza: 1 un acquifero freatico arealmente discontinuo, costituito da un litosoma sabbioso, sabbioso-limoso avente spessori molto variabili (0.5 8 m) e il tetto ad una profondità rispetto al piano campagna variabile che raggiunge un minimo di circa 5 6 m al di sotto del p.c.; 2 un acquifero profondo arealmente più continuo avente uno spessore variabile fra i 15 e i 25 m da p.c. e con il tetto situato fra i 5 10 m e 15 m da p.c. con una tendenza ad approfondirsi dal Po verso Sud; 3 tra i due acquiferi è presente un livello acquitardo costituito prevalentemente da livelli argillosi, argilloso-limosi con intercalazioni fini di materiale morboso, e con potenza variabile (5 10 m). PONTELAGOSCURO VECCHIO 19 PONTELAGOSCURO NUOVO 11 3 m da p.c Fig. 40: isobate del tetto dell acquifero nella zona di Pontelagoscuro. 97
13 A Pontelagoscuro Z143 9S 72S 78S B 80S 77S 79S 27S1 12N12 12F1-S2 12F1-S1 Possessione Palazzo 12D1 20S 12F12 PONTELAGOSCUR O NUOVO A' 27 F.S. Stazione 3S 1S 20S1 12E26 B' Fig.n 41 : traccia dei 2 profili ed ubicazione delle stratigrafie utilizzate:in verde sono segnate quelle profonde, in rosa quelle superficiali. 98
14 Fig.42/A :Profilo_A-A PROFILO B-B B B Fig.n 42/B :Profilo_B-B 99
15 16.3 INVESTIGAZIONE DEL PLUME ATTRAVERSO IL METODO DIRECT- PUSH Per verificare l effettiva area coinvolta dall inquinamento e la distribuzione verticale delle concentrazioni di CVM, si è proceduto ad una campagna di nuovi sondaggi utilizzando una strategia innovativa di perforazione e campionamento di acqua di falda, appositamente ideata per lo studio dei plume di contaminanti in falda: la metodologia direct-push (ASTM 1996). Il metodo direct-push è una tecnica di perforazione di terreno che permette velocità di perforazione assai elevate se paragonate ai metodi tradizionali (circa 30 m in 1 ora). Consente inoltre di prelevare campioni di acqua a diverse profondità. Alla fine delle operazioni di campionamento il foro creato viene a chiudersi naturalmente grazie alle modeste dimensioni ed al peso litostatico del terreno. In questa metodologia viene utilizzata una macchina idraulica con sistema di avanzamento ad infissione diretta a percussione. Il principio di funzionamento dei sistemi direct-push è simile a quello dei penetrometri utilizzati nel campo geotecnico, anche se è maggiore la frequenza e quindi l energia di infissione: un martello spinge a percussione ad alta frequenza una serie di aste, con all estremità una punta conica, fino alla profondità desiderata. Al termine delle aste viene estruso un campionatore filtrato adeguato, nel nostro caso un tratto filtrato del diametro di circa 3 cm e avente una lunghezza pari ad 80 cm (Fig. n 43, foto 1, foto 2). Fig. n. 43 Campionamento nel mezzo saturo tramite metodologia direct-push. 100
16 Foto n 1: Immagine del metodo direct-push al lavoro mentre inserisce le aste sul GP2. Foto 2 : filtro 101
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2)
 Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
Figura 3: Ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica riferita alla falda superficiale (v. Fig. 2) In particolare i valori di piezometria sono risultati più bassi rispetto a quelli del
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA
 INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO 2. LA PIEZOMETRIA 3. L INQUINAMENTO 4. LA BARRIERA IDRAULICA 1. IL MODELLO CONCETTUALE IDROGEOLOGICO? Il "modello concettuale idrogeologico
CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
 CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE ISPRA 1 La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico
CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE ISPRA 1 La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2 OPERE CIVILI LATO ITALIA MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM Componente acque sotterranee Obiettivi specifici Descrizione dell area
Fig. 2a Distorsione della linea equipotenziale conseguente all immissione in falda dell elettrolita nel pozzo N 29
 1 INDICE 1. PREMESSA.... pag. 2 2. SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI...... pag. 2 3. MISURA DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO IDRICO IN FALDA...... pag. 3 4. PRESENTAZIONE DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI.. pag. 3 FIGURE
1 INDICE 1. PREMESSA.... pag. 2 2. SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI...... pag. 2 3. MISURA DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO IDRICO IN FALDA...... pag. 3 4. PRESENTAZIONE DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI.. pag. 3 FIGURE
A scala del mezzo poroso
 C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
C È ACQUA E ACQUA!! A scala del mezzo poroso Acqua pellicolare Acqua capillare Argilla { Tavola { d acqua Zona satura Zona non satura A scala dell acquifero Piano campagna Zona vadosa Frangia capillare
Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume. Attività svolta nel 2008
 Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume Attività svolta nel 2008 Obiettivo attività: L attività oggetto della seguente presentazione è stata svolta da questa Agenzia su incarico
Monitoraggio sperimentale effettuato con campionatore ad alto volume Attività svolta nel 2008 Obiettivo attività: L attività oggetto della seguente presentazione è stata svolta da questa Agenzia su incarico
DALLA CARATTERIZZAZIONE ALLA BONIFICA DI UN SITO INDUSTRIALE ATTIVO IN UN CONTESTO NORMATIVO IN FASE DI CAMBIAMENTO
 DALLA CARATTERIZZAZIONE ALLA BONIFICA DI UN SITO INDUSTRIALE ATTIVO IN UN CONTESTO NORMATIVO IN FASE DI CAMBIAMENTO C. Sandrone, M. Carboni, P. Goria I siti contaminati, problematiche di bonifica Piacenza,
DALLA CARATTERIZZAZIONE ALLA BONIFICA DI UN SITO INDUSTRIALE ATTIVO IN UN CONTESTO NORMATIVO IN FASE DI CAMBIAMENTO C. Sandrone, M. Carboni, P. Goria I siti contaminati, problematiche di bonifica Piacenza,
Capitolo 12 Le acque sotterranee
 Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
LE ACQUE SOTTERRANEE Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente lungo fratture
SIGEA. La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo. da scavo
 SIGEA La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo Il Campionamento delle Terre e rocce da scavo Bari 14 giugno 2013 Geol. Marcello Panarese
SIGEA La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo Il Campionamento delle Terre e rocce da scavo Bari 14 giugno 2013 Geol. Marcello Panarese
CAPITOLO 7: LA QUALITA DELL ACQUA SOTTERRANEA DI PRIMA FALDA
 CAPITOLO 7: LA QUALITA DELL ACQUA SOTTERRANEA DI PRIMA FALDA PREMESSA L attività di monitoraggio dello stato qualitativo della prima falda della provincia di Verona nasce dalla necessità di conoscere in
CAPITOLO 7: LA QUALITA DELL ACQUA SOTTERRANEA DI PRIMA FALDA PREMESSA L attività di monitoraggio dello stato qualitativo della prima falda della provincia di Verona nasce dalla necessità di conoscere in
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO
GESTIONE delle RISORSE IDRICHE
 Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo Corso di GESTIONE delle RISORSE IDRICHE a.a. 2003-2004 Lezione 4 Prof. Luca Lanza Dipartimento di Ingegneria Ambientale
Indice. Approccio concettuale. Procedura operativa
 Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
Introduzione... pag. 1 Parte A Approccio concettuale 1 Tipi di monitoraggio... pag. 13 1.1 Stato attuale... pag. 13 2 Monitoraggio operativo finalizzato... pag. 19 2.1 Obiettivi del monitoraggio... pag.
ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA
 1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
1 / 20 ST-001 ALLEGATO I ATMOSFERA, CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 2 / 20 ST-001 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE Gli impianti di trattamento e di compressione gas della Concessione Stoccaggio
Accordo volontario per il Monitoraggio ricadute dell impianto di termovalorizzazione rifiuti di San Lazzaro Padova
 Dipartimento Provinciale di Padova Via Ospedale, 22 35121 Padova Italy Tel. +39 049 8227801 Fax +39 049 8227810 e-mail: dappd@arpa.veneto.it PEC: dappd@pec.arpav.it Accordo volontario per il Monitoraggio
Dipartimento Provinciale di Padova Via Ospedale, 22 35121 Padova Italy Tel. +39 049 8227801 Fax +39 049 8227810 e-mail: dappd@arpa.veneto.it PEC: dappd@pec.arpav.it Accordo volontario per il Monitoraggio
17 giugno 2016 Palazzo Gazzoli Via del Teatro Romano, giugno 2016 Palazzo uffici comunali Corso del Popolo, 30
 L'acqua che bevo, l'aria che respiro, il cibo che mangio Problemi, proposte e confronti 17 giugno 2016 Palazzo Gazzoli Via del Teatro Romano, 15 18 giugno 2016 Palazzo uffici comunali Corso del Popolo,
L'acqua che bevo, l'aria che respiro, il cibo che mangio Problemi, proposte e confronti 17 giugno 2016 Palazzo Gazzoli Via del Teatro Romano, 15 18 giugno 2016 Palazzo uffici comunali Corso del Popolo,
Progetto di Bonifica del Cromo esavalente nei terreni. Polo Chimico di Spinetta Marengo
 Progetto di Bonifica del Cromo esavalente nei terreni Polo Chimico di Spinetta Marengo LA BONIFICA: RIEPILOGHIAMO IL PUNTO DI PARTENZA GENNAIO 2012 - Approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Operativa
Progetto di Bonifica del Cromo esavalente nei terreni Polo Chimico di Spinetta Marengo LA BONIFICA: RIEPILOGHIAMO IL PUNTO DI PARTENZA GENNAIO 2012 - Approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Operativa
Ufficio Aria Dipartimento Provinciale
 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E METALLI P.zza VITTORIO EMANUELE - POTENZA - ANNO 15 1 Gestione, Manutenzione ed Elaborazione a cura di: Ufficio Aria, Dip. prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I. Rocco Marino
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO
 REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo
 Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Torino, 9-10 Ottobre 2013 Stefano LO RUSSO DIATI Dipartimento di Ingegneria dell Ambiente, del Territorio
Sistemi geotermici a bassa entalpia a ciclo aperto: modellazione dell'impatto termico nel sottosuolo Torino, 9-10 Ottobre 2013 Stefano LO RUSSO DIATI Dipartimento di Ingegneria dell Ambiente, del Territorio
Regione Emilia Romagna SEMINARIO TECNICO ORGANO-CLORURATI ED IDROGEOLOGIA DELLE AREE URBANE: INQUINAMENTO PUNTUALE O DIFFUSO?
 Regione Emilia Romagna SEMINARIO TECNICO ORGANO-CLORURATI ED IDROGEOLOGIA DELLE AREE URBANE: INQUINAMENTO PUNTUALE O DIFFUSO? Stato dell'arte sulla contaminazione da organo-alogenati nella piana di Firenze:
Regione Emilia Romagna SEMINARIO TECNICO ORGANO-CLORURATI ED IDROGEOLOGIA DELLE AREE URBANE: INQUINAMENTO PUNTUALE O DIFFUSO? Stato dell'arte sulla contaminazione da organo-alogenati nella piana di Firenze:
MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE
 Pag. 5.1-1 5 MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE Nel corso degli anni la Rete di Sorveglianza Ambientale dell Impianto Eurex ha subito diverse revisioni, in relazione soprattutto
Pag. 5.1-1 5 MONITORAGGIO AMBIENTALE 5.1 RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE Nel corso degli anni la Rete di Sorveglianza Ambientale dell Impianto Eurex ha subito diverse revisioni, in relazione soprattutto
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE Studi e indagini sull inquinamento delle falde Legge Regionale 26/2003 art. 43, comma 1d
 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE Studi e indagini sull inquinamento delle falde Legge Regionale 26/2003 art. 43, comma 1d La Provincia di Milano si adopera per individuare le cause dell inquinamento
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE Studi e indagini sull inquinamento delle falde Legge Regionale 26/2003 art. 43, comma 1d La Provincia di Milano si adopera per individuare le cause dell inquinamento
Cg1. Ca2. Cg2. Cm1. Ca3. Cm1. Ma2. Ca2. Cm2. Ma1. Ca1. Cg1. Arenarie (Miocene) Conglomerati (Oligocene) Marne (Eocene) Calcari (Cretacico)
 Ca2 Ca2 Ca3 Ca1 Ar Cg1 Cg1 Cg2 Ar Ma1 Ma2 Do Do Do Cm2 Cm1 Cm1 Cb Cb 600 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2000 1900 1800 2100 2200 1300 1400 1300 40 Arenarie
Ca2 Ca2 Ca3 Ca1 Ar Cg1 Cg1 Cg2 Ar Ma1 Ma2 Do Do Do Cm2 Cm1 Cm1 Cb Cb 600 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2000 1900 1800 2100 2200 1300 1400 1300 40 Arenarie
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
L approccio analitico
 L approccio analitico la sequenza analitica Estrazione della frazione aromatica Introduzione in un sistema cromatografico Separazione dei composti dell aroma Riconoscimento e quantificazione L approccio
L approccio analitico la sequenza analitica Estrazione della frazione aromatica Introduzione in un sistema cromatografico Separazione dei composti dell aroma Riconoscimento e quantificazione L approccio
ISTRUTTORIA TECNICA. Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI. Risultati Monitoraggio Corso d Opera.
 SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 4 Trimestre 2014
SUPPORTO TECNICO ALL OSSERVATORIO AMBIENTALE CASCINA MERLATA ISTRUTTORIA TECNICA Piano di Monitoraggio Ambientale ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI Risultati Monitoraggio Corso d Opera 4 Trimestre 2014
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA E TERRITORIO CORSO DI MODELLAZIONE GEOLOGICO- TECNICA ED IDROGEOLOGICA MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA (2 CFU)
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA E TERRITORIO CORSO DI MODELLAZIONE GEOLOGICO- TECNICA ED IDROGEOLOGICA MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA (2 CFU) Docente: Alessandro Gargini (E-mail: alessandro.gargini@unibo.it)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA E TERRITORIO CORSO DI MODELLAZIONE GEOLOGICO- TECNICA ED IDROGEOLOGICA MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA (2 CFU) Docente: Alessandro Gargini (E-mail: alessandro.gargini@unibo.it)
POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI
 REV 0 1 di 7 POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 20/06/2011 REV 0 2 di 7 SOMMARIO 1 RIFERIMENTI 3 2 DEFINIZIONI 3 3 SCOPO E CAMPO
REV 0 1 di 7 POP 03 PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE E POTABILI DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 20/06/2011 REV 0 2 di 7 SOMMARIO 1 RIFERIMENTI 3 2 DEFINIZIONI 3 3 SCOPO E CAMPO
Qualità dell Aria in Località San Lorenzo di Trevi
 UNI EN ISO 9001:2008* (*) emissione di pareri tecnici ed esecuzione di controlli ambientali. Gestione reti di monitoraggio della qualità dell aria. Gestione reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo
UNI EN ISO 9001:2008* (*) emissione di pareri tecnici ed esecuzione di controlli ambientali. Gestione reti di monitoraggio della qualità dell aria. Gestione reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo
Geo Probing - PROVE PENETROMETRICHE STATICHE - RAPPORTO ED ELABORAZIONE DEI VALORI MISURATI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 Geo Probing di Francesco Becattini Telefono cellulare: 347.6434222 Sede: Strada Perugia - Ponte Valleceppi, n 96 06135 Ponte Valleceppi (PG) Telefono e Fax: 075.5928321 e-mail: f.becattini@geoprobing.it
Geo Probing di Francesco Becattini Telefono cellulare: 347.6434222 Sede: Strada Perugia - Ponte Valleceppi, n 96 06135 Ponte Valleceppi (PG) Telefono e Fax: 075.5928321 e-mail: f.becattini@geoprobing.it
LIDL ITALIA S.R.L. Committente. Oggetto. Data 4 febbraio Engineering S.r.l.
 Comune ALESSANDRIA Provincia ALESSANDRIA Committente LIDL ITALIA S.R.L. Oggetto Indagine ambientale finalizzata alla verifica riguardante l assenza di amianto nei terreni di fondazione della filiale LIDL
Comune ALESSANDRIA Provincia ALESSANDRIA Committente LIDL ITALIA S.R.L. Oggetto Indagine ambientale finalizzata alla verifica riguardante l assenza di amianto nei terreni di fondazione della filiale LIDL
Direttore A.R.P.A.B Ing. Raffaele Vita
 POTENZA P.zza VITTORIO EMANUELE CAMPAGNA MONITORAGGIO PM10 E METALLI IN TRACCIA ANNO 2011 1 Gestione Manutenzione ed Elaborazione a cura di : Ufficio Aria Dip. Prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I.
POTENZA P.zza VITTORIO EMANUELE CAMPAGNA MONITORAGGIO PM10 E METALLI IN TRACCIA ANNO 2011 1 Gestione Manutenzione ed Elaborazione a cura di : Ufficio Aria Dip. Prov. Potenza P.I. Giuseppe Taddonio P.I.
PREMESSA FASE 0 MONITORAGGIO 1.0
 PREMESSA Il presente documento descrive e quantifica il Progetto delle modalità di prova e messa in funzione dell impianto SVE. Il programma si sviluppa per una durata complessiva di 24 mesi suddivisi
PREMESSA Il presente documento descrive e quantifica il Progetto delle modalità di prova e messa in funzione dell impianto SVE. Il programma si sviluppa per una durata complessiva di 24 mesi suddivisi
VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO
 VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO Le industrie petrolifere (raffinerie), metallurgiche, chimiche ecc. producono un cascame di calore che viene smaltito nelle acque dei fiumi, dei laghi o dei mari (acque di
VALUTAZIONE DEL CARICO TERMICO Le industrie petrolifere (raffinerie), metallurgiche, chimiche ecc. producono un cascame di calore che viene smaltito nelle acque dei fiumi, dei laghi o dei mari (acque di
1 PREMESSA. Quadrilatero Marche-Umbria Maxilotto 1 1 Sublotto 2.1
 1 PREMESSA La presente relazione riporta la verifica idraulica dei tombini idraulici posti lungo il Ramo H (strada di collegamento tra la S.S. 7 e la S.P. 441 in prossimità dell abitato di Colfiorito).
1 PREMESSA La presente relazione riporta la verifica idraulica dei tombini idraulici posti lungo il Ramo H (strada di collegamento tra la S.S. 7 e la S.P. 441 in prossimità dell abitato di Colfiorito).
Corso di Idrogeologia applicata. (prof. Alessio Fileccia) Presentazione
 Corso di Idrogeologia applicata (prof. Alessio Fileccia) Presentazione Le immagini ed i testi rappresentano una sintesi, non esaustiva, dell intero corso di Idrogeologia tenuto presso il Dipartimento di
Corso di Idrogeologia applicata (prof. Alessio Fileccia) Presentazione Le immagini ed i testi rappresentano una sintesi, non esaustiva, dell intero corso di Idrogeologia tenuto presso il Dipartimento di
Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano
 Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Pietro Capodaglio, Fulvio Simonetto ARPA VdA Inquadramento
Il monitoraggio delle acque sotterranee sul territorio valdostano Piano di Tutela delle Acque 2016 8 aprile 2016 - Primo Forum di partecipazione pubblica Pietro Capodaglio, Fulvio Simonetto ARPA VdA Inquadramento
Esplorazione del sottosuolo
 1 Esplorazione del sottosuolo Finalità Profilo stratigrafico Proprietà fisico-meccaniche Misura pressione neutra Permeabilità Verifica impiego analisi e tecnologie Raccomandazioni AGI (1977): Mezzi di
1 Esplorazione del sottosuolo Finalità Profilo stratigrafico Proprietà fisico-meccaniche Misura pressione neutra Permeabilità Verifica impiego analisi e tecnologie Raccomandazioni AGI (1977): Mezzi di
Incendio presso l impianto CITE (Onano, Viterbo) 3-5 settembre 2016 Considerazioni in merito alle aree interessate dalle sostanze emesse
 Incendio presso l impianto CITE (Onano, Viterbo) 3-5 settembre 2016 Considerazioni in merito alle aree interessate dalle sostanze emesse In data 3 settembre 2016, intorno alle ore 18:00 legali (ore 17:00
Incendio presso l impianto CITE (Onano, Viterbo) 3-5 settembre 2016 Considerazioni in merito alle aree interessate dalle sostanze emesse In data 3 settembre 2016, intorno alle ore 18:00 legali (ore 17:00
Struttura Semplice Siti Nucleari
 DIPARTIMENTO TEMATICO RADIAZIONI ATTIVITA DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL RINVENIMENTO DI FUSTI INTERRATI PRESSO IL SITO FN-SO.G.I.N. DI BOSCO MARENGO (AL) Relazione tecnica n. 8/SS21.02/2014 Redazione Verifica
DIPARTIMENTO TEMATICO RADIAZIONI ATTIVITA DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL RINVENIMENTO DI FUSTI INTERRATI PRESSO IL SITO FN-SO.G.I.N. DI BOSCO MARENGO (AL) Relazione tecnica n. 8/SS21.02/2014 Redazione Verifica
ASSETTO IDROGEOLOGICO
 Ass setto idr rogeolo gico ASSETTO IDROGEOLOGICO Lucio Martarelli, Gennaro Maria Monti, Rossella Maria Gafà Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia Roma, 07 giugno 2013 Ass setto
Ass setto idr rogeolo gico ASSETTO IDROGEOLOGICO Lucio Martarelli, Gennaro Maria Monti, Rossella Maria Gafà Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia Roma, 07 giugno 2013 Ass setto
SETTORE VIA-VAS NODO AV DI FIRENZE - ACQUE SOTTERRANEE. Supporto Tecnico all Osservatorio Ambientale del Nodo AV di Firenze
 Direzione tecnica SETTORE VIA-VAS Supporto Tecnico all Osservatorio Ambientale del Nodo AV di Firenze NODO AV DI FIRENZE - ACQUE SOTTERRANEE VALUTAZIONE MONITORAGGIO GENNAIO 212 MARZO 213. PREMESSA La
Direzione tecnica SETTORE VIA-VAS Supporto Tecnico all Osservatorio Ambientale del Nodo AV di Firenze NODO AV DI FIRENZE - ACQUE SOTTERRANEE VALUTAZIONE MONITORAGGIO GENNAIO 212 MARZO 213. PREMESSA La
Attività di Arpa nel procedimento di bonifica del sito Caffaro - ex Siapa di Galliera
 Commissione Ambiente Comune di Galliera - 11 gennaio 2016 procedimento di bonifica del sito Caffaro ex SIAPA Attività di Arpa nel procedimento di bonifica del sito Caffaro - ex Siapa di Galliera Giovanna
Commissione Ambiente Comune di Galliera - 11 gennaio 2016 procedimento di bonifica del sito Caffaro ex SIAPA Attività di Arpa nel procedimento di bonifica del sito Caffaro - ex Siapa di Galliera Giovanna
Applicazioni. Rete di monitoraggio idropluviometrica:verifica e taratura
 ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA REGIONE TOSCANA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA DI RICERCA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA REGIONE TOSCANA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA DI RICERCA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Img. 1.1 Tracciato previsto dal PRG pre vigente del Comune di Bologna
 PROVINCIA DI BOLOGNA Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti Documento: Relazione Geotecnica Studio di fattibilità del III lotto della strada Lungosavena a Bologna Cod.: S10011-SF-GE02-0 Data:
PROVINCIA DI BOLOGNA Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti Documento: Relazione Geotecnica Studio di fattibilità del III lotto della strada Lungosavena a Bologna Cod.: S10011-SF-GE02-0 Data:
Problematiche nella contaminazione delle falde da solventi clorurati
 Problematiche nella contaminazione delle falde da solventi clorurati Esperienze in provincia di Treviso Simone Busoni Alessandro Gnocchi Provincia di Treviso Settore Ecologia e Ambiente I solventi clorurati
Problematiche nella contaminazione delle falde da solventi clorurati Esperienze in provincia di Treviso Simone Busoni Alessandro Gnocchi Provincia di Treviso Settore Ecologia e Ambiente I solventi clorurati
Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN BIOTECNOLOGIE Determinazione dell azoto totale e ammoniacale in spettrofotometria: modalità di calibrazione e confrontabilità nel tempo Relatore:
Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica Università degli Studi di Napoli Federico II Napoli
 Prof. Alfonso Carotenuto Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica Università degli Studi di Napoli Federico II 80131 Napoli In relazione all incarico ricevuto dal Comune di Boscotrecase (Prof.
Prof. Alfonso Carotenuto Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica Università degli Studi di Napoli Federico II 80131 Napoli In relazione all incarico ricevuto dal Comune di Boscotrecase (Prof.
COPERTURA IN LEGNO CASTELLO DI XXXXXXX
 COPERTURA IN LEGNO CASTELLO DI XXXXXXX RILIEVO - INDAGINI DI LABORATORIO - VERIFICHE STRUTTURALI PROVA N. 3541 / GE Committente: Tecnico Comunale: Consulenti: Relatori: Comune di XXXXXX arch. XXXXXXXX
COPERTURA IN LEGNO CASTELLO DI XXXXXXX RILIEVO - INDAGINI DI LABORATORIO - VERIFICHE STRUTTURALI PROVA N. 3541 / GE Committente: Tecnico Comunale: Consulenti: Relatori: Comune di XXXXXX arch. XXXXXXXX
INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA
 INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA Supporto ai processi di caratterizzazione 471/99 TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D E 3D METODO ERT - GMS VERIFICA
INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA Supporto ai processi di caratterizzazione 471/99 TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D E 3D METODO ERT - GMS VERIFICA
Comune di Reggio Emilia
 Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - - Comune di A cura di: Servizio Sistemi Ambientali Rete di Monitoraggio della Qualità dell'aria di Agenzia
Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - - Comune di A cura di: Servizio Sistemi Ambientali Rete di Monitoraggio della Qualità dell'aria di Agenzia
ANALISI DEI PRELIEVI DA POZZO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 ANALISI DEI PRELIEVI DA POZZO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Dott. Francesco Treu - Università degli Studi di Trieste Udine, 1 marzo 2011 - Giornata di approfondimento sullo stato delle risorse idriche sotterranee
ANALISI DEI PRELIEVI DA POZZO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Dott. Francesco Treu - Università degli Studi di Trieste Udine, 1 marzo 2011 - Giornata di approfondimento sullo stato delle risorse idriche sotterranee
b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche.
 corpo idrico sotterraneo: Piana di Catania b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche L acquifero principale è costituito sia dalle alluvioni
corpo idrico sotterraneo: Piana di Catania b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche L acquifero principale è costituito sia dalle alluvioni
Qui di seguito sono commentati i risultati della campagna di prelievi ed analisi.
 RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE LUNGO LA VALLE DEL FIUME PESCARA FRA LA DISCARICA TRE MONTI ED IL CAMPO POZZI DI COLLE SANT ANGELO 1. INTRODUZIONE
RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE LUNGO LA VALLE DEL FIUME PESCARA FRA LA DISCARICA TRE MONTI ED IL CAMPO POZZI DI COLLE SANT ANGELO 1. INTRODUZIONE
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN DIDERO. Monitoraggio Inclinometrico Terza misura di esercizio. Gennaio 2013
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN DIDERO IMPIANTO DI MONITORAGGIO IN LOCALITA LEITERA INFERIORE Monitoraggio Inclinometrico Terza misura di esercizio Gennaio 2013 SOMMARIO PREMESSA...
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN DIDERO IMPIANTO DI MONITORAGGIO IN LOCALITA LEITERA INFERIORE Monitoraggio Inclinometrico Terza misura di esercizio Gennaio 2013 SOMMARIO PREMESSA...
Emanuele Romano, Paolo Roberto Di Palma, Sara Morelli, Elisabetta Preziosi
 CONTAMINAZIONE DA SOLVENTI ORGANOCLORURATI NELL'ACQUIFERO DELLA VALLE UMBRA: PROBLEMATICHE NELL'INTERPRETAZIONE DEI DATI E NELLA MODELLAZIONE DEI PROCESSI DI TRASPORTO Emanuele Romano, Paolo Roberto Di
CONTAMINAZIONE DA SOLVENTI ORGANOCLORURATI NELL'ACQUIFERO DELLA VALLE UMBRA: PROBLEMATICHE NELL'INTERPRETAZIONE DEI DATI E NELLA MODELLAZIONE DEI PROCESSI DI TRASPORTO Emanuele Romano, Paolo Roberto Di
IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
Valorizzare la qualità ambientale dei territori IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Modulo A introduzione al monitoraggio il caso del monitoraggio in falda Istituto Istruzione Superiore A. Spinelli 2013-2014 monitoraggio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO (Classe delle lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale, Classe N. L-7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
COMUNE DI RAVASCLETTO Via Edelweiss, Ravascletto (UD) LIVELLAZIONI E RILIEVI TOPOGRAFICI DI PRECISIONE. Relazione Tecnica Conclusiva
 COMUNE DI RAVASCLETTO Via Edelweiss,7 33020 Ravascletto (UD) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA FRAZIONE DI SALÀRS IN COMUNE DI RAVASCLETTO (UD) LIVELLAZIONI E RILIEVI TOPOGRAFICI DI PRECISIONE
COMUNE DI RAVASCLETTO Via Edelweiss,7 33020 Ravascletto (UD) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA FRAZIONE DI SALÀRS IN COMUNE DI RAVASCLETTO (UD) LIVELLAZIONI E RILIEVI TOPOGRAFICI DI PRECISIONE
ORDINE DEI GEOLOGI DELL ORDINE DEI GEOL A TOSCANA
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
1^ Campagna di Agosto 2005
 RAPPORTO QUINDICINALE SULLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE DELLA REGIONE VENETO (RILIEVI SUL CAMPO) 1^ Campagna di Agosto 2005 Nella prima campagna del mese di Agosto 2005, effettuata
RAPPORTO QUINDICINALE SULLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE DELLA REGIONE VENETO (RILIEVI SUL CAMPO) 1^ Campagna di Agosto 2005 Nella prima campagna del mese di Agosto 2005, effettuata
All. A al CSA SCHEDA TECNICA
 All. A al CSA SCHEDA TECNICA SISTEMA COSTITUITO DA: GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA (GC-MS), SISTEMA AUTOMATICO DI CAMPIONAMENTO PER ACQUE E TERRENI ED ESTRATTORE TIPO PURGE AND
All. A al CSA SCHEDA TECNICA SISTEMA COSTITUITO DA: GASCROMATOGRAFO CON RIVELATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA (GC-MS), SISTEMA AUTOMATICO DI CAMPIONAMENTO PER ACQUE E TERRENI ED ESTRATTORE TIPO PURGE AND
Creazione di una rete di monitoraggio e controllo degli aspetti idrogeologici relativi alle cave della provincia di Parma
 Creazione di una rete di monitoraggio e controllo degli aspetti idrogeologici relativi alle cave della provincia di Parma Barbara Dellantonio ARPA Sezione di Parma Servizio Sistemi Ambientali Ecosistema
Creazione di una rete di monitoraggio e controllo degli aspetti idrogeologici relativi alle cave della provincia di Parma Barbara Dellantonio ARPA Sezione di Parma Servizio Sistemi Ambientali Ecosistema
Organo clorurati in falda: casi dubbi tra contaminazione puntuale e diffusa.
 Organo clorurati in falda: casi dubbi tra contaminazione puntuale e diffusa. 11 giugno 2015 Casi nella Regione Emilia Romagna Geol. Laura Grandi ing. Claudia Ferrari 1 Degradazione del Tetracloroetilene
Organo clorurati in falda: casi dubbi tra contaminazione puntuale e diffusa. 11 giugno 2015 Casi nella Regione Emilia Romagna Geol. Laura Grandi ing. Claudia Ferrari 1 Degradazione del Tetracloroetilene
OGGETTO : inquinamento da CVM sotto asilo via Digione Pontelagoscuro.
 Amici della Terra Via Ponte Rigo 14 44123 Albarea Ferrara 0532 182 3449 347 3020818 Ferrara 17 febbraio 2012 Al Sindaco Tiziano Tagliani P.zza Municipale 44100 Ferrara USL Dipartimento Sanità Pubblica
Amici della Terra Via Ponte Rigo 14 44123 Albarea Ferrara 0532 182 3449 347 3020818 Ferrara 17 febbraio 2012 Al Sindaco Tiziano Tagliani P.zza Municipale 44100 Ferrara USL Dipartimento Sanità Pubblica
Monitoraggio ambientale sul territorio dell ex USL 76 seconda campagna. Polo Amianto - Responsabile Dott. Claudio Trova
 Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato Monitoraggio ambientale sul territorio dell ex USL 76 seconda campagna Polo Amianto - Responsabile Dott. Claudio Trova Sito di bonifica di interesse
Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato Monitoraggio ambientale sul territorio dell ex USL 76 seconda campagna Polo Amianto - Responsabile Dott. Claudio Trova Sito di bonifica di interesse
L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare
 L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Materiale didattico a cura della Dott.ssa Michela Lecchi Medicina Nucleare: strumentazione gamma camera
L acquisizione e l elaborazione delle immagini di Medicina Nucleare UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Materiale didattico a cura della Dott.ssa Michela Lecchi Medicina Nucleare: strumentazione gamma camera
DATI SIGNIFICATIVI DEL SITO
 DATI SIGNIFICATIVI DEL SITO STABILIMENTO PETROLCHIMICO NEL NORD ITALIA DIMENSIONI: 2 km x 1 km COSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO: anni 1950 ATTUALMENTE SONO INSEDIATE CIRCA 20 DIFFERENTI SOCIETA IDROGEOLOGIA:
DATI SIGNIFICATIVI DEL SITO STABILIMENTO PETROLCHIMICO NEL NORD ITALIA DIMENSIONI: 2 km x 1 km COSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO: anni 1950 ATTUALMENTE SONO INSEDIATE CIRCA 20 DIFFERENTI SOCIETA IDROGEOLOGIA:
EMISSIONI IN ATMOSFERA
 EMISSIONI IN ATMOSFERA RAPPORTO DI PROVA Rif. AMB-2015/22 Insediamento: SIME ENERGIA SRL - VIALE DELLO SPORT, 103 - ZOLA PREDOSA - BO Committente: SIME ENERGIA SRL EMISSIONE - sigla: E2 - origine: Caldaia
EMISSIONI IN ATMOSFERA RAPPORTO DI PROVA Rif. AMB-2015/22 Insediamento: SIME ENERGIA SRL - VIALE DELLO SPORT, 103 - ZOLA PREDOSA - BO Committente: SIME ENERGIA SRL EMISSIONE - sigla: E2 - origine: Caldaia
2.1. EMISSIONI ODORIGENE
 Indice Indice... 1 1. PREMESSA... 2 2. MONITORAGGIO... 3 2.1. EMISSIONI ODORIGENE... 3 2.2. IMMISIONI SONORE NELL AMBIENTE ESTERNO... 5 2.3. MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA... 7 Allegato 1: Punti di
Indice Indice... 1 1. PREMESSA... 2 2. MONITORAGGIO... 3 2.1. EMISSIONI ODORIGENE... 3 2.2. IMMISIONI SONORE NELL AMBIENTE ESTERNO... 5 2.3. MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA... 7 Allegato 1: Punti di
CARTINA 1 INCENERITORE DI ACERRA MONITORAGGIO AREE DI SEDIME INQUADRAMENTO GEOLOGICO
 PREMESSA CARTINA 1 INCENERITORE DI ACERRA MONITORAGGIO AREE DI SEDIME INQUADRAMENTO GEOLOGICO Per verificare se sussistono infiltrazioni di contaminanti prodotte dall inceneritore di Acerra nel sottosuolo
PREMESSA CARTINA 1 INCENERITORE DI ACERRA MONITORAGGIO AREE DI SEDIME INQUADRAMENTO GEOLOGICO Per verificare se sussistono infiltrazioni di contaminanti prodotte dall inceneritore di Acerra nel sottosuolo
ALLEGATO 5 APPROFONDIMENTO SISMICO DI 2 LIVELLO
 ALLEGATO 5 APPROFONDIMENTO SISMICO DI 2 LIVELLO 1 PROCEDURE REGIONALI PER IL 2 LIVELLO DI APPROFONDIMENTO SISMICO SULLA BASE DEI CRITERI DELLA D.G.R. N. IX/2616/2011 La procedura di cui al punto 1.4.4
ALLEGATO 5 APPROFONDIMENTO SISMICO DI 2 LIVELLO 1 PROCEDURE REGIONALI PER IL 2 LIVELLO DI APPROFONDIMENTO SISMICO SULLA BASE DEI CRITERI DELLA D.G.R. N. IX/2616/2011 La procedura di cui al punto 1.4.4
Boceto di Borgotaro - Laboratorio Mobile
 Valutazione della qualità dell'aria nella Provincia di Parma -7 Coordinate UTM X: 533 UTM Y: 99 anno 7 Inizio campagna: /7 Fine campagna: 3/5/7 Dati riepilogativi: inquinante BENZ NO O 3 PM1 SO dati dati
Valutazione della qualità dell'aria nella Provincia di Parma -7 Coordinate UTM X: 533 UTM Y: 99 anno 7 Inizio campagna: /7 Fine campagna: 3/5/7 Dati riepilogativi: inquinante BENZ NO O 3 PM1 SO dati dati
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni 1. Premessa In Italia la progettazione geotecnica è regolata dal N.T.C. 2008 ed è redatta ai sensi del p.to 6.2.2. La presente Relazione è relativa all Analisi sulle
Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni 1. Premessa In Italia la progettazione geotecnica è regolata dal N.T.C. 2008 ed è redatta ai sensi del p.to 6.2.2. La presente Relazione è relativa all Analisi sulle
PDF creato con FinePrint pdffactory versione dimostrativa
 Esempio di interrogazione sui principi attivi (Coltura e campionamento) figura 14 Fig.14 Come si vede dall'esempio sopra riportato, il programma filtra le analisi effettuate in funzione della coltura,
Esempio di interrogazione sui principi attivi (Coltura e campionamento) figura 14 Fig.14 Come si vede dall'esempio sopra riportato, il programma filtra le analisi effettuate in funzione della coltura,
Simulazione numerica delle prove di rimorchio in acqua calma di un peschereccio. Daniele Peri, E.F. Campana
 ÁÆ Ë Æ Simulazione numerica delle prove di rimorchio in acqua calma di un peschereccio Daniele Peri, E.F. Campana Committente: Intermarine SpA Loc. Cà del Sale PO Box 185 19038 SARZANA (SP) Roma, Gennaio
ÁÆ Ë Æ Simulazione numerica delle prove di rimorchio in acqua calma di un peschereccio Daniele Peri, E.F. Campana Committente: Intermarine SpA Loc. Cà del Sale PO Box 185 19038 SARZANA (SP) Roma, Gennaio
NOTA INTEGRATIVA INERENTE IN PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE A CESSAZIONE DELL ATTIVITA PER L IMPIANTO EUROCORPORATION, V. DE CATTANI, 178 FIRENZE.
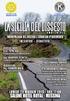 NOTA INTEGRATIVA INERENTE IN PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE A CESSAZIONE DELL ATTIVITA PER L IMPIANTO EUROCORPORATION, V. DE CATTANI, 178 FIRENZE. La presente nota è volta a rispondere alle richieste di
NOTA INTEGRATIVA INERENTE IN PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE A CESSAZIONE DELL ATTIVITA PER L IMPIANTO EUROCORPORATION, V. DE CATTANI, 178 FIRENZE. La presente nota è volta a rispondere alle richieste di
N.B. Per la risoluzione dei seguenti esercizi, si fa riferimento alle Tabelle riportate alla fine del documento.
 N.B. Per la risoluzione dei seguenti esercizi, si fa riferimento alle abelle riportate alla fine del documento. Esercizio 1 La concentrazione media di sostanze inquinanti osservata nelle acque di un fiume
N.B. Per la risoluzione dei seguenti esercizi, si fa riferimento alle abelle riportate alla fine del documento. Esercizio 1 La concentrazione media di sostanze inquinanti osservata nelle acque di un fiume
Se la profondità del pozzo è superiore a 30 metri, è obbligatorio darne comunicazione al Servizio Geologico d Italia
 PROGETTARE UN POZZO ELEMENTI NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE Uso dell acqua: indirizza per la scelta del tipo e i materiali del completamento Portata di emungimento: condiziona la scelta della pompa e quindi
PROGETTARE UN POZZO ELEMENTI NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE Uso dell acqua: indirizza per la scelta del tipo e i materiali del completamento Portata di emungimento: condiziona la scelta della pompa e quindi
RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA FALDA
 Sito d Interesse Nazionale «Brescia-Caffaro» RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA FALDA Massimiliano Confalonieri PERIMETRAZIONE DEL SIN «BRESCIA-CAFFARO» d.m. 24 febbraio 2003 Perimetrazione del Sito di Interesse
Sito d Interesse Nazionale «Brescia-Caffaro» RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA FALDA Massimiliano Confalonieri PERIMETRAZIONE DEL SIN «BRESCIA-CAFFARO» d.m. 24 febbraio 2003 Perimetrazione del Sito di Interesse
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO
 PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO SU STRADE E PIAZZALI DELLE AREE INDUSTRIALI E IMPLICAZIONI PER IL TRATTAMENTO Qualità delle acque. In prima analisi, a partire dagli idrogrammi
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
Le nostre acque sotterranee per uso potabile: Monti Catria e Nerone
 Le nostre acque sotterranee per uso potabile: Monti Catria e Nerone Coordinamento provinciale Acqua Bene Comune Pesaro e Urbino Urbino 7 maggio 2013 La fonte dei dati Studio commissionato dalla Regione
Le nostre acque sotterranee per uso potabile: Monti Catria e Nerone Coordinamento provinciale Acqua Bene Comune Pesaro e Urbino Urbino 7 maggio 2013 La fonte dei dati Studio commissionato dalla Regione
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA PROGETTO DEFINITIVO VERIFICHE IDROGEOLOGICHE. I e II TRATTO ING. MARIO ADDARIO ARCH. ORAZIA TRIBASTONE SCALA DATA
 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA PROGETTO: SISTEMAZIONE DELLA S.P. 45 "BUGILFEZZA - POZZALLO. TRATTI COMPRESI DAL KM 5+250 AL KM 5+550 E DAL KM 6+800 AL KM 7+000". PROGETTO DEFINITIVO TITOLO: VERIFICHE IDROGEOLOGICHE.
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA PROGETTO: SISTEMAZIONE DELLA S.P. 45 "BUGILFEZZA - POZZALLO. TRATTI COMPRESI DAL KM 5+250 AL KM 5+550 E DAL KM 6+800 AL KM 7+000". PROGETTO DEFINITIVO TITOLO: VERIFICHE IDROGEOLOGICHE.
Calcolo della Concentrazione Rappresentativa della Sorgente (CRS)
 Calcolo della Concentrazione Rappresentativa della Sorgente (CRS) Prof. Renato Baciocchi, Università di Roma Tor Vergata Emiliano Scozza Università di Roma Tor Vergata 1 Valutazione dei Dati Data Set di
Calcolo della Concentrazione Rappresentativa della Sorgente (CRS) Prof. Renato Baciocchi, Università di Roma Tor Vergata Emiliano Scozza Università di Roma Tor Vergata 1 Valutazione dei Dati Data Set di
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy
 4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) AREE DENOMINATE SITO A E SITO B. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 Nota integrativa
 PROJECT COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) AREE DENOMINATE SITO A E SITO B PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 Nota integrativa DOCUMENT N : Rev. Status Date Revision memo Issued by Checked
PROJECT COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) AREE DENOMINATE SITO A E SITO B PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 Nota integrativa DOCUMENT N : Rev. Status Date Revision memo Issued by Checked
COMUNE DI PALERMO. Area Pianificazione del Territorio. Ufficio Mare e Coste
 COMUNE DI PALERMO Area Pianificazione del Territorio Ufficio Mare e Coste Lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dei fondali del porto della Bandita di Palermo. PRELIEVO DI CAMPIONI PER LO
COMUNE DI PALERMO Area Pianificazione del Territorio Ufficio Mare e Coste Lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dei fondali del porto della Bandita di Palermo. PRELIEVO DI CAMPIONI PER LO
Obiettivi della Modellazione
 Università degli Studi di Catania sede di Enna Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Corso di Dinamica degli Inquinanti e bonifica dei siti contaminati, A.A. 2005-2006 Modellazione del Trasporto
Università degli Studi di Catania sede di Enna Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Corso di Dinamica degli Inquinanti e bonifica dei siti contaminati, A.A. 2005-2006 Modellazione del Trasporto
Studio G E O E C O S Dott. Geol. G. MENZIO. Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia. Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN)
 Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
Studio Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel0175977186-Fax1782737211-Cel.3402572786-mail:geoecos@libero.it Indirizzo di posta
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
Misure di fenomeni di aberrazione di una lente
 Padova, gennaio 00 Misure di fenomeni di aberrazione di una lente Indicare il numero identificativo e le caratteristiche geometriche della lente utilizzata: Lente num. =... Spessore =... Spigolo =... Indice
Padova, gennaio 00 Misure di fenomeni di aberrazione di una lente Indicare il numero identificativo e le caratteristiche geometriche della lente utilizzata: Lente num. =... Spessore =... Spigolo =... Indice
L acqua potabile nel comune di San Vittore Olona
 L acqua potabile nel comune di San Vittore Olona Introduzione Scopo di questa relazione è descrivere la qualità dell acqua fornita dall acquedotto di San Vittore Olona, quale risulta dai controlli effettuati
L acqua potabile nel comune di San Vittore Olona Introduzione Scopo di questa relazione è descrivere la qualità dell acqua fornita dall acquedotto di San Vittore Olona, quale risulta dai controlli effettuati
Fondamenti di idraulica stramazzi e idrometria
 Corso di Laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali Idrologia e Sistemazioni Idraulico-Forestali Fondamenti di idraulica stramazzi e idrometria Giancarlo Dalla Fontana Università di Padova A.A. 2013/2014
Corso di Laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali Idrologia e Sistemazioni Idraulico-Forestali Fondamenti di idraulica stramazzi e idrometria Giancarlo Dalla Fontana Università di Padova A.A. 2013/2014
Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua. Gianluigi Giannella
 Corso di Aggiornamento Professionale PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI POZZI ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVO-AMMINISTRATIVI Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua Gianluigi Giannella 17 Dicembre 2010
Corso di Aggiornamento Professionale PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI POZZI ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVO-AMMINISTRATIVI Il progetto e l esecuzione dei pozzi d acqua Gianluigi Giannella 17 Dicembre 2010
MODELLI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE DI SAN VITTORE DEL LAZIO
 MODELLI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE DI SAN VITTORE DEL LAZIO 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E METEOROLOGICO Il termovalorizzatore di san Vittore del Lazio si trova
MODELLI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE DI SAN VITTORE DEL LAZIO 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E METEOROLOGICO Il termovalorizzatore di san Vittore del Lazio si trova
