NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE
|
|
|
- Gastone Roberto
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie A, 109 (2004) pagg. 1-12, figg. 8 S. MARGIOTTA (*), A. VAROLA (*) NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE Riassunto - I numerosi studi scientifici che sono stati condotti nella Penisola salentina sin dagli inizi del secolo scorso, e che in particolare negli ultimi due decenni si sono succeduti, hanno evidenziato l importanza geologica e paleontologica di questo territorio; ciò nonostante, la scarsezza delle esposizioni a causa della morfologia per larghi tratti subpianeggiante, la limitata estensione degli affioramenti ed, in più luoghi, il loro cattivo stato di conservazione costituiscono elementi che rendono difficile la ricostruzione degli eventi. In questo lavoro si presentano i dati geologici paleontologici preliminari relativi a 4 nuovi affioramenti messi in luce dai lavori per la costruzione della tangenziale dell abitato di Lecce. Gli affioramenti in questione, che verranno in gran parte occlusi alla conclusione dei lavori, costituiscono quindi siti di particolare interesse (geositi) in quanto eccezionali testimonianze dei sedimenti in particolare oligocenici e miocenici presenti nell area di Lecce. Parole chiave - Oligocene, Miocene, geositi, Salento. Abstract - New geological and paleontological data on some important outcrops in the territory of Lecce. With the purpose to conjugate the economic affairs of a determined territory with the maintenance of the characteristic values of the same, cannot be put aside by the exploitation of the elements, in this case geological-paleontological, that confer meaning to the landscape and that, therefore, constitute of it a potential wealth s source. The term «geocity», definition applied within the project «Geocities» of the International Union of Geological Sciences (I.U.G.S.) is synonymous of «geological site» or «site of geological interest», understood as physical element able to furnish an essential contribution to the understanding of the geological history of a determined area. In this optics attributes of the site are not only the scientific component but also all that factors, cultural, didactics and partner-economics, that contribute to do a factor of development of it for the population. The numerous scientific studies that have been conducted in the salentina Peninsula since the beginnings of last century, and that, particularly in the last two decades, have been verified, have underlined the paleontological-geological importance of this territory; nevertheless, the shortage of the exposures because of the morphology for wide lines sublevel, the limited extension of the outcrops and, in more places, their bad state of maintenance constitute elements that makes difficult the reconstruction of the events. In this note the preliminary paleontological-geological data related to 4 new outcrops pointed out by the jobs for the construction of the bypass road of the inhabited area of Lecce have been shown. The outcrops in matter, that will come to a large extent obstructed to the conclusion of the jobs, constitute therefore sites of particular interest (geocities) as exceptional testimonies of the sediments particularly oligocenic and miocenic present in the area of Lecce. So that, the area in correspondence of which are situated the outcrops that are described is geographically inclusive among the inhabited area of Lecce at south and those of Novoli and Surbo at north; in correspondence of this area, in more places and particularly in the numerous sky opened cave there present, the miocenic unit of the Pietra leccese and of the Andrano Calcareniti result well exposed; the oligo-miocenic sediments of the Galatone Formation and the Lecce formation result scarce and badly preserved. In more places appear on the surface the sediments of the Cretaceous that constitute the substratum of these unities. Of the outcrops that are described in this note, one of them interest the Galatone Formation and one the Lecce formation while of the others two one is related to the contact Pietra leccese - Andrano Calcarenite and the other to the contact Pietra leccese - Gravina Calcarenite (Pleistocene). The first two outcrops are particularly interesting because situated in an area in which the presence of these two units was not verified and however they constitute the best exposures that are been observed in the whole area of Lecce. In this note therefore, departing from the observation of the exposures, a geologic survey of the area with the purpose to delimit the areal exstension of the Galatone Formation and the Lecce formation has been introduced. The choice to effect the geologic survey has been imposed from the necessity of a rigorous revision of the official geological cartography and for the evidence, particularly as it regards the Lecce formation to acquire further necessary data for a possible formalization of the unity. The other two exposures introduce geological and paleontological characters characteristic such as to constitute sites of particular interest that would be opportune to protect. Key words - Oligocene, Miocene, geological site, Salento. INTRODUZIONE Al fine di coniugare gli interessi economici di un determinato territorio con la conservazione dei beni caratteristici dello stesso, non si può prescindere dalla valorizzazione degli elementi, in questo caso geologici-paleontologici, che conferiscono significato al paesaggio e che ne costituiscono quindi una potenziale fonte di ricchezza. Il termine «geosito», definizione applicata nell ambito del progetto «Geocities» dell International Union of Geological Sciences (I.U.G.S.) è sinonimo di «sito geologico» o «sito di interesse geologico» (Wimbledon et al., 1996), inteso come elemento fisico in grado di fornire un contributo essenziale alla comprensione della storia geologica di una certa area (Brancucci & Gazzola, 2002). In quest ottica attributi del sito sono (*) Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia Ambientali, Università degli Studi di Lecce. stefano.margiotta@unile.it
2 2 S. MARGIOTTA, A. VAROLA non solo la componente scientifica ma anche quella culturale, didattica e socio-economica, tutti quei fattori cioè che contribuiscono a farne un fattore di sviluppo per la popolazione. I numerosi studi scientifici che sono stati condotti nella Penisola salentina sin dagli inizi del secolo scorso, e che in particolare negli ultimi due decenni si sono succeduti, hanno evidenziato l importanza geologica e paleontologica di questo territorio; ciò nonostante, la scarsezza delle esposizioni a causa della morfologia per larghi tratti subpianeggiante, la limitata estensione degli affioramenti ed, in più luoghi, il loro cattivo stato di conservazione costituiscono elementi che rendono difficile la ricostruzione degli eventi nei tempi geologici. In questo lavoro si presentano i dati geologici e paleontologici preliminari relativi a 4 nuovi affioramenti messi in luce dai lavori per la costruzione della tangenziale dell abitato di Lecce che per le loro caratteristiche possono essere definiti, a giusta ragione, geositi. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRATIGRAFICO L area in corrispondenza della quale sono ubicati gli affioramenti che vengono descritti (Fig. 1) è geograficamente compresa tra l abitato di Lecce a sud e quelli di Novoli e Surbo a nord; in corrispondenza di quest area risultano, in più luoghi ed in particolare nelle numerose cave a cielo aperto ivi presenti, ben esposte le unità mioceniche della Pietra leccese e delle Calcareniti di Andrano, mentre scarse e male conservate risultano le esposizioni relative ai sedimenti oligomiocenici della Formazione di Galatone e della formazione di Lecce. In più luoghi affiorano i sedimenti del Cretacico che costituiscono il substrato di queste unità. La Formazione di Galatone (Oligocene sup.; Esu et al., 1994; Bossio et al., 1998, 1999) affiora lungo una fascia orientata grosso modo NO-SE, a sud-ovest dell abitato di Lecce (Bossio et al., 1999). In sintesi, la Formazione di Galatone è rappresentata da una successione di ambiente palustre costiero, costituita da un irregolare alternanza di calcari e calcari dolomitici, di marne, di argille siltose e/o silt con saltuarie intercalazioni sia di livelli lignitiferi sia di paleosuoli argillo-sabbiosi di colore giallastro. La formazione di Lecce, sovrapposta alla precedente con limite inconforme e giacitura paraconcordante (Margiotta, 1999, 2000; Margiotta & Ricchetti, 2002) affiora a sud-ovest dell abitato di Lecce (Bossio et al., 1999) e corrisponde ad una bancata calcarenitica nella quale sono frequenti macroforaminiferi appartenenti al genere Operculina e gusci di echini, rappresentati in prevalenza dal genere Scutella. Questa unità è datata all Oligocene Superiore - Miocene basale. La Pietra leccese (Miocene inf.-sup.) affiora estesamente nell area interessata. Questa ben nota formazione (Bossio et al., 1992, 1994, 1999) è rappresentata da calcari detritici più o meno compatti, talvolta relativamente friabili, a grana uniforme medio-fine, con una colorazione variabile dal tipico giallo paglierino a tonalità verdastre nella varietà glauconitica («piromafo»), che solitamente chiude la successione. Sulla Pietra leccese affiorano con passaggio graduale e concordante (Bossio et al., 1992, 1994, 1999) le Calcareniti di Andrano (Miocene sup.), rappresentate da calcari e calcareniti più o meno marnose, di colore grigio chiaro con sfumature giallastre e biancastre. La roccia si presenta talvolta a grana fine, molto compatta e tenace, talaltra a grana media, porosa e friabile, specialmente laddove è molto fossilifera. Le Calcareniti di Andrano presentano in generale una netta suddivisione in strati di spessore variabile da qualche centimetro a oltre 1 m. A luoghi i sedimenti sopra menzionati sono interessati dalle coperture delle unita plio-pleistoceniche. Degli affioramenti che vengono descritti in questo lavoro, uno di essi interessa la Formazione di Galatone ed uno la formazione di Lecce, mentre degli altri due uno è relativo al contatto Pietra leccese - Calcareniti di Andrano e l altro al contatto Pietra leccese - Calcareniti di Gravina (Pleistocene medio). I 4 nuovi affioramenti che vengono presentati sono stati messi in luce dai lavori per la costruzione della tangenziale dell abitato di Lecce e potrebbero essere in gran parte occlusi, alla conclusione dei lavori stessi, da muri di contenimento. I primi due affioramenti sono particolarmente interessanti poiché ubicati in un area nella quale non era segnalata la presenza di queste due unità, e comunque costituiscono le migliori esposizioni che sono state osservate limitatamente a tutta l area di Lecce. In questa nota, quindi, si presenta anche un rilevamento geologico dell area al fine di delimitare le zone di affioramento della Formazione di Galatone e della formazione di Lecce. La scelta di effettuare il rilevamento geologico si impone quindi dalla necessità di una rigorosa revisione della cartografia geologica ufficiale, in accordo con Margiotta & Ricchetti (2002) e per la necessità, in particolare per quanto riguarda la formazione di Lecce, di acquisire ulteriori dati necessari per una eventuale formalizzazione dell unità. Gli altri due affioramenti, invece, presentano caratteri geologici e paleontologici caratteristici e tali da costituire siti di particolare interesse che sarebbe opportuno tutelare. I SITI AD OVEST DI LECCE L area in corrispondenza della quale sono ubicati i tre affioramenti che verranno descritti in seguito si estende tra gli abitati di Surbo e Trepuzzi a nord, Novoli a ovest e Arnesano a sud (Fig. 1). Secondo quanto riportato nel F 204 Lecce della C.G.I. (II ed. 1969), in quest area affiorano, oltre ai calcari del basamento carbonatico cretacico, lembi poco estesi della miocenica Pietra leccese e coperture dell unità plio-pleistocenica delle Calcareniti del Salento. I SITI DELLA FORMAZIONE DI GALATONE E DELLA FORMAZIONE DI LECCE I risultati dei rilevamenti e delle analisi stratigrafiche e paleontologiche effettuate sugli affioramenti che si
3 NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE 3 Fig. 1 - Ubicazione delle sezioni e carta geologica schematica dell area comprendente gli affioramenti 1, 2, 3.
4 4 S. MARGIOTTA, A. VAROLA descrivono in questo paragrafo hanno consentito di attribuire gli stessi rispettivamente alla Formazione di Galatone ed alla formazione di Lecce (Fig. 1). L affioramento attribuito alla Formazione di Galatone, di spessore di circa 22 m, è ubicato ( ,7 N; ,8 E) in corrispondenza di una trincea della Tangenziale ovest di Lecce, in costruzione nel tratto tra l abitato di Lecce e quello di Novoli (Fig. 2). La successione stratigrafica esposta su un estensione lineare di circa 250 m, è caratterizzata da marne e calcari sottilmente stratificati con intercalati livelli argillosi ed altri calcarei, questi ultimi stratificati con strati di spessore variabile da pochi centimetri a circa mezzo metro. A luoghi, è osservabile una laminazione piano parallela, particolarmente evidente negli intervalli più argillosi. I fossili, sempre piuttosto abbondanti, sono dispersi nel sedimento e rappresentati da esemplari tipici di questa formazione (Esu et al., 1994), quali Potamididae, Melanopsis sp. e Melanoides sp. tra i gasteropodi, nonché piccoli lamellibranchi. Nella parte stratigraficamente superiore della sezione (gli ultimi 3,5 m) l unità è caratterizzata da due banchi calcarenitici, di spessore di circa 1,5 m, delimitati al tetto da intervalli sottilmente stratificati. Questi banchi calcarenitici si presentano piuttosto massivi con all interno rari esemplari di Cardium sp. e costituiscono intervalli più prettamente marini all interno della successione. Nel complesso, gli strati presentano un orientazione variabile con blande ondulazioni riconducibili a pieghe con assi orientati circa E-O; all interno delle pieghe principali se ne notano altre di ordine inferiore e quindi raggio di curvatura minore. Queste strutture sono riferibili a fenomeni gravitativi (slump, Fig. 2). Il rilevamento geologico effettuato nell area ha messo in evidenza l estensione areale dell unità, lungo una fascia orientata circa NW-SE, ma non sono state riconosciute altre esposizioni che presentino spessori significativi (superiori cioè al metro). Alla base l unità poggia sui calcari del Cretacico e le giaciture riscontrate nelle due formazioni permettono di ipotizzare che il contatto tra le due unità, non osservato in sezione, sia di tipo discordante. I dati del sottosuolo (Fig. 3) relativi ad una stratigrafia rielaborata dagli scriventi e inerente una perforazione effettuata dall Ente Irrigazione nei primi anni Ottanta ed ubicata nei pressi dell abitato di Arnesano, evidenziano come interposti tra il Calcare di Altamura (Cretacico) e la Formazione di Galatone sia presente un livello, spesso circa 5 m, costituito da terra rossa con pisoliti bauxitiche. Inoltre la Formazione di Galatone sarebbe qui rappresentata oltre che dalla Fig. 2 - Tangenziale ovest di Lecce: sezione della Formazione di Galatone con particolari dell affioramento (a, b, c).
5 NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE 5 a b Fig. 3 - Stratigrafia rielaborata dagli scriventi relativa ad una carota di perforazione effettuata nell area di studio (a) e sezione stratigrafica originale (b) del pozzo «Calilli» presso Arnesano (da De Giorgi, 1922). caratteristica alternanza di strati calcarei ed argillosi da livelli lignitiferi. A questo proposito si segnala come già De Giorgi (1922) avesse indicato in corrispondenza di una perforazione presso Arnesano, nel Fondo S. Angelo (non è stato possibile ubicare esattamente questa perforazione), ad una profondità di circa 0,30 m rispetto al l.m.m. e per uno spessore di 0,82 m un banco di lignite, a straterelli sottili. Questo banco di lignite poggiava su un livello argilloso ed era delimitato al tetto da un calcare intercalato da argilla e da straterelli di calcare compatto riferibili anch essi alla Formazione di Galatone. Al tetto la Formazione di Galatone è qui delimitata dai sedimenti pleistocenici delle Calcareniti di Gravina. Anche in questo caso le giaciture suborizzontali misurate nell unità più recente definiscono un contatto discordante di tipo onlap tra le due unità. I dati ricavati dalla stratigrafia descritta, ed in particolare la quota di rinvenimento del tetto della Formazione di Galatone e dei calcari del Cretacico, nonché l evidenza di un gradino morfologico al contatto tra la più antica delle unità oligoceniche e la Calcarenite di Gravina, permettono di ipotizzare la presenza di una faglia grossomodo orientata nord ovest-sud est (indicata con un tratteggio rosso in Fig. 1) mascherata dalle coperture dei sedimenti pleistocenici. Le osservazioni effettuate permettono di definire, in accordo con i dati della bibliografia citata, un ambiente deposizionale subacqueo continentale con episodiche variazioni di salinità. Al momento, circa l età della formazione, non esistono elementi nuovi rispetto a quelli già indicati (Esu et al., 1994) e che riferiscono l unità al Cattiano (Oligocene). La formazione di Lecce affiora al margine est dell area di studio (Fig. 1). L affioramento più significativo ( ,7 N; ,8 E) si trova all intersezione tra la via vecchia provinciale per Novoli (s.p. 4) e la tangenziale ovest di Lecce. L esposizione che si presenta, spessa circa 10 m, rappresenta insieme a quello di cava i Rizzi, presso Galatone (Barbera et al., 1993) il migliore affioramento, sino ad oggi conosciuto, di questa unità (Fig. 4). La formazione di Lecce si presenta infatti nella sua facies tipica di calcareniti di colore biancastro, a grana variabile da media a grossa, massive, con stratificazione appena accennata in banchi di spessore variabile da 0,5 m a circa 3 m. Tra i fossili oltre a lamellibranchi, in particolare Cardium, gasteropodi marini, coralli (frequenti nel tratto basale della successione affiorante), briozoi, serpulidi e macroforaminiferi (rari) appartenenti al genere Operculina, sono frequenti gli echini, rappresentati prevalentemente dal genere Scutella. Queste ultime si trovano sia disperse nel sedimento sia concentrate in aggregati di più esemplari per lo più frammentati.
6 6 S. MARGIOTTA, A. VAROLA Fig. 4 - Strada provinciale Lecce-Novoli: sezione della formazione di Lecce con particolari dell affioramento (a, b, c). Nel complesso gli strati presentano un assetto monoclinale con immersione a E-SE complicato da deboli ondulazioni riferibili a pieghe aperte. A luoghi il sedimento è intensamente disturbato ed interessato da piccole faglie con scarso rigetto riferibili a fenomeni di slumping. L esposizione della formazione di Lecce è parzialmente nascosta dalla copertura dei sedimenti pleistocenici della Calcarenite di Gravina. Il rilevamento geologico effettuato ha messo in evidenza come nell area a nord di quella oggetto di studio l unità poggi direttamente sul Calcare di Altamura (Cretacico). Il contatto tra le due unità pur non essendo visibile in sezione, sulla base delle giaciture misurate, è di tipo discordante. A sud le coperture pleistoceniche non permettono di osservare i rapporti stratigrafici tra questa unità e quelle più antiche. I dati del sottosuolo ricavati dalla stratigrafia precedentemente segnalata, permettono di ipotizzare che tra l unità in questione e il basamento carbonatico cretacico sia interposta la Formazione di Galatone, in accordo con le osservazioni desunte dai rilievi di campagna.
7 NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE IL CONTATTO PIETRA GRAVINA LECCESE - CALCARENITE DI Nell area esaminata l unità miocenica della Pietra leccese non affiora in superficie a causa delle coperture dei sedimenti pleistocenici della Calcarenite di Gravina, ma i lavori di scavo per la costruzione della citata tangenziale ovest dell abitato di Lecce hanno messo in evidenza il contatto tra queste due unità. 7 L esposizione che si presenta è ubicata ( ,5 N; ,9 E) a sud di quella descritta dove ben affiora la Formazione di Galatone (Fig. 1). La Pietra leccese, esposta per massimo 2 m (Fig. 5), è caratterizzata da una calcarenite a grana media-fine, con una colorazione variabile dall avana al giallastro. I fossili si presentano dispersi nel sedimento e disposti casualmente; tra questi molto frequenti i lamellibranchi come Flabellipecten flabelliformis, echini (nella Fig. 5 - Tangenziale ovest di Lecce: contatto Pietra leccese - Calcarenite di Gravina (a); particolari del contatto con la parte superiore della unità miocenica caratterizzata dalla presenza di numerosi fori dovuti all azione di organismi litofagi (b, c); in c particolare dell interno di questi fori riempito dal sedimento della sovrastante unità pleistocenica con presenza di esemplari di balani.
8 8 S. MARGIOTTA, A. VAROLA maggior parte dei casi in frammenti) mentre sono stati notati rari esemplari di Ditrupa sp., chele di crostacei, ed ostreidi. Il sedimento è intensamente bioturbato. La stratificazione è indistinta o in banchi di circa mezzo metro di spessore; a luoghi sono presenti ondulazioni irregolari e dalla curvatura molto ampia. L unità miocenica è inoltre interessata da fratture subverticali, con apertura anche di una decina di centimetri riempite dal sedimento della sovrastante Calcarenite di Gravina. Al tetto la Pietra leccese è caratterizzata da un livello continuo per tutta l esposizione, di circa 15 centimetri di spessore, caratterizzato dalla presenza di numerosi fori dovuti all azione di organismi litofagi. La superficie superiore di questo livello è ondulata ed irregolare. La Calcarenite di Gravina poggia sulla Pietra leccese con contatto chiaramente discordante ad onlap. Alla base il sedimento della Calcarenite di Gravina riempie i vuoti (fori di litodomi e piccole faglie) presenti nell unità miocenica ed, all interno dei fori in particolare, sono stati notati esemplari di balani. L unità pleistocenica affiora al massimo per un metro di spessore ed è caratterizzata da un calcare detritico organogeno, compatto, di colore giallastro; tra i fossili, disposti sia dispersi nel sedimento che accumulati, con valve orientate con la concavità verso l alto in livelli discontinui spessi meno di una decina di centimetri, sono prevalenti alghe e molto frequenti lamellibranchi appartenenti alla famiglia degli ostreidi. La successione esposta ha un andamento pressoché orizzontale in ciò evidenziando la discordanza con la sottostante Pietra leccese. Il rilevamento geologico effettuato ha comunque consentito di individuare in corrispondenza di una cava ubicata poco a nord di Mass. «Mater Domini», ad ovest rispetto all affioramento descritto, la stessa sequenza, con caratteri molto simili e per uno spessore complessivo delle due unità di circa 25 m (Fig. 6). La cava, attualmente utilizzata come discarica abusiva, potrebbe quindi risultare nel caso di obliterazione dell esposizione in corrispondenza della tangenziale, un altro sito di particolare interesse geologico e paleontologico. I SITI AD EST DI LECCE L area in corrispondenza della quale è ubicato l affioramento che verrà descritto in seguito si estende a nord ed a est dell abitato di Lecce. Secondo quanto riportato nel F 204 Lecce della C.G.I. (II ed. 1969), in quest area affiorano le unità mioceniche della Pietra leccese e delle Calcareniti di Andrano, nonché le coperture delle unità plio-pleistoceniche. I lavori per la costruzione della tangenziale est dell abitato di Lecce hanno messo in evidenza numerosi affioramenti delle due unità mioceniche sopra citate ma in questa nota se intende presentarne solo uno in quanto ritenuto particolarmente significativo sia dal punto di vista geologico che paleontologico. Solo in corrispondenza dell esposizione che si descrive infatti è ben visibile il passaggio tra la Pietra leccese tipica e quella ricca in glauconite, nonché il contatto con le sovrastanti Calcareniti di Andrano. Inoltre all interno della Pietra leccese glauconitica sono stati rinvenuti numerosi resti fossili di vertebrati di particolare interesse. IL CONTATTO PIETRA LECCESE - CALCARENITI DI ANDRANO L affioramento che si descrive è ubicato ( ,7 N; ,9 E) all incrocio tra la tangenziale est dell abitato di Lecce e la via provinciale di Frigole (Fig. 1). Alla base della successione la Pietra leccese si presenta, per uno spessore di circa 3 m, nella sua facies tipica di calcareniti a grana media-fine, di colore giallobiancastro. I fossili sono comuni, dispersi nel sedimento e rappresentati in prevalenza da lamellibranchi quali Flabellipecten sp. ed Amusium cristatum. La stratificazione è in banchi con immersione di pochi gradi verso est. Il sedimento è intensamente bioturbato e al tetto le bioturbazioni sono riempite dalla Pietra leccese glauconitica sovrastante. Il passaggio tra le due varietà è caratterizzato da una superficie erosiva ondulata ed irregolare, a luoghi interessata da tasche, immergente anch essa verso est (Fig. 7). Il livello glauconitico, avente uno spessore di circa 6 m, presenta una parte basale con contenuto di questo minerale molto elevato. Nel complesso, la glauconite è distribuita spazialmente nel sedimento in maniera selettiva, con un evidente gradiente verticale e quindi una diminuzione del contenuto del minerale verso l alto stratigrafico con intercalati livelli particolarmente ricchi del minerale in oggetto all interno dei quali si ripete lo stesso trend. Prevalentemente alla base del livello glauconitico stesso, sono presenti numerosi noduli fosfatici, sia di natura biogenica che terrigena, di dimensioni variabili dal millimetro a qualche centimetro; a luoghi questi noduli sono concentrati in plaghe. La glauconite è quindi particolarmente concentrata in corrispondenza di piccole tasche, al di sopra della superficie erosiva, dove sono inoltre frequenti gli elementi fosfatici: in questo caso i frammenti fosfatici, costituiti in prevalenza da gusci mineralizzati di pteropodi, sono allineati ed orientati secondo la direzione della superficie erosiva stessa. Frequenti sono i fossili disposti casualmente e con valve disarticolate, a luoghi fosfatizzate e fra questi si riconoscono in particolare Amusium cristatum, Flabellipecten sp., Chlamys haueri, Neopycnodonte navicularis; laddove i fossili sono concentrati in livelli di spessore decimetrico, anch essi si presentano isorientati con la superficie erosiva. Meno ricorrenti sono i gasteropodi (eccezion fatta per gli pteropodi), i frammenti di echini (Spatangus sp.), i coralli nonché grossi anellidi spiralati, concentrati in plaghe. Molto frequenti sono i resti di vertebrati particolarmente concentrati ed allineati in due livelli posti circa 30 cm sopra la superficie erosiva uno e 1,25 m sopra l altro. Nel primo livello, per una estensione lineare di circa un metro, sono state riconosciute vertebre di delfino in connessione anatomica; molto probabilmente le restanti parti sono state distrutte dalle operazioni di sbancamento. Nel secondo livello per
9 NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE 9 Fig. 6 - Cava ubicata poco a nord di «Mass. Mater domini»: contatto Pietra leccese - Calcarenite di Gravina (a, b, c); particolari nei quali ben si evidenzia la superficie ondulata di contatto e la presenza di un livello continuo, al tetto dell unità miocenica, di fori dovuti all azione di organismi litofagi (b, c).
10 10 S. MARGIOTTA, A. VAROLA Fig. 7 - Tangenziale est di Lecce: contatto Pietra leccese - Calcareniti di Andrano con particolari della sezione; in c è evidenziato una parte del cranio di Cethoteridae riportato in Fig. 8.
11 NUOVI DATI GEOLOGICI E PALEONTOLOGICI SU ALCUNI AFFIORAMENTI NEL TERRITORIO DI LECCE uno spessore lineare di circa 4 m, sono stati ritrovati, in connessione anatomica, parte del cranio, vertebre e coste di un grosso cetaceo misticeto; i resti si presentano allineati secondo la direzione generale della stratificazione eccetto il cranio che sembra essere disposto quasi ortogonale agli altri. Questo dato, in accordo con la limitata estensione lineare dei resti in affioramento, permette di supporre che gli stessi non abbiano subito un notevole trasporto. La parte cranica è ascrivibile alla zona occipitale molto probabilmente del processo postgleinodeo. Gli spessori rilevati (da 2 cm a 3 cm) evidenziano la grossa taglia del misticeto, in questo tenendo conto anche della lunghezza (circa 50 cm) e dello spessore delle coste (Fig. 8). 11 La presenza di livelli fossiliferi, in corrispondenza dei quali vi è, come già osservato, una concentrazione di glauconite superiore rispetto a quella nel sedimento sotto e soprastante, indica la periodica attività di correnti che si alternano a fasi durante le quali riprende la normale sedimentazione. Queste osservazioni, in accordo con i criteri per la differenziazione tra glauconite di origine autoctona e alloctona (Amorosi, 1997), mettono in evidenza che i granuli glauconitici sono stati interessati da selezione idraulica e trasporto. Dalle osservazioni al microscopio si evince inoltre come i granuli di questo minerale rappresentino, in gran prevalenza, i modelli interni di foraminiferi planctonici tipicamente presenti nella Pietra leccese. Questo ulte- Fig. 8 - Assemblaggio del cranio di Cethoteridae rinvenuto nella Pietra leccese glauconitica di Fig. 7. 1, 2: rami mandibolari; 3: occipite; 4, 5: bulle timpaniche e periotici; 6, 7: mascellari.
12 12 S. MARGIOTTA, A. VAROLA riore dato, oltre alla mancanza di elevate quantità di glauconite nelle rocce sottostanti del Cretacico, suggerisce quindi una origine parautoctona del minerale. Sopra al «piromafo» si osserva un intervallo che potremmo definire di transizione alle Calcareniti di Andrano. Nel particolare, in questo intervallo di circa 2,5 m, si individua una parte inferiore, di spessore di circa 1,5 m, costituita da una calcarenite giallastra molto bioturbata, a grana fine, con un leggero contenuto in glauconite. Sono presenti, per quanto in quantità minori rispetto al piromafo, lamellibranchi (Neopycnodonte navicularis, Amussium cristatum, Chlamys haueri) e brachiopodi (Terebratula sp.); verso l alto questi fossili diminuiscono di taglia e ad essi si aggiungono modelli di lamellibranchi appartenenti a generi non presenti nell intervallo sottostante. La parte superiore (spessore massimo 1 m), è costituita da una calcarenite marnosa di colore grigio chiaro sulle superfici esposte e con tonalità ocracee in frattura fresca. Fra i fossili, oltre a pettinidi e piccoli brachiopodi, si riconoscono serpulidi, briozoi, balani e piccoli ostreidi. Le Calcareniti di Andrano sovrastanti sono rappresentate da calcari e calcareniti più o meno marnose, di colore grigio chiaro con sfumature giallastre e biancastre. La roccia si presenta a grana fine, molto compatta e tenace, a luoghi a grana media, porosa e friabile, specialmente laddove è molto fossilifera. I fossili sono abbondanti tanto da costituire spesso vere e proprie «lumachelle»; i più frequenti sono serpulidi, balani, briozoi, gasteropodi, lamellibranchi (Chlamys sp., Cardium sp., Ostrea sp., Modiola sp.) nonché brachiopodi e alghe. Le Calcareniti di Andrano sono stratificate con una netta suddivisione in strati di spessore variabile da qualche centimetro a oltre 1 m ed immersione sempre verso est. In accordo con i numerosi dati presenti in bibliografia (Bossio et al., 1992, 1994), i dati geologici e paleontologici osservati indicano al passaggio tra la Pietra leccese e le Calcareniti di Andrano una diminuzione batimetria dell ambiente di deposizione che diviene costiero. CONCLUSIONI I risultati delle osservazioni geologiche e paleontologiche condotte sugli affioramenti descritti in questa nota hanno messo chiaramente in evidenza come gli stessi costituiscano un importante chiave di lettura degli eventi geologici che hanno interessato l area a nord di Lecce durante l Oligocene Superiore ed il Miocene. In particolare gli affioramenti della Formazione di Galatone e della formazione di Lecce, oltre a portare un ulteriore contributo per la definizione dei caratteri peculiari di queste due unità ne hanno messo in luce l estensione anche in aree a nord del capoluogo salentino, laddove sinora non erano state individuate. Le altre due esposizioni rappresentano invece eccezionali testimonianze degli eventi che si sono succeduti nel Miocene e nel Pleistocene. Infine, la naturale ubicazione degli affioramenti descritti lungo la tangenziale della città di Lecce renderebbe possibile la realizzazione di un percorso scientifico culturale attraverso il mantenimento delle condizioni naturali degli affioramenti stessi, la creazione di pannelli esplicativi ed aree di sosta per i visitatori. BIBLIOGRAFIA Amorosi A., Detecting compositional, spatial, and temporal attributes of glaucony: a tool for provenance research. Sedimentary Geology 109: Barbera C., Bossio A., Mazzei R., Monteforti B., Salvatorini G., Un flash sul ciclo miocenico del Salento. Soc. paleont. Ital. XII convegno Guida alle escursioni: Bossio A., Mazzei R., Monteforti B., Salvatorini G., Notizie preliminari sul Miocene di S. Maria al Bagno - S. Caterina, presso Nardò (Lecce). Paleopelagos 2: Bossio A., Mazzei R., Monteforti B., Salvatorini G., La successione miocenica nell area tipo delle Calcareniti di Andrano (Puglia, Italia meridionale). Boll. Soc. paleont. ital. 33/2: Bossio A., Esu D., Foresi L.M., Girotti O., Iannone A., Luperto E., Margiotta S., Mazzei R., Monteforti B., Ricchetti G., Salvatorini G., Formazione di Galatone, nuovo nome per un unità litostratigrafia del Salento (Puglia, Italia meridionale). Atti Soc. tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A 105: Bossio A., Foresi L., Margiotta S., Mazzei R., Monteforti B., Salvatorini G., Carta geologica del settore nord orientale della Provincia di Lecce; scala 1:25.000; settore 7, 8, 10 scala 1: Università degli Studi di Siena. Brancucci G., Gazzola A., Geositi e percezione sociale degli elementi naturali. Geologia dell Ambiente, SIGEA 2/2002: 5-8. De Giorgi C., Descrizione geologica e idrografica della Provincia di Lecce. Tip. Salomi, Lecce: Esu D., Girotti O., Iannone A., Pignatti J.S., Ricchetti G., Lagoonal-continental Oligocene of southern Apulia (Italy). Boll. Soc. paleont. ital. 33/2: Leonardi P., Rossi D., Carta Geologica D Italia, Foglio Lecce II edizione. Rilevatori: Largaioli T., Mozzi G., Nardin M.; analista: Ungaro S. Margiotta S., Il contatto Formazione di Galatone-Formazione di Lecce: evidenze stratigrafico-sedimentologiche. Atti Soc. tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A 106: Margiotta S., Studio geologico bio e cronostratigrafico dell Oligocene Superiore - Miocene della Penisola Salentina: evoluzione paleoambientale e paleogeografia. Tesi di Dottorato in Scienze della Terra: Dip. Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari. Margiotta S., Ricchetti G., Stratigrafia dei depositi oligomiocenici del Salento (Puglia). Boll. Soc. Geol. It. 121: Wimbledon W.A.P., Andersen S., Clean C.J., Cowie J.W., Erikstad L., Gongjip G.P., Jhoansson C.E., Karis L.O. Suomen V., Geosites - A global comparative site inventory to enable priorisation for conservation. Second International Symposium on the Conservation of our Geological heritage/word heritage: geotype conservation worldwide, european and italian experiences (Rome, 1996) Mem. Descr. Carta Geol. D It. 2000: (ms. pres. il 2 febbraio 2004; ult. bozze il 20 settembre 2004)
BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta
 Geologica Romana 39 (2006), 1-14 BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio
Geologica Romana 39 (2006), 1-14 BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio
 RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
RELAZIONE INTEGRATIVA ERSU - Fondazione Brigata Sassari Studio Associato di Geologia Madau&Sechi via Pasubio 14 Sassari Tel. 0793493506896 Premessa La presente relazione definisce le caratteristiche litologico
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Capitolo 6 Rilevamento geologico
 Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
Capitolo 6 Rilevamento geologico Rilevamento geologico: finalizzato a fornire informazioni sulle caratteristiche geologiche (litologia rocce affioranti, datazione, rapporti spaziali) di una determinata
GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
Stefano margiotta Inquadramento geologico e territoriale della pietra leccese
 Stefano margiotta Inquadramento geologico e territoriale della pietra leccese La pietra leccese è costituita da biomicriti e biospariti a Foraminiferi planctonici, con dispersi piccoli granuli apatitici
Stefano margiotta Inquadramento geologico e territoriale della pietra leccese La pietra leccese è costituita da biomicriti e biospariti a Foraminiferi planctonici, con dispersi piccoli granuli apatitici
LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO LA FRANA DI TERMINI IMERESE CONTRADA FIGURELLA I GEOLOGI: Dott.ssa - Daniela Alario Dott. Ambrogio Alfieri Dott.
RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA
 RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA PREMESSA - OGGETTO DEI LAVORI I lavori hanno per oggetto l'esecuzione delle infrastrutture di supporto al Piano per gli Insediamenti Produttivi
RELAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA PREMESSA - OGGETTO DEI LAVORI I lavori hanno per oggetto l'esecuzione delle infrastrutture di supporto al Piano per gli Insediamenti Produttivi
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale. Variazioni relative del livello marino
 Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
TERREMOTO CENTRO ITALIA Di.Coma.C Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione. Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016
 Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 Nel corso della giornata sono state operative quattro squadre sul terreno, sono stati elaborati i dati raccolti, con particolare attenzione al database IFFI.
A2.1 - Tabelle per il calcolo dei coefficienti di amplificazione sismica (secondo livello di approfondimento)
 ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
ALLEGATO A2 TABELLE E FORMULE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA PER LE ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TOPOGRAFICI. A2.1 - Tabelle
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
LE ROCCE. Dott.ssa geol. Annalisa Antonelli
 LE ROCCE DEFINIZIONE ROCCIA: aggregato naturale di sostanze minerali cristalline o amorfe Rocce omogenee: costituite da un solo tipo di minerale (es. roccia gessosa, roccia calcarea, salgemma) Rocce eterogenee:
LE ROCCE DEFINIZIONE ROCCIA: aggregato naturale di sostanze minerali cristalline o amorfe Rocce omogenee: costituite da un solo tipo di minerale (es. roccia gessosa, roccia calcarea, salgemma) Rocce eterogenee:
Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali
 Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. VII Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali La Stratigrafia è la sub-disciplina delle Scienze Geologiche che studia, descrive e classifica
Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. VII Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali La Stratigrafia è la sub-disciplina delle Scienze Geologiche che studia, descrive e classifica
1^ Campagna di Agosto 2005
 RAPPORTO QUINDICINALE SULLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE DELLA REGIONE VENETO (RILIEVI SUL CAMPO) 1^ Campagna di Agosto 2005 Nella prima campagna del mese di Agosto 2005, effettuata
RAPPORTO QUINDICINALE SULLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE DELLA REGIONE VENETO (RILIEVI SUL CAMPO) 1^ Campagna di Agosto 2005 Nella prima campagna del mese di Agosto 2005, effettuata
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione:
 CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
Il ciclo delle rocce
 Stratigrafia In una serie rocciosa lo strato è l unità elementare. Uno strato è limitato da superfici generalmente parallele, dette giunti di stratificazione. Il ciclo delle rocce Principi di Stratigrafia
Stratigrafia In una serie rocciosa lo strato è l unità elementare. Uno strato è limitato da superfici generalmente parallele, dette giunti di stratificazione. Il ciclo delle rocce Principi di Stratigrafia
- pag.1 - SOMMARIO Introduzione Pag Caratteri Geologici e Stratigrafici dell Ambito Pag Campagna d indagine Pag.
 Via Giacomo Matteotti 41/ a tel. 071-910.861 - fax 914582 Partita I.V.A. 00161790423 e - mail: lenzicav@libero.it SOMMARIO 1.0. Introduzione Pag. 2 2.0. Caratteri Geologici e Stratigrafici dell Ambito
Via Giacomo Matteotti 41/ a tel. 071-910.861 - fax 914582 Partita I.V.A. 00161790423 e - mail: lenzicav@libero.it SOMMARIO 1.0. Introduzione Pag. 2 2.0. Caratteri Geologici e Stratigrafici dell Ambito
SEZIONI GEOLOGICHE. Esempio di rappresentazione di una sezione geologica
 SEZIONI GEOLOGICHE Una volta costruita, correttamente, la sezione topografica, il passo successivo è costituito dalla rappresentazione della successione di formazioni geologiche che sono presenti nel sottosuolo
SEZIONI GEOLOGICHE Una volta costruita, correttamente, la sezione topografica, il passo successivo è costituito dalla rappresentazione della successione di formazioni geologiche che sono presenti nel sottosuolo
INDICE ALLEGATI: STRALCIO CARTE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA PPE PLANIMETRIE SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE 1 PREMESSA 2 MODELLO GEOLOGICO
 INDICE 1 PREMESSA 2 MODELLO GEOLOGICO 3 MODELLO GEOMORFOLOGICO 4 MODELLO LITOSTRATIGRAFICO 4 INDAGINE IN SITO 4 CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE 7 COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 8 CONCLUSIONI
INDICE 1 PREMESSA 2 MODELLO GEOLOGICO 3 MODELLO GEOMORFOLOGICO 4 MODELLO LITOSTRATIGRAFICO 4 INDAGINE IN SITO 4 CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE 7 COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 8 CONCLUSIONI
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia
 Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
INDICE 1 PREMESSA FASE CONOSCITIVA INQUADRAMENTO GEOLOGICO INDAGINI GEOTECNICHE CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA...
 INDICE 1 PREMESSA... 2 2 FASE CONOSCITIVA... 3 2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO... 3 2.2 INDAGINI GEOTECNICHE... 5 3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA... 7 3.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA DEFORMABILITÀ DEGLI AMMASSI...
INDICE 1 PREMESSA... 2 2 FASE CONOSCITIVA... 3 2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO... 3 2.2 INDAGINI GEOTECNICHE... 5 3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA... 7 3.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA DEFORMABILITÀ DEGLI AMMASSI...
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
 COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Assessorato ai Lavori Pubblici PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE Elaborato: RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Laboratorio di monitoraggio Cavone
 Laboratorio di monitoraggio Cavone Nota relativa all evento sismico del 17 giugno 2016 Sulla base dell accordo per la prima applicazione delle Linee Guida del 23/07/2014 è stata elaborata la presente nota
Laboratorio di monitoraggio Cavone Nota relativa all evento sismico del 17 giugno 2016 Sulla base dell accordo per la prima applicazione delle Linee Guida del 23/07/2014 è stata elaborata la presente nota
PRIMA SEGNALAZIONE DI CYAMODONTOIDEA (PLACODONTIA) NEL CARNICO DELLA VALLE D AMPEZZO, DOLOMITI ORIENTALI
 Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 30 (2014) 415-419 2015 FABRIZIO BIZZARINI & FRANCESCO PIZZOLATO PRIMA SEGNALAZIONE DI CYAMODONTOIDEA (PLACODONTIA) NEL CARNICO DELLA VALLE D AMPEZZO,
Ann. Mus. civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. nat. Vol. 30 (2014) 415-419 2015 FABRIZIO BIZZARINI & FRANCESCO PIZZOLATO PRIMA SEGNALAZIONE DI CYAMODONTOIDEA (PLACODONTIA) NEL CARNICO DELLA VALLE D AMPEZZO,
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici. Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste
 APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
APAT Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine Servizio Difesa delle Coste CAPITOLO 3 IL CLIMA ONDOSO A LARGO DELLE COSTE ITALIANE
Sequenza sismica in Italia centrale: scarpate di faglia prodotte dall evento del 30 ottobre 2016
 Sequenza sismica in Italia centrale: scarpate di faglia prodotte dall evento del 30 ottobre 2016 Scritto da Silvia Mattoni 3 novembre 2016 Il terremoto del 30 ottobre in Italia Centrale ha prodotto almeno
Sequenza sismica in Italia centrale: scarpate di faglia prodotte dall evento del 30 ottobre 2016 Scritto da Silvia Mattoni 3 novembre 2016 Il terremoto del 30 ottobre in Italia Centrale ha prodotto almeno
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO
 REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
REGIONE VENETO ULSS n. 18 ROVIGO Viale Tre Martiri, 89 45100 R O V I G O A47 - PROGETTO PRELIMINARE RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOTECNICO 1.0 PREMESSE Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo
Analisi suolo e sottosuolo
 Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Geol. Paolo CIULLA Via Mancuso n. 5 cap Bisacquino (Pa)
 Geol. Paolo CIULLA Via Mancuso n. 5 cap. 90032 Bisacquino (Pa) INDICE CAPITOLO TITOLO Pag. 1. PREMESSA 2 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL AREA 4 3. GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA 5 4. GEOLOGIA E TETTONICA
Geol. Paolo CIULLA Via Mancuso n. 5 cap. 90032 Bisacquino (Pa) INDICE CAPITOLO TITOLO Pag. 1. PREMESSA 2 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL AREA 4 3. GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA 5 4. GEOLOGIA E TETTONICA
Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse
 Report attività ISPRA del 03 Settembre 2016 Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse 1. Anagrafica sopralluogo Denominazione sito: Comune
Report attività ISPRA del 03 Settembre 2016 Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse 1. Anagrafica sopralluogo Denominazione sito: Comune
5. CALCOLO DELL AZIONE SISMICA DI PROGETTO (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 14 GENNAIO 2008)
 5. CALCOLO DELL AZIONE SISMICA DI PROGETTO (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 14 GENNAIO 2008) L azione sismica di progetto si definisce a partire dalla pericolosità sismica di base del sito d interesse
5. CALCOLO DELL AZIONE SISMICA DI PROGETTO (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 14 GENNAIO 2008) L azione sismica di progetto si definisce a partire dalla pericolosità sismica di base del sito d interesse
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE
 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ INTRODUZIONE 1 Aids in Italia e in Europa 2 HIV/AIDS DIRITTI E RESPONSABILITÀ AIDS IN ITALIA E IN EUROPA Giovanni Rezza Centro Operativo Aids - Istituto Superiore di Sanità
16 Aprile Corso di Geologia e Litologia
 16 Aprile 2008 Corso di Geologia e Litologia Dr. Andrea Berlusconi Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali Università degli Studi dell'insubria via Lucini 3, 22100, Como, Italy mailto: andrea.berlusconi@uninsubria.it
16 Aprile 2008 Corso di Geologia e Litologia Dr. Andrea Berlusconi Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali Università degli Studi dell'insubria via Lucini 3, 22100, Como, Italy mailto: andrea.berlusconi@uninsubria.it
IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA
 TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
TRASPOL REPORT 2/16 IL CARPOOLING IN ITALIA: ANALISI DELL OFFERTA SINTESI DEI RISULTATI Le pratiche di mobilità innovativa (carsharing, carpooling, mobilità elettrica, etc.) mostrano una sempre maggiore
Laboratorio di monitoraggio Cavone
 Laboratorio di monitoraggio Cavone Sulla base dell accordo per la prima applicazione delle Linee Guida del 23/07/2014 è stata elaborata la presente nota per valutare in modo preliminare gli eventi sismici
Laboratorio di monitoraggio Cavone Sulla base dell accordo per la prima applicazione delle Linee Guida del 23/07/2014 è stata elaborata la presente nota per valutare in modo preliminare gli eventi sismici
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
POLO N. 2 - ARGENTA, PONTE BASTIA
 TIPOLOGIA DI POLO LITOLOGIA DEL GIACIMENTO Argilla COMUNE INTERESSATO Argenta INQUADRAMENTO DELL AREA L area è ubicata nei pressi di Ponte Bastia, nel Comune di Argenta. E delimitata a sud dalla Strada
TIPOLOGIA DI POLO LITOLOGIA DEL GIACIMENTO Argilla COMUNE INTERESSATO Argenta INQUADRAMENTO DELL AREA L area è ubicata nei pressi di Ponte Bastia, nel Comune di Argenta. E delimitata a sud dalla Strada
ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE ISSN: 0365-1576
 ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE ISSN: 0365-1576 Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste STUDIO PRELIMINARE DI REPERTI OSSEI DI DINOSAURI DEL CARSO TRIESTINO TIZIANA BRAZZATTI (*) & RUGGERO
ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE ISSN: 0365-1576 Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste STUDIO PRELIMINARE DI REPERTI OSSEI DI DINOSAURI DEL CARSO TRIESTINO TIZIANA BRAZZATTI (*) & RUGGERO
FOCUS Febbraio Una descrizione statistica del personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario PREMESSA
 FOCUS Febbraio 2014 Una descrizione statistica del personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario PREMESSA Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto
FOCUS Febbraio 2014 Una descrizione statistica del personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario PREMESSA Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto
COMUNE DI AGRA. Provincia di Varese
 COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
COMUNE DI AGRA Provincia di Varese STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. AI SENSI DELL ART. 57 DELLA L.R. 12/05 REV02 DEL NOVEMBRE 2009 NOTA TECNICA
3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA
 36 GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA 3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA Ove non specificato diversamente, i simboli areali in colonna A vanno utilizzati nei seguenti modi: 1) sul colore
36 GRUPPO DI LAVORO PER LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA 3. - NOTE PER L'USO DELLA SIMBOLOGIA Ove non specificato diversamente, i simboli areali in colonna A vanno utilizzati nei seguenti modi: 1) sul colore
BASE SISMICA A RIFRAZIONE ST1P (TAV. 2)
 BASE SISMICA A RIFRAZIONE ST1P (TAV. 2) 1. Il sismostrato-1 è caratterizzato da velocità delle onde P di comprese tra 480 m/sec e 540 m/sec; lo spessore di questo sismostrato è variabile: circa 1 m. (scoppio
BASE SISMICA A RIFRAZIONE ST1P (TAV. 2) 1. Il sismostrato-1 è caratterizzato da velocità delle onde P di comprese tra 480 m/sec e 540 m/sec; lo spessore di questo sismostrato è variabile: circa 1 m. (scoppio
Stratigrafia Sequenziale
 Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. IX Stratigrafia Sequenziale Stratigrafia Sequenziale La Stratigrafia Sequenziale si basa sul seguente concetto: Nelle aree marine, la sedimentazione
Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. IX Stratigrafia Sequenziale Stratigrafia Sequenziale La Stratigrafia Sequenziale si basa sul seguente concetto: Nelle aree marine, la sedimentazione
Antiforme con piano assiale verticale ed asse orizzontale (A profilo; B carta) 1/3. area con rilievi
 Analisi cartografica delle pieghe: Traccia del Piano assiale Se le condizioni di affioramento sono abbastanza buone è possibile determinare la forma e la giacitura di una piega direttamente in campagna.
Analisi cartografica delle pieghe: Traccia del Piano assiale Se le condizioni di affioramento sono abbastanza buone è possibile determinare la forma e la giacitura di una piega direttamente in campagna.
Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente.
 Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
Report ARPAT Monitoraggio Laguna di Orbetello Relazione mensile su dati rilevati dalle centraline di Laguna Levante e Laguna Ponente. Agosto 2014 Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto 1 Introduzione
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE
 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE La Carta geologica è una carta tematica che fornisce una rappresentazione bidimensionale dei terreni e delle rocce affioranti in una certa regione e dei
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE GEOLOGICHE La Carta geologica è una carta tematica che fornisce una rappresentazione bidimensionale dei terreni e delle rocce affioranti in una certa regione e dei
5.4. La matrice di correlazione
 6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
6 CO 4 (mg/m 3 ) 2 domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Giorni della settimana P. Bissuola Outliers Extremes P. Matter Outliers Extremes Le distribuzioni degli inquinanti non mostrano
Figura 1 Foto aerea del sito studiato. L area di interesse archeologico è delimitata dal cerchio rosso.
 ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA E DEI SUOI TESORI INVISIBILI: INDAGINI GEOFISICHE E DATABASE ON LINE PER IL SITO DI EGNAZIA ALLEGATO TECNICO Le tecniche geofisiche da oltre 50 anni offrono un importante contributo
ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA E DEI SUOI TESORI INVISIBILI: INDAGINI GEOFISICHE E DATABASE ON LINE PER IL SITO DI EGNAZIA ALLEGATO TECNICO Le tecniche geofisiche da oltre 50 anni offrono un importante contributo
di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico
 di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico L Isola di Sant Antioco si è formata oltre centocinquanta milioni di anni fa. A tale epoca risalgono le rocce più antiche
di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico L Isola di Sant Antioco si è formata oltre centocinquanta milioni di anni fa. A tale epoca risalgono le rocce più antiche
LA GEOMETRIA DELLE FAGLIE DIRETTE ED ASSOCIAZIONI DI FAGLIE DIRETTE
 LA GEOMETRIA DELLE FAGLIE DIRETTE ED ASSOCIAZIONI DI FAGLIE DIRETTE Per faglia si intende una discontinuità meccanica lungo cui si é sviluppato un movimento apprezzabile Consideriamo una successione di
LA GEOMETRIA DELLE FAGLIE DIRETTE ED ASSOCIAZIONI DI FAGLIE DIRETTE Per faglia si intende una discontinuità meccanica lungo cui si é sviluppato un movimento apprezzabile Consideriamo una successione di
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION
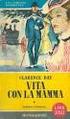 AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
SIGEA. La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo. da scavo
 SIGEA La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo Il Campionamento delle Terre e rocce da scavo Bari 14 giugno 2013 Geol. Marcello Panarese
SIGEA La disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, opportunità per la riduzione del consumo di suolo Il Campionamento delle Terre e rocce da scavo Bari 14 giugno 2013 Geol. Marcello Panarese
Caso II: Modellazione della generazione di fessurazioni e riattivazione delle faglie dovuta all estrazione di fluidi dal sottosuolo (Wuxi, China)
 Analisi modellistica del rischio idrogeologico connesso alla geomeccanica della produzione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo Omar Tosatto, Carlo Janna, Massimiliano Ferronato, Pietro Teatini www.m3eweb.it
Analisi modellistica del rischio idrogeologico connesso alla geomeccanica della produzione e stoccaggio di fluidi nel sottosuolo Omar Tosatto, Carlo Janna, Massimiliano Ferronato, Pietro Teatini www.m3eweb.it
Analisi delle condizioni di stabilità di una discarica di terra in Sant Agata di Puglia (Italia meridionale)
 Giornale di Geologia Applicata 4 (2006) 79-84, doi: 10.1474/GGA.2006-04.0-10.0138 Analisi delle condizioni di stabilità di una discarica di terra in Sant Agata di Puglia (Italia meridionale) Luigi Monterisi
Giornale di Geologia Applicata 4 (2006) 79-84, doi: 10.1474/GGA.2006-04.0-10.0138 Analisi delle condizioni di stabilità di una discarica di terra in Sant Agata di Puglia (Italia meridionale) Luigi Monterisi
Ambito antropico. a. L area di indagine
 Ambito antropico Questo primo rapporto relativo all analisi socio-economica dell area su cui insiste il Parco nazionale del Vesuvio intende fornire un primo inquadramento di carattere generale sulle caratteristiche
Ambito antropico Questo primo rapporto relativo all analisi socio-economica dell area su cui insiste il Parco nazionale del Vesuvio intende fornire un primo inquadramento di carattere generale sulle caratteristiche
Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord. Sopralluogo del 30 marzo 2016 * * *
 Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord * * * Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio Aprile 2016 NT/SUO 2016/063 1 PREMESSA Il giorno 30 marzo i tecnici ISPRA
Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'italia * * * Arenile Nord * * * Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio Aprile 2016 NT/SUO 2016/063 1 PREMESSA Il giorno 30 marzo i tecnici ISPRA
Parole e frequenze. Alessandro Lenci
 Parole e frequenze Alessandro Lenci Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica Via Santa Maria, 36, 5600 Pisa, Italy alessandro.lenci@ilc.cnr.it Linguaggio e comunicazione - LO042 Rango di una parola
Parole e frequenze Alessandro Lenci Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica Via Santa Maria, 36, 5600 Pisa, Italy alessandro.lenci@ilc.cnr.it Linguaggio e comunicazione - LO042 Rango di una parola
TOPOGRAFIA e CARTOGRAFIA
 1. Un ettometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 2. Un chilometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 3. Un decametro corrisponde a : a. 0,1 m ; b. 0,01 m ; c. 10
1. Un ettometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 2. Un chilometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 3. Un decametro corrisponde a : a. 0,1 m ; b. 0,01 m ; c. 10
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA
 RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA 1. PREMESSA Nella presente relazione viene riportato lo studio idrologico ed idraulico relativo al reticolo idrografico interferente con la strada di collegamento tra
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA 1. PREMESSA Nella presente relazione viene riportato lo studio idrologico ed idraulico relativo al reticolo idrografico interferente con la strada di collegamento tra
Ore 8:00 Partenza da Potenza (Piazza Zara) o da altra sede istituto scolastico interessato.
 VISITA GUIDATA: MATERA (VISITA AI SASSI) E MONTALBANO JONICO (DISCESA NEL PARCO DEI CALANCHI) Ore 8:00 Partenza da Potenza (Piazza Zara) o da altra sede istituto scolastico interessato. Ore 9:30 c.a. Arrivo
VISITA GUIDATA: MATERA (VISITA AI SASSI) E MONTALBANO JONICO (DISCESA NEL PARCO DEI CALANCHI) Ore 8:00 Partenza da Potenza (Piazza Zara) o da altra sede istituto scolastico interessato. Ore 9:30 c.a. Arrivo
LETTURA e INTERPRETAZIONE delle CARTE GEOLOGICHE
 LETTURA e INTERPRETAZIONE delle CARTE GEOLOGICHE Una carta geologica è la registrazione di come sono distribuite sulla superficie terrestre rocce di età e natura diverse; essa è anche, e soprattutto, una
LETTURA e INTERPRETAZIONE delle CARTE GEOLOGICHE Una carta geologica è la registrazione di come sono distribuite sulla superficie terrestre rocce di età e natura diverse; essa è anche, e soprattutto, una
Ambito estrattivo 3S - Scalello
 Ambito estrattivo 3S - Scalello Comune di: Sarsina Località: Scalello Area inserita nel PAE Comunale con sigla: Ii10 Stato di fatto: Area con attività estrattiva in corso L Area è inserita nel PIAE vigente?:
Ambito estrattivo 3S - Scalello Comune di: Sarsina Località: Scalello Area inserita nel PAE Comunale con sigla: Ii10 Stato di fatto: Area con attività estrattiva in corso L Area è inserita nel PIAE vigente?:
Aosta. 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone
 Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
Aosta 19 Ottobre 2011 STUDI DI PRIMO LIVELLO NELLA MICROZONAZIONE SISMICA: I COMUNI DI SUSA (TO) E DRONERO (CN) Gianluigi Perrone Dipartimento di Scienze della Terra Università di Torino Obiettivo: illustrare
 REGIONE PUGLIA Comune di Cassano delle Murge (Bari) Lame: protezione idraulica abitato - intervento per la realizzazione di un sistema di protezione idraulica dell abitato zona Nord-Ovest Sondaggio Geoelettrico
REGIONE PUGLIA Comune di Cassano delle Murge (Bari) Lame: protezione idraulica abitato - intervento per la realizzazione di un sistema di protezione idraulica dell abitato zona Nord-Ovest Sondaggio Geoelettrico
INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA
 INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA Supporto ai processi di caratterizzazione 471/99 TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D E 3D METODO ERT - GMS VERIFICA
INDAGINI GEOFISICHE NON INVASIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E AMBIENTALE DI UNA DISCARICA Supporto ai processi di caratterizzazione 471/99 TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D E 3D METODO ERT - GMS VERIFICA
POLO N. 5 BONDENO, SETTEPOLESINI
 TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
TIPOLOGIA DI POLO Polo esistente confermato nella pianificazione provinciale quale polo per la produzione di materiali pregiati a destinazione prevalente di trasformazione industriale. LITOLOGIA DEL GIACIMENTO
Esercizio 2 Domi di esfoliazione (Yosemite National Park, California, USA) Domande
 Esercizio 1 La carta mostra delle curve di livello solo in una sua parte. (a) Si definisca la scala della carta: (b) Utilizzando i punti quotati si disegnino le curve di livello principali (di 100 in 100
Esercizio 1 La carta mostra delle curve di livello solo in una sua parte. (a) Si definisca la scala della carta: (b) Utilizzando i punti quotati si disegnino le curve di livello principali (di 100 in 100
Aggiornamento Eruzione Etna 21 luglio 2008 Composizione dei vetri
 Prot. int. n UFVG2008/074 Aggiornamento Eruzione Etna 21 luglio 2008 Composizione dei vetri Rosa Anna Corsaro - Lucia Miraglia PREMESSA L eruzione in corso dal 13 maggio 2008 si è sviluppata in un contesto
Prot. int. n UFVG2008/074 Aggiornamento Eruzione Etna 21 luglio 2008 Composizione dei vetri Rosa Anna Corsaro - Lucia Miraglia PREMESSA L eruzione in corso dal 13 maggio 2008 si è sviluppata in un contesto
INTERVENTO 1 STRALCIO: URBANIZZAZIONI PROGETTO ESECUTIVO INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE DI VALUTAZIONE
 REGIONE PUGLIA INTERVENTO COFINANZIATO DAL PO FESR 2007-2013 ASSE VII LINEA DI INTERVENTO 7.1 AZIONE 7.1.2 CODICE OPERAZIONE FE7.100117 PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE PIRP SAN
REGIONE PUGLIA INTERVENTO COFINANZIATO DAL PO FESR 2007-2013 ASSE VII LINEA DI INTERVENTO 7.1 AZIONE 7.1.2 CODICE OPERAZIONE FE7.100117 PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE PIRP SAN
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA
 AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
AREE IMPORTANTI PER L AVIFAUNA NEL FIUME ARNO (PROV. DI FIRENZE): INDIVIDUAZIONE DELLE EMERGENZE E PROSPETTIVE DI TUTELA MICHELE GIUNTI & PAOLO SPOSIMO * c/o Nemo srl, via Giotto 33 50121, Firenze 055/674223
Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile
 1.8 SCENARIO DI CORRELATO ALL INTERRUZIONE VIABILISTICA E ALL ISOLAMENTO DI CENTRI ABITATI 1.8.1 IL CASO STUDIO DELLA S.P. 63: BALLABIO MORTERONE (LC) Alla luce della normativa vigente nel settore della
1.8 SCENARIO DI CORRELATO ALL INTERRUZIONE VIABILISTICA E ALL ISOLAMENTO DI CENTRI ABITATI 1.8.1 IL CASO STUDIO DELLA S.P. 63: BALLABIO MORTERONE (LC) Alla luce della normativa vigente nel settore della
La cartografia geomorfologica
 Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze della Terra La cartografia geomorfologica Prof. Massimiliano FAZZINI AA..AA..2015/16 1. Fondamenti della Cartografia Geomorfologica Le carte geomorfologiche
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze della Terra La cartografia geomorfologica Prof. Massimiliano FAZZINI AA..AA..2015/16 1. Fondamenti della Cartografia Geomorfologica Le carte geomorfologiche
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti
 Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Monterotondo Marittimo (GR). La Rocca degli Alberti Lo scavo all interno della Rocca degli Alberti, a Monterotondo M.mo, è iniziato nel 2005, nell ambito delle indagini sulle forme del popolamento nelle
Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici
 Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici L archeologia è una disciplina che cerca di ricostruire i processi storici a partire dagli oggetti Fuori contesto? Recupero di oggetti da
Fondamenti di Archeologia Archeologia e contesti archeologici L archeologia è una disciplina che cerca di ricostruire i processi storici a partire dagli oggetti Fuori contesto? Recupero di oggetti da
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL CENTRO STORICO DI ROMA
 GNGTS 2013 - Sessione 2.2 Effetti di sito Trieste, 21 novembre 2013 MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL CENTRO STORICO DI ROMA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL CENTRO STORICO DI ROMA M. Moscatelli
GNGTS 2013 - Sessione 2.2 Effetti di sito Trieste, 21 novembre 2013 MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL CENTRO STORICO DI ROMA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL CENTRO STORICO DI ROMA M. Moscatelli
L analisi stratigrafica delle murature in elevato
 Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Rilievo dell architettura. Il rilievo per l archeologia L analisi stratigrafica delle murature in elevato Rilevare la struttura muraria ed i suoi corredi funzionali ed estetici, costituisce una operazione
Complesso argilloso. Funtanamela. Analisi chimica argille. SiO2. TiO2 FUNTANAMELA
 Complesso argilloso Il complesso in questione, riferibile al Bajociano-Batoniano (Periodi del Giurese medio), è costituito da una sequenza di livelli argillosi ben stratificati, con colore variabile dal
Complesso argilloso Il complesso in questione, riferibile al Bajociano-Batoniano (Periodi del Giurese medio), è costituito da una sequenza di livelli argillosi ben stratificati, con colore variabile dal
CARTOGRAFIA 2 V 1 LA CARTA TRADIZIONALE. È la rappresentazione sul piano della superficie terrestre secondo determinate norme e segni convenzionali
 CARTOGRAFIA 2 V 2 P V 3 V 1 π LA CARTA TRADIZIONALE È la rappresentazione sul piano della superficie terrestre secondo determinate norme e segni convenzionali È costituita da un disegno che rappresenta
CARTOGRAFIA 2 V 2 P V 3 V 1 π LA CARTA TRADIZIONALE È la rappresentazione sul piano della superficie terrestre secondo determinate norme e segni convenzionali È costituita da un disegno che rappresenta
n 1 ZONE ARCHEOLOGICHE TORRE CASTELLO - AZETIUM
 n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
n 1 TORRE CASTELLO - AZETIUM TORRE CASTELLO - AZETIUM In contrada Torre Castello numerosi rinvenimenti occasionali ed estese indagini di superficie e campagne di scavo effettuate dalla Sovrintendenza Archeologica
CITTA' DI PARABITA TAV. D. Relazione Geologico-Geotecnica LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI PUBBLICHE PROVINCIA DI LECCE REGIONE PUGLIA
 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse I - Misura 125 - "miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" -Azione 3 "ammodernamento
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse I - Misura 125 - "miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" -Azione 3 "ammodernamento
RELAZIONE EVENTO 19-20/10/2016
 RELAZIONE EVENTO 19-1. Sommario 1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2. SITUAZIONE GENERALE... 2 3. FENOMENI OSSERVATI... 2 4. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI... 3 5. ANALISI DELLE IMMAGINI
RELAZIONE EVENTO 19-1. Sommario 1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2. SITUAZIONE GENERALE... 2 3. FENOMENI OSSERVATI... 2 4. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI... 3 5. ANALISI DELLE IMMAGINI
Fig. 51 Campioni delle tecniche murarie riconosciute nel palazzo.
 LE TECNICHE MURARIE Presentiamo in questa sede i primi risultati del lavoro di ricerca e documentazione sulle tecniche murarie in S. Giovanni Valdarno, relativamente al Palazzo d'arnolfo. Tutte le murature
LE TECNICHE MURARIE Presentiamo in questa sede i primi risultati del lavoro di ricerca e documentazione sulle tecniche murarie in S. Giovanni Valdarno, relativamente al Palazzo d'arnolfo. Tutte le murature
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE FACOLTA DI INGEGNERIA
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO (CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, CLASSE N. L-7) DIPARTIMENTO
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI
 SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
piante vascolari minacciate e liste Rosse: aggiornamento delle conoscenze in puglia
 422 informatore Botanico italiano, 45 (2) 393-432, 2013 Contributi scientifici Sezioni Regionali e Gruppi S.B.I. piante vascolari minacciate e liste Rosse: aggiornamento delle conoscenze in puglia R.p.
422 informatore Botanico italiano, 45 (2) 393-432, 2013 Contributi scientifici Sezioni Regionali e Gruppi S.B.I. piante vascolari minacciate e liste Rosse: aggiornamento delle conoscenze in puglia R.p.
Capitolo 12 Le acque sotterranee
 Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
Capitolo 12 Le acque sotterranee Acque sotterranee: si organizzano in corpi idrici con caratteristiche differenti a seconda del tipo di materiale Rocce cristalline o sedimentarie: circolano prevalentemente
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA Dott.ssa Geol. Daniela Alario
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA Dott.ssa Geol. Daniela Alario
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PROSPEZIONI GEOLOGICHE E CARTOGRAFIA
 CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PROSPEZIONI GEOLOGICHE E CARTOGRAFIA 1. Obiettivi formativi I laureati nel corso di Laurea Specialistica in Prospezioni geologiche e cartografia acquisiranno: - un elevata
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PROSPEZIONI GEOLOGICHE E CARTOGRAFIA 1. Obiettivi formativi I laureati nel corso di Laurea Specialistica in Prospezioni geologiche e cartografia acquisiranno: - un elevata
Pianta del fabbricato con ubicazione dell'impianto di dispersione - Stralcio Carta Geolitologica - scala 1:5000,
 C C A JJ 6 = L = E = A C = J + 7 -, 1/ 7 ), 6 ), 1 2 H L E? E= @ E2 A H K C E= 2 4 / - 6 6 2-4 ) 4 - ) 1 ) 1 -, 17 ) 7. ) 6 6, ) ), 1* 14 - ), ) 6 6 18 16 ) + - 4 + 1) - 5 16 1 + 8 6-4 A = E = E A @ EK
C C A JJ 6 = L = E = A C = J + 7 -, 1/ 7 ), 6 ), 1 2 H L E? E= @ E2 A H K C E= 2 4 / - 6 6 2-4 ) 4 - ) 1 ) 1 -, 17 ) 7. ) 6 6, ) ), 1* 14 - ), ) 6 6 18 16 ) + - 4 + 1) - 5 16 1 + 8 6-4 A = E = E A @ EK
IL PIANIO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. L ATTUAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA
 IL PIANIO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. L ATTUAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA Premessa. Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) [2], istituito dall art. 32 Legge 144/99, ha il fine di ridurre
IL PIANIO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. L ATTUAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA Premessa. Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) [2], istituito dall art. 32 Legge 144/99, ha il fine di ridurre
Relazione scientifica finale del fruitore del Programma STM Short Term Mobility
 Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali CNR Oggetto: Relazione scientifica finale del fruitore del Programma STM Short Term Mobility Anno 2015 Il soggiorno di ricerca nell ambito del programma STM 2015
Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali CNR Oggetto: Relazione scientifica finale del fruitore del Programma STM Short Term Mobility Anno 2015 Il soggiorno di ricerca nell ambito del programma STM 2015
LIVELLO 2 di MICROZONAZIONE SISMICA
 LIVELLO 2 di MICROZONAZIONE SISMICA Il Livello 2 di MS è obbligatorio, preventivamente all adozione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e ai Piani di Emergenza Comunali (PEC) presentati dopo il 28 Giugno
LIVELLO 2 di MICROZONAZIONE SISMICA Il Livello 2 di MS è obbligatorio, preventivamente all adozione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e ai Piani di Emergenza Comunali (PEC) presentati dopo il 28 Giugno
"Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido "
 "Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido " Facciamo seguito al nostro comunicato stampa del 16 marzo 2016 sulla questione sabbie nere e radioattività dei sedimenti lungo l'arenile
"Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto Lido " Facciamo seguito al nostro comunicato stampa del 16 marzo 2016 sulla questione sabbie nere e radioattività dei sedimenti lungo l'arenile
Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava
 Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava Volate tipo per l abbattimento di materiali lapidei in cave di porfido Volate tipo per la realizzazione di nuove viabilità all interno delle
Ottimizzazione dell uso dell esplosivo nei cantieri di cava Volate tipo per l abbattimento di materiali lapidei in cave di porfido Volate tipo per la realizzazione di nuove viabilità all interno delle
ORDINE DEI GEOLOGI DELL ORDINE DEI GEOL A TOSCANA
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 9 dicembre 2008 Elaborato a se stante, autonomo La relazione idrogeologica Mirata al tipo di progetto da supportare ma deve comunque sempre contenere informazioni sulla
