RAPPORTO SULL EVENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL 20 SETTEMBRE 2014
|
|
|
- Norberto Testa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RAPPORTO SULL EVENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL 2 SETTEMBRE 214 A cura di Centro Funzionale Regione Eilia-Roagna Unità Radareteorologia, Radarpluvioetria, Nowcasting e Reti non convenzionali Bologna, 3 ottobre 214 RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 1
2 RIASSUNTO La forazione di un vasto sistea convettivo organizzato (del tipo Mesoscale Convective Coplex), in seno a correnti sud-occidentali in quota calde e uide, ha deterinato, durante le prie ore del attino di sabato 2 settebre, precipitazioni estese e olto intense su tutto il settore centro orientale della regione. I assii quantitativi di pioggia sono stati registrati sulla parta alta dei bacini copresi fra il fiue Reno e il Montone. Tali quantitativi, che hanno raggiunto valori record di cuulata alla diverse scale teporali (1, 3, 6, 12 ore), hanno deterinato piene fluviali ipulsive con valori in olte sezioni superiori ai assii storici. Si segnalano gravi danni alle infrastrutture coe soronto di ponti e parziale allagaento di centri abitati (Iola, Castrocaro, Modigliana). In copertina: Danni al ponte di Rineggio, nei pressi di Borgo Tossignano, dovuti al soronto del fiue Santerno. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 2
3 INDICE 1. PREMESSA EVOLUZIONE METEOROLOGICA GENERALE E ZONE INTERESSATE ANALISI DELL EVOLUZIONE ALLA MESOSCALA SULL EMILIA-ROMAGNA LE PIENE DEI FIUMI SANTERNO, SENIO, LAMONE E MONTONE Analisi pluvioetrica sui bacini Propagazione della piena sui corsi d acqua LE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E MONITORAGGIO DEL CENTRO FUNZIONALE CONCLUSIONI E RAFFRONTO CON GLI EVENTI DEL PASSATO RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 3
4 1. PREMESSA La forazione di un vasto sistea convettivo, in seno a correnti sud-occidentali calde e uide in quota ha deterinato, durante le prie ore del attino di sabato 2 settebre, precipitazioni teporalesche estese e olto intense su tutto il settore centro orientale della regione. Il nubifragio è stato originato dalla forazione di un sistea convettivo organizzato alla esoscala (MCS). Questi, si differenziano dai teporali ordinari a cella singola o ulticella che di solito hanno durante inferiori o intorno all ora o occupano pochi K 2, per il aggior grado di organizzazione spaziale e durata. Gli MCS sono sistei teporaleschi che hanno diensioni spaziali superiori ai 25 K, durate uguali o superiori a 6 ore, che possono deterinare piogge estese. I assii quantitativi di pioggia sono stati registrati sulla parta alta dei bacini copresi fra il fiue Reno e il Montone. Tali quantitativi, che hanno raggiunto valori notevoli di cuulata alle diverse scale teporali (1 ora, 6 e 12 ore), hanno deterinato piene fluviali ipulsive con coli in olte sezioni dei tratti ontani, superiori o pari ai assii storici. I bacini aggiorente investiti da questo sistea sono stati quello del Santerno, Senio, Laone e Montone dove una precipitazione concentrata, soprattutto nel tratto ontano, anche superiore ai 15 in 6 ore, ha deterinato un iprovviso colo di piena che rapidaente ha raggiunto e superato il livello di allare in olte sezioni di chiusura dei bacini. Il transito della piena con tali livelli ha deterinato allagaenti diffusi anche oltre le norali zone di espansione fluviale raggiungendo spesso le aree di allagaento classificate con tepo di ritorno 2 anni fino alla chiusura dei bacini ontani. L alleggeriento della piena a onte, causato dalle diffuse esondazioni in più tratti, ha favorito l ingresso in pianura di una piena già contenuta per effetto della lainazione, a ancora in grado di far registrare livelli ragguardevoli aleno nelle prie sezioni del tratto arginato; poi rapidaente i livelli verso valle si sono attenuati progressivaente, grazie anche alle condizioni favorevoli dei ricettori e dello stato iniziale di inio deflusso dei fiui. L evento registrato è stato seguito e onitorato nella sua rapidissia evoluzione, a per le sue caratteristiche, che verranno esainate in dettaglio nei paragrafi che seguono, non è stato possibile prevederlo con la odellistica eteorologica nuerica. Nel territorio sono stati segnalati gravi danni alle infrastrutture dei ponti e delle traverse fluviali, nonchè allagaenti diffusi in prossiità dei nei centri abitati. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 4
5 2. EVOLUZIONE METEOROLOGICA GENERALE E ZONE INTERESSATE L evoluzione di un blocco anticiclonico, presente fino al 15 settebre sull Europa centrale, deterina il posizionaento di una vasta onda depressionaria in quota a ovest della penisola iberica già dal 17 settebre. Il progressivo avvicinaento e inclinazione dell onda ciclonica in quota spinge, già dal 17 settebre, verso il Mediterraneo centrale, asse d aria calde e uide olto instabili. Nel seno di queste correnti scorrono piccoli ipulsi perturbati che vanno ad interessare dappria la Francia eridionale, dove si registra la forazione di nuerosi sistei convettivi organizzati, all origine anche di una alluvione lapo il giorno 18 settebre che ha causato 5 orti in un capeggio di Laalou-Les-Bains. Dal 18 fino al 2 le correnti sudoccidentali tendono a uoversi lentaente verso est, portando il loro centro d azione verso il Mar Ligure, entre sulle regioni centro-eridionali perane un capo anticiclonico di origine subtropicale (vedi Figura 1). Figura 1: Mappe di analisi (da odello IFS-ECMWF) del capo di geopotenziale, teperatura e vento al livello di pressione di 5 hpa (sinistra) e 85 hpa (destra). Da notare la notevole avvezione di aria calda e uida nei bassi strati (85hPa). Durante la notte fra il 19 e 2, il sopraggiungere di altri corpi nuvolosi dal Tirreno ha deterinato una nuova intensificazione della fenoenologia, non ben prevista dai odelli nuerici a disposizione nella giornata di venerdì 19. Infatti i odelli (ECMWF e COSMO) prevedevano il passaggio di un odesto ipulso perturbato con precipitazioni sulla Toscana centrale e in un secondo tepo sulla pianura eiliana, entre invece, coe vedreo nel dettaglio, la zona di genesi e persistenza dei teporali è stata quella del crinale appenninico dal parense fino al forlivese. Inoltre, quello che assolutaente non era presente nella odellistica nuerica, anche nelle corse più prossie all evento, era l indicazione dell elevato grado di organizzazione dei sistei convettivi che hanno portato ad una precipitazione su aree olto estese, entre i odelli al più hanno fornito indicazioni di piogge teporaneaente intense e localizzate. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 5
6 Figura 2: Iagini satellitari MSG-Euetrain nel canale dell infrarosso (1.8) con colorazione del top delle nubi più fredde. Per caratterizzare la situazione eteorologica, dal punto di vista dinaico e terodinaico, sulla stessa appa sono state sovrapposte un indicatore del flusso a 3 hpa (jet level) e il lapse rate fra 85 e 5 hpa. A sinistra la situazione alle UTC a destra quella delle 6 UTC dove risulta orai olto evidente il sistea convettivo alla esoscala (MCC), orai in fase atura. 3. ANALISI DELL EVOLUZIONE ALLA MESOSCALA SULL EMILIA-ROMAGNA Dall analisi degli echi radar, riportati nelle appe in Figura 5 e Figura 6, a passi orari dalle 22 alle 5 UTC, è possibile cogliere bene l evoluzione dei sistei precipitanti che hanno dato luogo all evento. La precipitazione sul crinale appenninico ha inizio nella serata del giorno 19, con isolati nuclei di precipitazione convettiva intensa. Attorno alle 23 UTC sebra prevalere il sistea teporalesco presente sull Appennino bolognese, che da luogo a notevoli intensità istantanee a di breve durata, anche a carattere grandinigeno, coe evidenziato dal radar. Infatti in Figura 3 sono riportate le appe di VIL (grandezza che riporta il contenuto di acqua lungo la colonna verticale) e di POH (probabilità di grandine) tra le e le UTC. Nelle appe sono evidenziate dal cerchio bianco le aree dove è olto probabile la presenza di grandine. Il sistea poi transita veloceente verso l appennino forlivese dando luogo a cuulate in alcuni casi già significative a che posso rientrare nella dinaica di norale passaggio teporalesco. Successivaente invece di assistere ad un graduale iglioraento, coe previsto dai odelli, si verifica la nuova forazione di attività convettiva diffusa su tutto il crinale, che ha dato vita in aniera rapidissia e inaspettata (fra le 1 e le 3 UTC) alla forazione di un unico grande sistea convettivo classificabile coe Mesoscale Convective Coplex (MCC), nel quale si sono fusi tutti i sistei convettivi presenti. In questo periodo di forazione del MCC si sono registrate le precipitazioni più forti, inclusi i 67.8 /1h isurati dal pluvioetro di Firenzuola fra le 1.15 e le 2.15 UTC. Alle 6 UTC l MCC risultava già nella sua fase atura, ben visibile nella Figura 2 sul pannello di destra. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 6
7 Figura 3. Mappe di VIL (sopra) e POH (sotto) del 19/9/214 alle UTC, 23.4 UTC, UTC (da sinistra a destra). Zoo sull area di precipitazione intensa. Gli MCC, particolare sottocategoria di sistei convettivi alla esoscala (MCS), non sono inediti sul bacino del Mediterraneo anche se piuttosto rari. Essi richiedono infatti condizioni particolari per il loro sviluppo e anche a livello planetario non sono così frequenti (Barry and Carleton, 21). Le zone a aggiore probabilità di sviluppo degli MCC sono quelle prossie all equatore e alle grandi pianure degli Stati Uniti e dell Aerica del sud. Si sviluppano tipicaente durante le ore notturne in zone caratterizzate da una forte avvezione calda-uida nei bassi strati che deterina strati condizionataente instabili. Lo sviluppo tipico durante le ore notturne e su terrafera avviene poiché il processo di organizzazione della convezione è favorito dal forte raffreddaento per irraggiaento dal top delle nubi (aggiore durante la notte) e dalla presenza di un low level jet che si intensifica nelle ore notturne in presenza dell inversione terica. Altra condizione è la presenza del jet subtropicale in quota a curvatura anticiclonica che favorisce l afflusso di uidità e la divergenza in quota. In ultio le inforazioni derivanti dalla distribuzione cliatologica degli MCC suggeriscono una genesi preferenziale sottovento ad iportanti catene ontuose che evidenteente fungono da triggering per la nascita di celle conteporanee su un area vasta. Tutti questi ingredienti li ritroviao nell analisi dettagliata delle condizioni a esoscala che hanno portato alla forazione del sistea del 2 settebre, che può essere quindi classificato coe uno dei pochi casi di MCC registrati e analizzati sulla nostra regione in tepi recenti. Per accertarci che il sistea convettivo in oggetto si ascrivibile veraente ad un MCC, abbiao applicato i criteri di classificazione proposti da Maddox (198) basati sulle caratteristiche delle proprietà teriche, estensione spaziale e fora del top delle nubi. Coe ostrato in Figura 4 (pannello di sinistra) tale analisi soddisfa pienaente i criteri per gli MCC (area con Tep al top delle nubi < -52 C deve essere aggiore di 5ila K 2, la fora deve essere leggerente ellittica con asse aggiore lungo il vento prevalente in quota) ostrando un area con Ttop < - 52 C estesa per oltre 153ila K 2. La zona con teperature al top inori di -52 C corrisponde in via qualitativa alla zona interessata da precipitazioni al suolo di elevata intensità, è quindi RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 7
8 olto vasta. Fortunataente il sistea si è osso rapidaente verso est, scaricando il grosso del suo carico e della sua violenza in are. Sul are si sono infatti raggiunti i valori più bassi di teperatura delle nubi, che sono scesi sotto i -7 C su apie zone, indice di apie aree caratterizzate da fortissie correnti ascensionali. Il sondaggio di San Pietro Capofiue delle ore UTC del 2/9, poco pria della nascita del sistea, evidenzia coe l abiente fosse favorevole alla sua forazione dovuto alla presenza di apio strato instabile e alla rotazione con la quota in senso orario del vento negli strati edio bassi, indicatore di un avvezione calda in atto. Figura 4: Nel pannello di sinistra viene ostrata una particolare elaborazione dell iagine da satellite che evidenzia le diensioni raggiunte dall MCC nella sua fase atura, un area aggiore di 15 ila K 2. Nel pannello di destra è presente il radiosondaggio effettuato alle UTC, durante la fase i sviluppo del sistea, a S. Pietro Capofiue. Dall analisi della oviola radar e da satellite si stia la forazione del sistea intorno alle 1: UTC e il suo definitivo esauriento intorno alle 15 UTC dello stesso giorno sulla Bulgaria dopo aver attraversato l Adriatico centro settentrionale e la parte centro eridionale della regione balcanica. Si stia quindi un tepo di vita del sistea di circa 14 ore, quindi un ordine di grandezza in più rispetto ad un sistea teporalesco ordinario che di solito presenta un tepo di vita edio di circa 1 ora. Durante il suo percorso sulla nostra regione questo sistea convettivo ha scaricato notevolissie quantità di pioggia lungo il crinale appenninico centro-orientale a anche piogge oderate su tutta l area di pianura. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 8
9 Figura 5: Mappe di riflettività del 19/9/214 alle 22: UTC (in alto a sinistra), alle 23: UTC (in alto a destra), del 2/9/214 alle : UTC (in basso a sinistra) e alle 1: UTC (in basso a destra). Figura 6: Mappe di riflettività del 2/9/214 alle 2: UTC (in alto a sinistra), alle 3: UTC(in alto a destra), alle 4: UTC (in basso a sinistra) e alle 5: UTC (in basso a destra). RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 9
10 La Figura 7 illustra infatti la pioggia cuulata osservata traite radar nelle 15 ore centrali dell evento, dalla quale appare evidente coe l Appennino centro-orientale sia stata la zona aggiorente interessata dal fenoeno. Le cuulate di pioggia più elevate sono state registrate dai pluvioetri di Barco e Firenzuola, localizzati in corrispondenza delle nucleo di precipitazione radar aggiore, sebbene nell evento in esae i pluvioetri abbiano registrato cuulate inferiori a quelle del radar (vedi Figura 9), probabilente a causa della presenza di grandine, il cui contributo non è rilevato dai pluvioetri, e può deterinare una sottostia del quantitativo di precipitazione. Figura 7: Cuulate di precipitazione dalle 18: UTC del 19/9/214 alle 9: UTC del 2/9/214 con sovrapposte le stazioni che hanno isurati i assii di pioggia. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 1
11 Arpa Eilia-Roagna 4. LE PIENE DEI FIUMI SANTERNO, SENIO, LAMONE E MONTONE L evento eteorologico sopra descritto, caratterizzato da piogge di elevata intensità concentrate in poche ore, ha generato piene ipulsive sui bacini del Santerno, Senio, Laone e Montone, con livelli idroetrici che in olte sezioni del tratto ontano hanno superato o raggiunto i assii storici registrati. Travallino Sostegno S. Pietro Capofiue Nella Figura 8 sono illustrati i bacini idrografici interessati, con l ubicazione delle stazioni di Alberino Casoni Bentivoglio Forcelli isura. Bassarone Saiarino Meteo Padulle Saletto Beccara Nuova BANDO Ipianto Forcelli S. Martino in Argine Lavino di Sotto Paltrone ANZOLA CALDERARA DI RENO Anzola Ghironda Castelaggiore Dozza Budrio Olo Bova BOLOGNA UI S. Ruffillo Sasso Marconi Sasso Marconi o Panico Sasso Morelli Loiano MONTEACUTO VALLESE Sabro Invaso o Piancaldoli Le Taverne Casola Valsenio Rontana SENIO Roano Monte TRAVERSA Firenzuola Bibbiana Palazzuolo sul Senio Cottede o o Cainate Predappio TREDOZIO Barco Pratacci Capigna Borello Ponte Verucc Monte Iottone Pietracuta Rullato S. M Montriolo Capaccio «NOVAFELTRIA Quarto Lastra TERZO DI CARNAIO Diga di Ridracoli Maiano DIGA DI QUARTO SAVIO BAGNO DI ROMAGNA MARECCHIA Corsicchie Marecchia Figura 8: Bacini idrografici dei fiui Santerno, Senio, Laone (in e Montone con ubicazione dei pluviografi Laa Pennabilli verde), e delle stazioni idroetriche (in rosso) e pluvioetriche (in blu) in teleisura. VERGHERETO Casteldelci RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 Roversano Mercato Saraceno «Savignano Carpineta USO Corniolo S. Carlo S. Sofia RUBICONE Voltre PREMILCUORE S. Paola Civitella Due Tigli Martorano Calisese SAN BENEDETTO IN ALPE STRADA SAN ZENO MONTONE Museo Mesola Savio Bertinoro RONCO Cusercoli Vallicelle Cesenatico po Santarcang Rocca San Casciano Casaglia Cesenatico allaccia Cesena Teodorano Monte Grosso Matellica Meldola Trebbio CERVIA BEVANO LAMONE Savio Castiglione Ronco Castrocaro Ponte Calanca o S. Zaccaria S. Maria Nova S. MARTINO IN STRADA Modigliana Marradi Botte Ronco Forli' Lodolone S. Pietro in Vincoli Strada Casale Modigliana SAN CASSIANO Monte Faggiola Bevano Adriatica Coccolia Ponte Braldo Rivalta Sarna Castel del Rio SANTERNO Reda Faenza Monte Albano Brisighella PIETRAMALA DIGA DEL BRASIMONE o Casoni di Roagna Monghidoro S. BENEDETTO DEL QUERCETO o Codrignano Borgo Tossignano Madonna dei Fornell RIOLO TERME Tebano CLASSE IDROVORO FOSSO GHIAIA SAN PANCRAZIO Ponte Vico S. Bartolo Pieve Cesato Iola Mario Neri Castelbolognese Reda Faenza o Rasponi S. Marco Granarolo Faentino S. Cleente oo Monte Ceresa Loiano Ponte Savena MARINA DI RAVENNA Ponte Albergone Cotignola Santerno Senio 1 Santerno Senio 2 Iola MONTECATONE MONZUNO SILLARO Bubano Mordano Mordano o o Idrovoro Dane Alfonsine Mezzano IdrovoroFossette Riunite S. Agata sulsanterno Correcchio Botte Sillaro Ravenna urbana Molinetto LUGO DI ROMAGNA Castel S.Pietro Prugnolo RENO Idrovoro Tratturo Sesto Iolese IDICE Fusignano Varignana Pianoro ALFONSINE QUADERNA Ponte Chiavica S. Bernardino Palesio Settefonti GGIA Lavezzola Idrovoro Sabbadina Massarolo Portonovo Brocchetti S. Antonio Castenaso o o Zola Predosa Bologna urbana Casalecchio T.VoloBologna Torre Asinelli Bologna S. Luca Ponte Caselle Lavino di Sopra Centonara tino in Casola Casalecchio Canale Pizzocalvo Casalecchio Chiusa o Volta Scirocco Case Ponte Bastia Cardinala Accursi S. Antonio Mezzolara Arcoveggio Beccara Nuova Bonconvento 11
12 4.1. Analisi pluvioetrica sui bacini Nella Figura 9 è possibile osservare la cuulata di pioggia registrata dai pluvioetri dalle ore 12 di venerdì 19 settebre alle ore 12 di sabato 2. Appare evidente coe i quantitativi aggiori abbiano interessato la quasi totalità dei bacini ontani di Santerno, Senio, Laone, e Montone. Figura 9: Pioggia cuulata dell evento dalle ore 12 del 19 settebre alle ore 12 del 2 settebre sui bacini idrografici della Regione Eilia Roagna Dagli ietograi di pioggia oraria e cuulata più significativi, riportati nelle figure successive, si osserva coe in tutti i pluvioetri le intensità aggiori si siano registrate in realtà in un arco di tepo di circa 3-6 ore, ovvero in un tepo paragonabile al tepo di corrivazione dei bacini ontani interessati. Nella Tabella 1 è possibile osservare coe le piogge di assia intensità dell evento, per le durate da 3 a 12 ore, abbiano superato dovunque il tepo di ritorno 5 anni, ed in alcune stazioni del Santerno e del Laone anche il tepo di ritorno di 2 anni. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
13 Tabella 1: Precipitazioni assie dell evento e grafici di severità per durate < 24 ore, con i relativi tepi di ritorno, nelle stazioni pluvioetriche più significative. Stazione Bacino Tepo di ritorno (anni) 1 ora Prec () Tepo di ritorno (anni) 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore Prec () Tepo di ritorno (anni) Prec () Tepo di ritorno (anni) Prec () Tepo di ritorno (anni) M.Grosso Fiui Uniti > Pratacci Fiui Uniti >1 6. > > Vallicelle Fiui Uniti Voltre Fiui Uniti M.Roano Laone >1 87. > Marradi Laone > > Modigliana Arpa Laone > > > Trebbio Laone > > > Barco Reno > > Firenzuola Reno > >1 15. > > > Prec () Le piogge orarie registrate dai pluvioetri dell alto Santerno, illustrate nella Figura 1 e nella Tabella 2 che seguono, sono state le più intense dell evento, con la stazione di Firenzuola ( ) che ha fatto registrare 15 /3h, 167 /6/ e 173 /12h a fronte di riferienti storici con base di 8 anni, pari a 19 /3h, 13 /6h e 159 /12h; le curve di probabilità pluvioetrica calcolate per la stazione di Firenzuola ostrano coe i tepi di ritorno per tutte le durate risultano pari o superiori al tepo di ritorno di 2 anni. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
14 Arpa Eilia-Roagna Intensità (/h) 5 BARCO (72.s.l..) Cuulata () 18 Intensità (/h) 5 CASTEL DEL RIO (183.s.l..) Cuulata () /9 2/9 19/9 2/9 Intensità (/h) 5 FIRENZUOLA (476.s.l..) Cuulata () 18 h[] 2 Stazione: FIRENZUOLA - curve di probabilità pluvioetrica EVENTO 2 19/9 2/ t [ore] Figura 1: Pioggia oraria e cuulata nelle stazioni più significative del bacino ontano del Santerno e curve di probabilità pluvioetrica nella stazione di Firenzuola Confrontando le assie intensità dell evento con i valori assii delle serie storiche disponibili (Tabella 2), è possibile osservare coe l evento in esae nel pluvioetro di Firenzuola è il prio caso critico dal 1928, per tutte le durate aggiori di 6 ore, a Barco il prio caso critico dal 199. Tabella 2: Precipitazioni assie dell evento per durate < 24 ore, a confronto con le precipitazioni assie storiche, nelle stazioni del bacino ontano del Santerno e del Senio STAZIONE QUOTA PIOGGE di ax intensità del 2/9/14 PIOGGE di ax intensità al 213 Santerno.s.l.. 1h 3h 6h 12h 24h 1h 3h 6h 12h 24h Barco Firenzuola Castel del Rio Borgo Tossignano Iola Senio.s.l.. 1h 3h 6h 12h 24h 1h 3h 6h 12h 24h Palazzuolo sul Senio Casola Valsenio RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
15 Arpa Eilia-Roagna Anche nella stazione di Palazzuolo sul Senio le piogge di assia intensità registrate nell evento in esae rappresentano il prio caso critico dal 199. Le precipitazione più intense (Figura 11) e le cuulate più elevate si sono verificate sul crinale tra Santerno e Senio (pluvioetro di Monte Faggiola). Intensità (/h) 4 MONTE FAGGIOLA (929.s.l..) Cuulata () 15 Intensità (/h) 4 PALAZZUOLO SUL SENIO (5.s.l..) Cuulata () /9 2/9 19/9 2/9 Figura 11: Pioggia oraria e cuulata nelle stazioni più significative del bacino ontano del Santerno e Senio Sul bacino del Laone i pluvioetri hanno registrato intensità e cuulate notevoli, con intensità assie che per le durate di tre e sei ore hanno raggiunto e in qualche caso superato i assii storici (Tabella 3). In particolare nella stazione di Tredozio le piogge di assia intensità registrate nell evento sono le assie della serie storica dal 1941, con un tepo di ritorno per le durate di 6 e 12 ore superiore ai 2 anni, e di circa 1 anno per la durata di 3 ore (Figura 12). Tabella 3: Precipitazioni assie dell evento per durate < 24 ore, a confronto con le precipitazioni assie storiche, nelle stazioni del bacino ontano del Laone STAZIONE QUOTA PIOGGE di ax intensità del 2/9/214 PIOGGE di ax intensità al 213 Laone.s.l.. 1h 3h 6h 12h 24h 1h 3h 6h 12h 24h Marradi S.Cassiano Tredozio Trebbio RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
16 Arpa Eilia-Roagna 5 Intensità (/h) MARRADI (35.s.l..) Cuulata () 14 Intensità (/h) 5 TREBBIO (57.s.l..) Cuulata () /9 2/9 19/9 2/9 Intensità (/h) 5 TREDOZIO (334.s.l..) Cuulata () 14 h[] 16 Stazione: TREDOZIO - curve di probabilità pluvioetrica EVENTO 19/9 2/ t [ore] Figura 12: Pioggia oraria e cuulata nelle stazioni più significative del bacino ontano del Laone e curve di probabilità pluvioetrica nella stazione di Tredozio RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
17 Arpa Eilia-Roagna Sul bacino del Montone invece, le assie intensità sono state registrate sul crinale occidentale lungo la linea di displuvio del bacino del Laone, coe è possibile osservare nella Figura 13 dove si riportano i pluvi grai delle stazioni di Pratacci e di Modigliana (stazione in teleisura ubicata sul versante del bacino del Montone in prossiità della linea di displuivio). Tabella 4: Precipitazioni assie dell evento per durate < 24 ore, nelle stazioni del bacino ontano del Montone STAZIONE QUOTA Piogge di ax intensità del 2/9/14 Montone.s.l.. 1h 3h 6h 12h 24h Pratacci Modigliana Arpa Intensità (/h) 6 PRATACCI (75.s.l..) Cuulata () 12 Intensità (/h) 6 MODIGLIANA Arpa (556.s.l..) Cuulata () /9 2/9 19/9 2/9 Figura 13: Pioggia oraria e cuulata nelle stazioni più significative del bacino ontano del Montone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
18 4.2. Propagazione della piena sui corsi d acqua Le piene fluviali che si sono sviluppate su Santerno, Senio, Laone e Montone hanno avuto lo stesso coportaento ipulsivo, facendo registrare un rapidissio increento di livello idroetrico nella fase di concentrazione ed una diinuzione altrettanto rapida in fase di esauriento dell onda, in ragione anche delle nuerose esondazioni che si sono registrate lungo l attraversaento del tratto ontano del bacino. Nelle tabelle e grafici che seguono sono riportate le schede di archiviazione delle piene per ciascun corso d acqua con l indicazione degli orari e dei livelli idroetrici al colo di piena nelle varie sezioni struentate da onte verso valle, nonché i relativi idrograi che descrivono la propagazione fino alle sezioni terinali di valle in tratto arginato. FIUMI SANTERNO E SENIO I coli che sono stati raggiunti nelle prie sezioni di onte del fiue Santerno, coe descritto nelle stesse schede di piena, hanno superato o raggiunto in olti casi i assii storici registrati dalla struentazione in teleisura esistente, che nel solo caso della stazione di Codrignano dispone di una serie di dati in teleisura a partire dal In alcune sezioni coe ad esepio quella di Borgo Tossignano alla traversa di Rineggio sul Santerno il livello registrato (2,53) dallo struento a onte della traversa stessa è stato inferiore al colo di piena perché l increento idroetrico è stato tale da raggiungere il capo di non lettura struentale del sensore ad ultrasuoni. E stato counque possibile ricostruire il colo dalle tracce di piena ottenendo un valore di 3,16. Nel caso specifico di questa sezione inoltre, l onda di piena è stata in grado di asportare un porzione considerevole del ciglio della traversa in calcestruzzo creando una gaveta centrale di circa 3 per una profondità edia di circa 5 c (vedi Foto ), pertanto anche il valore al colo dedotto di 3,16 potrebbe risentire del cabio di sezione del punto di isura durante l evento stesso. Foto 1: F. Santerno - Stazione di Borgo Tossignano Traversa di Rineggio. Passaggio del colo di piena alle ore 9:3 locali con 3,16 con soronto del ponte a valle ( fonte SIAT) RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
19 Foto 2: F. Santerno - Stazione di Borgo Tossignano Traversa di Rineggio dopo il passaggio dell onda di piena. Nella sezione più a valle alla traversa di Codrignano il colo di piena ha raggiunto un livello di 1,79 (anche questo valore non rilevato, è stato dedotto dalle tracce di piena) che rappresenta il assio storico dal 1981, ovvero dall entrata in funzione della struentazione idroetrica in teleisura. In questa sezione esistono delle effeeridi storiche di altezze di assia piena di lunga durata anche se con struentazione e riferienti idroetrici diversi. Da una pria indagine sebra che il colo di piena in questo punto sia paragonabile, se non di poco superiore, al colo registrato nella piena del 4 novebre del 1966 (3,8 con il riferiento storico equivalente ad un valore attuale di circa 1,75 ). Un altro evento di piena, forse il più gravoso al oento conosciuto risale al 1 ottobre 1893 dove a Codrignano sono stati isurati 3,95 rispetto al riferiento storico che dovrebbero corrispondere al un altezza idroetrica riferita all attuale sensore di 1,9. A onte della sezione di Borgo Tossignano in località Carseggio anche il ponte di via Macerato è stato danneggiato, entre l adiacente ponte bailey in disuso è stato distrutto dalla piena che ha deterinato un incollo dell onda in questa sezione con aggiraento del anufatto in sinistra idraulica. Questo episodio ha deterinato un ulteriore increento che ha odificato leggerente il picco di piena già abbastanza pronunciato. Il fenoeno è stato registrato bene alla traversa di Codrignano dove in fase di colo con livello idroetrico di 1.75 si è osservato pria un apparente diinuzione dell onda e poi una rapidissia risalita del livello a 1,79.. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
20 Foto 3: F. Santerno Ponte di Carseggo (Via Macerato) poco a onte di Fontanelice Più a valle nella sezione di Iola il colo di piena è transitato dal ponte di via Dante, dove risulta posizionato l idroetro, con un livello di 4,35 alle ore 11: solari del 2 settebre con circa un etro di argine rispetto al sottotrave del ponte. Procedendo ancora verso valle alla chiusura del bacino ontano, il colo di piena, ridotto in volue per i nuerosi fenoeni di allagaento e diffusione nelle aree inondabili, ha fatto il suo ingresso in pianura nel tratto arginato facendo registrare a Mordano un livello di 13,3 alle ore 16:. In questa sezione, nonostante il livello idroetrico risulta inferiore soltanto al 1 caso critico di 13,25 registrato il 23 dicebre del 29, e quindi un dato ragguardevole per il tratto di pianura, si sono sentiti gli effetti di lainazione dovuti alle esondazioni del tratto ontano con il passaggio della piena con livello idroetrico inferiore alla soglia di allare (14, ). Il ridotto volue di piena e le condizioni iniziali favorevoli di deflusso del fiue e non ultie le recenti operazioni di anutenzione delle sponde arginali, hanno deterinato un ulteriore riduzione del colo di piena per effetto della lainazione dell onda procedendo verso le sezioni terinali di valle fino allo sbocco in Reno coe si può osservare dagli idrograi di Figura 14. Anche l evoluzione della piena del fiue Senio è stata caratterizzata da un rapidissio increento dei livelli idroetrici a onte con attenuazione dell onda di piena nel tratto vallivo. Si sottolinea ancora il dato di precipitazione della stazione di Palazzuolo sul Senio che per le durate di 3 e 6 ore ha fatto registrare intensità rispettivaente di 11 e 137,8 dove i assii precedenti conosciuti erano 56,8 in 3h e 78,6 in 6h. A Casola Val Senio la stazione idroetrica ha registrato un colo alle ore 7:3 di 1,54 che rappresenta il 1 caso critico della di serie disponibile distinguendosi nettaente dai precedenti coli di piena, counque con una serie liitata in questo caso a partire dal 23. Non si hanno altre registrazioni di livello idroetrico nel bacino ontano, a anche in questo caso si sono registrati allagaenti ed esondazioni in più punti, anzi le prie criticità idrauliche del giorno 2 sono state segnalate in RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 2
21 questo bacino quando ancora la struentazione di onitoraggio idroetrico non indicava una situazione critica iinente. Alla chiusura di bacino alla sezione di Castelbolognese il colo di piena invece è stato più contenuto con un livello di 4,85 alle ore 14:. Procedendo verso valle la lainazione è stata favorita anche in questo caso dalle recenti operazioni di anutenzione fluviale ordinaria che hanno fatto si che il passaggio alla sezione critica di Cotignola è avvenuto in sicurezza con un livello idroetrico di 14,5 alle ore 19:. Foto 4: F. Senio (26/9/214) Ponte di Cotignola con evidente traccia della piena del 2 settebre in sponda sinistra. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
22 Tabella 5: Scheda di archiviazione della piena dei fiui Santerno e Senio Servizio Idro - Mete - Clia CENTRO FUNZIONALE EMILIA ROMAGNA P6a14 BACINO DEL RENO TABELLA delle PUNTE MASSIME PIENA de i gg se tte bre T orre nte SANT ERNO Denoinazione Distanze Attenzione Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. Borgo Tossignano (Rineggio) ,16* ax livello dal 22 COD R IGN AN O ,79* ax livello dal 1981 IMOLA ax livello dal 1995 MORDANO SANT'AGATA S. BER N AR D IN O sbocco in Reno T orre nte SENIO Denoinazione Distanze Attenzione Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. CASOLA VALSENIO CAST ELBOLOGN ESE COTIGNOLA FUSIGNANO ALFON SIN E sbocco in Reno Note: Le piene di Santerno e Senio, deterinate da precipitazioni edie cuulate nei tratti ontani di 15 in 6-8 ore, hanno fatto registrare increenti di livello notevoli con coli che hanno superato anche i assii storici Si sono avuti notevoli allagaenti diffusi oltre le zone di espansione fluviale fino alla chiusura dei bacini ontani e questo ha favorito l'ingresso in pianura di una piena già lainata a ancora in grado di far registrare livelli ragguardevoli * Livelli idroetrici rilevati dalle tracce di piena, per ancata lettura degli idroetri in teleisura RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
23 3. Santerno a Borgo Tossignano Santerno a Codrignano Santerno ad Iola Figura 14: Propagazione della piena lungo le sezioni ontane del Santerno RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
24 Santerno a Mordano Santerno a S. Agata Santerno a S. Bernardino Figura 15: Propagazione della piena lungo le sezioni vallive del fiue Santerno RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
25 2. Senio a Casola Valsenio Senio a Castelbolognese Figura 16: Propagazione della piena lungo le sezioni ontane del fiue Senio RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
26 15. Senio a Cotignola Senio a Fusignano Senio ad Alfonsine Figura 17: Propagazione della piena lungo le sezioni vallive del fiue Senio RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
27 FIUMI LAMONE E MONTONE La piena del fiue Laone e del fiue Montone ha fatto registrare su tutti gli idroetri di onte i livelli idroetrici assii conosciuti dall inizio della serie in teleisura ed oltre. In alcuni casi, coe nella sezione di Laone a Sarna il livello raggiunto è da considerarsi ancora provvisorio in quanto il colo di piena ha intercettato il sensore stesso interropendone il corretto funzionaento (vedi grafico di Figura 18) dove è stato antenuta l anoalia della registrazione idroetrica). Nel torrente Marzeno, affluente in destra del fiue Laone alla sezione di chiusura di Rivalta è stato raggiunto un livello assio di 5,49 con un andaento dell idrograa al colo piuttosto appiattito, causa le esondazioni che si sono avute a onte della sezione e che hanno liitato di fatto il raggiungiento di altezze idroetriche aggiori. Si segnalano in particolare i valori di precipitazioni registrate a Tredozio che anche in questo caso per le durate di 6 e 12 ore hanno raggiunto i assii storici rispettivaente con 133,6 e 141,6, con tepi di ritorno superiori ai 2 anni. Nella sezione più a onte del torrente Marzeno a Modigliana si sono avute esondazioni, già nei prii tratti fluviali con un picco registrato alla stazione idroetrica di 3,12 che rappresenta il assio della serie e counque da verificare, visto l andaento anoalo dell idrograa causa il trasporto solido e l irruenza della piena che ha danneggiato la zona di isura. In pianura nel tratto arginato la piena del Laone si è ridotta in volue per effetto delle esondazioni a onte, a ha counque raggiunto livelli ragguardevoli facendo registrare anche dei assii coe alla sezione di Reda con 8,37 alle 17:. La piena del fiue Montone ha avuto analogo coportaento con precipitazioni a onte alle stazioni di Pratacci e Modigliana particolarente intense. A Castrocaro il colo di piena ha raggiunto il livello assio della serie conosciuta con 3,73 alle ore 11: con nuerose esondazioni nello stesso tratto fluviale. Alla sezione di Forlì dopo la confluenza del Rabbi il fiue Montone ha raggiunto il livello idroetrico di 6,94 alle 15: di poco superiore a livello di allare e prossio al assio registrato nella serie di dati disponibile. CONSIDERAZIONI SULLE PORTATE AL COLMO Il transito dei coli di piena che hanno interessato i fiui in questione, hanno odificato durante il loro passaggio la configurazione stessa della sezione, oltre che produrre in vari tratti esondazioni che di fatto hanno ridotto progressivaente il volue delle onde di piena. Di conseguenza le scale di portate andranno verificate in ogni sezione e ricalcolate alla luce di questo evento, anche per assegnare i valori stessi delle portate al colo nei vari tratti. Al oento si possono solo fare delle stie sull entità del tepo di ritorno dell evento liitataente al tratto ontano ascrivibile al tepo dei 2 anni, tenuto conto della distribuzione ed intensità della precipitazione nonché delle linee di esondazione osservate rispetto alle aree inondabili conosciute. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
28 Tabella 6: Scheda di archiviazione della piena dei fiui Laone e Montone Servizio Idro - Meteo - Clia CENTRO FUNZIONALE EMILIA ROMAGNA P3a14 BACINI ROMAG NOLI TABELLA delle PUNTE MASSIME PIENA de i gg se tte bre 214 Fiue LAMONE Denoinazione Distanze Guardia Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. MARRADI ax livello serie in teleisura STRADA CASALE ax livello serie in teleisura SARNA (4,51) ax livello serie in teleisura confluenza Marzeno FAENZA ax livello serie in teleisura REDA ax livello serie in teleisura PIEVE CESATO pari al ax livello P.ALBERGONE fuori uso MEZZANO sbocco in are T orre nte MARZENO Denoinazione Distanze Guardia Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. MODIGLIANA ax livello serie in teleisura RIVALTA (5.49) ax livello serie in teleisura sbocco in Laone Fiue MONT ONE - Fiui UNIT I Denoinazione Distanze Guardia Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. ROCCA.S.CASCIANO ax livello serie in teleisura CASTROCARO ax livello serie in teleisura confluenza Rabbi FORLI' prossio al ax P.BRALDO P.VICO S.MARCO * confluenza Ronco RASPONI * sbocco in are Fiue RABBI Denoinazione Distanze Guardia Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. PREDAPPIO P.CALANCA sbocco in Montone Fiue RONCO Denoinazione Distanze Guardia Punta ax registrata Tepi Note del SENSORE parziali progres. H idr.ca H idr.ca gior. ora parziali progres. origine.. S.SOFIA confluenza Voltre MELDOLA RONCO COCCOLIA S.BARTOLO * sbocco in Montone - F.Uniti Note: Si sono avuti notevoli allagaenti diffusi oltre le zone di espansione fluviale fino alla chiusura dei bacini ontani e questo ha favorito l'ingresso in pianura di una piena già lainata a ancora in grado di far registrare livelli ragguardevoli,che prograssivaente nei tratti terinali allo sbocco si sono attenuati rapidaente I livelli al colo indicati tra parentesi a Sarna e Rivalta sono provvisori, da conferare. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
29 3. Laone a Marradi Laone a Strada Casale Laone a Sarna Figura 18: Propagazione della piena lungo le sezioni ontane del fiue Laone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
30 3.5 Marzeno a Modigliana Marzeno a Rivalta Laone a Faenza Figura 19: Propagazione della piena lungo le sezioni ontane del Marzeno e alla confluenza con il Laone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 214 3
31 9. Laone a Reda Laone a Pieve Cesato Laone a Mezzano Figura 2: Propagazione della piena lungo le sezioni vallive del fiue Laone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
32 Rabbi a Predappio Rabbi a Ponte Calanca /3 19/3 2/3 21/3 2. Montone a Rocca S.Casciano /3 19/3 2/3 21/3 Figura 21: Propagazione della piena lungo le sezioni ontane del Rabbie del Montone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
33 4. Montone a Castrocaro Montone a Forlì Montone a Ponte Braldo Figura 22:Propagazione della piena lungo le sezioni vallive del fiue Montone RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
34 Montone a Ponte Vico Montone a S.Marco Fiui Uniti a Rasponi Figura 23: Propagazione della piena lungo le sezioni vallive del fiue Montone e alla confluenza Fiui Uniti RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
35 5. LE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E MONITORAGGIO DEL CENTRO FUNZIONALE Coe descritto nei prii paragrafi, la odellistica eteorologica di cui al oento si dispone, a tutte le risoluzioni, non è stata in grado di prevedere il fenoeno eteorologico in esae con un anticipo teporale sufficiente ad eettere un Avviso Meteo e un Avviso di Criticità idrogeologica e idraulica il giorno precedente l evento. L evento eteorologico e le conseguenti piene fluviali sono state seguite e onitorate in tepo reale, nella loro rapidissia evoluzione, con l eissione di 5 Bollettini di onitoraggio, dalle ore 9: di sabato 2 settebre, alle ore 9: di doenica CONCLUSIONI E RAFFRONTO CON GLI EVENTI DEL PASSATO Questo evento è stato quindi originato dalla forazione di un sistea convettivo coplesso e organizzato sottovento alla catena appenninica, che ha scaricato rilevanti quantità di precipitazioni su aree vaste (a scala di bacino) in brevissio tepo (6 ore). Altra caratteristica è che è accaduto di notte. E olto interessante notare coe da una analisi, basata sugli annali del Servizio Idrografico e da altre fonti storiche, i precedenti aggiori eventi di piena del bacino del Reno siano accaduti di notte con una tipologia siile a quella del 2 settebre. Riportiao qui di seguito un breve estratto dei tre principali eventi di piena sul bacino ontano del Reno. La piena storica del Reno del 1 Ottobre del 1893, che deterinò un livello alla Chiusa di Casalecchio pari a 4,5 (finora ibattuto), con il cediento della Chiusa stessa, fu originata da fortissii teporali in appennino coe descritto in questo docuento: Nessuno, a Casalecchio, infatti sapeva che quel teporale per cui erano riasti svegli parte della notte, era stato ben peggiore su tutto il crinale appenninico, anzi era stato un vero nubifragio di inaudita violenza, con frane, sottaenti, traciazione di tutti i corsi d acqua. Tanto diavolerio era il centro di una apia area ciclonica che aveva investito, con effetti disastrosi, ezza Europa e particolarente il centro e nord Italia [ ] i ponti ferroviari di Riola e Pioppe di Salvaro erano crollati, interropendo le counicazioni con Roa. Vittie c erano state alla Laa di Marzabotto, Casteldebole, Bertalia, entre olte persone vennero salvate da iprovvisati soccorritori, dai Carabinieri e dal Genio Militare. Alle due del poeriggio il Ponte della Ferrovia Milano-Bologna, a valle del Pontelungo saltò, coe si trattasse di un fuscello di paglia (cronaca dal Resto del Carlino ) 1. Altro evento siile è quello che ha colpito il bacino del Reno e del Santerno il 27 settebre 1932, per il quale l annale idrologico riporta: detti bacini furono interessati da una propaggine di un eccezionale nubifragio verificatosi nella notte fra il 26 e il 27 settebre sul contiguo versante della Toscana. Il assio valore di pioggia è stato registrato ad Acquerino con 236,4. A seguito di questo nubifragio, che sul Santerno fece cadere quantità d acqua paragonabili o leggerente inferiori all evento in esae (13/6h a Firenzuola), sul corso d acqua vennero registrati i assii increenti di livello dell anno. E ancora, la notte fra il 5 e il 6 Ottobre del 1937 un nubifragio di eccezionale violenza colpì la parte alte dei bacini di Reno e i suoi affluenti di destra scaricando circa 2 in poche ore 1 La Grande Piena del 1893, tratto Casalecchio Notizie ( at=5691&id=58819&tipoeleento=categoria) RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
36 durante l intero evento. Piena storica sul Reno a Porretta e sul Santerno a Borgo Tossignano dove vennero registrati /s ed il livello assio ai registrato di 4,8. Queste testionianze del passato, alla luce di quanto recenteente accaduto e delle conoscenze nel frattepo acquisite sulla fenoenologia convettiva a esoscala, che quindi contepla, coe abbiao visto, anche fenoeni olto più intensi della edia, acquistano ora una iportanza diversa. Esse infatti fanno supporre che seppur rari questi fenoeni possano essere stati all origine di grandi alluvioni del passato, in particolare di quelle registrate nei esi non ancora propriaente autunnali/invernali. Se questo fosse vero dovreo rivedere la percezione coune che le grandi piene fluviali sulla nostra regione siano associate esclusivaente a episodi di prolungate piogge autunno/invernali, ad evoluzione più lenta e ben prevedibili dalla odellistica nuerica, sulle quali è stato basato il sistea di allertaento. Questi nubifragi, capaci di andare in piena un intero bacino fluviale nel giro di poche ore, pongono infatti nuove sfide al sistea di allertaento regionale che dovrà ettere in grado una strategia per isurarsi con eventi ancora poco prevedibili, anche a brevi scadenze teporali (ore invece che giorni) e che per la loro rapidità e intensità offrono argini d allertaento olto ridotti. RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
37 Arpa Eilia-Roagna Via Po 5, Bologna Servizio IdroMeteoClia Viale Silvani 6, Bologna RAPPORTO SULL EVENTO DEL 2 SETTEMBRE
Rapporto dell evento meteorologico del maggio 2014
 Rapporto dell evento meteorologico del 30-31 maggio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 30-31 maggio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
RAPPORTO SPEDITIVO SULL EVENTO ALLUVIONALE DEL SETTEMBRE 2015
 RAPPORTO SPEDITIVO SULL EVENTO ALLUVIONALE DEL 13-14 SETTEMBRE 215 A cura di Centro Funzionale Regione Eilia-Roagna Unità Radareteorologia, Radarpluvioetria, Nowcasting e Reti non convenzionali Bologna,
RAPPORTO SPEDITIVO SULL EVENTO ALLUVIONALE DEL 13-14 SETTEMBRE 215 A cura di Centro Funzionale Regione Eilia-Roagna Unità Radareteorologia, Radarpluvioetria, Nowcasting e Reti non convenzionali Bologna,
Bollettino di Monitoraggio
 PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 987/06/CF DATA EMISSIONE mar, 18 nov 01:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 987/06/CF DATA EMISSIONE mar, 18 nov 01:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
Rapporto dell evento meteorologico del 7 ottobre 2011
 Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 7 ottobre 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa
Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 7 ottobre 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa
Rapporto dell evento meteorologico del 24 giugno 2013
 Rapporto dell evento meteorologico del 24 giugno 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 24 giugno 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del agosto 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 15-16 agosto 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 15-16 agosto 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico dal 14 al 15 luglio 2016
 Rapporto dell evento meteorologico dal al luglio 20 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico dal al luglio 20 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 3 e 4 maggio 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 3 e 4 maggio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 3 e 4 maggio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 15 maggio 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 15 maggio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 15 maggio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Bollettino di Monitoraggio
 PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 900/05/CF DATA EMISSIONE mar, 11 feb 13:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 900/05/CF DATA EMISSIONE mar, 11 feb 13:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
LIVELLI DI RIFERIMENTO Zona di allertamento A e B FIUMI ROMAGNOLI E LORO AFFLUENTI
 Zone A&B Difesa del suolo, della coste e bonifica Agenzia Regionale di Protezione Civile LIVELLI DI RIFERIMENTO Zona di allertamento A e B FIUMI ROMAGNOLI E LORO AFFLUENTI IDROMETRO SOGLIA 1 SOGLIA 2 SOGLIA
Zone A&B Difesa del suolo, della coste e bonifica Agenzia Regionale di Protezione Civile LIVELLI DI RIFERIMENTO Zona di allertamento A e B FIUMI ROMAGNOLI E LORO AFFLUENTI IDROMETRO SOGLIA 1 SOGLIA 2 SOGLIA
Rapporto dell evento meteorologico del 21 aprile 2014
 Rapporto dell evento meteorologico del 21 aprile 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 21 aprile 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 settembre 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento idrologico e meteo-marino del novembre 2013
 Rapporto dell evento idrologico e meteo-marino del - novembre 3 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche
Rapporto dell evento idrologico e meteo-marino del - novembre 3 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche
Rapporto dell evento meteorologico del 14 agosto 2014
 Rapporto dell evento meteorologico del 14 agosto 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 14 agosto 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 9 e 10 agosto 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 9 e 10 agosto 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 9 e 10 agosto 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico dell 1 e 2 luglio 2016
 Rapporto dell evento meteorologico dell 1 e 2 luglio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico dell 1 e 2 luglio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteo-marino del 18 aprile 2017
 Rapporto dell evento meteo-marino del 18 aprile 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni, Area Modellistica
Rapporto dell evento meteo-marino del 18 aprile 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni, Area Modellistica
EVENTO TEMPORALESCO DEL 2 LUGLIO 2016
 EVENTO TEMPORALESCO DEL 2 LUGLIO 2016 A cura del Dipartimento Sistemi Previsionali. Torino, 15 luglio 2016 IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA E CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA SAI GLOBAL ITALIA ARPA Piemonte
EVENTO TEMPORALESCO DEL 2 LUGLIO 2016 A cura del Dipartimento Sistemi Previsionali. Torino, 15 luglio 2016 IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA E CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA SAI GLOBAL ITALIA ARPA Piemonte
Rapporto dell evento meteorologico del 15 e 16 aprile 2017
 Rapporto dell evento meteorologico del 15 e 16 aprile 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 15 e 16 aprile 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Tipo rilevatore: 1 Idrografico, 2 Volontario, 3 Nivometro. QUOTA (m) NOME_STAZIONE X_LONG Y_LAT COMUNE PROV REGIONE
 ,, X_LONG Y_LAT COMUNE REGIONE 1 Albinea 2 163 10.601697 44.620200 ALBINEA RE EMILIA-ROMAGNA 2 Alfonsine 1 5 12.044520 44.493012 FUSIGNANO RA EMILIA-ROMAGNA 3 Anzola Emilia 1 42 11.182582 44.579090 ANZOLA
,, X_LONG Y_LAT COMUNE REGIONE 1 Albinea 2 163 10.601697 44.620200 ALBINEA RE EMILIA-ROMAGNA 2 Alfonsine 1 5 12.044520 44.493012 FUSIGNANO RA EMILIA-ROMAGNA 3 Anzola Emilia 1 42 11.182582 44.579090 ANZOLA
Rapporto radar dell evento meteorologico del 23 e 24 gennaio 2009
 Rapporto radar dell evento meteorologico del 23 e 24 gennaio 2009 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Stratiforme Dal 23/01/2009
Rapporto radar dell evento meteorologico del 23 e 24 gennaio 2009 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Stratiforme Dal 23/01/2009
Analisi meteorologica della perturbazione del 27 e 28 novembre 2012
 30 novembre 2012 Analisi meteorologica della perturbazione del 27 e 28 novembre 2012 Tra la serata di lunedì 26 e mercoledì 28 una perturbazione ha portato precipitazioni diffuse sul territorio trentino
30 novembre 2012 Analisi meteorologica della perturbazione del 27 e 28 novembre 2012 Tra la serata di lunedì 26 e mercoledì 28 una perturbazione ha portato precipitazioni diffuse sul territorio trentino
Rapporto dell evento meteorologico del 4-5 giugno 2011
 Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 4-5 giugno 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala
Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 4-5 giugno 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala
Precipitazioni intense del 20 settembre a cura di Andrea Piazza -
 Precipitazioni intense del 20 settembre 1999 - a cura di Andrea Piazza - 1. INTRODUZIONE La giornata del 20 settembre 1999 è stata caratterizzata da precipitazioni intense che hanno interessato l Italia
Precipitazioni intense del 20 settembre 1999 - a cura di Andrea Piazza - 1. INTRODUZIONE La giornata del 20 settembre 1999 è stata caratterizzata da precipitazioni intense che hanno interessato l Italia
Rapporto dell evento meteorologico del maggio 2013
 Rapporto dell evento meteorologico del 16-17 maggio 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 16-17 maggio 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area Centro
Rapporto dell evento meteorologico del 4 e 5 aprile 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 4 e 5 aprile 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 4 e 5 aprile 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto radar dell evento meteorologico del ottobre 2008
 Rapporto radar dell evento meteorologico del 28 29 30 ottobre 2008 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Frontale, Stratiforme/Convettivo
Rapporto radar dell evento meteorologico del 28 29 30 ottobre 2008 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Frontale, Stratiforme/Convettivo
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs , n. 58
 Allegato a) alla determinazione del Settore Contabile n. 726 del 11/11/2010 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 HERA S.P.A. Holding
Allegato a) alla determinazione del Settore Contabile n. 726 del 11/11/2010 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 HERA S.P.A. Holding
Rapporto dell evento meteorologico dal 18 al 19 agosto 2016
 Rapporto dell evento meteorologico dal 18 al 19 agosto 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento meteorologico dal 18 al 19 agosto 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento meteorologico del 25 e 26 giugno 2017
 Rapporto dell evento meteorologico del 25 e 26 giugno 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 25 e 26 giugno 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 giugno 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 giugno 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 16 e 17 giugno 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima. Rapporto dell evento meteorologico del 19 e 20 ottobre 2011
 Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 19 e 20 ottobre 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità
Arpa Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Rapporto dell evento meteorologico del 19 e 20 ottobre 2011 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità
Transito di un fronte freddo e temporali sparsi nella notte tra il 29 e 30 giugno 2011
 Transito di un fronte freddo e temporali sparsi nella notte tra il 29 e 30 giugno 2011 INTRODUZIONE Nella giornata del 29 giugno 2011 sopra L Europa centrale è transitato un fronte freddo, che nel suo
Transito di un fronte freddo e temporali sparsi nella notte tra il 29 e 30 giugno 2011 INTRODUZIONE Nella giornata del 29 giugno 2011 sopra L Europa centrale è transitato un fronte freddo, che nel suo
Rapporto dell evento idro-meteorologico del gennaio 2014
 Rapporto dell evento idro-meteorologico del 17-19 gennaio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Rapporto dell evento idro-meteorologico del 17-19 gennaio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Rapporto radar dell evento meteorologico del 7-9 gennaio 2010
 Rapporto radar dell evento meteorologico del 7-9 gennaio 2010 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Stratiforme Dal 07/01/2010 ore
Rapporto radar dell evento meteorologico del 7-9 gennaio 2010 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna 1.1 Dati disponibili Stratiforme Dal 07/01/2010 ore
Settembre Il Clima in Piemonte. Arpa Piemonte Sistemi Previsionali
 Il Clima in Piemonte Settembre 2014 In Piemonte il mese di Settembre 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
Il Clima in Piemonte Settembre 2014 In Piemonte il mese di Settembre 2014 è stato caratterizzato da temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori alla climatologia del periodo 1971-2000.
PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000
 PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000 Febbraio 2012 Documento a cura di:maurizio Masetti Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza.
PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000 Febbraio 2012 Documento a cura di:maurizio Masetti Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza.
Provincia di Bologna. Sup. in km 2 Abitanti per km 2. resid.1/1/2016
 Provincia di Bologna Comuni Pop. resid.1/1/2016 Sup. in km 2 Abitanti per km 2 Alto Reno Terme 6.947 73,64 94,35 Anzola dell'emilia 12.289 36,6 335,80 Argelato 9.850 35,1 280,60 Baricella 6.949 45,48 152,78
Provincia di Bologna Comuni Pop. resid.1/1/2016 Sup. in km 2 Abitanti per km 2 Alto Reno Terme 6.947 73,64 94,35 Anzola dell'emilia 12.289 36,6 335,80 Argelato 9.850 35,1 280,60 Baricella 6.949 45,48 152,78
RELAZIONE EVENTO 19-20/10/2016
 RELAZIONE EVENTO 19-1. Sommario 1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2. SITUAZIONE GENERALE... 2 3. FENOMENI OSSERVATI... 2 4. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI... 3 5. ANALISI DELLE IMMAGINI
RELAZIONE EVENTO 19-1. Sommario 1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2. SITUAZIONE GENERALE... 2 3. FENOMENI OSSERVATI... 2 4. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI... 3 5. ANALISI DELLE IMMAGINI
Gestione delle dinamiche fluviali: esperienze in Regione Emilia Romagna
 Gestione delle dinamiche fluviali: esperienze in Regione Emilia Romagna Dal punto di vista Amministrativo: UFFICIO DELLA REGIONE PREPOSTA ALLA GESTIONE DEL FIUME RENO E DEI SUOI AFFLUENTI (Deliberazione
Gestione delle dinamiche fluviali: esperienze in Regione Emilia Romagna Dal punto di vista Amministrativo: UFFICIO DELLA REGIONE PREPOSTA ALLA GESTIONE DEL FIUME RENO E DEI SUOI AFFLUENTI (Deliberazione
Rapporto dell evento meteorologico dal 21 al 23 maggio 2015
 Rapporto dell evento meteorologico dal 21 al 23 maggio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento meteorologico dal 21 al 23 maggio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto radar dell evento meteorologico del 2, 3 e 4 novembre 2008
 Rapporto radar dell evento meteorologico del 2, 3 e 4 novembre 2008 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna Misto Dal 02/11/2008 dalle 22.30 al 4/11/2008
Rapporto radar dell evento meteorologico del 2, 3 e 4 novembre 2008 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia Romagna Misto Dal 02/11/2008 dalle 22.30 al 4/11/2008
Analisi meteorologica della perturbazione del 10 e 11 novembre 2012
 19 novembre 2012 Analisi meteorologica della perturbazione del 10 e 11 novembre 2012 Sabato 10 e domenica 11 novembre 2012 un intensa perturbazione atlantica ha interessato la penisola italiana determinando
19 novembre 2012 Analisi meteorologica della perturbazione del 10 e 11 novembre 2012 Sabato 10 e domenica 11 novembre 2012 un intensa perturbazione atlantica ha interessato la penisola italiana determinando
Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015
 Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
SCHEDA EVENTO 30/05/2014
 SCHEDA EVENTO Sommario 1 INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2 FENOMENI OSSERVATI... 2 3 DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA... 3 3.1 Precipitazioni accumulate... 3 3.2 Precipitazioni significative
SCHEDA EVENTO Sommario 1 INQUADRAMENTO METEOROLOGICO... 2 2 FENOMENI OSSERVATI... 2 3 DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA... 3 3.1 Precipitazioni accumulate... 3 3.2 Precipitazioni significative
Rapporto dell evento meteorologico del novembre 2010
 Rapporto dell evento meteorologico del 20-22 novembre 2010 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia-Romagna Stratiforme Dalle 22 UTC del 19/11/2010 alle 15 UTC
Rapporto dell evento meteorologico del 20-22 novembre 2010 1 Descrizione dell evento Tipo evento Data e Ora Inizio Fine sulla Regione Emilia-Romagna Stratiforme Dalle 22 UTC del 19/11/2010 alle 15 UTC
Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 luglio 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 luglio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 5 e 6 luglio 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
RAPPORTO METEO IDROGEOLOGICO SUGLI EVENTI DAL 17 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2008
 RAPPORTO METEO IDROGEOLOGICO SUGLI EVENTI DAL 17 MAGGIO AL 18 GIUGNO 28 A cura di: Miria Celano Michele Di Lorenzo Alessandro Donati Rosanna Foraci Sandro Nanni Sara Pignone Bologna - giugno 28 RAPPORTO
RAPPORTO METEO IDROGEOLOGICO SUGLI EVENTI DAL 17 MAGGIO AL 18 GIUGNO 28 A cura di: Miria Celano Michele Di Lorenzo Alessandro Donati Rosanna Foraci Sandro Nanni Sara Pignone Bologna - giugno 28 RAPPORTO
Rapporto dell evento meteorologico del 6 settembre 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 6 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 6 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
REPORT EVENTI METEO-IDROLOGICI OCCORSI NEL PERIODO 5-19 MARZO 2013 SUL TERRITORIO REGIONALE
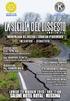 Regione Toscana Servizio Idrologico Regionale CENTRO FUNZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA DL 11/07/1998, n. 180; Legge 3/08/1998, n. 267; DPCM del 15/12/1998 Delibera G.R. n. 1003 del 10/09/2001; Delibera
Regione Toscana Servizio Idrologico Regionale CENTRO FUNZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA DL 11/07/1998, n. 180; Legge 3/08/1998, n. 267; DPCM del 15/12/1998 Delibera G.R. n. 1003 del 10/09/2001; Delibera
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
 ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2014-649 del 18/09/2014 Oggetto Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2014-649 del 18/09/2014 Oggetto Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione
25 giugno 2017: forte temporale a Rovereto
 12 luglio 2017 25 giugno 2017: forte temporale a Rovereto Figura 1. Le intense precipitazioni della mattina del 25 giugno hanno provocato notevoli disagi alla viabilità (immagine da Il Dolomiti - http://www.ildolomiti.it/)
12 luglio 2017 25 giugno 2017: forte temporale a Rovereto Figura 1. Le intense precipitazioni della mattina del 25 giugno hanno provocato notevoli disagi alla viabilità (immagine da Il Dolomiti - http://www.ildolomiti.it/)
Rapporto dell evento meteorologico del 21 settembre 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 21 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 21 settembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO.
 METEO E CLIMA LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO. Si riporta una breve sintesi della situazione meteorologica registrata con alcuni dati più significativi e confronti
METEO E CLIMA LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO. Si riporta una breve sintesi della situazione meteorologica registrata con alcuni dati più significativi e confronti
Rapporto dell evento meteorologico del 19-20 febbraio 2014
 Rapporto dell evento meteorologico del 19-20 febbraio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Rapporto dell evento meteorologico del 19-20 febbraio 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
5.2 PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE MURATURE Martinetti piatti L uso dei martinetti piatti nella diagnosi dello stato delle murature ha due -
 5.2 PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE MURTURE 5.2.1 Martinetti piatti L uso dei artinetti piatti nella diagnosi dello stato delle urature ha due - - finalità: ottenere lo stato di esercizio tensionale di una
5.2 PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE MURTURE 5.2.1 Martinetti piatti L uso dei artinetti piatti nella diagnosi dello stato delle urature ha due - - finalità: ottenere lo stato di esercizio tensionale di una
Figura 1. Situazione meteo vista da satellite delle ore UTC del Elaborazione grafica a cura di Michele Salmi.
 Dopo aver concluso un inverno con temperature molto rigide ed episodi nevosi di un certo rilievo al centro-sud italiano, anche la primavera ha deciso di farsi ricordare subito per una intensa perturbazione
Dopo aver concluso un inverno con temperature molto rigide ed episodi nevosi di un certo rilievo al centro-sud italiano, anche la primavera ha deciso di farsi ricordare subito per una intensa perturbazione
PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000
 PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000 Giugno 2014 Documento a cura di:maurizio Masetti Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza.
PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ART. 48 L.R. 20/2000 Giugno 2014 Documento a cura di:maurizio Masetti Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza.
Rapporto dell evento meteorologico del 28 giugno 2017
 Rapporto dell evento meteorologico del 28 giugno 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, RadarpluviometriaNowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Rapporto dell evento meteorologico del 28 giugno 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, RadarpluviometriaNowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA,
Questi indicatori sono stati elaborati in relazione al territorio della Provincia di Ravenna.
 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC) 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della qualità dell
3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC) 3.1 - Gli indicatori meteorologici per lo studio della qualità dell
Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua.
 Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua. Valerio Buonomo, borsista c/o CNR-ISAFOM. Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, docente del Master in Pianificazione Comunale,
Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua. Valerio Buonomo, borsista c/o CNR-ISAFOM. Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, docente del Master in Pianificazione Comunale,
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) FCE0113
 BRIANZACQUE S.r.l. Sede Legale Viale Enrico Feri 105 20900 MONZA (MB) Telefono 039262301 Fax 0392174 www.brianzacque.it brianzacque@legalail.it PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COMUNE DI CESANO MADERNO (MB)
BRIANZACQUE S.r.l. Sede Legale Viale Enrico Feri 105 20900 MONZA (MB) Telefono 039262301 Fax 0392174 www.brianzacque.it brianzacque@legalail.it PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COMUNE DI CESANO MADERNO (MB)
ESAURIMENTO ATTENUAZIONE STAZIONARIETA' INTENSIFICAZIONE ALTRO:
 Centro Funzionale Regione Emilia Romagna CF-RER Viale Silvani, 6-40122 Bologna tel.: 051-6497606-523651 reperibilità meteo : 051-5282399 telefax : 051-5274352 e-mail: cf-rer@arpa.emr.it AVVISO METEO Avviso
Centro Funzionale Regione Emilia Romagna CF-RER Viale Silvani, 6-40122 Bologna tel.: 051-6497606-523651 reperibilità meteo : 051-5282399 telefax : 051-5274352 e-mail: cf-rer@arpa.emr.it AVVISO METEO Avviso
[Carta topografica] Ferrara. Sheet 76. IV. 1944, Stampato, 1 c. [cm 63 x 50] sc. 1: Army map service (so), US Army
![[Carta topografica] Ferrara. Sheet 76. IV. 1944, Stampato, 1 c. [cm 63 x 50] sc. 1: Army map service (so), US Army [Carta topografica] Ferrara. Sheet 76. IV. 1944, Stampato, 1 c. [cm 63 x 50] sc. 1: Army map service (so), US Army](/thumbs/64/51493759.jpg) Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna" 11. Carte geografiche d'italia - Rilievi particolari 11.1. Zone geografiche: 70 [Carta topografica] Cento. Sheet 75. II. S.W. 1944. Stampato, 1 c. [cm. 63 x 50] sc.
Fondo 8º brigata Garibaldi "Romagna" 11. Carte geografiche d'italia - Rilievi particolari 11.1. Zone geografiche: 70 [Carta topografica] Cento. Sheet 75. II. S.W. 1944. Stampato, 1 c. [cm. 63 x 50] sc.
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA
 RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
RELAZIONE METEOROLOGICA MENSILE LOMBARDIA SETTEMBRE 2015 Indice 1. Andamento meteorologico mensile... 2 2. Mappe dei principali parametri meteorologici... 3 2.1. Temperature... 3 2.2. Precipitazioni...
DALLA PREVISIONE METEOROLOGICA ALLA GESTIONE DELL ALLERTA METEO
 DALLA PREVISIONE METEOROLOGICA ALLA GESTIONE DELL ALLERTA METEO Servizio Idrologico Regionale Centro Funzionale della Regione Toscana Alessandro Santucci GIORNATA DI FORMAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE Gaiole
DALLA PREVISIONE METEOROLOGICA ALLA GESTIONE DELL ALLERTA METEO Servizio Idrologico Regionale Centro Funzionale della Regione Toscana Alessandro Santucci GIORNATA DI FORMAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE Gaiole
Evento del novembre 2012 Sintesi Meteo
 Evento del 27-28 novembre 2012 Sintesi Meteo A cura di: Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Servizio Meteorologico Una intensa perturbazione ha interessato il Veneto tra il pomeriggio di martedì
Evento del 27-28 novembre 2012 Sintesi Meteo A cura di: Dipartimento per la Sicurezza del Territorio - Servizio Meteorologico Una intensa perturbazione ha interessato il Veneto tra il pomeriggio di martedì
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE RAPPORTO DI EVENTO DEL OTTOBRE 2015 BACINO DELL'ANIENE. Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale
 CENTRO FUNZIONALE REGIONALE RAPPORTO DI EVENTO DEL 13-15 OTTOBRE 2015 BACINO DELL'ANIENE Periodo evento 13-15 ottobre 2015. Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale Il giorno 13 ottobre
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE RAPPORTO DI EVENTO DEL 13-15 OTTOBRE 2015 BACINO DELL'ANIENE Periodo evento 13-15 ottobre 2015. Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale Il giorno 13 ottobre
Rapporto dell evento meteorologico del novembre 2016
 Rapporto dell evento meteorologico del 18-19 novembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Rapporto dell evento meteorologico del 18-19 novembre 2016 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni Unità
Analisi meteorologica mensile. luglio Lago di Calaita Vanoi (24 luglio 2016) Paolo Trevisan
 Analisi meteorologica luglio Lago di Calaita Vanoi (24 luglio ) Paolo Trevisan Luglio è risultato nella norma sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. Le temperature sono state in
Analisi meteorologica luglio Lago di Calaita Vanoi (24 luglio ) Paolo Trevisan Luglio è risultato nella norma sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. Le temperature sono state in
Rapporto dell evento meteorologico dal 13 al 15 giugno 2014
 Rapporto dell evento meteorologico dal 13 al 15 giugno 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Rapporto dell evento meteorologico dal 13 al 15 giugno 2014 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Figura 3. Precipitazione cumulata il Dati ottenuti dalla Rete Stazioni Meteonetwork CEM.
 Questo mese di aprile si è presentato tipicamente primaverile: belle giornate di sole alternate a fasi perturbate con rovesci e temperature da fine inverno, soprattutto negli ultimi giorni del mese, quando
Questo mese di aprile si è presentato tipicamente primaverile: belle giornate di sole alternate a fasi perturbate con rovesci e temperature da fine inverno, soprattutto negli ultimi giorni del mese, quando
Aspetti meteorologici a grande scala del mese di maggio 2003
 Relazione sulla situazione meteorologica in Emilia Romagna nel periodo aprile giugno 23 Andrea Selvini e Rodica Tomozeiu ARPA, Servizio Meteorologico Regionale Dal punto di vista meteorologico i mesi di
Relazione sulla situazione meteorologica in Emilia Romagna nel periodo aprile giugno 23 Andrea Selvini e Rodica Tomozeiu ARPA, Servizio Meteorologico Regionale Dal punto di vista meteorologico i mesi di
Precipitazioni intense sulla bassa padovana del giorno 28 aprile 2014
 Precipitazioni intense sulla bassa padovana del giorno 28 aprile 2014 Teolo, 29 aprile 2014 Tra domenica e lunedì una perturbazione presente sulla Francia si estende verso il Mediterraneo e interessa il
Precipitazioni intense sulla bassa padovana del giorno 28 aprile 2014 Teolo, 29 aprile 2014 Tra domenica e lunedì una perturbazione presente sulla Francia si estende verso il Mediterraneo e interessa il
RAPPORTO SULL EVENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL MAGGIO 2008
 RAPPORTO SULL EVENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL 2-21 MAGGIO 28 A cura di: Miria Celano Michele Di Lorenzo Alessandro Donati Rosanna Foraci Sara Pignone Bologna, giugno 28 INDICE 1. INTRODUZIONE...4
RAPPORTO SULL EVENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO DEL 2-21 MAGGIO 28 A cura di: Miria Celano Michele Di Lorenzo Alessandro Donati Rosanna Foraci Sara Pignone Bologna, giugno 28 INDICE 1. INTRODUZIONE...4
GESTIONE DEL CONSEGUENTE AI. da parte del sistema di allerta della Regione del Veneto
 GESTIONE DEL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO CONSEGUENTE AI TEMPORALI FORTI da parte del sistema di allerta della Regione del Veneto Giugno 2016 Dott. Vincenzo Sparacino LA SCALETTA Iter costitutivo CFD Veneto
GESTIONE DEL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO CONSEGUENTE AI TEMPORALI FORTI da parte del sistema di allerta della Regione del Veneto Giugno 2016 Dott. Vincenzo Sparacino LA SCALETTA Iter costitutivo CFD Veneto
Linea Bologna Poggio Rusco ORARIO DAL 12 GIUGNO AL 10 DICEMBRE 2016
 Linea Bologna Poggio Rusco Categoria Reg Reg Reg Reg. Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg. BUS Numero Treno 11402 11556 6328 6324 11410 11452 11542 11454 11458 6258 6404 6506 6262 6400 6260 96310
Linea Bologna Poggio Rusco Categoria Reg Reg Reg Reg. Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg. BUS Numero Treno 11402 11556 6328 6324 11410 11452 11542 11454 11458 6258 6404 6506 6262 6400 6260 96310
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
 I 00143 Roma Via di Vigna Murata 605 Tel: (0039) 06518601 Fax: (0039) 0651860580 URL: www.ingv.it email: aoo.roma@pec.ingv.it Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Rapporto sulla sismicità nell
I 00143 Roma Via di Vigna Murata 605 Tel: (0039) 06518601 Fax: (0039) 0651860580 URL: www.ingv.it email: aoo.roma@pec.ingv.it Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Rapporto sulla sismicità nell
REPORT EVENTO METEO-IDROLOGICO DEI GIORNI 23 e 24 APRILE 2016
 Regione Toscana Servizio Idrologico Regionale CENTRO FUNZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA DL 11/07/1998, n. 180; Legge 3/08/1998, n. 267; DPCM del 15/12/1998 Delibera G.R. n. 1003 del 10/09/2001; Delibera
Regione Toscana Servizio Idrologico Regionale CENTRO FUNZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA DL 11/07/1998, n. 180; Legge 3/08/1998, n. 267; DPCM del 15/12/1998 Delibera G.R. n. 1003 del 10/09/2001; Delibera
Rendiconto idro-pluviometrico delle piogge temporalesche del giorno 2 agosto 2014 sul Varesotto
 Rendiconto idro-pluviometrico delle piogge temporalesche del giorno 2 agosto 2014 sul Varesotto a cura di Paolo Valisa (Centro Geofisico Prealpino) Inquadramento meteorologico. Le piogge dell'inizio di
Rendiconto idro-pluviometrico delle piogge temporalesche del giorno 2 agosto 2014 sul Varesotto a cura di Paolo Valisa (Centro Geofisico Prealpino) Inquadramento meteorologico. Le piogge dell'inizio di
MISURE IDROMETRICHE NEI FIUMI LIVENZA, MONTICANO E NEL CANALE MALGHER NEI GIORNI SETTEMBRE 2007
 DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO MISURE IDROMETRICHE NEI FIUMI LIVENZA, MONTICANO NEI GIORNI 26-29 SETTEMBRE 27 Relazione n. 7/7 5/11/27 Data 5/11/27 MISURE IDROMETRICHE NEI FIUMI
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO MISURE IDROMETRICHE NEI FIUMI LIVENZA, MONTICANO NEI GIORNI 26-29 SETTEMBRE 27 Relazione n. 7/7 5/11/27 Data 5/11/27 MISURE IDROMETRICHE NEI FIUMI
Analisi meteorologica mensile. maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio 2016)
 Analisi meteorologica maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio ) Maggio è risultato un po più freddo e più piovoso della media. (7 maggio ) CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA DEL MESE DI Maggio, come
Analisi meteorologica maggio Belvedere Torbole sul Garda (24 maggio ) Maggio è risultato un po più freddo e più piovoso della media. (7 maggio ) CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA DEL MESE DI Maggio, come
Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare.
 Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare. Dall inizio del 2010 si stanno eseguendo ricerche e monitoraggio circa i movimenti verticali del mare particolarmente accentuati
Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare. Dall inizio del 2010 si stanno eseguendo ricerche e monitoraggio circa i movimenti verticali del mare particolarmente accentuati
Vento forte 9-11 gennaio 2015
 12 marzo 2015 Vento forte 9-11 gennaio 2015 Figura 1. Pannelli solari danneggiati dalle raffiche di foehn a Spiazzo l'11 gennaio 2015. Tra il 9 e l'11 gennaio 2015 forti venti settentrionali hanno interessato
12 marzo 2015 Vento forte 9-11 gennaio 2015 Figura 1. Pannelli solari danneggiati dalle raffiche di foehn a Spiazzo l'11 gennaio 2015. Tra il 9 e l'11 gennaio 2015 forti venti settentrionali hanno interessato
I REDDITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
 I REDDITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Obiettivo Rapportando l imponibile Irpef al numero di e alla popolazione residente si ottengono degli indicatori in grado di definire il livello di ricchezza
I REDDITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Obiettivo Rapportando l imponibile Irpef al numero di e alla popolazione residente si ottengono degli indicatori in grado di definire il livello di ricchezza
Glossario dei termini meteorologici più utilizzati nel bollettino meteo
 Glossario dei termini meteorologici più utilizzati nel bollettino meteo Glossario dei termini meteorologici più utilizzati nel bollettino meteo (ORDINE ALFABETICO) (RAGGRUPPATI PER TEMA) ORDINE ALFABETICO:
Glossario dei termini meteorologici più utilizzati nel bollettino meteo Glossario dei termini meteorologici più utilizzati nel bollettino meteo (ORDINE ALFABETICO) (RAGGRUPPATI PER TEMA) ORDINE ALFABETICO:
Le Aliquote IMU 2012 dei comuni della provincia di Bologna e dei capoluoghi della regione Emilia Romagna
 Le Aliquote IMU 2012 dei comuni della provincia di Bologna e dei capoluoghi della regione Emilia Romagna Responsabile Osservatorio Immobiliare Confabitare Eduart Murati Introduzione Con la manovra finanziaria
Le Aliquote IMU 2012 dei comuni della provincia di Bologna e dei capoluoghi della regione Emilia Romagna Responsabile Osservatorio Immobiliare Confabitare Eduart Murati Introduzione Con la manovra finanziaria
ESAURIMENTO ATTENUAZIONE STAZIONARIETA' INTENSIFICAZIONE ALTRO:
 Centro Funzionale Regione Emilia Romagna CF-RER Viale Silvani, 6-40122 Bologna tel.: 051-6497606-523651 reperibilità meteo : 051-5282399 telefax : 051-5274352 e-mail: cf-rer@arpa.emr.it AVVISO METEO Avviso
Centro Funzionale Regione Emilia Romagna CF-RER Viale Silvani, 6-40122 Bologna tel.: 051-6497606-523651 reperibilità meteo : 051-5282399 telefax : 051-5274352 e-mail: cf-rer@arpa.emr.it AVVISO METEO Avviso
Rapporto dell evento meteorologico dal 24 al 26 agosto 2013
 Rapporto dell evento meteorologico dal 24 al 26 agosto 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
Rapporto dell evento meteorologico dal 24 al 26 agosto 2013 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Unità Sala Operativa Previsioni Meteorologiche Area
BOLLETTINO STRAORDINARIO RISERVE IDRICHE
 Riserva idrica (Milioni di mc) STATO DELLE Quadro generale per l'area alpina e prealpina Riserve idriche Anno 2017 (a) Totale Lombardia - Situazione al 19/3/2017 Anno medio di riferimento (media periodo
Riserva idrica (Milioni di mc) STATO DELLE Quadro generale per l'area alpina e prealpina Riserve idriche Anno 2017 (a) Totale Lombardia - Situazione al 19/3/2017 Anno medio di riferimento (media periodo
Bollettino di Monitoraggio
 PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 974/03/CF DATA EMISSIONE mer, 05 nov 16:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
PROGRESSIVO IN CORSO DI EVENTO N 974/03/CF DATA EMISSIONE mer, 05 nov 16:00 attuali ZONE DI ALLERTAMENTO LEGENDA A Bacini montani dei Fiumi Romagnoli B Pianura di Forlì e Ravenna C Bacino montano del Reno
SECONDO RAPPORTO SULL EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DEL 20 GIUGNO 2007
 SECONDO RAPPORTO SULL EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DEL 20 GIUGNO 2007 A cura di: Area Previsione e Monitoraggio Ambientale; Centro Regionale per le ricerche territoriali e Geologiche, in collaborazione con
SECONDO RAPPORTO SULL EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DEL 20 GIUGNO 2007 A cura di: Area Previsione e Monitoraggio Ambientale; Centro Regionale per le ricerche territoriali e Geologiche, in collaborazione con
Analisi meteorologica mensile. febbraio febbraio 2017 Lago di Garda (Efisio Siddi)
 r Analisi meteorologica febbraio 2017 25 febbraio 2017 Lago di Garda (Efisio Siddi) Febbraio 2017 è risultato più caldo della media tanto che per la prima volta da quando sono iniziate le registrazioni
r Analisi meteorologica febbraio 2017 25 febbraio 2017 Lago di Garda (Efisio Siddi) Febbraio 2017 è risultato più caldo della media tanto che per la prima volta da quando sono iniziate le registrazioni
(Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA - SIMC)
 Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
Elaborazione dati della qualità dell aria Provincia di Ravenna - Rapporto 21 3 - LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (Elaborazioni grafiche a cura di G. Bonafè - ARPA
L evento meteo e gli effetti al suolo
 REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza Ufficio Protezione Civile EVENTI IDROMETEREOLOGICI DEI GIORNI 30-31 OTTOBRE L evento meteo e gli effetti al suolo Traversa fiume Sinni - Rotondella Il Dirigente
REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza Ufficio Protezione Civile EVENTI IDROMETEREOLOGICI DEI GIORNI 30-31 OTTOBRE L evento meteo e gli effetti al suolo Traversa fiume Sinni - Rotondella Il Dirigente
Il sistema Meteosat Giovedì 30 Aprile :04 - Ultimo aggiornamento Sabato 16 Maggio :52
 Il sistea Meteosat Giovedì 30 Aprile 2009 08:04 - Ultio aggiornaento Sabato 16 Maggio 2009 06:52 MSG (Meteosat Seconda Generazione) I 12 canali di MSG Il SEVIRI (Spanning Enhanced Visible Infrared Iager)
Il sistea Meteosat Giovedì 30 Aprile 2009 08:04 - Ultio aggiornaento Sabato 16 Maggio 2009 06:52 MSG (Meteosat Seconda Generazione) I 12 canali di MSG Il SEVIRI (Spanning Enhanced Visible Infrared Iager)
Radio Tetra Tipo A n.30 Radio UHF Tipo B n.32
 DISCIPLINARE TECNICO Fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza delle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio idropluviometrico dei fiumi romagnoli. La rete della stazioni in telemisura
DISCIPLINARE TECNICO Fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza delle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio idropluviometrico dei fiumi romagnoli. La rete della stazioni in telemisura
24 giugno 2014: maltempo in Trentino
 24 giugno 2014: maltempo in Trentino Nella giornata del 24 giugno 2014 gli indici temporaleschi erano molto favorevoli per lo sviluppo di forti temporali con associati forte vento e grandinate di rilievo.
24 giugno 2014: maltempo in Trentino Nella giornata del 24 giugno 2014 gli indici temporaleschi erano molto favorevoli per lo sviluppo di forti temporali con associati forte vento e grandinate di rilievo.
Rapporto dell evento meteorologico del 12 e 13 gennaio 2017
 Rapporto dell evento meteorologico del 12 e 13 gennaio 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
Rapporto dell evento meteorologico del 12 e 13 gennaio 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni
