Bollettino Astronomico
|
|
|
- Benvenuto Zamboni
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Bollettino Astronomico 412 / 2017
2 OSSERVATORIO ASTRONOMICO e PLANETARIO G.Galilei SUNO (NO) Tel / info@osservatoriogalilei.com Mercoledì 5 Luglio 2017, dopo le ore 21, in osservatorio, per i tradizionali incontri del primo mercoledì di ogni mese, vi sarà una serata dedicata alle proiezioni al planetario e, in caso di condizioni meteo favorevoli, osservazioni al telescopio. In caso di cattivo tempo sarà in uso il solo planetario. La Luna, sarà in fase crescente con illuminazione del 90% - sorge alle 18:09 e tramonta alle 03:22 Le osservazioni di oggetti deboli del profondo cielo saranno molto disturbate dalla presenza della luna. Si potranno vedere le principali costellazioni estive. Il pianeta Giove sarà visibile nella prima parte della notte. Saturno sorgerà nella prima parte della notte tramontando poco dopo la Luna, la ridotta altezza sull orizzonte rende però l osservazione ancora disturbata dalla turbolenza. CALENDARIO LUNARE DI LUGLIO 2
3 IL CIELO DEL 5 LUGLIO 2017 (a cura di Corrado Pidò) RECENSIONI (a cura di Silvano Minuto) DAVA SOBEL - LE STELLE DIMENTICATE Storia delle scienziate che misurarono il cielo Rizzoli 2017 Pag. 284 Formato 14 x 21 cm Dalla fine del XIX secolo, l Osservatorio astronomico di Harvard iniziò ad assumere alcune donne come calcolatori umani. L harem così veniva talvolta deriso il personale femminile era formato da signore di tutte le età: esperte di matematica, astronome dilettanti, mogli, sorelle e figlie dei professori; alcune laureate, altre semplicemente appassionate. Attraverso l universo di vetro che avevano a disposizione, formato da circa mezzo milione di lastre fotografiche su cui erano impresse le immagini delle stelle, queste studiose fecero alcune scoperte straordinarie: svilupparono un sistema di classificazione che fu accettato a livello internazionale ed è ancora in uso; intuirono la verità sulla composizione chimica dei cieli, e definirono una scala per misurare le distanze nello spazio. (segue) 3
4 Alla loro storia Dava Sobel dedica il suo libro più appassionato, arricchito dai testi inediti di diari e lettere: Quando hanno letto i nomi dei membri scrive Annie Jump Cannon, una delle protagoniste, mi sono assai meravigliata di scoprire che ero stata inserita nella Commissione per la classificazione degli spettri stellari, e una delle esperienze inattese è stata la riunione con i suoi membri. Sedevano a un lungo tavolo, quegli uomini provenienti da varie nazioni, e io ero l unica donna. Era stata lei a studiare per anni gli spettri stellari, e fu lei a parlare per tutto il tempo. DIARIO ASTRONOMICO (a cura di Silvano Minuto) Presentazione nel bollettino n. 355 del e Sono anni difficili per l Italia e le osservazioni si riducono di conseguenza. Nei due anni vengono descritte una eclisse parziale di luna nel 1930 e una totale di Luna l anno successivo. Parte Ottobre Eclissi parziale di Luna. Principio penombra 17h 41m; ombra 19h 46m; fase massima 20h 7m; fine ombra 20h 27m; penombra 22h 32. L osservazione è stata favorita dal cielo completamente sereno. A 19h 15m, principio dell osservazione, si avverte ad occhio nudo l effetto della penombra, che però non è molto evidente e sfuggirebbe facilmente a persona non prevenuta. Essa è molto meglio visibile al binocolo come un ombreggiatura grigia, senza limiti precisi che però sembra estendersi attenuata fin verso il centro del disco. La sua visibilità aumenta col procedere dell eclisse e specialmente negli ultimi minuti precedenti il contatto con l ombra; tuttavia è solo dopo l ingresso di questa che il fenomeno appare immediatamente anche ad occhio nudo attira anche uno sguardo distratto. Al momento della fase massima (20h 47m) la penombra appare al binocolo estesa a gran parte del disco. L ombra non ha limiti ben definiti; una piccola parte del lembo è invisibile e la contigua una fascia bruna che si estende a gran parte di Mare Frigoris. Nessuna traccia di colorazione rossastra Settembre Eclissi totale di Luna. Principio penombra 17h 41m; principio della totalità 20h 6m; in ombra 20h 48m; Fase massima (1.326) a 20h 48m; fine della totalità 21h 31m; dell ombra 22h 42m; della penombra 23h 55m. 18h 46m. La Luna che appare attraverso leggeri cirri stratiformi mostra un evidente offuscamento nella parte sinistra superiore, vicina al lembo. 18h 55m. L ombra ha già interessato il disco, e il fenomeno attira immediatamente l attenzione. Ad occhio nudo la parte eclissata appare grigia. Ripresa l osservazione a 19h 52m, si nota che l eclissi è ormai molto avanzata e l ombra ha invaso la maggior parte del disco, ma rimane sempre un ampio segmento luminoso. La parte eclissata è visibile ad occhio nudo; più chiara verso il bordo rimanente e presenta una sensibile tinta rossastra. 20h 9m. L aspetto è sensibilmente cambiato. La Luna è completamente nell ombra; tuttavia la parte del disco eclissata per ultima rimane notevolmente chiara: il rimanente presenta una tinta aranciata molto accentuata. 4 (segue)
5 20h 33m. Osservata al binocolo la Luna presenta sempre le caratteristiche notate a occhio nudo a 20h 9m. Anche la parte di ombra di tinta rossastra è abbastanza trasparente, si da lasciar apparire le grandi configurazioni del suolo. 20h 41m. La tinta che copre la parte settentrionale del disco, a Nord del Mare Crisium fino al termine di Mare Frigoris è più francamente rossastra, mentre quella che copre la parte centrale del disco e l Oceanus Procellarum tende più al bruno (binocolo). 21h 0m. Si nota la rotazione del segmento luminoso. Al cannocchiale (54mm) si riconoscono le configurazioni generali e si nota che la tinta rossastra è specialmente evidente nelle regioni chiare della parte centrale della Luna e specialmente su quelle prossime al polo Nord. Varie stelle sono visibili tutto intorno, in prossimità della Luna. 21h 6m. La zona di Tycho fino al termine delle terre australi è sempre notevolmente chiara, e i dettagli vi sono assai più facilmente visibili (ad. es. Grimaldi), che nella parte opposta dove la tinta rossastra è più intensa. Come è stato notato a 21h 12m, la tinta rossastra è assai più accentuata al binocolo che al cannocchiale e più ancora ad occhio nudo, in cui l astro appare di una tinta rossa intensa, tendente un po al bruno. Viceversa il dettaglio del suolo lunare è meno facilmente visibile che al cannocchiale. 21h 26m. Il centro della zona rossa è prossimo a raggiungere Mare Crisium. La parte opposta è notevolmente chiara fino a notevole distanza dal lembo; il circo di Tycho, sebbene un po fuori da questa zona è distintamente visibile. 21h 31m. Ad occhio nudo la Luna, salvo un largo segmento chiaro, presenta una tinta rossastra, meno intensa in prossimità del segmento, più cupa all estremità opposta, ove l Oceano Procellarum e i Mari Serenitatis e Nectaris formano una macchia oscura dai contorni imprecisi. 21h 33m. La totalità è terminata, e l estremità del disco mostra una stretta orlatura luminosa. A 21h 35m,5 Grimaldi è già emerso dall ombra. 21h 38m. La tinta rossastra è specialmente intensa intorno a Mare Crisium; che tuttavia è sempre ben visibile al cannocchiale. 21h 52. Kepler e Aristarco sono già usciti dall ombra, che attraversa Tycho. 21h 58m. Il limite dell ombra presenta una larga degradazione. La parte opposta mostra sempre una accentuata tinta rossastra. 22h 7m. L ombra raggiunge Platone. Il contorno è sfumato e orlato da una zona grigia diffusa. La parte eclissata ha una tinta grigia oscura sulla quale le configurazioni lunari sono assai peggio visibili che durante la totalità: la parte più lontana presenta sempre tracce di tinta rossastra. 22h 19m. L ombra ha un aspetto grigio opaco; ma forse si tratta solo di un effetto di contrasto perché, facendo uscire dal campo la parte illuminata, quella eclissata presenta tuttora una spiccata tinta rossastra, con visibilità delle configurazioni del suolo. 22h 33m. La parte eclissata è ancora visibile. Il contorno dell ombra è estremamente vago, e presenta una orlatura sfumata, la cui larghezza sembra un po minore di quella del Mare Serenitatis. 22h 43m. La Luna è uscita dall ombra, ma l offuscamento prodotto dalla penombra è evidente nella regione di Mare Crisium e a Sud di essa, tanto che il lembo mostra un po schiacciato. 22h 49m. La regione a Sud di Mare Crisium e quella circostante presenta una luminosità assai sensibilmente inferiore a quella delle altre regioni lunari ma è soprattutto al binocolo che essa appare più evidentemente oscurata. 22h 57m. L effetto dell ombra è sempre facilmente riconoscibile al cannocchiale e al binocolo. 23h 8m. La Luna splende in tutto il suo fulgore, e le piccole stelle osservate a 21h non sono più visibili. Le regioni occidentali sembrano però presentare un sensibile offuscamento. 5
6 IMPARARE GLI ALLINEAMENTI - CRATERE (a cura di Silvano Minuto) Da: Osservare il Cielo Corso per imparare a riconoscere le stelle e le costellazioni Un osservatore che per la prima volta affronta un cielo stellato con la volontà di riconoscere le costellazioni, può essere preso dallo sconforto: le stelle sono tante, più o meno luminose, più o meno vicine fra loro; orientarsi in un mare così caotico può sembrare difficile. Quando si inizia ad osservare il cielo, occorre innanzitutto cercare delle forme caratteristiche, dette asterismi. Fondamentale per l'apprendimento è un cielo non inquinato e buio, possibilmente sgombro da intralci fisici (come montagne alte molto vicine) che impediscano l'osservazione di grandi aree della volta celeste. In questa esposizione non seguiremo necessariamente le stagioni, ma procederemo ad illustrare le varie costellazioni per raggruppamenti omogenei. Una sezione interattiva per imparare gli allineamenti di base è disponibile sul sito istituzionale APAN alla pagina: I - Riconoscere il Grande Carro (o Orsa Maggiore) II Riconoscere la Stella Polare III Cassiopeia IV Costellazioni circumpolari V Cefeo VI Drago VII Perseo VIII Cani da Caccia IX Triangolo estivo X La Lira XI Il Cigno XII L Aquila XIII Alcune costellazioni minori XIX Boote e dintorni XX Boote e Corona Boreale XXI Chioma di Berenice XXII Spica e la Vergine XXIII Trovare Ercole XXIV Dal Triangolo estivo all Ofiuco XXV La testa dell Ofiuco XXVI Ofiuco XXVII Serpente XXVIII Scorpione XXIX Bilancia XXX Sagittario XXXI Capricorno XXXII Verso l Acquario XXXIII Pegaso XXXIV Andromeda XXXV Il Quadrato del Pegaso XXXVI Perseo XXXVII Ariete e Triangolo XXXVIII Pesci XXXIX Il grande pentagono di Auriga XL Il Toro XLI I Gemelli XLII Auriga XLIII Lepre XLIV Colomba XLV Eridano XLVI Poppa XLVII Canopo XLVIII Le Vele XLIX L Orsa Maggiore XLX - Il Leone XLXI Il Cancro XLXII Verso l Idra XLXIII Arturo e dintorni XLXIV Boote e Corona Boreale XLXV Spica e la Vergine XLXVI Chioma di Berenice XLXVII Il triangolo di primavera XLXVIII Il Leone XLXIX Il Cancro XLXXI Il gigante Orione XLXXIII Il Cane Maggiore XLXXIX Il Cane Minore e l Unicorno XLXXXI Il Toro XLXXIII L Auriga XLXXV Il Corvo XLXX Verso l Idra XLXXII Sirio e il Triangolo invernale XLXXX A Nord di Orione XLXXXII I Gemelli XLXXIV Il Centauro 6
7 Lo Scorpione Verso la fine di aprile inizia ad apparire, verso l'orizzonte sud-est, una stella di un colore rosso vivo, luminosa, circondata verso nord da un archetto di stelle azzurre: la stella rossa è Antares e forma, con le stelle vicine, la testa dello Scorpione, una delle costellazioni che saranno poi dominanti nei cieli estivi. Lo Scorpione è una costellazione che si estende principalmente a sud dell'eclittica, dunque è di difficile osservazione, specie nel nord Italia, e abbisogna alle nostre latitudini di un orizzonte meridionale libero da ostacoli. La parte della testa è la più settentrionale. Come lo Scorpione sorge, emerge dall'orizzonte anche il rigonfiamento centrale della Via Lattea, che sarà ben visibile d'estate. Poco a sud, fra Scorpione e Centauro, sono presenti alcune stelle di terza magnitudine, appartenenti alla costellazione del Lupo. Da: Osservare il Cielo Corso per imparare a riconoscere le stelle e le costellazioni (segue) 7
8 Il Dragone Conosciuto anche semplicemente come Drago. Culmina al meridiano intorno alle ore 22 del 25 maggio. Copre 1083 gradi quadrati e contiene 80 stelle più brillanti della sesta magnitudine. Costellazione circumpolare molto estesa, si snoda tra le due Orse. La parte meglio visibile è costituita dalla testa che riposa in cielo ai piedi del gigante Ercole. Con la nostra concezione moderna ci aspetteremmo di vedere la figura di un drago alato che emette fuoco da una o più bocche. In realtà in greco Drago significa serpente ed è proprio questa figura che si vuole rappresentare. Mella mitologia si ricorda Ladone, il serpente, che custodiva l ingresso delle Esperidi, dove crescevano le mele d oro. La stella più luminosa della costellazione è Gemma. Nel 1724 Bradley cercò di determinarne la distanza mediante il metodo della parallasse; non ci riuscì ma in compenso scoprì il fenomeno dell aberrazione della luce. (segue) 8
9 Alfa Thuban AR 14h 04m D Mag. 3.6 sp. A0 Il nome in arabo significa testa del serpente. Non è l astro più brillante della costellazione; si trova a 309 anni luce di distanza e brilla come 254 soli. E importante dal punto di vista storico: nel 2800 a.c. era la stella più vicina al polo e ora, a causa della precessione degli equinozi è lontana ben 25. Beta - Rastaban AR 17h 30m D Mag. 2.8 sp. G0 Si tratta di una gigante 780 volte più luminosa del Sole, distante 362 anni luce. Ha una debole compagna di magnitudine 14 a 4.2, non visibile con i telescopi amatoriali. Gamma - Etamin AR 17h 57m D Mag. 2.2 sp. K5 E la stella più luminosa della costellazione. Gigante rossa distante 147 anni luce, e 216 volte più luminosa del Sole. Pare che gli antichi egiziani l abbiano utilizzata per orientare alcuni templi. Proprio studiando questa stella, che passa quasi esattamente allo zenit alle latitudini inglesi, James Bradley riuscì nel 1725 a scoprire il fenomeno dell aberrazione della luce. Epsilon AR 19h 48m D Separazione 3.1 mag. 3.8 e 7.4 AP 15 Stella doppia con componenti giallastre visibile con un piccolo telescopio. Eta AR 16h 24m D Separazione 5.2 mag. 2.7 e 8.7 AP 142 Componenti di colore giallo, visibili con un piccolo telescopio. Nu 1,2 AR 17h 32m D Separazione 61.9 mag. 4.9 e 4.9 AP 312 E una delle stelle della testa del Dragone; componenti bianche con magnitudine identica. Tipica doppia binoculare. Omicron AR 18h 51m D Separazione 34.2 mag. 4.8 e 7.8 AP 326 Doppia con componenti gialla e bluastra. Facile da osservare anche con piccoli strumenti. 39 Draconis AR 18h 24m D Separazione mag. 5.0, 8.0 e 7.9 AP Sistema costituito da due stelle, una bianca e una bluastra con magnitudine 5.0 e 8.0 che si trovano a 3.8 di distanza. Un altra componente di mag. 7.9 risulta più distante (89 ). Gamma Draconis AR 09h 42m D Tipo Mira mag periodo 325 gg (segue) 9
10 Variabile tipo Mira con oscillazione tra magnitudine 6.2 e 15.0 in 325 giorni. Si trova in una zona dove sono presenti poche stelle brillanti e quindi è difficile da localizzare. Può essere d aiuto il suo colore rosso e la vicinanza con il massimo di luminosità. NGC 5866 AR 15h 06m D Dimensioni 6.6x3.2 Magnitudine 9.9 Tipo Galassia Una volta si pensava fosse il famoso oggetto mancante dal catalogo di Messier, M 102. In realtà risulta che M 102 è un doppione di M 101 in Orsa Maggiore. Siamo in presenza di una delle galassie più luminose della costellazione ed è visibile, almeno per quanto riguarda la zona centrale, con medi telescopi. Se si osserva con grandi strumenti è possibile vedere una sottile banda di polveri che la attraversa. Si trova a 4 a SSO della stella Iota Dra. N GC 6543 AR 17h 58m D Dimensioni 18 Magnitudine 8.1 Tipo Planetaria E una nebulosa planetaria tra le più brillanti; ha magnitudine 8.1 e un diametro di 18 (all incirca quello medio di Saturno). Con strumenti di piccole dimensioni appare come una stella sfuocata di colore verdastro. L astro centrale di 11^ magnitudine è molto caldo con temperatura superficiale di K. Si trova ad oltre 2000 anni luce di distanza. (segue) 10
11 Sciami meteorici In questa costellazione è visibile lo sciame delle Draconidi, attivo tra il 27 e il 30 giugno, sciame che produce poche meteore molto lente. Ha in comune con Boote lo sciame delle Quadrantidi. 11
12 SUPERNOVE - (a cura di Silvano Minuto) Supernova 2017ewv Scoperta il 23 giugno 2017 da: All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) Nella Galassia UGC 8287 (Chioma di Berenice) R.A. = 13h10m59s.310, Decl. = '36".65 Mag 16.9:6/23, Type IIP 12
13 STELLARIUM SCRIPTING (a cura di Roberto Brisig ) Quinto appuntamento di una serie di articoli, iniziata con il bollettino 407/2017 dedicati alla programmazione degli scripts di Stellarium dove si cercherà di illustrare alcune peculiarità e possibilità del programma cercando di ovviare alla scarsa documentazione di Stellarium sull argomento limitandosi a mettere a disposizione semplicemente il repertorio dei comandi senza alcuna descrizione specifica. Introduzione Il noto programma di simulazione astronomica Stellarium può essere pilotato, oltre che dai comandi del mouse con le icone del display e dai numerosi comandi da tastiera (ricordiamo che sono elencati nella finestra di aiuto, richiamabile con F1) anche con dei programmi editabili in un file detto Script. Questi script contengono una sequenza di istruzioni che permette a Stellarium di presentare in modo automatico qualsiasi situazione astronomica, senza alcuna necessità di digitare alcunchè sulla tastiera o usare il mouse, così da poter replicare a volontà le presentazioni con essi preparati. Gli script sono dei file di testo scritti secondo il linguaggio ECMAscript (noto anche come JavaScript) che dà al programmatore l accesso a tutte le peculiarità di questo linguaggio quali istruzioni condizionali, cicli, variabili, manipolazione di stringhe, ecc. L interazione con Stellarium è data mediante l uso di una collezione di istruzioni specifiche che permettono di effettuare ogni e qualsiasi azione del programma. Il repertorio completo di queste istruzioni è disponibile all indirizzo Stellarium è liberamente scaricabile alla pagina: ed è disponibile per le piattaforme Windows, MacOS e Linux. In questo capitolo vengono elencati i comandi principali contenuti nella classe LabelMgr relativi alla creazione ed alla gestione di testi, scritte ed etichette. Questi comandi sono tutti preceduti dalla parola chiave LabelMgr. Il repertorio completo di queste istruzioni è disponibile all indirizzo Il metodo per far apparire sullo schermo un testo consiste nella chiamata di una delle tre funzioni preposte che assegneranno ad una variabile un valore che servirà da identificatore per ulteriori operazioni su quel testo. (segue) 13
14 Queste tre funzioni permettono di far apparire un testo: 1. Legato ad un particolare oggetto celeste 2. In una determinata posizione di coordinata azimutale 3. In una determinata posizione dello schermo Impostazione di un testo legato ad un oggetto celeste labelobject(text, objectname, visible, fontsize, fontcolor, side, labeldistance, style) text = testo da far apparire objectname = nome dell oggetto celeste, in inglese, press oil quale il testo apparirà visible = true se il testo apparirà immediatamente oppure false se il testo sarà solo impostato e fatto apparire successivamente fontsize = grandezza dei caratteri (14 per default) fontcolor = colore dei caratteri secondo il sistema HTML. (P.es "#ffff00" per il giallo) side = posizione del testo rispetto all oggetto e il display: N sopra, S sotto, E a destra, W a sinistra ma sono ammessi anche "NE", "NW", "SE", "SW" labeldistance = distanza dall oggetto: -1.0 style = TextOnly NOTA: i parametri labeldistance e style sono di effetto non chiaro e possono essere tralasciati Esempio: LabelMgr.labelObject("N: sopra","moon",true,14,"#ff0000","n"); LabelMgr.labelObject("S: sotto","moon",true,14,"#ff0000","s"); LabelMgr.labelObject("W: sinistra","moon",true,14,"#ff0000","w"); LabelMgr.labelObject("E: destra","moon",true,14,"#ff0000","e"); (segue) 14
15 Queste quattro linee (unitamente a zoom e orario adeguati) danno il seguente risultato: Vi è anche da tenere in considerazione un comando già visto in precedenza e più precisamente core.setflaggravitylabel(b) Questa istruzione imposta l allineamento delle etichette all orizzonte più vicino, per esempio in caso di deformazione per proiezione in cupola. Esempi: Core.setFlagGravityLabel(true); Core.setFlagGravityLabel(false); (segue) 15
16 Impostazione di un testo in una posizione di coordinate azimutale labelhorizon(text, az, alt, visible, fontsize, fontcolor) text = testo da far apparire az = valore dell azimuth espresso in gradi alt = valore dell altitudine espressa in gradi visible = true se il testo apparirà immediatamente oppure false se il testo sarà solo impostato e fatto apparire successivamente fontsize = grandezza dei caratteri (14 per default) fontcolor = colore dei caratteri secondo il sistema HTML. (P.es "#ffff00" per il giallo) Impostazione di un testo in una posizione determinata sul display labelscreen(text, x, y, visible, fontsize, fontcolor) text = testo da far apparire x = posizione orizzontale del testo, in pixel, dal lato sinistro del display y = posizione verticale del testo, in pixel, dal lato superiore del display visible = true se il testo apparirà immediatamente oppure false se il testo sarà solo impostato e fatto apparire successivamente fontsize = grandezza dei caratteri (14 per default) fontcolor = colore dei caratteri secondo il sistema HTML. (P.es "#ffff00" per il giallo) ATTENZIONE : poichè le dimensioni in pixel (risoluzione) possono variare anche in modo importante da uno schermo all altro, le coordinate x e y sono da adattarsi alla risoluzione dell apparecchio finale. Attivazione / disattivazione di un testo setlabelshow(id, show) id = variabile identificativa che è stata assegnata da una delle funzioni di creazione elencate sopra show = parametro true oppure false che renderà visibile o nasconderà il testo impostato Se durante l impostazione di un testo il parametro visible fosse già stato definito come true, questo comando diventa utile solo se si vuol nascondere il testo. 16
17 Modifica di una etichetta setlabeltext(id, newtext) id = variabile identificativa che è stata assegnata da una delle funzioni di creazione elencate sopra newtext = nuovo testo che ne sostituirà uno precedente mantenendo caratteristiche uguali Eliminazione di una etichetta deletelabel(id) L etichetta identificata con id viene eliminata deletealllabels() Tutte le etichette vengono eliminate. Esempio // // Si definisce un testo da mettere in centro allo schermo Wtxt = LabelMgr.labelScreen( Benvenuti, 600, 400, true, 25, #f9e397 ); // Si fa una pausa di 5 secondi core.wait(5); // Si definisce un altro testo in sostituzione al primo LabelMgr.setLabelText(Wtxt, al planetario ); core.wait(5); // Dopo 5 secondi si eliminano tutti i testi LabelMgr.deleteAllLabels() // 17
18 Astronomy Picture of The Day (APOD) - 12 giugno 2017 (a cura di Corrado Pido) è un archivio redatto a partire dal 1995 da Robert Nemiroff e Jerry Bonnell. L archivio APOD contiene la più grande raccolta di immagini astronomiche ed ognuna di esse è corredata da una breve descrizione fatta da esperti. Per visio nare l archivio basta digitare in internet la sigla APOD e di seguito l indice Immagine tridimensionale con tecnica anaglifica (occhiale Rosso-Blu) del suolo di Marte. (Credit NASA ) 18
19 ARCHIViO IMMAGINI (Osservatorio) A partire dal bollettino 411 pubblichiamo immagini astronomiche riprese nel tempo dai soci. Molte di queste sono riproduzioni digitali di stampe o diapositive Spettacolare immagine di M45 (pleiadi) riprese da Giancarlo Solda, socio e amico scomparso prematuramente. 19
20 FLY ME TO THE MOON Il cratere " Manzinus ", (a cura di Davide Crespi Al bordo meridionale della Luna possiamo osservare il cratere "Manzinus", una formazione danneggiata di 100Km con versanti scoscesi su cui si trovano Manzinus D a sud-ovest e Manzinus T e U ad est. Sulle alte pareti parzialmente terrazzate si trovano un piccolo cratere a nord-ovest e Manzinus A a sud. Nel fondo piatto piccoli crateri. La sua formazione risale al periodo Pre-Nectariano (da miliardi di anni a miliardi di anni). Il periodo migliore per la sua osservazione è 5 giorni dopo la Luna nuova oppure 4 giorni dopo la Luna piena. (segue) 20
21 Alcuni dati: Longitudine: East Latitudine: South Faccia: Nearside Quadrante: Sud-Est Area: Bordo Meridionale della Luna Origine del nome: Dettagli: Carlo A. Manzini Filosofo e astronomo italiano del 17 secolo nato in Italia Nato nel 1599 Morto nel 1677 Autore del nome: sonosciuto Nome dato da Riccioli: Tannerus Nelle foto una ripresa amatoriale del cratere "Manzinus" e il frontespizio di una delle sue opere. Lo strumento minimo per poter osservare questa formazione è un rifrattore da 60mm. Hanno collaborato: Silvano Minuto, Roberto Brisig, Corrado Pidò, Davide Crespi, Vittorio Sacco, Alessandro Segantin Immagine di copertina : M20 M8 (nebulosi trifida e laguna) di Alessandro Segantin 21
22 Tra poco, in occasione della dichiarazione dei redditi, si dovrà scegliere a chi destinare il 5 per mille. Sottoscrivere il cinque per mille a favore dell Osservatorio, ci permette di ammodernare ed ampliare la struttura e di migliorare le prestazioni, in particolar modo nel campo della divulgazione e della ricerca. Queste le coordinate: APAN - Associazione Provinciale Astrofili Novaresi - Onlus C.F. osservatorio Casella sostegno del volontariato. Per collaborare al bollettino inviare una a: info@osservatoriogalilei.com L'osservatorio ha una propria pagina facebook: La pagina è moderata, quindi qualsiasi cosa scritta sulla bacheca non apparirà in pubblico prima di essere vagliata dagli amministratori. Ricordiamo che è possibile iscriversi all'associazione versando la quota per il 2017, invariata da anni, di 25,00. I versamenti dei soci sono gli unici proventi dell'osservatorio. La quota può essere versata in osservatorio oppure con bonifico su IBAN IT43J
Calendario serate d osservazione astronomica 2017
 Calendario serate d osservazione astronomica 2017 Sabato 15 aprile La costellazione della Vergine a sud-est e le stelle brillanti Spica e Porrima con numerosi ammassi e galassie. Molto interessanti M49,
Calendario serate d osservazione astronomica 2017 Sabato 15 aprile La costellazione della Vergine a sud-est e le stelle brillanti Spica e Porrima con numerosi ammassi e galassie. Molto interessanti M49,
ASTRONOMIA VALLI DEL NOCE.
 ASTRONOMIA VALLI DEL NOCE www.astronomiavallidelnoce.it info@astronomiavallidelnoce.it IL CATALOGO MESSIER Il Catalogo di Messier è stato il primo catalogo astronomico di oggetti celesti diversi dalle
ASTRONOMIA VALLI DEL NOCE www.astronomiavallidelnoce.it info@astronomiavallidelnoce.it IL CATALOGO MESSIER Il Catalogo di Messier è stato il primo catalogo astronomico di oggetti celesti diversi dalle
sfera celeste e coordinate astronomiche
 sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti
 ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
ASTRONOMIA=scienza che studia i corpi celesti Definizioni UNIVERSO o COSMO = è lo spazio che comprende tutti gli oggetti celesti; comprende le GALASSIE, stelle e i PIANETI GRUPPO LOCALE GALASSIE = insieme
Il taccuino dell esploratore
 Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Bollettino Astronomico
 Bollettino Astronomico 410 / 2017 OSSERVATORIO ASTRONOMICO e PLANETARIO G.Galilei 28019 SUNO (NO) Tel. 032285210 / 335275538 www.osservatoriogalilei.com info@osservatoriogalilei.com Mercoledì 7 giugno
Bollettino Astronomico 410 / 2017 OSSERVATORIO ASTRONOMICO e PLANETARIO G.Galilei 28019 SUNO (NO) Tel. 032285210 / 335275538 www.osservatoriogalilei.com info@osservatoriogalilei.com Mercoledì 7 giugno
Corso di astronomia pratica
 Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI
 IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
OSSERVATORIO ASTRONOMICO GALILEO GALILEI 28019 SUNO (NO) - Tel. 032285210-335275538 apansuno @ tiscali.it www.apan.it - www.osservatoriogalilei.
 OSSERVATORIO ASTRONOMICO GALILEO GALILEI 28019 SUNO (NO) - Tel. 032285210-335275538 apansuno @ tiscali.it www.apan.it - www.osservatoriogalilei.com Le coordinate dell osservatorio sono: 45 38 16 Nord 8
OSSERVATORIO ASTRONOMICO GALILEO GALILEI 28019 SUNO (NO) - Tel. 032285210-335275538 apansuno @ tiscali.it www.apan.it - www.osservatoriogalilei.com Le coordinate dell osservatorio sono: 45 38 16 Nord 8
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
LA TERRA. La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI.
 LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
EVENTI ASTRONOMICI 2016
 Commissione Divulgazione UAI Unione Astrofili Italiani http://divulgazione.uai.it EVENTI ASTRONOMICI 2016 Un diario dei principali eventi astronomici che potremo osservare dall'italia durante l'anno 2016.
Commissione Divulgazione UAI Unione Astrofili Italiani http://divulgazione.uai.it EVENTI ASTRONOMICI 2016 Un diario dei principali eventi astronomici che potremo osservare dall'italia durante l'anno 2016.
Le Coordinate Astronomiche
 Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra
 Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica
 Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
11 Prefazione 14 Ringraziamenti. 15 Parte prima I testi base
 Indice 11 Prefazione 14 Ringraziamenti 15 Parte prima I testi base 16 Capitolo I Il MUL.APIN 16 Un inquadramento storico 17 L astronomia fra i due fiumi 19 Il più antico documento astronomico 20 Data e
Indice 11 Prefazione 14 Ringraziamenti 15 Parte prima I testi base 16 Capitolo I Il MUL.APIN 16 Un inquadramento storico 17 L astronomia fra i due fiumi 19 Il più antico documento astronomico 20 Data e
SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$
![SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$ SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$](/thumbs/54/35044472.jpg) &$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
&$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
Sfera Celeste e Coordinate Astronomiche. A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011
 Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA
 ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA Competenza in matematica: soluzioni a situazioni Competenze digitali: Saper utilizzare i linguaggi e le diverse tecniche della comunicazione
ALLA RICERCA DELLA STELLA PERDUTA LABORATORIO DI ASTRONOMIA Competenza in matematica: soluzioni a situazioni Competenze digitali: Saper utilizzare i linguaggi e le diverse tecniche della comunicazione
PLS. CAMERINO 16 febbraio 2011 - Angelo Angeletti
 PLS CAMERINO 16 febbraio 2011 - Angelo Angeletti Le costellazioni sono dei gruppi di stelle che, proiettate in una stessa zona della volta celeste, danno luogo a delle figure alle quali quasi tutti i popoli
PLS CAMERINO 16 febbraio 2011 - Angelo Angeletti Le costellazioni sono dei gruppi di stelle che, proiettate in una stessa zona della volta celeste, danno luogo a delle figure alle quali quasi tutti i popoli
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017. Scuola di Astronomia. Contenuti dei corsi e dei seminari.
 Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
Astronomia Osservazione del cielo
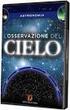 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015
 FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016
 FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016 Il 1 luglio, intorno alle 02:00 T.U., in direzione dell orizzonte Est troviamo la Luna (mag. -10.75, fase 15%, calante) in Taurus, prossima all ammasso aperto delle Pleiadi
FENOMENI ASTRONOMICI LUGLIO 2016 Il 1 luglio, intorno alle 02:00 T.U., in direzione dell orizzonte Est troviamo la Luna (mag. -10.75, fase 15%, calante) in Taurus, prossima all ammasso aperto delle Pleiadi
Le costellazioni sono un'illusione prospettica lista di 48, definite da Tolomeo nel 137 d.c. lista attuale di 88, definite dalla IAU nel 1930
 1 Il cielo ad occhio nudo: 2000 stelle visibili in una notte limpida, senza Luna, dalla montagna solo 50-200 stelle visibili dalla città in una notte limpida Relatore: Lorenzo Comolli Le costellazioni
1 Il cielo ad occhio nudo: 2000 stelle visibili in una notte limpida, senza Luna, dalla montagna solo 50-200 stelle visibili dalla città in una notte limpida Relatore: Lorenzo Comolli Le costellazioni
Corso di astronomia pratica
 Corso di astronomia pratica Centro di Divulgazione Scientifica Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto
Corso di astronomia pratica Centro di Divulgazione Scientifica Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto
VENERDI 15 GENNAIO Alla scoperta del Grande Cacciatore Orione. DOMENICA 7 FEBBRAIO Osservazione solare. VENERDI 19 FEBBRAIO Il ruggito del Leone
 2016 VENERDI 15 GENNAIO Alla scoperta del Grande Cacciatore Orione Iniziamo l anno nuovo andando a scoprire il Grande Cacciatore, ossia la costellazione di Orione con tutte le sue meravigliose nebulose,
2016 VENERDI 15 GENNAIO Alla scoperta del Grande Cacciatore Orione Iniziamo l anno nuovo andando a scoprire il Grande Cacciatore, ossia la costellazione di Orione con tutte le sue meravigliose nebulose,
L illuminazione della Terra
 L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
La Luna e le sue fasi
 La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
Riuscire a leggere il cielo notturno
 Stella Polare - Il cielo del trimestre Il cielo autunnale: gennaio, febbraio e marzo 2011 di Vittorio Napoli (astronomiavisuale@infinito.it) Stella Polare Riuscire a leggere il cielo notturno vuol dire
Stella Polare - Il cielo del trimestre Il cielo autunnale: gennaio, febbraio e marzo 2011 di Vittorio Napoli (astronomiavisuale@infinito.it) Stella Polare Riuscire a leggere il cielo notturno vuol dire
IL SISTEMA TERRA- LUNA
 L UNIVERSO o COSMO È l insieme di tutti i corpi celesti (galassie,stelle,pianeti,satelliti ecc.) e dello spazio che li contiene. Si è formato circa 13.7 miliardi di anni fa, per cause sconosciute,in seguito
L UNIVERSO o COSMO È l insieme di tutti i corpi celesti (galassie,stelle,pianeti,satelliti ecc.) e dello spazio che li contiene. Si è formato circa 13.7 miliardi di anni fa, per cause sconosciute,in seguito
4 CORSO DI ASTRONOMIA
 4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
4 CORSO DI ASTRONOMIA Ammassi di stelle, Nebulose e Galassie 16 gennaio 2016 spiegazioni di Giuseppe Conzo Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Oratorio Salvo D Acquisto SOMMARIO Dalle stelle agli ammassi
Piramidi e allineamento celeste. di MARIA PACE
 di MARIA PACE Innanzitutto una premessa: l orientamento degli edifici sacri era ritenuto di grande importanza nell antichità e, dunque, anche quello delle Piramidi, per gli Egizi. Quando, però, si discute
di MARIA PACE Innanzitutto una premessa: l orientamento degli edifici sacri era ritenuto di grande importanza nell antichità e, dunque, anche quello delle Piramidi, per gli Egizi. Quando, però, si discute
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania. Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior. Problemi con soluzioni
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
AUTUNNO. Programma di osservazione
 AUTUNNO Programma di osservazione 1 Il programma osservativo dell Autunno Tipo Nome Cost A.R. Dec Mag Sep Diam ** Gamma Ari 01h 54m +19 20 3.9-3.9 7.7 ** Gamma And 02h 04m +42 22 2.1-4.8 9.8 ** Zeta Psc
AUTUNNO Programma di osservazione 1 Il programma osservativo dell Autunno Tipo Nome Cost A.R. Dec Mag Sep Diam ** Gamma Ari 01h 54m +19 20 3.9-3.9 7.7 ** Gamma And 02h 04m +42 22 2.1-4.8 9.8 ** Zeta Psc
Fenomeni astronomici del Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti
 Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO. Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011.
 Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Aldebaran α Tauri Mirfak α Persei. Altair α Aquilae Mizar α Ursae Majoris. Antares α Scorpii Polluce β Geminorum
 G CARTE CELESTI Quando si deve fare un viaggio in una regione sconosciuta, è indispensabile portarsi dietro una carta geografica, dove si possono riconoscere i fiumi, i monti, le strade. Anche chi guarda
G CARTE CELESTI Quando si deve fare un viaggio in una regione sconosciuta, è indispensabile portarsi dietro una carta geografica, dove si possono riconoscere i fiumi, i monti, le strade. Anche chi guarda
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO
 Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO
 LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO G. Iafrate, M. Ramella INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste Informazioni e contatti: http://vo-for-education.oats.inaf.it - iafrate@oats.inaf.it 1. Introduzione Sentiamo
LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO G. Iafrate, M. Ramella INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste Informazioni e contatti: http://vo-for-education.oats.inaf.it - iafrate@oats.inaf.it 1. Introduzione Sentiamo
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
relat ore Iras GAD Iras/
 data ora argomento 1/8/2013 ago-13 Le stelle del Palio (astronomia in citta', in Molo Italia / Passeggiata 21,00 Morin - osservazione pubblica del cielo con i telescopi dell') relat ore org luogo Molo
data ora argomento 1/8/2013 ago-13 Le stelle del Palio (astronomia in citta', in Molo Italia / Passeggiata 21,00 Morin - osservazione pubblica del cielo con i telescopi dell') relat ore org luogo Molo
10 7 metri Il nostro pianeta, la Terra, vista da una distanza di chilometri dalla sua superficie.
 10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
10 2 metri Qui parte il sentiero che vi porterà dal centro di Bologna, fino ai confini più estremi dell Universo visibile. Il nostro punto di partenza è a 100 metri di altezza su Piazza Maggiore. 10 3
Moti della Terra. Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari
 Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
L Astrolabio. di Alberto Nicelli. GAE Gruppo Astrofili Eporediesi
 L Astrolabio di Alberto Nicelli GAE Gruppo Astrofili Eporediesi L Astrolabio (vedi kit allegato) è così costituito: Il Piatto, che riproduce in proiezione stereografica: o l Orizzonte Locale, relativo
L Astrolabio di Alberto Nicelli GAE Gruppo Astrofili Eporediesi L Astrolabio (vedi kit allegato) è così costituito: Il Piatto, che riproduce in proiezione stereografica: o l Orizzonte Locale, relativo
Anno Accademico 2007/2008. Astronomia. Corso di Laurea in Scienze Naturali. Alessandro Marconi
 Anno Accademico 2007/2008 Astronomia Corso di Laurea in Scienze Naturali Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Università di Firenze Bibliografia Il testo su cui sono basate
Anno Accademico 2007/2008 Astronomia Corso di Laurea in Scienze Naturali Alessandro Marconi Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio, Università di Firenze Bibliografia Il testo su cui sono basate
Astronomia Lezione 23/1/2012
 Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Astronomia Lezione 23/1/2012 Docente: Alessandro Melchiorri e.mail:alessandro.melchiorri@roma1.infn.it Slides: oberon.roma1.infn.it/alessandro/ Libri di testo: - An introduction to modern astrophysics
Le Galassie I mattoni dell Universo
 Le Galassie I mattoni dell Universo Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Da Terra vediamo solo una grande fascia di stelle, gas e polveri Questa ad esempio è la zona della costellazione
Le Galassie I mattoni dell Universo Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Da Terra vediamo solo una grande fascia di stelle, gas e polveri Questa ad esempio è la zona della costellazione
Alla ricerca di un altra Terra!
 Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
Alla ricerca di un altra Terra! pianeti extra-solari ed altro Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Kepler 186f Sono notizie ormai quasi comuni quelle relative alla scoperta di un pianeta
Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle.
 1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
1 Salve a tutti, comincia oggi la nostra avventura alla scoperta del cielo. Ci avviamo alla scoperta delle stelle. Si, proprio le stelle che si vedono ogni volta che fa buio, se è sereno, come puntolini
L ORIGINE DELLA LUNA
 LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
Dati caratteristici. La Luna ed i suoi movimenti
 La Luna ed i suoi movimenti Dati caratteristici Raggio medio: 1738 km Volume: 22 109 km 3 Massa: 7,35 1022 kg Densità: 3,34 g/cm 3 Dato che ha una massa che è circa 1/81 di quella della Terra, la sua gravità
La Luna ed i suoi movimenti Dati caratteristici Raggio medio: 1738 km Volume: 22 109 km 3 Massa: 7,35 1022 kg Densità: 3,34 g/cm 3 Dato che ha una massa che è circa 1/81 di quella della Terra, la sua gravità
Toro sta bene con Pesci?
 Toro sta bene con Pesci? ovvero i rapporti fra l astrologia e la scienza Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Passioni astrologiche Il discutere serenamente di astrologia sembra a volte
Toro sta bene con Pesci? ovvero i rapporti fra l astrologia e la scienza Stefano Covino INAF / Osservatorio Astronomico di Brera Passioni astrologiche Il discutere serenamente di astrologia sembra a volte
Scientifico Tecnologico
 Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
PLS. Per insegnanti delle scuole secondarie. Camerino febbraio maggio 2011
 PLS Per insegnanti delle scuole secondarie Camerino febbraio maggio 2011 Obiettivo L obiettivo primario del progetto è quello di coinvolgere insegnanti delle scuole secondarie di scienze e di fisica per
PLS Per insegnanti delle scuole secondarie Camerino febbraio maggio 2011 Obiettivo L obiettivo primario del progetto è quello di coinvolgere insegnanti delle scuole secondarie di scienze e di fisica per
Universo invisibile: a caccia di Raggi X
 Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
Universo invisibile: a caccia di Raggi X Anna Wolter INAF Osservatorio Astronomico di Brera Ringrazio Fabio Pizzolato per alcune immagini Astronomia X e l ITALIA Bruno Rossi con Marjorie Townsend e UHURU
Topografia e orientamento
 CAI - ALPINISMO GIOVANILE Secondo Corso Di Avvicinamento Alla Montagna 2012 Topografia e orientamento C A I B o r g o m a n e r o A l p i n i s m o G i o v a n i l e 2 0 1 2 Pagina 1 Introduzione Per un
CAI - ALPINISMO GIOVANILE Secondo Corso Di Avvicinamento Alla Montagna 2012 Topografia e orientamento C A I B o r g o m a n e r o A l p i n i s m o G i o v a n i l e 2 0 1 2 Pagina 1 Introduzione Per un
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari
 Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
LA LUNA. INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste Istituto Comprensivo S. Giovanni Sc. Sec. di primo grado M. Codermatz" - Trieste
 LA LUNA (b) G. Iafrate (a), M. Ramella (a) e V. Bologna (b) (a) INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste Istituto Comprensivo S. Giovanni Sc. Sec. di primo grado M. Codermatz" - Trieste Informazioni
LA LUNA (b) G. Iafrate (a), M. Ramella (a) e V. Bologna (b) (a) INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste Istituto Comprensivo S. Giovanni Sc. Sec. di primo grado M. Codermatz" - Trieste Informazioni
CONCETTO. DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo
 DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo CONCETTO Il Deep Sky ReiseAtllas è l'equivalente cartografico della guida del profondo cielo e integra dati, mappe dettagliate, descrizioni, foto e
DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo CONCETTO Il Deep Sky ReiseAtllas è l'equivalente cartografico della guida del profondo cielo e integra dati, mappe dettagliate, descrizioni, foto e
Impariamo ad orientarci
 Impariamo ad orientarci A cura di Paola Gagliardi Docente dell ITC A. Serra Quaderno dei senti Corso di Orientamento e sentstica Quaderno dei sent Quaderno dei senti La carta topografica è un disegno che
Impariamo ad orientarci A cura di Paola Gagliardi Docente dell ITC A. Serra Quaderno dei senti Corso di Orientamento e sentstica Quaderno dei sent Quaderno dei senti La carta topografica è un disegno che
Olimpiadi Italiane di Astronomia 2011 Finale Nazionale. Prova Teorica - Categoria Junior
 Olimpiadi Italiane di Astronomia 2011 Finale Nazionale Reggio Calabria 17 Aprile 2011 Prova Teorica - Categoria Junior Problema 1. La Luna piena, nelle migliori condizioni osservative, ha una magnitudine
Olimpiadi Italiane di Astronomia 2011 Finale Nazionale Reggio Calabria 17 Aprile 2011 Prova Teorica - Categoria Junior Problema 1. La Luna piena, nelle migliori condizioni osservative, ha una magnitudine
La misura delle distanze stellari
 La misura delle distanze stellari Gisella Clementini INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna Eratostene di Cirene, 240 a.c. - raggio Terrestre Ipparco di Nicea, 150 a.c. - distanza Terra-Luna Giovanni
La misura delle distanze stellari Gisella Clementini INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna Eratostene di Cirene, 240 a.c. - raggio Terrestre Ipparco di Nicea, 150 a.c. - distanza Terra-Luna Giovanni
Costellazioni. Obiettivi
 Costellazioni Obiettivi Riflettere su esperienze e vissuti personali ed esprimerli nel gruppo classe. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. Rinforzare e verificare le conoscenze
Costellazioni Obiettivi Riflettere su esperienze e vissuti personali ed esprimerli nel gruppo classe. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. Rinforzare e verificare le conoscenze
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione
 Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione Lo scorpione a me sembra la più ricca e bella costellazione del cielo, ma è oggettivamente molto difficile da osservare
Spunti per la fotografia e l osservazione di oggetti Sharpless Parte I - lo scorpione Lo scorpione a me sembra la più ricca e bella costellazione del cielo, ma è oggettivamente molto difficile da osservare
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA CLASSE 1^ H. a. s Prof.ssa RUBINO ALESSANDRA
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane.
 Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Cartes du Ciel / Sky Charts Comandi del Menu
 Cartes du Ciel / Sky Charts Comandi del Menu Tutti i comandi sono accessibili sia attraverso il menu, sia con i pulsanti video. È possibile cambiare la posizione di ciascun gruppo di pulsanti e di scegliere
Cartes du Ciel / Sky Charts Comandi del Menu Tutti i comandi sono accessibili sia attraverso il menu, sia con i pulsanti video. È possibile cambiare la posizione di ciascun gruppo di pulsanti e di scegliere
NOTTE DI STELLE. MarghErITa hack. le costellazioni fra scienza e mito: le più belle storie scritte nel cielo
 NOTTE DI STELLE le costellazioni fra scienza e mito: le più belle storie scritte nel cielo contiene il maxi poster con la mappa del cielo MarghErITa hack viviano DOMENIcI La notte stellata non è solo uno
NOTTE DI STELLE le costellazioni fra scienza e mito: le più belle storie scritte nel cielo contiene il maxi poster con la mappa del cielo MarghErITa hack viviano DOMENIcI La notte stellata non è solo uno
Ciao! Ma puoi sapere qualcos altro dalla luce?
 Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
Gli indizi a favore di questa ipotesi erano molteplici:
 La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
La forma della Terra Nell antichità la forma della Terra è stata oggetto di numerose ipotesi. Nonostante la limitatezza degli strumenti di osservazione di allora, già gli antichi svilupparono l idea che
LA TERRA. La Terra studiata come copro celeste, risulta essere un PIANETA un copro celeste di forma sferica che ruota attorno ad una stella il SOLE
 IL PIANETA TERRA LA TERRA La Terra studiata come copro celeste, risulta essere un PIANETA un copro celeste di forma sferica che ruota attorno ad una stella il SOLE FORMA E DIMENSIONI DELLA TERRA Agli
IL PIANETA TERRA LA TERRA La Terra studiata come copro celeste, risulta essere un PIANETA un copro celeste di forma sferica che ruota attorno ad una stella il SOLE FORMA E DIMENSIONI DELLA TERRA Agli
1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6.
 1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6. Le eclissi 7. Le maree Il pianeta blu Ecco come appare
1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6. Le eclissi 7. Le maree Il pianeta blu Ecco come appare
SEMINARIO DI REGGIO EMILIA GUASTALLA LE STELLE NELLA SACRA SCRITTURA
 SEMINARIO DI REGGIO EMILIA GUASTALLA LE STELLE NELLA SACRA SCRITTURA 13 dicembre 2012 «Poi lo condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle (M ¹ƒḰŸJ! ), se riesci a contarle"; e soggiunse:
SEMINARIO DI REGGIO EMILIA GUASTALLA LE STELLE NELLA SACRA SCRITTURA 13 dicembre 2012 «Poi lo condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle (M ¹ƒḰŸJ! ), se riesci a contarle"; e soggiunse:
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Senior 1. Fra un mese Se questa sera una stella sorge verso le ore 22, a che ora sorgerà, approssimativamente, tra un mese?
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2013 FINALE NAZIONALE Prova Teorica - Categoria Senior 1. Fra un mese Se questa sera una stella sorge verso le ore 22, a che ora sorgerà, approssimativamente, tra un mese?
Opere di Domenico Bresolin
 Opere di Domenico Bresolin Fig. I: Autoritratto, 1840 ca., olio su tela, cm 64x48, collezione Soliman, Pesaro. Fig. II: Nudo di fanciulla, forse 1840-43, matita e acquerello su carta, collezione Soliman,
Opere di Domenico Bresolin Fig. I: Autoritratto, 1840 ca., olio su tela, cm 64x48, collezione Soliman, Pesaro. Fig. II: Nudo di fanciulla, forse 1840-43, matita e acquerello su carta, collezione Soliman,
Di cosa parliamo stasera
 1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo. Seconda lezione. Antonio Maggio. INAF Osservatorio Astronomico di Palermo
 Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo Seconda lezione Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Argomenti e concetti già introdotti Astrometria: posizione
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo Seconda lezione Antonio Maggio INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Argomenti e concetti già introdotti Astrometria: posizione
Le nebulose. Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma.
 Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
Le nebulose Le nebulose sono agglomerati di idrogeno, polveri e plasma. Esistono vari tipi di nebulosa: nebulosa oscura all interno della quale avvengono i fenomeni di nascita e formazione di stelle; nebulosa
IL DIRIGENTE DELLA P. L. RICHIAMATA
 Ordinanza n. 172/15 Comune di Ardea Città metropolitana di Roma Capitale POLIZIA LOCALE Servizio Viabilità U.O. AA.GG./Segreteria Comando Via del Tempio 29 00040 Ardea (Roma) Tel. +39 06.913800500 Fax
Ordinanza n. 172/15 Comune di Ardea Città metropolitana di Roma Capitale POLIZIA LOCALE Servizio Viabilità U.O. AA.GG./Segreteria Comando Via del Tempio 29 00040 Ardea (Roma) Tel. +39 06.913800500 Fax
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni hanno comunque un indubbio valore storico/culturale, oltre a permettere un facile orientamento nel cielo
 LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
Progetto di Astronomia all interno del piano ISS. Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12
 Istituto Comprensivo Moncalieri - Moriondo Progetto di Astronomia all interno del piano ISS Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12 Referente: Ins. Rosella Villata CLASSI COINVOLTE : TERZA
Istituto Comprensivo Moncalieri - Moriondo Progetto di Astronomia all interno del piano ISS Scuola Primaria G. Marconi Anno scolastico 2011/ 12 Referente: Ins. Rosella Villata CLASSI COINVOLTE : TERZA
CIELO DI LUGLIO 2012
 CIELO DI LUGLIO 2012 I L CIELO DEL ME SE DI LUGL I O 2012 Guida al cielo di Luglio. Come riconoscere le costellazioni in cielo. La visibilità dei pianeti nel mese di Luglio. Gli sciami meteorici del mese.
CIELO DI LUGLIO 2012 I L CIELO DEL ME SE DI LUGL I O 2012 Guida al cielo di Luglio. Come riconoscere le costellazioni in cielo. La visibilità dei pianeti nel mese di Luglio. Gli sciami meteorici del mese.
Come si riconoscono gli astri: il form Planetario
 OsservazioniCelesti:OSSERVAZ.ION 22-12-2009 9:10 Pagina 23 Come si riconoscono gli astri: il form Planetario Abbiamo installato il programma sul nostro computer, lo abbiamo fatto partire cliccando sul
OsservazioniCelesti:OSSERVAZ.ION 22-12-2009 9:10 Pagina 23 Come si riconoscono gli astri: il form Planetario Abbiamo installato il programma sul nostro computer, lo abbiamo fatto partire cliccando sul
Una notte sotto le stelle
 Una notte sotto le stelle Impariamo a guardare il cielo Non occorre essere degli esperti per rimanere colpiti dalla bellezza delle stelle, e saper riconoscere stelle e pianeti dà una soddisfazione in più!
Una notte sotto le stelle Impariamo a guardare il cielo Non occorre essere degli esperti per rimanere colpiti dalla bellezza delle stelle, e saper riconoscere stelle e pianeti dà una soddisfazione in più!
Astronomia e Scienze della Terra
 Astronomia e Scienze della Terra Didattica per le scuole - Anno Scolastico 2016-2017 Relatore: Nino Ragusi in collaborazione con Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo Premessa Le proposte di incontri sotto
Astronomia e Scienze della Terra Didattica per le scuole - Anno Scolastico 2016-2017 Relatore: Nino Ragusi in collaborazione con Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo Premessa Le proposte di incontri sotto
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi.
 Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
Ciao! Oggi apriamo l Osservatorio per scoprire la nostra Galassia e l Universo per come possiamo conoscerli oggi. Se stasera è sereno, alza il naso al cielo e guarda le stelle. Tutte quelle che vedi fanno
CON IL NASO ALL INSÙ
 Direzione Didattica 2 circolo Sassuolo (Mo) Scuola dell infanzia Walt Disney Sez.5 anni CON IL NASO ALL INSÙ A.s. 2010/11 Ins. Giacobbe Francesca Cassandra Marilena Premessa Il cielo fa parte dell immaginario
Direzione Didattica 2 circolo Sassuolo (Mo) Scuola dell infanzia Walt Disney Sez.5 anni CON IL NASO ALL INSÙ A.s. 2010/11 Ins. Giacobbe Francesca Cassandra Marilena Premessa Il cielo fa parte dell immaginario
Anno scolastico Programma svolto. Testo: Scopriamo la Chimica di F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa Ed.
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
IL MOTO di ROTAZIONE. CONSEGUENZE del MOTO di ROTAZIONE
 IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
MOTO DI ROTAZIONE da ovest verso est asse terrestre
 I moti della Terra La Terra compie numerosi movimenti poiché gira: intorno a se stessa a 0,4 Km/s; attorno al Sole a 30 Km/s; insieme a tutto il sistema solare a 220 Km/s quindi è come se si muovesse
I moti della Terra La Terra compie numerosi movimenti poiché gira: intorno a se stessa a 0,4 Km/s; attorno al Sole a 30 Km/s; insieme a tutto il sistema solare a 220 Km/s quindi è come se si muovesse
MASTER IN DIRITTO PENALE DELL IMPRESA - MIDPI
 MASTER IN DIRITTO PENALE DELL IMPRESA - MIDPI PROGRAMMA DIDATTICO IV EDIZIONE ANNO ACCADEMICO 2015/2016 10 dicembre 2015 CONVEGNO INAUGURALE 15/16 gennaio 2016 I. Crimini organizzati dei colletti bianchi
MASTER IN DIRITTO PENALE DELL IMPRESA - MIDPI PROGRAMMA DIDATTICO IV EDIZIONE ANNO ACCADEMICO 2015/2016 10 dicembre 2015 CONVEGNO INAUGURALE 15/16 gennaio 2016 I. Crimini organizzati dei colletti bianchi
LUNA - Eclissi Totale
 DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
1. La luce delle stelle
 1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
IL PIANETA URANO. Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL.
 IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
Osservatorio di Bassano Bresciano Manuale TCS2009
 Pag.1/10 1 TCS2009 revisione 2.1... 2 1.1 Attività generali... 2 1.2 La console... 3 1.3 La pagina principale... 4 1.4 Pagina di puntamento... 5 1.5 Pagina di allineamento... 6 1.6 Pagina di monitor motori...
Pag.1/10 1 TCS2009 revisione 2.1... 2 1.1 Attività generali... 2 1.2 La console... 3 1.3 La pagina principale... 4 1.4 Pagina di puntamento... 5 1.5 Pagina di allineamento... 6 1.6 Pagina di monitor motori...
*COMUNICATO STAMPA* Almanacco astronomico del mese di giugno
 *COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
*COMUNICATO STAMPA* Venerdì 27/5 - ore 21.30 - - - Almanacco astronomico del mese di giugno seguirà Osservazione notturna al telescopio Sabato 28/5 - ore 21.30 - - - La ricerca di una nuova terra. Gli
