Capitolo 5. Carta dei suoli della Regione Veneto. Suoli delle litologie molto competenti: dolomia e Calcari Grigi. Formazione dei suoli
|
|
|
- Bonifacio Leoni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 i suoli
2 Formazione dei suoli I diversi fattori ambientali che, secondo l equazione di Jenny, trasformano il materiale di partenza e portano alla formazione del suolo, determinandone le caratteristiche e l organizzazione in orizzonti, possono essere ricondotti a clima, organismi viventi, rilievo, roccia madre e tempo (Jenny, 1941). La distribuzione dei suoli nel paesaggio regionale, quindi, è strettamente legata all eterogeneità degli ambienti e alle diverse combinazioni di fattori che in essi si verificano. Fig..1: L inizio della pedogenesi su rocce calcaree. Nelle situazioni dove la pedogenesi non ha avuto il tempo o le condizioni di stabilità necessarie per seguire il suo corso (fig..1), i suoli sviluppano un profilo poco differenziato con un orizzonte organo-minerale (A o O) che poggia direttamente sul substrato inalterato (C o R). Sono diffusi prevalentemente in aree a sedimentazione fluviale recente (Fluvisols), su pendii montani soggetti ad erosione (attuale o passata) e ad eccessivo pascolamento (Regosols, Leptosols) o in condizioni climatiche estreme, tipiche degli ambienti di alta montagna (fig..2a) caratterizzati da diffusa roccia affiorante (Lithosols). Talvolta i suoli possono presentare accumulo di sostanza organica in superficie (Chernozems, Phaeozems, Mollic Regosols) a causa di condizioni particolari che ne inibiscono o rallentano la mineralizzazione, come l eccessivo tenore in carbonati, il clima rigido o condizioni di idromorfia dovute alla presenza di falda superficiale. In alcune aree umide con falda subaffiorante, l accumulo di sostanza organica e la sua degradazione in condizioni di totale anossia, portano alla formazione di suoli organici in cui la componente minerale è molto scarsa (Histosols). Si tratta di situazioni nel complesso poco diffuse ma ecologicamente importanti in quanto molto vulnerabili e legate a biotopi con caratteri di biodiversità eccezionali. Il processo di gran lunga predominante nei suoli della Regione è quello della brunificazione, ossia della formazione di un orizzonte di alterazione (orizzonte cambico Bw) al di sotto dell orizzonte organo-minerale, sensibilmente differenziato dal materiale di origine (fig..2b). I suoli che rispondono a queste caratteristiche (Cambisols) sono relativamente evoluti e presentano moderata differenziazione del profilo (A-Bw-C). In particolari condizioni idrologiche e climatiche, su substrati calcarei, alla formazione dell orizzonte di alterazione segue un processo di dilavamento dei carbonati lungo il profilo e di loro successiva precipitazione in profondità sottoforma di concrezioni di carbonato di calcio (orizzonte Bk o Ck). Ci sono poi processi che richiedono tempi molto lunghi o condizioni particolari per manifestarsi (lisciviazione delle argille e podzolizzazione) e sono quindi limitati a suoli sviluppatisi su superfici indisturbate e particolarmente stabili dal punto di vista geomorfologico. La lisciviazione si innesca solo dopo il totale dilavamento dei carbonati lungo il profilo e consiste nel movimento verticale delle argille da un orizzonte eluviale (E) ad uno di accumulo illuviale (orizzonte argico Bt) tipici di suoli evoluti (Luvisols) con spiccata differenziazione del profilo (A-E- Bt-C), che si formano sulle superfici più antiche della pianura o su quelle poco pendenti e stabili della zona collinare e prealpina (fig..2c). In queste situazioni, infatti, le condizioni climatiche non estreme, le abbondanti precipitazioni, la diffusione di litotipi particolarmente alterabili (calcari marnosi) e l assenza dell azione erosiva del glacialismo, hanno fatto sì che i processi pedogenetici non fossero ostacolati nel tempo. La podzolizzazione, infine, è un processo meno diffuso nella Regione in quanto legato a combinazioni di fattori molto specifiche (substrati acidi, clima rigido e umido, vegetazione forestale, tessitura grossolana). Si manifesta quindi solo nei suoli di alta montagna e dà luogo a suoli evoluti (Podzols) con profilo molto differenziato (A-E-Bs-Bhs-C) in cui si distinguono chiaramente orizzonti di impoverimento (E) e orizzonti di accumulo di sesquiossidi di ferro ed alluminio (Bs) e di sostanza organica (Bhs), mobilizzati nel suolo a causa delle condizioni di forte acidità (fig..2d). Da un punto di vista applicativo, le caratteristiche interne dei suoli che ne influenzano l uso, sono principalmente il drenaggio, la presenza di scheletro, la tessitura, la profondità utile all approfondimento radicale e secondariamente la reazione e il tasso di saturazione. Nelle zone di montagna il drenaggio dei suoli risulta generalmente buono, mentre sono molto diffuse forti limitazioni all approfondimento radicale dovute alla presenza della roccia e all abbondanza dello scheletro; anche in questi ambienti, tuttavia, si formano suoli moderatamente profondi e a tessitura a b c d Fig..2: a: Leptosol di alta montagna con accumulo di sostanza organica in superficie; b: sui dossi della bassa pianura è comune trovare Cambisols a tessitura sabbiosa e drenaggio buono; c: Luvisol tipico dei versanti prealpini su calcari marnosi; d: i Podzols in Veneto sono presenti solo ad alta quota e su substrati silicatici. più fine, sui litotipi più facilmente alterabili e su superfici poco pendenti (stabili). Nell alta pianura ghiaiosa i suoli sono ben drenati ma solo moderatamente profondi a causa dell elevato contenuto in ghiaia. Nella bassa pianura sono generalmente profondi ma possono presentare lievi problemi di idromorfia che diventano più gravi nelle aree depresse. Pesanti limitazioni alla profondità utile alle radici, legate alla falda superficiale, si incontrano invece nelle aree di risorgiva o in quelle situate al di sotto del livello del mare, dove comunque le opere di regimazione idraulica e l emungimento meccanico hanno forzato l abbassamento della falda per consentire la messa a coltura delle superfici. Suoli e paesaggi È possibile suddividere il territorio regionale in due grandi aree relativamente ai processi di formazione e modellamento delle superfici: un area montano-collinare, posta nel settore più settentrionale, dove prevalgono i processi di erosione e modellamento ed un area di pianura nel settore meridionale, originatasi in seguito al trasporto e alla deposizione di materiali sciolti ad opera dei principali corsi d acqua. Per fornire un inquadramento dei suoli del territorio regionale si procede di seguito ad una breve descrizione dei caratteri salienti, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo il sistema di riferimento World Reference Base (FAO, 1998). Per una più agevole lettura, la descrizione dei suoli si riferisce a tre ambiti pedo-geografici: rilievi alpini, rilievi prealpini e pianura. SUOLI DEI RILIEVI ALPINI Il settore alpino del Veneto presenta una notevole variabilità geologica, passando dalle rocce metamorfiche del basamento cristallino (Comelico e Agordino) alla Dolomia Principale dei gruppi montuosi più importanti della Regione (Sella, Pordoi, Cime di Lavaredo, Pelmo, ecc.) attraverso le litologie della successione stratigrafica calcarea e terrigena dolomitica. La stretta associazione di rocce calcareo-dolomitiche molto competenti, con rocce vulcaniche e terrigene, meno competenti e quindi più erodibili, è un carattere che rende unico l ambiente dolomitico ed è la ragione principale della particolarità di questo paesaggio. Alle diverse litologie corrispondono forme molto differenziate: aspre e ad alta energia del rilievo dove prevale la dolomia, arrotondate e meno pendenti in corrispondenza di rocce vulcaniche e terrigene. Un fenomeno che ha fortemente influenzato la storia geomorfologica e pedologica dell area alpina è quello delle glaciazioni che hanno dato origine a diffusi depositi di spessore molto variabile, a volte successivamente rimobilizzati da altri agenti, ricchi in matrice fine e molto eterogenei sia nella granulometria che nella litologia. Dal punto di vista pedologico, questi depositi, la cui natura non sempre coincide con quella della formazione geologica che ricoprono, sono il materiale da cui il suolo si forma (materiale parentale) e la loro natura è un fattore fondamentale nell indirizzare l evoluzione pedologica. Suoli delle litologie molto competenti: dolomia e Calcari Grigi La dolomia e i Calcari Grigi, rocce resistenti e compatte, quando soggetti a forme di erosione, determinano alle massime 76 77
3 quote vette scoscese, cime scolpite in forma di torri, guglie e creste, prevalentemente prive di suolo. Dove la pendenza diminuisce, ma sempre su versanti acclivi e instabili, si formano suoli sottili, con elevato contenuto in scheletro, a bassa differenziazione del profilo (Humi-Rendzic Leptosols). Tali suoli, dominanti nella fascia alpina sopra al limite naturale della vegetazione arborea ( m), presentano un alto tenore in sostanza organica a causa del clima rigido che ne inibisce la mineralizzazione. Scendendo di quota, dove la pedogenesi è favorita dalla maggior stabilità dei versanti e dal clima meno rigido, sotto vegetazione arborea si trovano perlopiù suoli moderatamente evoluti, più profondi, con orizzonte cambico (Episkeleti-Calcaric Cambisols). Sulle falde di detrito al piede delle pareti rocciose, costituite da frammenti grossolani e colonizzate da vegetazione pioniera, si trovano suoli poco evoluti ma profondi, con accumulo di sostanza organica in profondità (fig..3), favorito dall efficiente drenaggio interno di questi suoli molto poveri in matrice fine (Hyperhumi-Rendzic Leptosols). Suoli delle litologie moderatamente competenti (rocce del basamento cristallino e rocce calcareo-marnose e pelitico-arenitiche della serie stratigrafica dolomitica) Fig..3: È evidente l accumulo di sostanza organica in profondità tipico dei suoli sulle falde di detrito (unità tipologica di suolo CFR1). Le rocce silicatiche presenti nel Veneto (Formazioni sedimentarie vulcaniche basiche di La Valle, Fernazza e Conglomerato della Marmolada, Monzoniti e Andesiti, porfidi e Arenarie della Valgardena) sono facilmente alterabili e danno luogo a dolci pendii colonizzati da vegetazione arborea o utilizzati a pascolo. Dove le condizioni del clima e della vegetazione lo permettono, ossia oltre ai 2000 metri di quota, si verificano marcati processi di podzolizzazione. In queste condizioni si originano suoli a profilo molto differenziato, con accumulo di sostanza organica e di sesquiossidi in profondità (orizzonte Bhs) anche se non profondi a causa dell elevato contenuto in scheletro (Episkeletic Podzols, Skeleti-Entic Podzols). Scendendo di quota, il pedoclima meno freddo e la più intensa evapotraspirazione rendono meno spiccati i processi di traslocazione (fig..4); ne risulta un accumulo di sesquiossidi di ferro e alluminio (orizzonte Bs), ma non di composti organici (Dystric Cambisols, Dystri-Episkeletic Cambisols). I suoli originatisi da Arenarie della Valgardena, analoghi ai precedenti per quanto riguarda la genesi, si caratterizzano per il tipico colore rossastro proprio del materiale parentale (Chromi-Skeletic Cambisols (Dystric)). Le facies più fini (con prevalenza di argille e limi) delle Arenarie della Val Gardena e delle siltiti della Formazione di La Valle, danno origine a suoli in cui non si innesca il processo di podzolizzazione, ma un processo di traslocazione in profondità della frazione argillosa (Cutani-Chromic Luvisols, Dystri-Cutanic Luvisols). Tipicamente lungo i fianchi delle maggiori vallate alla base dei grandi gruppi dolomitici, affiora la Formazione di Werfen, costituita principalmente da argille e calcari ben stratificati dai colori vivaci (Bosellini, 1996). Tali litotipi, erodibili e spesso fortemente rimaneggiati dal glacialismo, favoriscono nella maggior parte dei casi la formazione di suoli ben differenziati e profondi anche su versanti molto ripidi, con orizzonte ad accumulo di argilla di notevole spessore e ben strutturato (Cutanic Luvisols). Le Vette Feltrine rappresentano una zona particolare dell ambiente alpino. La loro posizione geografica esterna alle Alpi (distretto esalpico) le rende climaticamente peculiari e la presenza, oltre alla Dolomia, di formazioni calcareo-marnose del Cretaceo (Biancone, Scaglia Rossa) dà luogo a forme molto arrotondate su cui prevalgono suoli evoluti (Cutani-Albic Luvisols) ma spesso erosi dal pascolo o dall uso antropico (Episkeleti-Cutanic Luvisols). Le cosiddette Buse, infine, sono interessate da intensi fenomeni di carsismo e qui sono frequenti suoli profondi, con profilo decarbonatato, relativa desaturazione del complesso di scambio e illuviazione di argilla in profondità (Dystri-Cutanic Luvisols). Fig..4: L orizzonte Bs, dato dall accumulo di sesquiossidi di ferro e alluminio, è riconoscibile dal tipico colore ocra. Suoli delle litologie poco competenti Sostanziali peculiarità geologico-pedologiche presentano alcune zone la cui morfologia dolcemente ondulata è dovuta alla presenza diffusa della Formazione ladinico-carnica di S. Cassiano. Essa è costituita da strati calcarei giallastri, arenarie fini e marne (Regione Veneto, 1990), facilmente erodibili e spesso causa di evidenti movimenti di massa e colate che interessano la coltre superficiale. Casi esemplari di questi fenomeni sono rappresentati dalla Conca di Cortina d Ampezzo, dal Passo Pordoi, dal Passo Tre Croci e dalla piana di Misurina. I suoli che si originano da questi materiali sono generalmente ricchi di argilla e relativamente profondi ma solo moderatamente differenziati nel profilo, a causa del drenaggio difficoltoso (fig..) e del conseguente ristagno d acqua (Eutric Gleysols). Anche le marne e le argille della Formazione di Raibl tendono a ricoprire i substrati circostanti, espandendosi sotto forma di colate più o meno spesse, come è evidente nei pressi delle Cinque Torri (Cortina d Ampezzo). I suoli a cui questi materiali danno origine sono sempre ricchi nella frazione limoso-argillosa, si riconoscono per il colore tipicamente rossastro, sono poveri in scheletro e mostrano evidenze di accumulo di argilla in profondità (Cutani-Chromic Luvisols). Fig..: I suoli che si sono formati dalla Formazione di San Cassiano presentano spesso un drenaggio difficoltoso riconoscibile dalle colorazioni grigie. Suoli dei fondovalle I fondovalle principali e secondari sono ammantati di depositi fluviali o di origine glaciale rimobilizzati dalle acque, prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e calcareo-dolomitici, che formano terrazzi e conoidi. Nelle situazioni meno stabili (conoidi attivi e terrazzi recenti) i suoli sono poco differenziati, sottili, ricchi in scheletro dolomitico e in carbonati (Calcaric Leptosols). Su superfici più stabili (conoidi e terrazzi più antichi) i suoli presentano maggior differenziazione del profilo e sono moderatamente profondi (Episkeleti-Calcaric Cambisols). La valle di Padola e la zona di Malga Ciapela costituiscono due casi a parte, in quanto in esse prevalgono i depositi silicatici che danno origine a suoli prevalentemente sottili, poco differenziati e acidi (Dystri-Episkeletic Regosols) e occasionalmente moderatamente differenziati, subacidi e profondi (Endoskeletic Phaeozems). SUOLI DEI RILIEVI PREALPINI E COLLINARI I litotipi più diffusi nell area prealpina sono calcarei, appartenenti in particolare alle Formazioni dei Calcari Oolitici di S. Vigilio e dei Calcari Grigi di Noriglio che formano l altopiano di Asiago, la porzione settentrionale dei Monti Lessini e la parte alta 78 79
4 del massiccio del Monte Baldo; è possibile inoltre distinguere formazioni calcaree che presentano una certa percentuale di componente terrigena e assumono le caratteristiche di calcari marnosi (Rosso Ammonitico, Biancone e Scaglia Rossa) presenti nei Lessini meridionali e sulla dorsale del Col Visentin. I rilievi della Lessinia orientale sono modellati sulle colate basaltiche del vulcanesimo terziario, mentre nella zona di Recoaro e delle Piccole Dolomiti, a causa di particolari condizioni tettoniche, emerge una successione stratigrafica più antica, permo-triassica, la cui evoluzione è analoga a quella dei rilievi alpini dolomitici. Anche nei rilievi prealpini la morfologia ha risentito dell effetto dei ghiacciai che ha portato alla formazione di valli fortemente incise e interessate da diffusi depositi morenici (Valbelluna) e ad apparati morenici frontali allo sbocco in pianura (anfiteatro del Garda e di Vittorio Veneto); a questi si aggiungono i depositi di piccoli apparati glaciali posti alle quote più alte. La notevole presenza di rocce calcaree ha contribuito allo sviluppo delle tipiche forme del paesaggio dovute al carsismo (doline, campi solcati). Isolati all interno della pianura o posti alla base dei sistemi montuosi prealpini si trovano i rilievi collinari caratterizzati da morfologie dolci prevalentemente tabulari. La morfologia del complesso collinare dei Berici è fortemente condizionata dalla litostratigrafia: nel settore occidentale prevalgono i calcari arenaceo-marnosi più erodibili, mentre il settore orientale è dominato da formazioni di calcari di scogliera che hanno dato origine a un altopiano intensamente carsificato delimitato da ripide scarpate (Regione Veneto, 1990). I sistemi collinari del trevigiano si estendono al piede dei versanti strutturali dei rilievi prealpini e sono costituiti da formazioni terziarie prevalentemente terrigene (calcari marnosi, marne, argilliti, siltiti, arenarie e conglomerati). I Colli Euganei, dalla forma conica e dai versanti estremamente ripidi, si sono originati in seguito a intrusioni o effusioni vulcaniche terziarie che hanno intercettato, e in alcuni casi sollevato, le rocce sedimentarie preesistenti (Piccoli et al., 1981). Suoli delle incisioni fluviali I fiumi che attraversano l area prealpina originano gole profonde e strette, con versanti molto acclivi, incisi prevalentemente in Dolomia Principale (Adige, Astico e Brenta) e calcari duri (Piave). Su pendenze molto elevate, si ritrovano suoli sottili, poco evoluti, con accumulo di sostanza organica in superficie (Humi-Rendzic Leptosols) mentre su depositi stabili di falda si sviluppano suoli profondi, da poco a moderatamente evoluti, con un elevato contenuto di sostanza organica fino in profondità (Episkeleti- Calcaric Cambisols, Hyperhumi-Rendzic Leptosols). Nel fondovalle e nelle aree ad apporto recente di materiale fluviale si formano suoli a scarsa differenziazione del profilo, ricchi in scheletro (Skeleti-Calcaric Regosols, Calcaric Leptosols). Suoli degli altipiani Sulle superfici subpianeggianti pascolate negli altipiani di Asiago, del Grappa e del Cansiglio, sono evidenti le forme tipiche del paesaggio carsico, con inghiottitoi e doline di varia grandezza e forma. Sui fianchi delle depressioni, erosi dal pascolamento, si formano suoli sottili fortemente condizionati dai frequenti affioramenti rocciosi (Humi-Rendzic Leptosols, Calcari-Epileptic Cambisols), mentre sul fondo, si accumulano depositi colluviali e si sviluppano suoli profondi, a moderata o alta differenziazione del profilo (Chromi-Calcaric Cambisols, Endoskeleti-Cutanic Luvisols). Su versanti boscati, carsificati, con le tipiche forme dei campi solcati, si formano suoli ad alta differenziazione del profilo caratterizzati dall accumulo illuviale di argilla negli orizzonti profondi che penetrano nelle ampie fessure della roccia (Cutani-Endoleptic Luvisols). Il paesaggio dell Altopiano dei Lessini, è costituito da una caratteristica serie di deboli rilievi tabulari tronco-conici e mammellari, interrotti da ripide incisioni fluviali torrentizie a V (denominati vaj) con direzione N-S. Le formazioni più diffuse di questo altopiano (Biancone e Scaglia Rossa), conferiscono forme dolci ed arrotondate; qui i suoli sono decarbonatati e acidificati in superficie e presentano accumulo illuviale di argilla negli orizzonti profondi (Dystri-Cutanic Luvisols, Cutani-Endoleptic Luvisols). Questi suoli si possono trovare anche su versanti più ripidi purchè stabili, impostati sugli stessi materiali (fig..6). Nelle incisioni dei vaj, caratterizzate da versanti ripidi e poco stabili, si trovano suoli a moderata differenziazione del profilo e accumulo di sostanza organica in superficie (Calcari-Epileptic Cambisols, Calcari-Mollic Cambisols) mentre i fondovalle sono occupati da alluvioni recenti. I rilievi meridionali della Lessinia orientale sono modellati invece su colate e brecce basaltiche; sui versanti generalmente boscati dei rilievi coniformi isolati, si sviluppano suoli a reazione subacida, moderatamente profondi e con accumulo di sostanza organica in superficie (Endoleptic Phaeozems) mentre sui versanti complessi con inclusioni di formazioni calcaree, i suoli sono ricchi di carbonati (Episkeleti-Calcaric Cambisols). Sui ripiani di versante su rocce vulcanoclastiche, si sviluppano suoli molto profondi ed argillosi con un orizzonte argico di notevole spessore (Cutani-Profondic Luvisols, Eutri- Cutanic Luvisols). Fig..6: Luvisols formatisi da calcari marnosi tipici delle superfici sommitali ondulate degli altipiani. È evidente l orizzonte eluviale (E) al di sotto dell orizzonte A riconoscibile dalle colorazioni schiarite. Una situazione particolare è quella determinata dal substrato flyschoide dell altopiano dell Alpago. Questi rilievi sono caratterizzati da profilo arrotondato, versanti brevi, fitto reticolo idrografico e valli solitamente ampie. Molto diffusi sono i fenomeni franosi che determinano suoli molto sottili a causa del continuo ringiovanimento delle superfici (Calcaric Leptosols, Humi-Rendzic Leptosols). Nelle aree di accumulo si ritrovano suoli a moderata differenziazione del profilo, molto calcarei e con deboli fenomeni di idromorfia (Calcaric Cambisols, Episkeleti-Calcaric Cambisols). Suoli delle Piccole Dolomiti Nella zona di Recoaro affiora l eterogenea successione stratigrafica calcarea e terrigena dolomitica (basamento cristallino, arenarie della Valgardena, Formazione a Bellerophon, Formazione di Werfen, formazioni calcaree e rocce di origine vulcanica, Dolomia Principale) già descritta per l ambiente alpino (Regione Veneto, 1990). L elevata erodibilità delle filladi conferisce al paesaggio sia forme arrotondate con suoli che evidenziano processi di traslocazione di sesquiossidi di ferro ed alluminio e di argilla (Chromi-Epileptic Luvisols, Dystri-Chromic Luvisols), sia versanti instabili localmente dirupati con suoli più sottili e processi di differenziazione poco evidenti (Dystric Leptosols). I ripidi versanti sviluppati sulle sequenze litologiche di Werfen/Bellerophon/Arenarie della Val Gardena, sono generalmente caratterizzati da una certa instabilità e da spesse coperture colluviali miste con suoli non calcarei e molto profondi (Dystri-Profondic Luvisols, Dystri-Episkeletic Cambisols). Le rioliti emergono in massicci (M. Alba, M. Pusta, Spitz dei Giotti) con ripide scarpate boscate bordate al piede dai relativi depositi detritici su cui si originano suoli con orizzonte eluviale moderatamente espresso e accumulo di sesquiossidi di ferro ed alluminio in profondità (Dystric Cambisols). Suoli delle aree soggette all azione del glacialismo Testimonianza evidente dell influenza glaciale è l ampio fondovalle della Valbelluna. Sulle superfici più antiche la decarbonatazione è stata completa e i suoli risultano privi di carbonati in tutto il profilo (Dystric Cambisols, fig..7). Sono diffuse le depressioni chiuse con versanti acclivi, talora ancora occupate da piccoli stagni e paludi. Si verifica quindi un accumulo di sostanza organica che porta alla formazione di torbiere (Humi- Mollic Gleysols, Ombri-Sapric Histosols). Sui depositi morenici, talvolta misti a detriti di falda, con matrice limosa in cui sono immersi clasti grossolani di dimensioni variabili e natura prevalentemente calcareo-dolomitica, si originano suoli moderatamente profondi, ricchi in scheletro e con diversi livelli evolutivi, spesso correlabili al grado di antropizzazione, Fig..7: Sulle superfici di origine glaciale tipiche del fondovalle della Valbelluna sono diffusi i Cambisols solo parzialmente decarbonatati e ricchi in scheletro
5 Capitolo all uso del suolo e al tipo di vegetazione (Eutri-Endoskeletic e il rimescolamento degli orizzonti con formazione di suoli nel grado di cementazione delle rocce. Su versanti a litologie SUOLI DELLA PIANURA Cambisols, Calcari-Mollic Cambisols, Endoskeletic Luvisols). da sottili a profondi, a bassa differenziazione del profilo ed prevalentemente arenacee si formano suoli moderatamente La genesi della pianura veneta si deve alla deposizione di sedi- Sono anche presenti aree a morfologia depressa corrispon- estremamente calcarei, similmente al substrato (Endoskeleti- differenziati e parzialmente decarbonatati (Eutric Cambisols, menti alluvionali da parte dei fiumi di origine alpina (Po, Adige, denti ad antiche conche lacustri generate solitamente dalla Endopetric Regosols). Dove l intervento antropico è stato meno Calcaric Cambisols). Brenta, Piave e Tagliamento) e secondariamente da parte dei saldatura di due cordoni morenici, ancora oggi influenzate da radicale si trovano suoli moderatamente profondi, modera- Su marne e argilliti, sulle superfici più erose, i suoli si presen- torrenti prealpini. Al suo interno si possono facilmente distinguere fenomeni di ristagno idrico, prive o quasi di drenaggio esterno tamente differenziati e con un alto contenuto di carbonati tano poco differenziati e con tessiture fini (Calcaric Regosols) ambienti diversi: l alta e la bassa pianura, separate dalla fascia e con un notevole accumulo di sostanza organica in superficie in tutto il profilo (Calcaric Cambisols). Sulle parti sommitali mentre su quelle più stabili e meno acclivi sono caratterizzati delle risorgive, la fascia costiera e la zona lagunare. (Calcari-Mollic Gleysols, Eutri-Humic Gleysols). subpianeggianti, sui versanti moderatamente pendenti e sui da una maggiore differenziazione e talvolta sviluppano orizzonti Gli elementi strutturali che caratterizzano l alta pianura sono i terrazzi di contatto glaciale dei cordoni morenici, parzialmente profondi con accumuli secondari di carbonati di calcio (Calcaric conoidi ghiaiosi coalescenti di origine fluvioglaciale, originatisi Suoli dei rilievi collinari isolati nella pianura preservati dalle lavorazioni, si trovano suoli profondi ad alta Cambisols, Haplic Calcisols). allo sbocco delle vallate alpine, successivamente sovrapposti e Il graben della Val Liona divide il complesso collinare dei Colli differenziazione del profilo, caratterizzati da un orizzonte ad Un elemento morfostrutturale di particolare interesse è rap- compenetrati lateralmente tra loro in eventi successivi, cosicché Berici in due settori. Nel settore occidentale prevalgono i calcari accumulo di argilla di notevole spessore (Cutanic Luvisols) e presentato dal Montello, costituito da conglomerati grossola- il sottosuolo risulta interamente costituito di ghiaie per tutto lo arenaceo-marnosi, più erodibili, che danno forme piuttosto mor- talvolta con accumulo di carbonati in profondità e formazione ni miocenici, di natura prevalentemente carbonatica. Lo svilup- spessore del materasso alluvionale. La larghezza di questa fascia bide con suoli moderatamente profondi e fortemente calcarei di un orizzonte calcico (Hypercalcic Luvisols). Il collegamento po di intensi processi carsici ha portato alla formazione di a materasso indifferenziato varia da a oltre 20 chilometri a (Gleyic Calcisols, Eutri-Endoleptic Calcisols) mentre il settore tra le cerchie moreniche e le aree poste a quote minori è dato in-numerevoli doline e sistemi ipogei molto ramificati. Le su- partire dal piede dei rilievi montuosi prealpini. orientale è caratterizzato dalla presenza di ripide scarpate che da versanti a bassa pendenza, di origine glaciale o costituiti da per-fici sono molto antiche e i suoli sono estremamente pro- I depositi dell alta pianura, spostandosi verso valle, presentano delimitano un altopiano con modeste ondulazioni e spiccato depositi colluviali, fluvioglaciali o di conoide, sui quali si trovano fondi e differenziati (Humi-Plinthic Acrisols, Cutani-Chromic percentuali di sabbia sempre maggiori, fino a giungere alla fascia carsismo epigeo. In questo ambiente, nelle situazioni a minor suoli di colore rossastro con evidente accumulo di argilla negli Luvisols, fig..8). delle risorgive dove si rinvengono nel suolo e nel sottosuolo, pendenza, si sono formati suoli moderatamente profondi più o orizzonti profondi e un alto contenuto in scheletro (Endoskeleti- meno decarbonatati e arrossati (Chromi-Epileptic Cambisols); Cutanic Luvisols, Chromi-Calcic Luvisols). nelle situazioni a maggior pendenza invece si trovano suoli molto sottili a diretto contatto con la roccia e con accumulo di Suoli dei rilievi collinari neogenici sostanza organica in superficie (Calcari-Rendzic Leptosols). La I sistemi collinari del trevigiano sono sviluppati su una se- superficie sommitale è un relitto di un altopiano interessato da quenza sedimentaria molto variabile nella granulometria e intenso carsismo, ora attenuatosi. I processi pedogenetici più rilevanti sono il dilavamento dei carbonati e, nelle situazioni più stabili, l illuviazione dell argilla (Endoleptic Luvisols, ChromiEpileptic Cambisols). I Colli Euganei sono caratterizzati da rocce eruttive subvulcaniche a prevalente chimismo acido e solo secondariamente a chimismo basico. Le forme hanno una forte energia del rilievo, risultato dell erosione legata all azione superficiale dell acqua e ai fenomeni gravitativi presenti sui versanti più acclivi; i suoli sono poco differenziati nelle aree interessate dal continuo ringiovanimento delle superfici (Dystric Leptosols) e moderatamente differenziati e profondi nelle zone a maggior stabilità (Dystric Cambisols). All interno del complesso dei Colli Euganei sono presenti anche rocce di origine sedimentaria (Scaglia e Marne Euganee) sulle quali si sono sviluppati suoli a moderata differenziazione del profilo, a tessitura fine, che presentano a volte accumulo di carbonato di calcio in profondità (Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols); sulle superfici più stabili i suoli hanno orizzonti argici ben sviluppati (Cutani-Chromic Luvisols). Altro grande ambiente di origine glaciale è l anfiteatro morenico gardesano. Qui le diffuse opere di gradonatura o regolarizzazione dei versanti per la coltivazione, hanno causato la decapitazione 82 Fig..8: Suolo tipico del Montello; i versanti poco pendenti e l assenza di glaciazioni nel periodo wurmiano hanno favorito la genesi di suoli estremamente evoluti con forti colorazioni rosse dovute all accumulo residuale di ossidi di ferro. Fig..9: Sistemi deposizionali della pianura veneta. Legenda: A pianura alluvionale dell Adige; B pianura alluvionale del Brenta; C pianura alluvionale dei corsi d acqua prealpini; D pianura costiera e lagunare; P pianura alluvionale del Piave; T pianura alluvionale del Tagliamento; Z Alpi, Prealpi, colline e sistemi morenici. 83
6 alternati ai materiali sabbioso-ghiaiosi, orizzonti limoso-argillosi che, in corrispondenza di depressioni topografiche, favoriscono la venuta a giorno delle acque sotterranee. In questo settore si originano importanti corsi d acqua di risorgiva quali il Sile, il Dese e lo Zero. A partire dalla fascia delle risorgive, si sviluppa la bassa pianura che si distingue, attraverso un attenta analisi del microrilievo, in dossi, corrispondenti ad argini naturali dei corsi d acqua e caratterizzati da sedimenti prevalentemente sabbiosi, pianura modale limosa, e aree depresse a sedimenti argilloso-limosi. Mentre le dinamiche di deposizione ora esposte sono analoghe all interno dei singoli bacini, notevoli differenze sono invece dovute alla litologia dei sedimenti trasportati, in funzione dei bacini di provenienza dei depositi. Nei sedimenti in particolare, il contenuto medio in carbonati aumenta notevolmente dal settore occidentale e meridionale a quello orientale, passando da una percentuale del 10-20% di carbonati nei sedimenti del Po e dell Adige, al 3% del Brenta, fino ad arrivare al 40-0% del Piave e a oltre il 60% del Tagliamento (fig..9). Anche i torrenti prealpini hanno contribuito in qualche misura alla formazione della pianura e possono essere anch essi distinti in base al contenuto in carbonati dei sedimenti. Solo alcuni tra quelli provenienti dai Lessini orientali (Agno-Guà e Chiampo), sono a prevalente apporto di sedimenti poco carbonatici, derivanti dall alterazione dei basalti. Tutti i restanti fiumi sono caratterizzati da un alta percentuale di carbonati nei sedimenti, spesso superiore al 0%; i più importanti tra questi sono i torrenti dei Lessini centro-occidentali, il Leogra, il Timonchio, il Bacchiglione, l Astico-Tesina, il Monticano e il Livenza. Suoli dell alta pianura I conoidi ghiaiosi dell alta pianura sono estese strutture a ventaglio per la maggior parte di origine fluvioglaciale, depositate dai fiumi in fasi successive, originatesi quando il loro regime era caratterizzato da portate molto più elevate rispetto a quelle attuali, in conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai (ultime glaciazioni tardo-pleistoceniche). Presentano tracce più o meno evidenti di paleoidrografia riconducibili ad un regime dei fiumi a canali intrecciati (fig..10), in cui si riconoscono zone a sedimenti più ghiaiosi (barre) o sabbiosi e limosi (canali). Successivamente, durante l Olocene, le portate si sono ridotte e i fiumi sono andati in incisione sulle superfici precedentemente deposte, formando terrazzi fluviali, come nel caso dell Adige, o conoidi di dimensioni inferiori incastrati in quelli più antichi, come nel caso del Brenta e del Tagliamento. Il Piave e l Astico hanno invece cambiato il proprio corso, passando dal conoide di Montebelluna a quello di Nervesa, il primo, e da Piovene a Breganze, il secondo. Fig..10: Il tipico andamento a canali intrecciati dei corsi d acqua alpini in alta pianura; il fiume Piave nei pressi di Spresiano (TV), a sinistra. Sulle superfici pleistoceniche dei conoidi, i suoli sono molto antichi e presentano quindi forte differenziazione del profilo e orizzonti di accumulo di argilla illuviale, a evidente rubefazione. I suoli formatisi dove il materiale di partenza conteneva una quantità di ghiaia inferiore (canale) sono profondi, con scheletro e conservano l orizzonte di illuviazione dell argilla (Skeleti-Chromic Luvisols); sulle barre, invece, dove la ghiaia è più superficiale, i suoli sono meno profondi, ricchi in ghiaia e l orizzonte ad accumulo di argilla è stato spesso incorporato nell orizzonte superficiale dalle lavorazioni (Skeleti-Aric Regosols). Nel settore orientale (conoide dell Adige e piana proglaciale dell apparato gardesano), dove le precipitazioni sono sensibilmente inferiori al resto dell alta pianura ( mm contro gli oltre 1000 mm del settore occidentale), i suoli presentano lo stesso modello di distribuzione, ma hanno in aggiunta un orizzonte ad accumulo di carbonato di calcio in profondità (Calci-Luvic Kastanozems (Skeletic), Skeletic Calcisols) che altrove non si è formato per il forte dilavamento dei carbonati da parte delle acque (fig..11). Sulle superfici dei conoidi e dei terrazzi formatisi in epoca più recente (Olocene inferiore e medio), dove la pedogenesi ha portato a una parziale decarbonatazione del suolo, troviamo suoli con una bassa o moderata differenziazione del profilo, rispettivamente in corrispondenza dei depositi di barra (Eutri- Skeletic Regosols) o di canale (Eutri-Skeletic Cambisols). I suoli relativi alle superfici in assoluto più recenti (aree di divagazione e alvei attuali, Olocene superiore) non sono altro che i corrispettivi dei suoli precedenti, ma calcarei (Skeleti-Calcaric Regosols, Calcari-Fluvic Cambisols, fig..12). Alle superfici più recenti di età olocenica sono da ricondurre anche zone interessate dalle deposizioni dei fiumi prealpini che sono andate a riempire i fondovalle (es. torrenti lessinei), a formare veri e propri conoidi o, più spesso, a riempire depressioni di interconoide con depositi prevalentemente fini e molto vari dal punto di vista litologico anche se prevalgono generalmente i depositi carbonatici. I suoli a cui danno origine, sono relativamente profondi, calcarei, più o meno ghiaiosi e caratterizzati dalla presenza di successivi e riconoscibili eventi di deposizione relativamente recenti (Calcari-Fluvic Cambisols). Nel caso delle depressioni di interconoide riempite da sedimenti fini, i suoli presentano la tendenza a fessurare nel periodo estivo e sono generalmente poco calcarei (Eutri-Vertic Cambisols). Data la granulometria del materiale di partenza, i suoli dell alta pianura presentano sempre drenaggio da buono a moderatamente rapido e una moderata capacità di ritenzione idrica; richiedono per questo un consistente apporto di acque di irrigazione per un agricoltura redditizia. Questa è assicurata nella maggior parte dei casi da una fitta rete di canali, ora sostituiti da condotte interrate, che consentono l irrigazione dei campi. Le colture presenti su questi terreni, una volta considerati come i più poveri, vanno dal mais, la coltura più diffusa, prevalentemente sul conoide di Bassano e di Montebelluna, alla vite, sul conoide di Nervesa nel trevigiano, ai frutteti del veronese, sul conoide dell Adige e dell apparato gardesano. Un caso a sé è il territorio del conoide recente del Brenta (Carmignano di Brenta), dove frequente è l uso a prato, in associazione alla diffusione dell allevamento di bovini da latte. Suoli della bassa pianura e della pianura costiera La porzione di pianura situata al di sotto dalla fascia delle risorgive, caratterizzata da modelli deposizionali sostanzialmente Fig..11: I carbonati secondari, una volta dilavati dagli orizzonti superficiali, si ridepositano in profondità. Le concrezioni sono evidenti sulla superficie inferiore dello scheletro più grossolano. Fig..12: I suoli ghiaiosi e poco profondi tipici dell alta pianura recente. Il suolo della foto si è originato dalle alluvioni estremamente calcaree del Piave. diversi, è denominata bassa pianura. Si distinguono aree in cui, per le basse pendenze, il fiume sviluppa un andamento meandriforme (piana di divagazione a meandri) da aree in cui il fiume sviluppa un modello di deposizione a dossi e depressioni. Nella piana a meandri i sedimenti sono in genere costituiti da alternanze di strati sabbiosi, con altri limosi e argillosi, i primi prevalenti nelle aree di barra, i secondi nella piana vera e propria occupata da depositi di decantazione. Nel secondo modello di deposizione, il fiume, scorrendo pensile sulla pianura, contribuisce alla deposizione dei sedimenti in modo più omogeneo: i più grossolani (sabbie) lungo il corso e i più fini man mano che ci si allontana (limi e infine argille). Si formano in questo modo fasce rilevate di circa 1-2 metri sulla pianura circostante (dossi) ed aree di esondazione (pianura modale e depressioni) tra un dosso e l altro. Tra le superfici più antiche (tardo-pleistoceniche) presenti nella pianura si può annoverare la parte della piana proglaciale dell apparato gardesano e dell Adige al di sotto della fascia delle risorgive, caratterizzata da sedimenti prevalentemente sabbiosi sia nelle aree di dosso che nella pianura indifferenziata, con presenza di suoli a differenziazione da moderata ad alta, totale dilavamento dei carbonati (Eutric Cambisols) e talvolta traslocazione di argilla in profondità (Cutani-Chromic Luvisols). Nelle aree di dosso, una volta rilevate e ora spianate dall opera 84 8
7 dell uomo, troviamo suoli ormai poco differenziati, sabbiosi e a drenaggio rapido (Rubi-Calcaric Arenosols), particolarmente adatti alla coltivazione del tabacco. Nelle aree più depresse, la falda non molto profonda, determina un drenaggio mediocre e spesso la formazione di un orizzonte di accumulo di carbonato di calcio, localmente detto scaranzo (Gleyic Calcisols); questa situazione risulta favorevole alla coltivazione del riso, altra coltura tipica della zona. Altre superfici di età tardo-glaciale sono relative alla bassa pianura del Brenta, del Piave e del Tagliamento. La prima è presente con continuità a partire dalle estremità del conoide di Bassano fino alla laguna di Venezia mentre la seconda, suddivisa in lembi in parte rimaneggiati dalle alluvioni di epoca successiva, si trova al di sotto del conoide di Nervesa e la terza, di cui solo le propaggini meridionali sono presenti nella nostra regione, nell area di Lison-Pramaggiore. In tutte queste superfici è riconoscibile un modello a dossi, pianure modali e depressioni. Sui dossi troviamo suoli a moderata differenziazione del profilo, con tessiture caratterizzate dalla presenza di sabbia (franco grossolane), decarbonatati, con falda molto profonda e drenaggio buono (Eutric Cambisols). Nelle restanti aree risulta molto ben espressa la formazione di un orizzonte calcico in profondità (localmente detto caranto ), dovuto alla presenza della falda e alla tessitura più fine che va da limosa, nella pianura modale, ad argillosa, nelle depressioni, con drenaggio da mediocre a lento (Gleyic Calcisols, fig..13). Nelle aree più recenti, di età olocenica invece, i suoli sui dossi, franco grossolani o sabbiosi, possono essere a decarbonatazione parziale o nulla e a differenziazione del profilo da moderata a bassa (Hypocalcic Calcisols, Calcaric Cambisols, Calcaric Fluvisols); il drenaggio è generalmente buono tranne dove la Fig..13: Particolare delle screziature ossimorfiche (brune) e riducimorfiche (grigie) tipiche dei suoli della bassa pianura a drenaggio mediocre o lento. Questo pattern di colori è dovuto all alternanza di condizioni riducenti ed ossidanti, data dall oscillazione stagionale della falda. tessitura risulta più fine (suoli limoso grossolani, originatisi da sabbie molto fini e limi). Anche nelle aree di pianura modale e nelle aree depresse si va dai suoli più evoluti, parzialmente decarbonatati (Hypocalci-Gleyic Calcisols), a quelli meno evoluti (Gleyi-Fluvic Cambisols (Calcaric)), con drenaggio da mediocre a lento, tessiture da limose ad argillose e falda presente entro il profilo. Nelle aree di divagazione a meandri i suoli sono simili, ma presentano una distribuzione individuabile non tanto mediante lo studio della morfologia (microrilievo), quanto grazie all uso della fotointerpretazione che permette di distinguere i meandri, aree di barra a granulometria più grossolana, e gli alvei, con depositi fini limoso-argillosi a copertura delle sabbie, dalla piana a tessitura limosa. Un caso a sé rappresentano le aree di pianura dove è prevalso l apporto dei torrenti dei Lessini orientali (Chiampo e Agno-Guà) che hanno eroso i lembi di pianura fluvioglaciale dell Adige e li hanno parzialmente coperti con depositi di materiale argilloso, di colore scuro, non calcareo, derivato dall alterazione dei basalti. I suoli che ne risultano hanno un orizzonte calcico in profondità, formatosi nel materiale alluvionale calcareo dell Adige, un drenaggio mediocre e presentano una discreta tendenza a fessurare nella stagione estiva (Humi-Vertic Calcisols). Vi sono poi aree in cui il drenaggio risultava particolarmente difficoltoso per la presenza di strutture rilevate a valle, quali dossi di fiumi in corrispondenza di una confluenza, o cordoni dunali lungo la linea di costa; queste aree, una volta sede di paludi, ora sono state bonificate e presentano suoli con notevoli accumuli di sostanza organica in superficie, a volte veri e propri strati di torba, che si sono formati quando la presenza di acqua libera nel suolo impediva la decomposizione dei residui della vegetazione palustre. Tra le più importanti ed estese vi sono le Valli Veronesi, formatesi a monte della confluenza tra un antico dosso dell Adige e quello attuale del Po, e la zona di Cavarzere nel veneziano, che insieme alle contigue aree del Basso Polesine, presenta vaste aree depresse formatesi all interno di quello che era un antico delta del Po, sbarrato a valle dai cordoni dunali relitti che da Chioggia si estendono verso sud fino al confine regionale, proseguendo poi nel ferrarese. Altre aree, di limitata estensione, si trovano nei bacini del Piave e del Livenza, al contatto con le aree più propriamente lagunari (Fontana et al., 2004). In tutte queste zone predominano le deposizioni fini, limi e argille, che hanno dato origine a suoli con orizzonte mollico in superficie (fig..14) e drenaggio lento (Gleyi-Fluvic Cambisols (Mollic), Calcari-Mollic Gleysols); spesso in queste aree depresse, che si configurano come dei bacini chiusi, sono individuabili Fig..14: Nelle aree palustri, ora bonificate, della bassa pianura dell Adige è comune la presenza di suoli con accumulo di sostanza organica in superficie (orizzonte mollico). dei canali di rotta che presentano tessiture più grossolane, con alternanza di strati limosi e sabbiosi (Molli-Gleyic Fluvisols). Nelle aree del delta interno del Po, spesso sotto il livello del mare, troviamo anche suoli con problemi di acidità e di salinità e con strati di torba sepolti (Pachi-Gleyic Phaeozems e Humi- Thaptohistic Gleysols), fino ad arrivare a suoli completamente organici, con scarsa presenza della componente minerale e presenza di materiali sulfurei che conferiscono agli orizzonti profondi una notevole acidità, una volta ossidati per l abbassamento della falda freatica con le opere di bonifica idraulica (Sapri-Thionic Histosols). Questi ultimi sono localizzati nell area del Canale dei Cuori, dove il termine cuora viene utilizzato localmente per indicare la torba. La diffusione di questi suoli risulta ormai sempre più limitata, sia per le attività di cava cui sono soggetti, sia per l intensa mineralizzazione, attivata dalle condizioni ossidanti instauratesi in seguito alla bonifica. Nelle aree di risorgiva, al contatto tra alta e bassa pianura, dove all aumento della presenza di sedimenti più fini si accompagna l approssimarsi della falda alla superficie, i suoli presentano una notevole variabilità, dovuta non solo alla diversa granulometria dei sedimenti (si va da suoli sabbiosi a suoli limosi), ma anche al drenaggio difficoltoso che in situazioni particolarmente spinte porta alla formazione di orizzonti ad accumulo di sostanza organica (Calcic Gleysols, Molli-Gleyic Fluvisols (Calcaric)). Nella zona costiera si possono distinguere due grandi sistemi profondamente diversi tra loro, quello dei cordoni dunali e quello delle aree lagunari bonificate. Nelle aree lagunari l elemento che predomina è il limo con suoli che sono per la maggior parte limoso grossolani (Calcari-Gleyic Fluvisols) e secondariamente limoso fini (Gleyi-Fluvic Cambisols (Calcaric)), con drenaggio difficoltoso e a emungimento meccanico delle acque. Nel sistema dei cordoni dunali, dominato dalla presenza delle sabbie, sulle dune più rilevate i suoli hanno profilo poco differenziato e drenaggio moderatamente rapido (Calcaric Arenosols) mentre sulle dune meno rilevate o spianate ad opera dell uomo (fig..1), i suoli possono presentare segni di idromorfia se la falda risulta più superficiale (Calcari-Gleyic Arenosols). Nelle rare zone in cui si è preservata anche la fascia di interduna, sui cordoni più antichi, i suoli sono sempre sabbiosi ma ben differenziati e con un accumulo di sostanza organica in superficie (Molli-Fluvic Cambisols). Nelle isole lagunari, accanto ai suoli citati, si trovano anche suoli di riporto, originati dai materiali lagunari dragati dai canali; questi, pur evidenziando una notevole variabilità, sono tendenzialmente limosi, a volte con interstrati sabbiosi e presentano qualche problema di salinità e di drenaggio (Endogleyi-Terric Anthrosols). Fig..1: I suoli tipici dell ambiente costiero, oggi spesso coltivati, presentano bassa differenziazione del profilo, tessiture sabbiose e falda prossima alla superficie
8 I suoli della bassa pianura e della pianura costiera sono in gran parte utilizzati a seminativo, con prevalenza delle colture più produttive e redditizie, specificatamente il mais, per il quale gli apporti meteorici sono in grado di soddisfare le esigenze idriche della coltura, pur con l aiuto di qualche irrigazione di soccorso. Nella pianura alluvionale del Po e dell Adige, dove le precipitazioni sono inferiori al resto della regione ( mm all anno nel Polesine, nella bassa padovana e nel basso veneziano), si pratica una maggiore gamma di colture, in alternativa al mais. Vi sono alcune aree particolarmente vocate alle colture ortive, quali le aree sabbiose del dosso dell Adige a Lusia e i cordoni dunali di Chioggia. Altre colture tipiche come quella del radicchio di Treviso, nell area di Zero Branco e Scorzè, sono favorite, più che dai suoli, dalla presenza delle falde artesiane che in questa zona forniscono l acqua necessaria alla lavorazione del prodotto. Aree vocate alla viticoltura sono presenti sia nella pianura alluvionale del Piave che del Tagliamento (D.O.C. Piave e D.O.C. Lison-Pramaggiore), che grazie alla fertilità dei suoli portano spesso a elevate produzioni. Alcuni lembi di vegetazione naturale, ormai di dimensioni assai limitate, sono ancora presenti nelle aree di risorgiva. Humus forestali La definizione delle forme di humus associate ai differenti suoli forestali è di fondamentale importanza sia per un completo inventario della risorsa suolo, sia per finalità forestali, sia per consentire elaborazioni quali la stima del contenuto in carbonio. È evidente infatti che solo dando la dovuta attenzione agli strati organici (olorganici ed emiorganici) si può operare un esaustiva caratterizzazione dei suoli sotto foresta, nei quali la frazione organica è sempre abbondante e riveste notoriamente un ruolo capitale. Nel corso del rilevamento di campagna è stata eseguita la descrizione morfologica della forma di humus di ciascun profilo di suolo sotto foresta (fig..16). In molti casi si è proceduto anche a osservazioni speditive nell intorno del sito del profilo, per determinare l eventuale variabilità in relazione alla micromorfogia superficiale e alle differenze nella vegetazione (in particolare nella densità della copertura arborea ed erbacea). Una parte dei campioni è stata analizzata in laboratorio. L insieme di tali operazioni ha permesso di individuare la forma o le forme di humus dominanti per ogni unità tipologica di suolo. Per la classificazione si è utilizzato il Référentiel Pédologique (AFES, 199) il quale in studi precedenti (Calabrese et al., 1996; Calabrese et al., 1997; Zanella et al., 2001) si era rivelato Fig..16: Accumulo di lettiera di latifoglie alla superficie del suolo. il sistema più idoneo per l ambiente alpino. È noto però che questo sistema costituisce solo un primo tentativo di sostituire la nomenclatura tradizionale con una tassonomia oggettiva ed esaustiva e presenta perciò molti limiti. Essi riguardano in particolare le forme di humus Mull-Moder, dove l attività dei lombrichi e della mesofauna sono entrambe dominanti; sono forme molto abbondanti negli ambienti studiati (Sartori et al., 2004) che presentano elevata eterogeneità ma che vengono grossolanamente riunite in un unica classe (Amphimull). Altre incertezze riguardano il limite tra le forme Mull-Moder (Amphimull) a prevalente attività di lombrichi e le forme Moder (Dysmoder) a prevalente attività della mesofauna (enchitreidi, artropodi, larve di ditteri), e tutto il campo delle forme di tipo Mor (Mor), a dominante attività fungina. Si può quindi affermare che non è ancora disponibile un valido e collaudato sistema di classificazione. La grandissima varietà climatica, ambientale e litologica delle Alpi e delle Prealpi venete si riflette in una gamma molto ampia di forme di humus. Tra i fattori che condizionano la presenza delle varie forme c è anche l impatto antropico, attuale e/o pregresso. È evidente che gli strati superficiali del suolo sono quelli che risentono in maniera più drastica delle attività dell uomo, nei loro effetti diretti (es. disboscamento) e indiretti (es. condizioni microambientali dovute alla gestione del bosco). La scarsità di forme a dominante attività fungina (Mor) descritte nel piano subalpino, in particolare, sembra essere legata alla grandissima diffusione dei pascoli nel passato, testimoniata oggi dalla frequente presenza del larice, con il denso strato erbaceo che lo accompagna, nella formazione tipica della pecceta subalpina. Come già osservato in altre zone alpine (Calabrese et al., 1996), a parità di altri fattori, la distribuzione delle varie forme di humus mostra un legame con il tipo di suolo, a sua volta legato al tipo di materiale parentale. Di seguito vengono sintetizzate le forme prevalenti, rispettivamente sui suoli sviluppati da materiali carbonatici e silicatici. Materiali parentali carbonatici Su materiali parentali carbonatici, le forme di humus (fig..18a e b) sono legate alla presenza e all interazione di fattori limitanti l efficienza della degradazione della sostanza organica, tra cui i principali sembrano essere: la presenza di carbonati nel topsoil; determinati gruppi funzionali acidi dei colloidi inorganici, in assenza di carbonati, hanno un effetto catalizzante sulla degradazione della sostanza organica (Calvet, 2003); la scarsità di frazioni fini nel topsoil (tessitura grossolana e/o abbondanza di scheletro); il clima sfavorevole: freddo (alte quote) o siccità estiva (distretti esalpico e versanti esposti a sud); la scarsa degradabilità dei materiali della lettiera (abete rosso/ericacee < abete bianco/faggio < altre latifoglie). In assenza di fattori limitanti dominano le forme di humus molto attive (Eumull, Mésomull e Oligomull), vale a dire con minor accumulo di sostanza organica indecomposta (fig..17). La presenza di un fattore fortemente limitante o la compresenza di più fattori dà origine a forme di humus poco attive (Amphimull). La presenza di un consistente strato erbaceo di graminacee nel sottobosco, a parità di altri fattori, è sempre legata a forme di humus relativamente più attive. Mancano completamente le forme Moder e Mor. La forma di humus più frequente dei suoli su substrati carbonatici è quella relativamente poco efficiente Mull-Moder (Amphimull), caretterizzata da un pacchetto di lettiera indecomposta (OL) e parzialmente o totalmente decomposta (OF e OH), sovrastante un orizzonte A strutturato per effetto dell attività dei lombrichi (biomacrostrutturato). Tale forma domina nella fascia collinare, se Fig..17: Particolare di Eumull; la presenza di alcune porzioni della superficie prive di lettiera evidenziano la veloce alterazione della sostanza organica, tipica di forme di humus molto attive. il fattore limitante è la presenza di carbonati nel topsoil (Humi- Rendzic Leptosols, Calcaric Cambisols), e nella fascia subalpina, sotto conifere a causa del clima freddo, indipendentemente dalla presenza di carbonati in superficie (fig..18.a). Forme Mull moderatamente attive con orizzonti organici OL e OF (Dysmull) e attive con solo orizzonte organico OL (Mésomull, Oligomull) sono presenti nella fascia collinare, dati il clima e la vegetazione favorevoli alla degradazione della sostanza organica, e secondariamente nella fascia montana su suoli con orizzonte superficiale (A) decarbonatato (fig..18b). Le forme di Mull più attive (Eumull), caratterizzate dall assenza di orizzonti olorganici, ad eccezione della lettiera caduta in autunno osservata nei mesi invernali, sono molto rare. Esse sono presenti solo dove tutti i fattori concorrono all efficienza della mineralizzazione, ossia in ambiente esalpico, alle basse quote, su suoli con A privo di carbonati (Cutanic Luvisols) e sotto latifoglie, con lettiera facilmente decomponibile. Materiali parentali silicatici In ambito regionale i litotipi silicatici sono meno diffusi rispetto a quelli carbonatici, in modo particolare a bassa quota. Questo spiega in parte la totale assenza di forme di humus molto attive (Eumull, Mésomull e Oligomull) su tali litotipi. Su materiali silicatici i fattori limitanti sembrano essere: l estrema acidità del topsoil; la scarsità di frazioni fini nel topsoil; il clima sfavorevole: freddo o siccità estiva; la scarsa degradabilità dei materiali della lettiera (abete rosso/ericacee < abete bianco/faggio < altre latifoglie). Una combinazione di fattori sfavorevoli può comportare l assenza dei lombrichi quali principali agenti della degradazione e la conseguente comparsa di forme di humus poco attive, a prevalente attività di artropodi ed enchitreidi (Moder). Le forme di humus più diffuse sono i Dysmoder, caratterizzati da una sequenza di orizzonti a crescente grado di decomposizione (OL, OF, OH), che sovrastano un orizzonte minerale privo della struttura poliedrica tipica dell attività dei lombrichi. Sono frequenti alle alte quote e su topsoil a reazione fortemente acida e tessitura grossolana dei suoli bruni ocrici (Dystric Cambisols) e podzolici (Podzols). Alle quote più basse, su suoli a tessitura media e a reazione meno acida sono frequenti forme relativamente attive (Dysmull) o poco attive (Amphimull), comunque con presenza di lombrichi (fig..18c). Sono assenti le forme Mor
9 Fig..18a: Schema della distribuzione delle forme di humus su suoli con topsoil neutro o subacido. Le forma di humus più attive (Eumull) sono molto rare, compaiono solo quando tutti i fattori concorrono a incrementare l efficienza della degradazione della sostanza organica: basse quote, lettiera degradabile, clima temperato prealpino. Forme Mésomull e Oligomull sono frequenti alle basse quote. Forme Dysmull (OL-OF) sono diffuse a quote medie sotto boschi di latifoglie. Forme Amphimull (OL-OF-OH) sono diffuse a quote medie e alte sotto boschi di conifere o faggete, con climi freddi. Forme Moder e Mor sono assenti. Fig..18c: Schema della distribuzione delle forme di humus su suoli con topsoil acido. Forme Dysmull (OL-OF) e Amphimull (OL-OF-OH) sono prevalenti a basse quote, Amphimull a quote tendenzialmente più alte e nel distretto mesalpico. Forme Dysmoder sono diffuse nelle fasce montana e subalpina, perlopiù nel distretto endalpico. Nella fascia subalpina forme Dysmoder sono nettamente dominanti su suoli bruni ocrici o podzolici. Non sono presenti forme a bassa attività (Mor), nè forme ad alta efficienza (Eumull, Mésomull, Oligomull). Fig..18b: Schema della distribuzione delle forme di humus su suoli con topsoil calcareo. Le forme più diffuse sono Amphimull (OL-OF-OH) e Dysmull (OL-OF). Forme Amphimull sono più frequenti sotto boschi di conifere, su suoli sottili e ricchi in scheletro (rendzina) e su versanti esposti a sud. Mésomull e Oligomull sono frequenti solo nella fascia collinare. La forma più attiva (Eumull) non è presente. Forme Moder e Mor sono anch esse assenti
Foto 7 Ponte sul Raboso
 Moriago della Battaglia (TV) Valutazione 2011 Foto 7 Ponte sul Raboso Foto 8 Confluenza tra il torrente Raboso (a sinistra nell immagine) e il torrente Rosper (a destra) H:\clie\MORI1006\Produzione\Word\12_Compatibilita_idraulica\comp_idraulica_2011_10_19.doc
Moriago della Battaglia (TV) Valutazione 2011 Foto 7 Ponte sul Raboso Foto 8 Confluenza tra il torrente Raboso (a sinistra nell immagine) e il torrente Rosper (a destra) H:\clie\MORI1006\Produzione\Word\12_Compatibilita_idraulica\comp_idraulica_2011_10_19.doc
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa MAURO ZANONE. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Mauro Zanone area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti tra loro diversi per situazione
Terreno naturale e terreno agrario. rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno
 Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
Terreno naturale e terreno agrario il profilo del terreno rappresenta la successione degli orizzonti che costituiscono il terreno In relazione al tipo di profilo che un terreno presenta, possiamo distinguere:
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa LA FATTORIA di Morris Grinovero
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa La Fattoria di Morris Grinovero area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA I terreni gestiti dall azienda ricadono prevalentemente
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa La Fattoria di Morris Grinovero area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA I terreni gestiti dall azienda ricadono prevalentemente
Regione Friuli Venezia Giulia azienda dimostrativa EUROAGRICOLA di Denis Paron. Localizzazione
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Euroagricola di Denis Paron area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti di bassa
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa Euroagricola di Denis Paron area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA L azienda gestisce terreni in ambienti di bassa
GEOMORFOLOGIA. Modellamento dei versanti
 GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
GEOMORFOLOGIA La Geomorfologia ha per fine lo studio e l interpretazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento del rilievo terrestre I processi geodinamici possono distinguersi in due
MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI
 A cura di V. Francani VALLE GLACIALE MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI La foto descrive la morfologia tipica di una valle recentemente abbandonata dal ghiacciaio (Val Viola, Sondrio). Si notano i fianchi
A cura di V. Francani VALLE GLACIALE MORFOLOGIA DEI DEPOSITI GLACIALI La foto descrive la morfologia tipica di una valle recentemente abbandonata dal ghiacciaio (Val Viola, Sondrio). Si notano i fianchi
Carta geologica "CIMITERO DI LAURIA" in scala 1:2000
 Carta geologica "CIMITERO DI LAURIA" in scala 1:2000 fig.16 55 Sito d' interesse N Carta geologica scala 1:2000 Carta geologica "FOSSO LO MONACO" in scala 1:2000 fig.14 Sito d' interesse N Carta geologica
Carta geologica "CIMITERO DI LAURIA" in scala 1:2000 fig.16 55 Sito d' interesse N Carta geologica scala 1:2000 Carta geologica "FOSSO LO MONACO" in scala 1:2000 fig.14 Sito d' interesse N Carta geologica
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. I N D E 2 R G A H
 COMMITTENTE: : GENERAL CONTRACTOR: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 LINEA A.V. /A.C. TORINO VENEZIA Tratta MILANO VERONA Lotto Funzionale Brescia-Verona PROGETTO
COMMITTENTE: : GENERAL CONTRACTOR: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 LINEA A.V. /A.C. TORINO VENEZIA Tratta MILANO VERONA Lotto Funzionale Brescia-Verona PROGETTO
Regione EMILIA ROMAGNA azienda dimostrativa GLI ULIVI. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa GLI ULIVI. area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA
 Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa GLI ULIVI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nelle colline dell Appennino romagnolo sulla Formazione Marnoso-Arenacea membro
Localizzazione Legenda: azienda agricola dimostrativa GLI ULIVI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nelle colline dell Appennino romagnolo sulla Formazione Marnoso-Arenacea membro
Allegato D1. Descrizione dei suoli
 Allegato D1 Descrizione dei suoli 2 Profili pedologici descritti ex novo (2010) vedi Cap.2, paragrafo 2.4 P1 Località: Civiglio, a monte di San Nicola Coordinate: 1509351, 5073592 Quota: 730 m s. l. m.
Allegato D1 Descrizione dei suoli 2 Profili pedologici descritti ex novo (2010) vedi Cap.2, paragrafo 2.4 P1 Località: Civiglio, a monte di San Nicola Coordinate: 1509351, 5073592 Quota: 730 m s. l. m.
COMUNE DI GUASILA. Provincia di CAGLIARI
 Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE FAO-UNESCO
 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE FAO-UNESCO La classificazione FAO è basata sull identificazione degli orizzonti diagnostici: histico, umbrico, ocrico, petrocalcico, gypsico, petrogypsico, sulfurico, albico,
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE FAO-UNESCO La classificazione FAO è basata sull identificazione degli orizzonti diagnostici: histico, umbrico, ocrico, petrocalcico, gypsico, petrogypsico, sulfurico, albico,
3.3 Il bacino del fiume Cavone
 3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
3.3 Il bacino del fiume Cavone 3.3.1 Il territorio Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale
3. I SuOLI 3.1 INquADRAmENTO geografico 3.2 FATTORI DELLA PEDOgENESI geologia, geomorfologia e idrologia
 3. i suoli 41 3. i suoli 3.1 Inquadramento geografico L area oggetto di studio ricopre una superficie complessiva di circa 11.000 ettari ed è interamente compresa all interno della provincia di Vicenza
3. i suoli 41 3. i suoli 3.1 Inquadramento geografico L area oggetto di studio ricopre una superficie complessiva di circa 11.000 ettari ed è interamente compresa all interno della provincia di Vicenza
Le province di suoli dei rilievi collinari
 Le province di suoli dei rilievi collinari PROVINCIA DI SUOLI - RC Rilievi collinari prealpini posti al piede dei massicci, in forma di dorsali strette e allungate o di emergenze tabulari, con morfologia
Le province di suoli dei rilievi collinari PROVINCIA DI SUOLI - RC Rilievi collinari prealpini posti al piede dei massicci, in forma di dorsali strette e allungate o di emergenze tabulari, con morfologia
RELAZIONE GEOLOGICA E COMPATIBILITA SISMICA
 TECNOGEO S.a.s. Studio Tecnico di Geologia Via Col Visentin, 7-31044 Montebelluna Tel.: 0423.303043 - Cell.: 335.6159235 P.Iva: 03549450264 Regione del Veneto COMUNE DI PEDEROBBA Provincia di Treviso VARIANTE
TECNOGEO S.a.s. Studio Tecnico di Geologia Via Col Visentin, 7-31044 Montebelluna Tel.: 0423.303043 - Cell.: 335.6159235 P.Iva: 03549450264 Regione del Veneto COMUNE DI PEDEROBBA Provincia di Treviso VARIANTE
Solo il 10% è suolo!
 Il suolo è l epidermide della Terra, come la buccia di una mela ma: Solo il 25% di questa mela non è sommerso dalle acque Di cui il 15% è deserto, ghiaccio o roccia affiorante Solo il 10% è suolo! Il suolo
Il suolo è l epidermide della Terra, come la buccia di una mela ma: Solo il 25% di questa mela non è sommerso dalle acque Di cui il 15% è deserto, ghiaccio o roccia affiorante Solo il 10% è suolo! Il suolo
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
 AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
AREA R6 DI CASANOVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA Dott. geol. Ferruccio Capecchi Pistoia 22 marzo 2011 Largo San Biagio 149 51100 PISTOIA Tel./fax 0573 24355 e-mail:gtigeologi@tin.it
STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA
 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO STUDIO SULL EROSIONE DELLA COSTA TERRITORIO COMUNALE DI TUSA Dott.ssa Geol. Daniela Alario - Dr. Geol. Giovanni
2 EROSIONE DEL SUOLO. 2.1 Definizioni e terminologia. 2 Erosione del suolo
 2 EROSIONE DEL SUOLO In questo capitolo si concentrerà l attenzione sulle forme di erosione del suolo dovute all acqua meteorica (dilavamento), anche se da un punto di vista generale l erosione del suolo
2 EROSIONE DEL SUOLO In questo capitolo si concentrerà l attenzione sulle forme di erosione del suolo dovute all acqua meteorica (dilavamento), anche se da un punto di vista generale l erosione del suolo
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Incontri Lariani: I suoli del parco Brughiera Briantea. sabato 11 giugno Escursione pedologica a Cucciago e Vertemate (CO)
 Incontri Lariani: I suoli del parco Brughiera Briantea sabato 11 giugno 2016 Escursione pedologica a Cucciago e Vertemate (CO) A cura di: Gruppo Naturalistico della Brianza associazione ONLUS; Comitato
Incontri Lariani: I suoli del parco Brughiera Briantea sabato 11 giugno 2016 Escursione pedologica a Cucciago e Vertemate (CO) A cura di: Gruppo Naturalistico della Brianza associazione ONLUS; Comitato
DEL COMUNE DI COLLIO V.T. (BS) 4 stralcio
 LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI IN LOCALITA' CROCI - PEZZEDA MATTINA DEL COMUNE DI COLLIO V.T. (BS) 4 stralcio inquadramento territoriale ALTA VALTROMPIA BACINO DEL FIUME MELLA VERSANTE SINISTRO
LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI IN LOCALITA' CROCI - PEZZEDA MATTINA DEL COMUNE DI COLLIO V.T. (BS) 4 stralcio inquadramento territoriale ALTA VALTROMPIA BACINO DEL FIUME MELLA VERSANTE SINISTRO
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio
 UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
UN VIAGGIO IDEALE: 1. Lo studio del paesaggio 1 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell avere nuovi occhi (Marcel Proust) 2 Questi nuovi occhi ci serviranno per leggere
TETTO FRATI limoso-grossolana, fase tipica TTF1
 TETTO FRATI limoso-grossolana, fase tipica TTF1 Distribuzione geografica e pedoambiente Si tratta di una tipologia pedologica diffusa nella piana del Po dal confine tra le provincia di Torino e Cuneo fino
TETTO FRATI limoso-grossolana, fase tipica TTF1 Distribuzione geografica e pedoambiente Si tratta di una tipologia pedologica diffusa nella piana del Po dal confine tra le provincia di Torino e Cuneo fino
Geomorfologia strutturale
 Studia i rapporti tra forme del rilievo e strutture geologiche (giacitura delle rocce, deformazioni tettoniche, ecc.). Tali rapporti sono in genere molto stretti, in quanto le condizioni geologico strutturali
Studia i rapporti tra forme del rilievo e strutture geologiche (giacitura delle rocce, deformazioni tettoniche, ecc.). Tali rapporti sono in genere molto stretti, in quanto le condizioni geologico strutturali
Regione Piemonte azienda dimostrativa CERUTTI. Localizzazione. Azienda Agricola Cerutti fraz. Corveglia Villanova d Asti (AT)
 Localizzazione Azienda Agricola Cerutti fraz. Corveglia Villanova d Asti (AT) area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA Il campo sperimentale dell azienda si trova sull Altopiano
Localizzazione Azienda Agricola Cerutti fraz. Corveglia Villanova d Asti (AT) area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA Il campo sperimentale dell azienda si trova sull Altopiano
Brevi note geologiche e geomorfologiche sulla Val Rosandra
 Brevi note geologiche e geomorfologiche sulla Val Rosandra Il Carso Triestino fa parte di una serie di piattaforme carbonatiche che si sono depositate nella regione periadriatica in età mesozoico-terziaria.
Brevi note geologiche e geomorfologiche sulla Val Rosandra Il Carso Triestino fa parte di una serie di piattaforme carbonatiche che si sono depositate nella regione periadriatica in età mesozoico-terziaria.
Figura 3.1 Inquadramento dei paesaggi della parte nord-orientale della provincia di Venezia
 41 3. i suoli DEL LISON-PRAMAGGIORE 3.1 Inquadramento geografico e fattori della pedogenesi Geologia, geomorfologia e idrologia Il territorio tra Livenza e Tagliamento in cui ricade l area oggetto di studio
41 3. i suoli DEL LISON-PRAMAGGIORE 3.1 Inquadramento geografico e fattori della pedogenesi Geologia, geomorfologia e idrologia Il territorio tra Livenza e Tagliamento in cui ricade l area oggetto di studio
Riguardano principalmente i calcari e le dolomie
 Fenomeni carsici Riguardano principalmente i calcari e le dolomie anche se con il termine carsismo si possono indicare fenomeni che hanno a che fare con la dissoluzione di gessi e salgemma Calcari e Dolomie
Fenomeni carsici Riguardano principalmente i calcari e le dolomie anche se con il termine carsismo si possono indicare fenomeni che hanno a che fare con la dissoluzione di gessi e salgemma Calcari e Dolomie
suolo Sorgenti del Piave frequente (25-50%) USDA: Typic Haplorthods coarse-loamy, mixed, frigid WRB: Epileptic Entic Podzols
 37.1 - Leptosol-Region con Podzols e Cambisols delle Alpi centrali, in parte con ghiacciai o copertura nevosa permanente. Materiale parentale: rocce ignee e metamorfiche (graniti, gneiss e scisti). MA
37.1 - Leptosol-Region con Podzols e Cambisols delle Alpi centrali, in parte con ghiacciai o copertura nevosa permanente. Materiale parentale: rocce ignee e metamorfiche (graniti, gneiss e scisti). MA
Regione Lombardia azienda dimostrativa REBOLLINI. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa Rebollini. area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA
 Localizzazione azienda agricola dimostrativa Rebollini area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda si sviluppa nel Distretto pedologico della Bassa collina interna ad Est della Val Staffora nell ambito
Localizzazione azienda agricola dimostrativa Rebollini area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda si sviluppa nel Distretto pedologico della Bassa collina interna ad Est della Val Staffora nell ambito
SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL SUOLO
 SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL SUOLO Localizzazione azienda agricola dimostrativa CERZOO area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura pedemontana in ambiente di conoide su lembi
SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL SUOLO Localizzazione azienda agricola dimostrativa CERZOO area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura pedemontana in ambiente di conoide su lembi
Le precipitazioni sul Veneto - Valori mensili
 Le precipitazioni sul Veneto - Valori mensili Adriano Barbi, Federica Checchetto, Irene Delillo, Francesco Rech Servizio Meteorologico Teolo (PD) ARPAV, Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio
Le precipitazioni sul Veneto - Valori mensili Adriano Barbi, Federica Checchetto, Irene Delillo, Francesco Rech Servizio Meteorologico Teolo (PD) ARPAV, Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio
Aree sorgenti di sedimento - generalità
 Aree sorgenti di sedimento - generalità In molti bacini montani, specialmente in regioni a clima umido, l apporto di detriti alle rete idrografica è dovuto ad aree relativamente limitate, nelle quali i
Aree sorgenti di sedimento - generalità In molti bacini montani, specialmente in regioni a clima umido, l apporto di detriti alle rete idrografica è dovuto ad aree relativamente limitate, nelle quali i
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI
 SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 1 - DATI IDENTIFICATIVI N di riferimento e denominazione 1 / Sorgente Nuova Fiume Località Gesiola Comune Provincia Varese Sezione CTR A4C3 Coordinate chilometriche
Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana
 Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
Adriano Zanferrari Dipartimento di Georisorse e Territorio Università di Udine Nascita, formazione ed evoluzione della pianura friulana INDICE - che cos è la pianura? - architettura del substrato roccioso
azienda agricola dimostrativa RUOZZI
 Localizzazione azienda agricola dimostrativa RUOZZI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura alluvionale prossima alla pianura pedemontana, in ambiente interfluviale.
Localizzazione azienda agricola dimostrativa RUOZZI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura alluvionale prossima alla pianura pedemontana, in ambiente interfluviale.
RUSSIA, limoso-fine, fase tipica RSS1
 RUSSIA, limoso-fine, fase tipica RSS1 Distribuzione geografica e pedoambiente Questo suolo è caratteristico di terrazzi alluvionali antichi in parte influenzati da depositi morenici portati da scaricatori
RUSSIA, limoso-fine, fase tipica RSS1 Distribuzione geografica e pedoambiente Questo suolo è caratteristico di terrazzi alluvionali antichi in parte influenzati da depositi morenici portati da scaricatori
Servizio Geologico e Difesa del Suolo ARPAV LEGENDA
 LEGENDA LEGENDA GUIDA ALLA LEGENDA La legenda che accompagna la carta dei suoli è articolata in quattro livelli gerarchici, tre riguardano il paesaggio, il quarto il suolo. I livelli relativi al paesaggio
LEGENDA LEGENDA GUIDA ALLA LEGENDA La legenda che accompagna la carta dei suoli è articolata in quattro livelli gerarchici, tre riguardano il paesaggio, il quarto il suolo. I livelli relativi al paesaggio
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana
 La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
La formazione della Pianura Padana La Pianura Padana L assetto geomorfologico della pianura padana è strettamente connesso al modello genetico della sua formazione. La Pianura Padana costituisce l avanfossa
Le rocce rocce rocce
 Le rocce Per rocce si intendono aggregati di minerali cristallini, a volte con presenza di sostanze amorfe. La maggior parte delle rocce è formata da minerali diversi; più raramente le rocce sono formate
Le rocce Per rocce si intendono aggregati di minerali cristallini, a volte con presenza di sostanze amorfe. La maggior parte delle rocce è formata da minerali diversi; più raramente le rocce sono formate
Carta dei Suoli. del Veneto. in scala 1:
 Carta dei Suoli del Veneto in scala 1:250.000 in scala 1:250.000 VERSIONE 2015 VERSIONE 2015 LA CARTA DEI SUOLI DEL VENETO IN SCALA 1:250.000 pag. 3 GUIDA ALLA LEGENDA pag. 3 LEGENDA pag. 7 Province di
Carta dei Suoli del Veneto in scala 1:250.000 in scala 1:250.000 VERSIONE 2015 VERSIONE 2015 LA CARTA DEI SUOLI DEL VENETO IN SCALA 1:250.000 pag. 3 GUIDA ALLA LEGENDA pag. 3 LEGENDA pag. 7 Province di
TERRITORI VINCOLATI DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985 DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO LAMA SAN GIORGIO- LAMA GIOTTA
 TERRITORI VINCOLATI DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985 DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO LAMA SAN GIORGIO- LAMA GIOTTA Il territorio delle Lame riveste notevole interesse perché è caratterizzato
TERRITORI VINCOLATI DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985 DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO LAMA SAN GIORGIO- LAMA GIOTTA Il territorio delle Lame riveste notevole interesse perché è caratterizzato
Le province di suoli dei rilievi alpini
 Le province di suoli dei rilievi alpini PROVINCIA DI SUOLI - MA Alti versanti e porzioni sommitali dei rilievi alpini, a morfologia arrotondata, con diffuse coperture glaciali, su rocce del basamento metamorfico,
Le province di suoli dei rilievi alpini PROVINCIA DI SUOLI - MA Alti versanti e porzioni sommitali dei rilievi alpini, a morfologia arrotondata, con diffuse coperture glaciali, su rocce del basamento metamorfico,
a) SEDIMENTI CONTINENTALI QUATERNARI del BACINO del MERCURE LAO.
 Relazione Geologica Integrativa relativa alle litologie potenzialmente contenenti amianto per Concessione per derivazione di acqua superficiale per uso idroelettrico nel Comune di Castelluccio Inf. Committente:
Relazione Geologica Integrativa relativa alle litologie potenzialmente contenenti amianto per Concessione per derivazione di acqua superficiale per uso idroelettrico nel Comune di Castelluccio Inf. Committente:
Copyright Esselibri S.p.A.
 CAPITOLO NONO LA GEOMORFOLOGIA Sommario: 1. Il modellamento della crosta terrestre. - 2. Alterazioni fisiche e chimiche delle rocce. - 3. La gravità come agente erosivo. - 4. La formazione del suolo. 1.
CAPITOLO NONO LA GEOMORFOLOGIA Sommario: 1. Il modellamento della crosta terrestre. - 2. Alterazioni fisiche e chimiche delle rocce. - 3. La gravità come agente erosivo. - 4. La formazione del suolo. 1.
Localizzazione. Regione Piemonte azienda dimostrativa MOSCA. azienda agricola dimostra Paolo Maria Mosca loc. C.na Cesiola Vecchia Crescentino (VC)
 Localizzazione azienda agricola dimostra Paolo Maria Mosca loc. C.na Cesiola Vecchia Crescentino (VC) area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA I suoli dell Azienda sono
Localizzazione azienda agricola dimostra Paolo Maria Mosca loc. C.na Cesiola Vecchia Crescentino (VC) area di progetto (soil region di Italia: 18.7-18.8) I SUOLI DELL AZIENDA I suoli dell Azienda sono
Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico
 AUTORITA' di BACINO del RENO Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI Zonizzazione Aree a Rischio SCHEDA N. 145 Località:
AUTORITA' di BACINO del RENO Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i. I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI Zonizzazione Aree a Rischio SCHEDA N. 145 Località:
Processi degradativi dei suoli nelle regioni pedologiche italiane, a cura di Edoardo A.C. Costantini e Gaia Righini 1
 1 2.1. Processi degradativi dei suoli nelle regioni pedologiche italiane, a cura di Edoardo A.C. Costantini e Gaia Righini 1 2.1.1. Introduzione L'orientamento della politica agricola dell' Unione Europea
1 2.1. Processi degradativi dei suoli nelle regioni pedologiche italiane, a cura di Edoardo A.C. Costantini e Gaia Righini 1 2.1.1. Introduzione L'orientamento della politica agricola dell' Unione Europea
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
 di Morbin Francesco e C. REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA COMUNE DI ISOLA VICENTINA Domanda di ricerca d acqua da falda sotterranea (R.D. n.1775/33) Richiedente Ubicazione AVI ZEN Società agricola semplice
di Morbin Francesco e C. REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA COMUNE DI ISOLA VICENTINA Domanda di ricerca d acqua da falda sotterranea (R.D. n.1775/33) Richiedente Ubicazione AVI ZEN Società agricola semplice
Analisi suolo e sottosuolo
 Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
Analisi suolo e sottosuolo Atelier città paesaggio 2015/2016 Gruppo 02 Gruppo 16 Andrea Verzini Giacomo De Caro Niccolò Antonielli Pia Fleischer Simone Valbusa Anca Spiridon Alexia Brodu Matija Perić Rischio
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
I rilievi. Mondadori Education
 I rilievi I rilievi italiani che superano i 600 m di altezza sono suddividi tra le Alpi, che si estendono da ovest a est nella parte settentrionale della penisola, e gli Appennini, che invece la attraversano
I rilievi I rilievi italiani che superano i 600 m di altezza sono suddividi tra le Alpi, che si estendono da ovest a est nella parte settentrionale della penisola, e gli Appennini, che invece la attraversano
COMUNE DI SAN VERO MILIS
 RELAZIONE AGRONOMICA "$" % & ' ( ) * ' +,,, - 1 RELAZIONE AGRONOMICA (./01) + 2, 2, 3 4 5 )64.7789 ' $ 5 9, 2 RELAZIONE AGRONOMICA : ' $ ( $ ; 3/? 3 "$ ( ( @8A0 59B8B053
RELAZIONE AGRONOMICA "$" % & ' ( ) * ' +,,, - 1 RELAZIONE AGRONOMICA (./01) + 2, 2, 3 4 5 )64.7789 ' $ 5 9, 2 RELAZIONE AGRONOMICA : ' $ ( $ ; 3/? 3 "$ ( ( @8A0 59B8B053
Geomorfologia Eolica
 Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
Geomorfologia Eolica Forme determinate dall azione del vento Duna: rilievo di sabbia costruito dal vento Tipi più comuni di dune Barcana: duna isolata che in pianta assomiglia ad una mezzaluna Esempi di
CARNEVALE franco-grossolana, fase tipica CNL1
 CARNEVALE franco-grossolana, fase tipica CNL1 Distribuzione geografica e pedoambiente Lungo tutto il corso del Tanaro, poco dopo la confluenza dello Stura da S. Vittoria d'alba (CN) verso nord fino ad
CARNEVALE franco-grossolana, fase tipica CNL1 Distribuzione geografica e pedoambiente Lungo tutto il corso del Tanaro, poco dopo la confluenza dello Stura da S. Vittoria d'alba (CN) verso nord fino ad
INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE...
 1. PREMESSA... 2 2. OBIETTIVI... 3 3. INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE... 5 3.1 Inquadramento geologico del tracciato con particolare riferimento alla stratigrafia... 6 3.1.1 Geomorfologia... 6 3.1.2 Geologia
1. PREMESSA... 2 2. OBIETTIVI... 3 3. INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE... 5 3.1 Inquadramento geologico del tracciato con particolare riferimento alla stratigrafia... 6 3.1.1 Geomorfologia... 6 3.1.2 Geologia
Per rocce si intendono aggregati di minerali La maggior parte delle rocce è formata da minerali diversi; ;più raramente le rocce sono formate da un
 LE ROCCE Per rocce si intendono aggregati di minerali La maggior parte delle rocce è formata da minerali diversi; ;più raramente le rocce sono formate da un solo minerale Le rocce si classificano in tre
LE ROCCE Per rocce si intendono aggregati di minerali La maggior parte delle rocce è formata da minerali diversi; ;più raramente le rocce sono formate da un solo minerale Le rocce si classificano in tre
sponda Terrazzo Piana alluvionale Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo barra isola Canale di magra
 Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
Terrazzo Piana alluvionale Alveo attivo sponda Terrazzo Piana alluvionale barra isola Canale di magra Canale di magra: parte dell alveo che risulta totalmente o parzialmente ricoperta di acqua per la maggior
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI
 DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
La montagna. Ghiacciai. Clima e vegetazione
 La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
La montagna Le montagne sono disposte in modo ordinato lungo una catena montuosa o in un massiccio (non in linea). I rilievi sono costituiti da versanti delimitati in cima dai crinali (o spartiacque) e
Regione EMILIA ROMAGNA. azienda agricola dimostrativa CAVALLINI
 Localizzazione azienda agricola dimostrativa CAVALLINI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura deltizia superiore in aree di dosso costruite dai rami distributori del
Localizzazione azienda agricola dimostrativa CAVALLINI area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata nella pianura deltizia superiore in aree di dosso costruite dai rami distributori del
1. PREMESSA. Le schede monografiche dedicate alle aree urbanistiche sono in totale 30.
 2 1. PREMESSA Per ciascuna delle aree interessate da nuovi insediamenti, individuate sulla base delle scelte urbanistiche, è stata compilata una scheda monografica, seguendo le indicazioni contenute nella
2 1. PREMESSA Per ciascuna delle aree interessate da nuovi insediamenti, individuate sulla base delle scelte urbanistiche, è stata compilata una scheda monografica, seguendo le indicazioni contenute nella
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005)
 SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
SCHEDE DESCRITTIVE DI SINTESI SITI POTENZIALMENTE IDONEI PER IMPIANTI DI TRASFERENZA (gennaio 2005) AREA DI STUDIO 1 Stralcio ubicazione UBICAZIONE E ACCESSIBILITA L area è situata in comune di Spigno
Carta dei Suoli. del Veneto. Catalogo dei suoli ARPAV. Carta dei Suoli del Veneto - Catalogo dei suoli. Agenzia Regionale per la Prevenzione e
 ARPAV ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Direzione Generale Via Matteotti, 27 35137 Padova (Italy) Tel. +39 049 823 93 41-354 Fax +39 049 660 966 e-mail: dg@arpa.veneto.it
ARPAV ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Direzione Generale Via Matteotti, 27 35137 Padova (Italy) Tel. +39 049 823 93 41-354 Fax +39 049 660 966 e-mail: dg@arpa.veneto.it
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari 2 INDICE PREMESSA Tali indagini hanno lo scopo dell accertamento e della verifica delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei
FUSINA S.R.L. INDAGINI NEL SOTTOSUOLO
 FUSINA S.R.L. INDAGINI NEL SOTTOSUOLO COMMITTENTE : CENTRO GRAFICO DG SPA MARCALLO CON CASONE (MI) 1844_13 RELAZIONE IDROGEOLOGICA DI DETTAGLIO IN SUPPORTO AL PROGETTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE A MARCALLO
FUSINA S.R.L. INDAGINI NEL SOTTOSUOLO COMMITTENTE : CENTRO GRAFICO DG SPA MARCALLO CON CASONE (MI) 1844_13 RELAZIONE IDROGEOLOGICA DI DETTAGLIO IN SUPPORTO AL PROGETTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE A MARCALLO
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Servizio Meteorologico. Precipitazioni sul Veneto. Anno Francesco Rech Irene Delillo
 Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Servizio Meteorologico Precipitazioni sul Veneto Francesco Rech Irene Delillo Anno 2013 Precipitazioni anno 2013 considerazioni generali Nell anno
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Servizio Meteorologico Precipitazioni sul Veneto Francesco Rech Irene Delillo Anno 2013 Precipitazioni anno 2013 considerazioni generali Nell anno
AGLIANO argilloso-fine, fase tipica AGL1
 AGLIANO argilloso-fine, fase tipica AGL1 Distribuzione geografica e pedoambiente Rilievi collinari più o meno simmetrici, con crinali allungati e versanti con pendenza molto lieve ma regolare; le valli
AGLIANO argilloso-fine, fase tipica AGL1 Distribuzione geografica e pedoambiente Rilievi collinari più o meno simmetrici, con crinali allungati e versanti con pendenza molto lieve ma regolare; le valli
Regione Lombardia azienda dimostrativa CARPANETA. Localizzazione. azienda agricola dimostrativa ERSAF Carpaneta. area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA
 Localizzazione azienda agricola dimostrativa ERSAF Carpaneta area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata su superfici del livello fondamentale della pianura nell area di contatto tra
Localizzazione azienda agricola dimostrativa ERSAF Carpaneta area di progetto I SUOLI DELL AZIENDA L azienda è localizzata su superfici del livello fondamentale della pianura nell area di contatto tra
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESISTICA E AMBIENTALE AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA)
 AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
AFFIORAMENTI DI CONGLOMERATO PRESSO PORTO D ADDA (COMUNE DI CORNATE D ADDA) Particolare di paleosuolo (presso Porto d Adda) NOME LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO Affioramenti
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 1 ART. 6 LR N.11/2004 PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE DI SAN PIETRO IN ANTIOCHIA Area residenziale ZTO A Centro Storico VALUTAZIONE
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 1 ART. 6 LR N.11/2004 PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE DI SAN PIETRO IN ANTIOCHIA Area residenziale ZTO A Centro Storico VALUTAZIONE
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 8 ART. 6 LR N.11/2004 Sigg. ANDRIAN FLAVIO e SARTORI ANNALISA Area residenziale e commerciale ZTO C2A_8b comparto 4 VALUTAZIONE
PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO N. 8 ART. 6 LR N.11/2004 Sigg. ANDRIAN FLAVIO e SARTORI ANNALISA Area residenziale e commerciale ZTO C2A_8b comparto 4 VALUTAZIONE
b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Localizzazione geografica e morfologia del corpo idrico
 corpo idrico sotterraneo: Lentinese b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Localizzazione geografica e morfologia del corpo idrico Localizzazione geografica Si estende in affioramento
corpo idrico sotterraneo: Lentinese b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche. Localizzazione geografica e morfologia del corpo idrico Localizzazione geografica Si estende in affioramento
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1
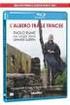 Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
Cenni Idrologia Friuli Venezia Giulia 2014 PAS 059 1 Notare: 1 aree carsiche senza idrografia sup 2 area centrale apparentemente senza drenaggio??? 4 serie di fiumi che iniziano in pianura 2 Isonzo Vipacco,
1. PREMESSA IL PROGETTO ANALISI AMBIENTALE...
 Pozzo Cascina Daga 1 dir Studio di Impatto Ambientale Relazione Ambientale Terre e Rocce da Scavo 1. PREMESSA... 3 2. IL PROGETTO... 3 3. ANALISI AMBIENTALE... 5 3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO... 5 3.2.
Pozzo Cascina Daga 1 dir Studio di Impatto Ambientale Relazione Ambientale Terre e Rocce da Scavo 1. PREMESSA... 3 2. IL PROGETTO... 3 3. ANALISI AMBIENTALE... 5 3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO... 5 3.2.
LE ROCCE. Dott.ssa geol. Annalisa Antonelli
 LE ROCCE DEFINIZIONE ROCCIA: aggregato naturale di sostanze minerali cristalline o amorfe Rocce omogenee: costituite da un solo tipo di minerale (es. roccia gessosa, roccia calcarea, salgemma) Rocce eterogenee:
LE ROCCE DEFINIZIONE ROCCIA: aggregato naturale di sostanze minerali cristalline o amorfe Rocce omogenee: costituite da un solo tipo di minerale (es. roccia gessosa, roccia calcarea, salgemma) Rocce eterogenee:
LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO.
 METEO E CLIMA LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO. Si riporta una breve sintesi della situazione meteorologica registrata con alcuni dati più significativi e confronti
METEO E CLIMA LE PRECIPITAZIONI ALLUVIONALI DEL 30 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2014 IN VENETO. Si riporta una breve sintesi della situazione meteorologica registrata con alcuni dati più significativi e confronti
INDAGINI GEO-ELETTRICHE
 INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
INDAGINI GEO-ELETTRICHE Il metodo di indagine geoelettrica multielettrodo consiste nel ricostruire la distribuzione della resistività reale del sottosuolo mediante immissione di corrente elettrica e misura
sedimenti, realizzando adattamenti morfologici (dimensioni, forma, tracciato,
 CAPITOLO 1 ELEMENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE In un progetto di gestione e riqualificazione di un corso d acqua la conoscenza delle problematiche e dei processi fisici e biologici, è la base per poter
CAPITOLO 1 ELEMENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE In un progetto di gestione e riqualificazione di un corso d acqua la conoscenza delle problematiche e dei processi fisici e biologici, è la base per poter
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA =============== Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II TRAVERSA VIA ELENA 1. PREMESSA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA =============== Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE II TRAVERSA VIA ELENA 1. PREMESSA
Cartografia geologica e microzonazione sismica
 Sala A conferenze, Terza Torre - 19 aprile 12 MICROZONAZIONE SISMICA UNO STRUMENTO CONSOLIDATO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO L esperienza della Regione Emilia-Romagna Cartografia geologica e microzonazione
Sala A conferenze, Terza Torre - 19 aprile 12 MICROZONAZIONE SISMICA UNO STRUMENTO CONSOLIDATO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO L esperienza della Regione Emilia-Romagna Cartografia geologica e microzonazione
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)
 Cell. 333/5398952 e-mail: studiogeosc@gmail.com Via Michele Latorre, 82/B 70013 Castellana Grotte (BA) COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) RELAZIONE GEOLOGICA IN MERITO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN
Cell. 333/5398952 e-mail: studiogeosc@gmail.com Via Michele Latorre, 82/B 70013 Castellana Grotte (BA) COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) RELAZIONE GEOLOGICA IN MERITO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN
Il fenomeno carsico. Carsismo: Insieme dei processi di dissoluzione chimica delle rocce calcaree da parte delle acque
 Il carsismo Il fenomeno carsico Carsismo: Insieme dei processi di dissoluzione chimica delle rocce calcaree da parte delle acque Il carso è una regione geografica a confine tra Italia e Slovenia Le rocce
Il carsismo Il fenomeno carsico Carsismo: Insieme dei processi di dissoluzione chimica delle rocce calcaree da parte delle acque Il carso è una regione geografica a confine tra Italia e Slovenia Le rocce
IL SUOLO. Introduzione. Inquadramento pedologico della provincia di Belluno
 IL SUOLO Introduzione Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002 Il suolo è una risorsa vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni. L importanza della
IL SUOLO Introduzione Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002 Il suolo è una risorsa vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni. L importanza della
SUOLO IL SUOLO LUNGO IL PASSANTE: UNA PREZIOSA RISORSA DA SALVAGUARDARE INQUADRAMENTO DEI SUOLI DELL AREA DEL PASSANTE
 SUOLO IL SUOLO LUNGO IL PASSANTE: UNA PREZIOSA RISORSA DA SALVAGUARDARE La costruzione di una grande infrastruttura stradale come il Passante di Mestre comporta necessariamente la rinuncia per l intera
SUOLO IL SUOLO LUNGO IL PASSANTE: UNA PREZIOSA RISORSA DA SALVAGUARDARE La costruzione di una grande infrastruttura stradale come il Passante di Mestre comporta necessariamente la rinuncia per l intera
La degradazione meteorica
 La Degradazione meteorica chimica (alterazione) comporta un cambiamento nella natura chimica delle rocce, con formazione di nuove sostanze Acqua piovana (idratazione) La degradazione meteorica Ossigeno
La Degradazione meteorica chimica (alterazione) comporta un cambiamento nella natura chimica delle rocce, con formazione di nuove sostanze Acqua piovana (idratazione) La degradazione meteorica Ossigeno
Il rilevamento geologico dei depositi alluvionali e marino marginali pleistocenici e olocenici dell Appennino settentrionale e della pianura padana
 Il rilevamento geologico dei depositi alluvionali e marino marginali pleistocenici e olocenici dell Appennino settentrionale e della pianura padana Paolo Severi marzo 2018 1 La cartografia geologica d
Il rilevamento geologico dei depositi alluvionali e marino marginali pleistocenici e olocenici dell Appennino settentrionale e della pianura padana Paolo Severi marzo 2018 1 La cartografia geologica d
LE ACQUE SOTTERRANEE
 LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
LE ACQUE SOTTERRANEE Le forme dell acqua In un territorio alpino l acqua è presente come: ghiacciaio ad alta quota acqua corrente nei fiumi e nei torrenti acqua ferma nei laghi acqua fluente nel sottosuolo
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo
 Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Nuova zonazione sismica e procedure per la valutazione degli effetti sismici di sito nel territorio lombardo F. Pergalani, M. Compagnoni, M.P. Boni Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
COMUNE DI CAPOLONA PROVINCIA DI AREZZO. Progetto: Piano di Recupero in zona A. Committente: Amministrazione Comunale di Capolona.
 Dott. Franco Bulgarelli - Geologo - Via del Gavardello n 73 (Arezzo) /fax - 0575/380676 E-mail: frageo@inwind.it COMUNE DI CAPOLONA PROVINCIA DI AREZZO Progetto: Piano di Recupero in zona A. Località:
Dott. Franco Bulgarelli - Geologo - Via del Gavardello n 73 (Arezzo) /fax - 0575/380676 E-mail: frageo@inwind.it COMUNE DI CAPOLONA PROVINCIA DI AREZZO Progetto: Piano di Recupero in zona A. Località:
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
 COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Elab. Redazione: Dott. Geol. Francesco Morbin Via Natisone, 50/A - 35100 PADOVA Tel. 049/631083-8644379 - 0335/5289131 ETRA S.p.A. si riserva la proprieta' del disegno, vietandone
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Elab. Redazione: Dott. Geol. Francesco Morbin Via Natisone, 50/A - 35100 PADOVA Tel. 049/631083-8644379 - 0335/5289131 ETRA S.p.A. si riserva la proprieta' del disegno, vietandone
ROVASENDA limoso-fine, fase anthraquica RVS2
 ROVASENDA limoso-fine, fase anthraquica RVS2 Distribuzione geografica e pedoambiente Questo suolo è presente su estese superfici ondulate ed incise, che rappresentano i residui di una pianura molto antica
ROVASENDA limoso-fine, fase anthraquica RVS2 Distribuzione geografica e pedoambiente Questo suolo è presente su estese superfici ondulate ed incise, che rappresentano i residui di una pianura molto antica
