Studio sulle specie di Phytophthora presenti in ambienti forestali della Sardegna
|
|
|
- Gilberta Giglio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Università degli Studi di Sassari SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA Scienze dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari Indirizzo Monitoraggio e Controllo degli ecosistemi forestali in Ambiente Mediterraneo Ciclo XXII Studio sulle specie di Phytophthora presenti in ambienti forestali della Sardegna Dott. Bruno Scanu Direttore della Scuola: Referente di Indirizzo Docente Guida prof. Giuseppe Pulina prof. Antonio Franceschini prof. Antonio Franceschini Anno accademico
2 INDICE INDICE 1. INTRODUZIONE pag MALATTIE ENDEMICHE ED EPIDEMICHE DELLE PIANTE FORESTALI I PATOGENI ESOTICI E INVASIVI I SISTEMI DI PREVENZIONE 7 2. STATO DELL ARTE IL GENERE PHYTOPHTHORA CICLO BIOLOGICO SPECIE INVASIVE DI PHYTOPHTHORA SPECIE DI PHYTOPHTHORA IN ITALIA: NATURA E DIFFUSIONE SCOPO DELLA TESI MATERIALI E METODI SITI D INDAGINE VALUTAZIONE DELLO STATO SANITARIO DI POPOLAMENTI DI CASTAGNO E DI LECCIO CAMPIONAMENTI SUBSTRATI DI CRESCITA METODI D ISOLAMENTO DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA IDENTIFICAZIONE DEGLI ISOLATI DI PHYTOPHTHORA CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA ACCRESCIMENTO MICELIARE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA COMPORTAMENTO SESSUALE CARATTERIZZAZIONE BIOMOLECOLARE SAGGI DI PATOGENICITÀ PRODUZIONE IN VITRO DI METABOLITI SECONDARI FITOTOSSICI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA ELABORAZIONE DEI DATI RISULTATI INDAGINE NEI CASTAGNETI STATO SANITARIO DEI POPOLAMENTI ISOLAMENTO, IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA 43 i
3 INDICE ATTIVITÀ PATOGENETICA ATTIVITÀ FITOTOSSICA INDAGINE NEI QUERCETI STATO SANITARIO DEI POPOLAMENTI ISOLAMENTO, IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA SISTEMI RIPARI STATO SANITARIO DEI POPOLAMENTI ISOLAMENTO, IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA VIVAI FORESTALI STATO SANITARIO DEI POPOLAMENTI ISOLAMENTO, IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA PATOGENICITÀ DELLE SPECIE DI PHYTOPHTHORA ISOLATE DISCUSSIONE E CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA RIASSUNTO ABSTRACT ii
4 INTRODUZIONE 1. INTRODUZIONE 1.1 Malattie endemiche ed epidemiche delle piante forestali Lo sviluppo del bosco è assicurato anche da una salutare quantità di malattia che consente di eliminare le piante meno vigorose, facilitando nel contempo la successione vegetale (Manion, 1991). In questo contesto si inquadrano le malattie endemiche, causate dai vari parassiti che nel tempo si sono co-evoluti con i loro ospiti nei diversi ecosistemi forestali. Ovviamente una rottura di tale equilibrio dovuta a cause antropiche o naturali può comportare il superamento di quella soglia di malattia oltre la quale un fatto morboso non è più funzionale all evoluzione del bosco, ma ne determina il progressivo degrado assumendo caratteri epidemici. Già Hartig nel 1891 e prima di lui altri fitopatologi francesi dell 800 (D Arbois de Jubainville, Rousseau), affermavano che la recrudescenza delle malattie nei popolamenti forestali era in larga misura una conseguenza dei cambiamenti silvocolturali operati dall uomo per migliorare la produzione legnosa dei boschi. Ciò attraverso la messa a coltura di piante forestali in ambienti naturali o seminaturali, con rimboschimenti artificiali a scopo protettivo e produttivo, con l introduzione da altri paesi o continenti di specie arboree più produttive, ma spesso anche più suscettibili agli attacchi parassitari. Tra le cause naturali che possono influenzare la stabilità degli ecosistemi, di sicuro sono da annoverare le modificazioni del clima, ma anche situazioni pedologiche deteriorate o un aumento progressivo dell inquinamento ambientale. Tali condizioni oltre a provocare danneggiamenti specifici alle piante, possono causare nelle stesse forti squilibri fisiologici con allontanamento dal loro livello metabolico ottimale. Questo stato delle piante, comunemente definito con il termine di stress (Matta e Pennazio, 1984), identifica una condizione di sofferenza vegetativa che a seconda dell intensità, frequenza e durata dei fattori avversi coinvolti, può essere elastica, cioè reversibile, ovvero plastica con insorgenza di veri e propri stati patologici, riduzione di efficienza 1
5 INTRODUZIONE funzionale, perdita di produttività, alterazione di sviluppo, disseccamenti e infine morte delle piante. Scenari di questo tipo si sono sempre manifestati nei soprassuoli forestali mediterranei, ma nel corso degli ultimi decenni hanno assunto più spesso caratteri epidemici, principalmente a seguito dei mutamenti climatici intervenuti, in particolare, dell aumento progressivo della temperatura media e dell alterazione del regime delle precipitazioni annuali. Tali condizioni, infatti, da un lato hanno indotto nelle piante stati di stress idrico, limitandone la tolleranza alle avversità, dall altro hanno influenzato la bio-ecologia di molti parassiti, in particolare di quelli più termofili (per es. molti funghi patogeni agenti di cancri e disseccamenti appartenenti alle famiglie delle Botryosphaeriaceae e Xylariaceae, e altri pericolosi patogeni sia della chioma come Ceratocystis e Chalara agenti di avvizzimenti, sia tellurici come le Phytophthorae agenti di marciumi radicali e del colletto ) che si sono avvantaggiati dell aumento termico per espandere il loro areale di distribuzione o ampliare la gamma di specie ospiti, per riprodursi più velocemente incrementando le sorgenti di inoculo, per esprimere al meglio del loro potenziale genetico tutta la loro aggressività e virulenza (Franceschini et al. 1999, 2004; Moricca e Panconesi, 2000; Desprez- Loustau et al., 2006; Gonthier et al., 2006; Jurc e Ogris, 2006; Linaldeddu et al., 2007, 2009, 2010b; Slippers e Wingfield, 2007; La Porta et al., 2008; Vannini et al., 2009). Le malattie che si sviluppano di conseguenza e la cui incidenza negli ecosistemi forestali è aumentata negli ultimi anni vengono comunemente definite malattie emergenti (Damsteegt, 1999). Tale termine comprende le malattie nuove, le malattie endemo-epidemiche e le malattie potenzialmente pericolose. Le malattie nuove sono quelle segnalate per la prima volta su un nuovo ospite e/o in una nuova area geografica; le endemo-epidemiche sono malattie già note in un'area geografica ma diventate improvvisamente epidemiche; le malattie potenzialmente pericolose sono invece quelle che non sono state ancora segnalate in un'area geografica, oppure lo sono state ma con 2
6 INTRODUZIONE una distribuzione molto limitata; tra queste rientrano le malattie causate dai cosiddetti patogeni da quarantena. A queste tipologie di malattie caratterizzate da un rapporto univoco tra patogeno e ospite, si aggiungono negli ecosistemi forestali quelle definite complesse o ad eziologia complessa. Sono infatti causate dall interazione di più fattori avversi (abiotici, biotici e antropici) che agiscono in concomitanza o in successione inducendo nelle piante stati progressivi di sofferenza vegetativa fino a determinarne la morte (Manion, 1991). La peculiarità di queste malattie è dovuta al fatto che nessuno dei fattori coinvolti, se preso singolarmente e applicato a piante sane, è in grado di riprodurre la stessa sindrome osservata in bosco. Inoltre, la loro insorgenza negli ecosistemi forestali non si limita a compromettere la componente vegetazionale, ma comporta l avvio di forme di degrado via via più gravi con perdita di biodiversità e semplificazione degli stessi. Non a caso queste malattie, di difficile definizione a causa della variabilità per tipo, intensità, frequenza e durata dei fattori avversi che possono essere coinvolti nelle diverse realtà forestali, vengono genericamente indicate col termine di deperimento del bosco (Anselmi e Franceschini, 2007). Attualmente esse, per le ampie aree geografiche sulle quali si manifestano, le numerose specie forestali implicate, la loro complessità eziologica e le conseguenti difficoltà che sussistono nel definire e applicare misure efficaci di prevenzione, rappresentano uno dei principali problemi, se non il principale problema sanitario delle formazioni forestali a livello mondiale. 3
7 INTRODUZIONE 1.2 I patogeni esotici e invasivi Una delle cause principali di sviluppo di epidemie negli ecosistemi forestali è sicuramente rappresentata dall introduzione e diffusione di patogeni esotici in aree che ne sono prive (Desprez-Loustau et al., 2007; Cushman e Meentemeyer, 2008). L introduzione può avvenire attraverso diversi mezzi, principalmente tramite piante asintomatiche, suolo compreso, o con piante malate non diagnosticate correttamente (Brasier, 2008). I patogeni, una volta introdotti in un nuovo ambiente, possono trovare condizioni ottimali per sopravvivere, svilupparsi, riprodursi e diffondersi in forma epidemica con effetti detrimentosi, soprattutto se favoriti sia dalla mancanza di resistenze efficaci da parte di ospiti nuovi che non si sono co-evoluti col patogeno, sia dalla presenza di nuovi vettori indigeni o anch essi esotici. Altrettanto dannose e devastanti possono essere le conseguenze legate alla ricombinazione di specie correlate, autoctone ed esotiche, con la possibile formazione di patogeni nuovi o modificati dotati di maggiore virulenza e/o in grado di ampliare lo spettro d ospiti (Brasier e Delcan, 2001). La storia fitopatologica è ricca di esempi di epidemie gravi causate in seguito all introduzione e successiva diffusione di patogeni esotici sia in campo agrario che in quello forestale. In ambito agrario, uno degli eventi epidemici più eclatanti fu causato da Phytophthora infestans, agente della peronospora della patata, introdotto in Europa dal continente americano. L epidemia si verificò intorno alla metà del 1800 e causò la distruzione di estese coltivazioni di patate in tutto il centro Europa, con ripercussioni gravissime sulle popolazioni rurali, in quanto le patate costituivano all epoca la principale fonte di sostentamento (Fry et al., 1992; Smart e Fry, 2001). In ambito forestale, e quindi in ambienti naturali o semi-naturali dove la biodiversità è molto più elevata rispetto agli ambienti agrari, l introduzione accidentale di parassiti che nel loro areale di origine sono del tutto inoffensivi, può avere conseguenze imprevedibili legate alle maggiori opportunità che gli 4
8 INTRODUZIONE stessi hanno di incontrare nei nuovi ambienti vari ospiti potenzialmente suscettibili o di trovare condizioni climatiche più favorevoli per svilupparsi o per esprimere tutta la loro virulenza. Un esempio in tal senso è rappresentato dal fungo Diplodia scrobiculata, presente come parassita di equilibrio nell areale d origine del Pinus radiata in California (USA), che si è manifestato come un patogeno altamente virulento sullo stesso ospite e su altri ospiti in Europa e Sud Africa (Burgess et al., 2004; Linaldeddu et al., 2006; Bihon et al., 2010; Linaldeddu et al., 2010a). In Italia, la gran parte dei patogeni forestali esotici sono stati introdotti dalle Americhe nel corso del XX secolo, in seguito all intensificazione dei rapporti commerciali e all uso di mezzi di trasporto più veloci che consentivano agli stessi di mantenersi vivi nei materiali vegetali trasferiti da un continente all altro (Anselmi, 1992). In tal modo arrivarono nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, due patogeni altamente virulenti: Cryphonectria parasitica agente del cancro corticale del castagno e Ophiostoma ulmi agente della grafiosi dell olmo. Essi nel giro di pochi anni si diffusero in tutte le regioni italiane causando devastazioni nei popolamenti dei rispettivi ospiti. I danni causati da C. parasitica hanno contribuito all abbandono della castanicoltura in vaste aree del Paese e alla conseguente crisi del settore. I danni da grafiosi sono aumentati in epoca più recente in seguito a una seconda ondata epidemica della malattia, questa volta causata da un ceppo più virulento del patogeno (Ophiostoma novo-ulmi), anch esso introdotto attraverso l importazione di legname e prodotti derivati infetti (Brasier e Kirk, 2001b). Nei primi anni 50 fece la sua comparsa il Seiridium cardinale, agente del cancro del cipresso, che causò disseccamenti e morie di piante in ambito urbano, nei parchi periurbani e nei cipresseti. Nel 1963 fu segnalato per la prima volta un pericoloso patogeno del pioppo: Marssonina brunnea, agente della bronzatura, che da allora continua a rappresentare un problema serio per la pioppicoltura italiana. Nel 1970 e nel 1976 furono introdotti due dannosi patogeni del platano, rispettivamente: Ceratocystis fimbriata f. sp. platani agente del cancro colorato e Microsphaera platani agente del mal bianco. 5
9 INTRODUZIONE Tra gli altri patogeni esotici rivelatisi deleteri in Italia assumono rilevanza: Sirococcus strobilinus, un pericoloso patogeno del pino introdotto nel 1992, ed Erwinia amylovora agente del fuoco batterico delle pomoidee, riscontrato per la prima volta nel Attualmente, tra i diversi patogeni esotici di recente introduzione in Italia e non ancora ampiamente diffusi nei soprassuoli forestali, costituiscono una serie minaccia: - Chalara fraxinea: agente di disseccamenti e morie di alberi di Fraxinus spp. Tale patogeno, è stato segnalato per la prima volta in Polonia (Kowalski, 2006) e si è rapidamente diffuso in diversi paesi dell Europa centrale provocando ingenti danni sia in bosco che in vivaio. La sua presenza in regioni del Nord Italia è stata segnalata nel 2010 da Ogris e coll. (2010). - Phytophthora cinnamomi: uno dei patogeni più temuti a livello mondiale quale agente di marciumi radicali e del colletto di numerose specie forestali. In Australia è stata segnalata su circa 3000 delle 9000 specie vascolari presenti nel Paese ed è considerato come una seria minaccia per la biodiversità degli ecosistemi naturali australiani (Dunstan et al., 2010). - Phytophthora ramorum: patogeno della parte aerea delle piante e causa di estese morie di Quercus spp. in America. Nel nostro Paese la sua presenza è stata segnalata finora solo in vivaio. A questo proposito appare opportuno sottolineare che proprio i vivai rappresentano gli ambienti più a rischio per quanto riguarda l introduzione di nuove specie patogene. Ciò è dovuto al fatto che in tali ambienti confluiscono varie specie vegetali importate da aree geografiche diverse. Inoltre, le piante vi vengono coltivate in modo intensivo, creando condizioni ideali per lo sviluppo e la diffusione di patogeni anche su specie vegetali che in natura non sono loro ospiti preferenziali (Jung e Blashke, 2006). Peraltro, le infezioni di molti patogeni in vivaio restano asintomatiche per lunghi periodi di tempo, per cui sussiste un elevato rischio di diffusione inconsapevole da parte degli acquirenti di materiale vegetale infettivo in ambienti forestali diversi. È anche vero che la sola presenza di materiale vegetale infetto in vivaio, rappresenta di per se un 6
10 INTRODUZIONE problema. Infatti, in mancanza di interventi di eradicazione del patogeno o comunque di contenimento del suo potenziale d inoculo, le aree utilizzate per lo stoccaggio di materiale vegetale possono rappresentare un importante sorgente di inoculo di svariati patogeni potenzialmente in grado di diffondersi in altre aree del vivaio e all esterno (Brasier et al., 2005). Ciò, ovviamente, risulta molto pericoloso se i vivai sono ubicati in vicinanza di aree boschive. Tale rischio, come sottolineato in numerose comunicazioni presentate all ultimo Convegno Internazionale di Patologia vegetale (ICPP, 2008), è particolarmente grave nel caso dei patogeni terricoli veicolati con i substrati di coltivazione. Tra questi patogeni assumono rilevanza soprattutto quelli afferenti al genere Phytophthora. In un lavoro recentemente pubblicato, Moralejo e coll. (2009) hanno riscontrato in diversi vivai e nei garden centers della Spagna, la presenza di 17 specie di Phytophthora su 37 nuovi ospiti. Ben cinque di queste specie sono risultate nuove per la scienza. I risultati di questa indagine rappresentano un classico esempio di diffusione di microrganismi patogeni attraverso il commercio di piante in Europa e allo stesso tempo comprovano il fatto che numerose specie di Phytophthora, in virtù della loro polifagia, possono costituire una seria minaccia per gli ecosistemi forestali quando introdotte attraverso attività di forestazione e/o riforestazione. Ciò anche in considerazione del fatto che questi patogeni possono essere facilmente movimentati da un ambiente all altro attraverso vari vettori tra cui l uomo, le macchine e gli animali (Shearer e Tippett, 1989; Davidson et al., 2005; Webber e Rose, 2008) I sistemi di prevenzione Allo scopo di prevenire l'introduzione e la diffusione di patogeni esotici potenzialmente pericolosi, i paesi dell Unione Europea hanno istituito l International Plant Protection Convention (IPPC). Tale organizzazione ha il compito di ispezionare tutto il materiale vegetativo da e verso i paesi comunitari e verificare la presenza di patogeni pericolosi sia nei punti di entrata che nei punti di destinazione finale di tale materiale (MacLeod et al., 2010). A livello 7
11 INTRODUZIONE nazionale ciascun Paese ha predisposto delle liste di quarantena, gestite dall'eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization), organismo responsabile della cooperazione internazionale nel settore della difesa fitosanitaria nella regione Europea e Mediterranea, che sin dagli anni '70 del secolo scorso, fornisce un elenco dei patogeni da quarantena suddivisi in due liste: A1 e A2 ( Esistono inoltre altre due liste, la prima l Alert list, include i patogeni che recentemente hanno provocato allarme in altre regioni nel mondo, mentre la seconda, l Action list, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli Stati membri, nei confronti degli organismi che sono stati inclusi recentemente nelle liste A1 e A2 o per i quali si ritiene sia necessario applicare immediate misure fitosanitarie. Il principale compito di queste istituzioni è quello di segnalare la diffusione e la movimentazione dei patogeni invasivi e di allertare i paesi membri quando è necessario attuare un programma di eradicazione. Le operazioni di eradicazione sono abbastanza semplici quando la diffusione dei microrganismi invasivi è confinata all interno dei vivai, mentre risulta ben più problematica e difficoltosa quando questa avviene in bosco dove, spesso accade che ci si accorga di un problema fitosanitario solo quando i danni sono ormai rilevanti e il patogeno si è già ampiamente diffuso. Questo è, per esempio, quello che recentemente è accaduto per le nuove specie di Phytophthora rinvenute in Europa, e dimostra nel caso specifico la necessità di aggiornare e approfondire le conoscenze scientifiche sia per quanto riguarda il monitoraggio di questi microrganismi, sia per la messa a punto di nuovi protocolli diagnostici e di controllo (Brasier, 2008). 8
12 STATO DELL ARTE 2. STATO DELL ARTE 2.1 Il genere Phytophthora La progressiva diffusione di nuovi patogeni, definiti come emergenti o invasivi, avvenuta nel corso degli ultimi decenni, rappresenta un serio pericolo per l integrità e la biodiversità di vari ecosistemi forestali (Agrios, 2005; Brasier, 2008). Tra questi assumono particolare rilevanza alcune specie afferenti al genere Phytophthora de Bary. Il genere Phytophthora dal greco phyto (pianta) e phthora (distruttore), annovera al suo interno alcuni dei patogeni più distruttivi, in grado di causare epidemie gravi e danni ingenti di natura sia economica che ambientale. Sebbene ancora oggi questi microrganismi vengano spesso inseriti tra gli organismi fungini in virtù del loro accrescimento filamentoso, studi di carattere genetico e biochimico hanno dimostrato la loro sostanziale diversità dai miceti, tanto che di recente sono stati classificati nel nuovo Regno dei Straminipila, insieme alle alghe brune e alle diatomee (Erwin e Ribeiro, 1996; Judelson e Blanco, 2005). Gli anglosassoni sono soliti indicare le Phytophthorae col termine water moulds, per sottolineare due dei caratteri distintivi di questi microrganismi e cioè la predilezione a vivere in ambienti umidi, e la differenziazione di strutture riproduttive molto simili a quelle delle alghe (Kamoun, 2003). Le Phytophthorae appartengono alla classe degli Oomiceti, organismi che presentano numerosi caratteri morfologici e biochimici differenti dai funghi veri e propri. In particolare, hanno ife diploidi con pareti cellulari costituite da cellulosa, anziché ife aploidi o dicarion con pareti cellulari chitinose tipiche dei funghi, e accumulano micolaminarano come carboidrato di riserva al posto del glicogeno accumulato nei funghi (Tab. 1). 9
13 STATO DELL ARTE Tabella 1. Principali caratteri distintivi tra Oomiceti (Regno Straminipila) e funghi (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota). Carattere Oomiceti Funghi Riproduzione sessuale Stato nucleare del micelio Fertilizzazione delle oospore con nuclei provenienti dall anteridio. Diploide Il risultato della riproduzione sessuale sono: zygospore, ascospore o basidiospore Aploide o dicarion Parete cellulare Cellulosa Chitina Tipo di flagello nelle zoospore Uno posteriore a forma di frusta e uno anteriore fibroso e cigliato Posteriormente se presente, a forma di frusta Mitocondrio Con cresta tubolare Con cresta appiattita Ciclo biologico Il ciclo biologico delle specie di Phytophthora è costituito da uno stadio vegetativo di tipo miceliare e dalla formazione di strutture di resistenza, quali i rigonfiamenti ifali (hyphal swelling), le clamidospore, e le strutture riproduttive, quali sporangi, zoospore e oospore (Fig. 1). Figura 1. Ciclo biologico della peronospora della patata, causata dai Phytophthora infestans (da Agrios, 2005, pag. 425). 10
14 STATO DELL ARTE Ognuna di queste strutture assolve a differenti funzioni biologiche: - le hyphal swelling, si formano nel micelio in modo sia intercalare che terminale e possono avere forme variabili a seconda della specie. La funzione di queste strutture non è ancora ben conosciuta, presumibilmente costituiscono degli organi di conservazione; - le clamidospore, sono le tipiche strutture di resistenza di forma globosa con pareti cellulari piuttosto spesse. Esse garantiscono la sopravvivenza della specie nel terreno, anche per lunghi periodi di tempo. Si formano nel micelio in modo sia terminale che intercalare (Fig. 2 a) assumendo forme e dimensioni molto simili fra le varie specie. In alcuni casi la forma e la dimensione delle clamidospore può rappresentare un carattere diagnostico informativo; - gli sporangi, sono le strutture di moltiplicazione agamica più caratteristiche delle Phytophthorae. Essi rivestono un ruolo chiave nell epidemiologia delle malattie causate da questi microrganismi. La morfologia degli sporangi varia considerevolmente tra le diverse specie e rappresenta un elemento tassonomico molto importante per l identificazione a livello di specie (Waterhouse, 1963; Erwin e Ribeiro, 1996). A tal fine vengono considerati la lunghezza, la larghezza, il rapporto lunghezza/larghezza, la presenza e la forma della papilla e del pedicello degli sporangi (Fig. 2 b). Nelle specie più ancestrali infeudate ad ambienti acquatici o particolarmente umidi, gli sporangi rimangono aderenti alle ife da cui si differenziano (rami sporangiofori), mentre nelle specie più evolute gli sporangi sono decidui e una volta distaccati possono essere dispersi tramite l acqua e/o il vento, permettendo una più efficiente disseminazione dell inoculo rispetto alle specie con sporangi persistenti. La germinazione degli sporangi può avvenire tramite la produzione di zoospore e/o anche direttamente attraverso un tubulo germinativo. Questi due meccanismi possono variare tra le varie specie e nell ambito della stessa specie anche in base alle condizioni ambientali; - le zoospore, sono delle strutture biflagellate senza parete esterna. Dopo un periodo di motilità nell acqua e dopo aver preso contatto con un ospite suscettibile si incistano, perdendo i flagelli e differenziando la parete. Se le 11
15 STATO DELL ARTE condizioni ambientali sono favorevoli emettono un tubulo germinativo oppure occasionalmente rilasciano nuove zoospore, fenomeno quest ultimo che prende il nome di diplanetismo. Le zoospore costituiscono il principale propagulo infettivo del genere Phytophthora ed esibiscono un comportamento chemiotattico che gli permette di trovare il sito ottimale per l infezione nella pianta ospite (es. ferite o apici radicali); - le oospore, sono le spore sessuali che derivano dalla fusione tra i nuclei aploidi delle due strutture sessuali specializzate (gametangi), denominate rispettivamente oogoni e anteridi. L anteridio può fecondare l oogonio con due differenti meccanismi: nel primo denominato anfigino, l anteridio penetra all interno dell oogonio avvolgendone il gambo alla base (Fig. 2 c); nel secondo chiamato paragino, l anteridio aderisce lateralmente al gambo dell oogonio. Dopo la fertilizzazione si ha lo sviluppo di una singola oospora di forma circolare all interno dell oogonio. Le oospore sono caratterizzate dall avere una parete particolarmente spessa che consente a queste strutture di superare condizioni ambientali sfavorevoli fungendo da spore di resistenza. Inoltre, esse rivestono una notevole importanza per la corretta identificazione e descrizione delle specie del genere Phytophthora, in quanto in alcuni casi possono presentare caratteristiche ornamentazioni della parete. Papilla Oogonio Oospora Anteridio a b c Figura 2. Propaguli di Phytophthora spp.: clamidospore (a), sporangio papillato (b), oogonio, oospora e anteridio anfigino (c). Barra = 20 µm. 12
16 STATO DELL ARTE Alcune specie di Phytophthora sono omotalliche, self-fertili, ossia differenziano oogoni e anteridi in singola coltura e sono in grado di auto fecondarsi. In altre specie chiamate eterotalliche, non self-fertili, la fecondazione avviene in seguito all incontro di due miceli di differente tipo sessuale mating type comunemente definiti di tipo A1 e A2. Il processo di gametangiogamia nelle specie eterotalliche è tipicamente anfigino, in quanto il ramo oogoniale che si differenzia in prossimità di quello anteridiale, penetra entro quest ultimo attraverso l anteridio in modo che la struttura oogoniale risulti adagiata sull anteridio stesso che a sua volta circonda come un anello il peduncolo su cui l oogonio è inserito. Le specie omotalliche possono avere gametangi con anteridi sia anfigini che paragini. In entrambi i meccanismi di gametangiogamia, i nuclei diploidi migrano dalle ife verso i gametangi dove avviene il processo meiotico che porta alla formazione di nuclei aploidi. Successivamente, un nucleo aploide dell anteridio si riversa nell oogonio attraverso un tubulo fecondativo (Brasier e Sansome, 1975). Un eccesso di nuclei aploidi sia nell oogonio che nell anteridio spesso porta ad un aborto spontaneo delle oospore. Il processo di riproduzione sessuale è di fondamentale importanza per lo scambio di materiale genetico all interno delle popolazioni. Alcune specie di Phytophthora (per es.: P. gonapodyides) non sono in grado di riprodursi sessualmente, sono tuttavia in grado di stimolare la produzione di gamentangi in altre specie allorché vengano a contatto (Pittis e Colhoun, 1984; Brasier et al., 1993a). 13
17 STATO DELL ARTE 2.2 Specie invasive di Phytophthora Al genere Phytophthora afferiscono un centinaio di specie, di cui circa la metà sono state descritte nel corso degli ultimi 20 anni: nel 1931 si conoscevano solo 20 specie (Tucker, 1931), nel 1990 il numero di specie note era di circa 60 (Erwin e Ribeiro, 1996), al 2007 figurano ufficialmente descritte 105 specie (IUFRO, 2007). Questo rapido incremento è da attribuire, in parte alla scoperta di nuove specie criptiche all interno di specie note, e in parte alla scoperta di specie nuove soprattutto negli ecosistemi naturali. Stante la crescita esponenziale del numero di nuove specie descritte (Fig. 3), è presumibile che nei prossimi anni verranno scoperte e descritte da 100 a 500 nuove specie di Phytophthora (Brasier, 2008). Figura 3. Andamento esponenziale del numero di specie di Phytophthora descritte (da IUFRO 2007). L incremento del commercio internazionale delle piante, in seguito alla globalizzazione dei mercati, ha permesso l introduzione in nuovi ambienti sia di numerose specie di Phytophthora, sia dei loro rispettivi ospiti. L introduzione di piante esotiche con i relativi patogeni in ambienti diversi da quelli di origine, da un lato agevola l incontro tra nuovi ospiti potenzialmente suscettibili per le 14
18 STATO DELL ARTE specie di Phytophthora endemiche e dall altro lato favorisce un più ampio range di ospiti vegetali infettabili per i patogeni esotici introdotti. Oltre al caso di Phytophthora infestans già citato in premessa, numerose altre specie appartenenti a questo genere hanno originato danni gravi. Un esempio classico è rappresentato da Phytophthora cinnamomi, considerata come già detto una seria minaccia in ecosistemi di diverse aree del mondo. Sin dalla sua presunta introduzione in Oceania, agli inizi del 1900, tale specie si è ampiamente diffusa nelle foreste di Eucalyptus marginata in Australia e Nuova Zelanda, causando la morte non solo degli eucalitteti ma anche di numerose specie vegetali presenti nel sottobosco di queste foreste, con gravi ripercussioni sulla biodiversità dell intero ecosistema. In tali Paesi sono attualmente in atto misure preventive di quarantena volte a impedire e/o limitare la diffusione di questo patogeno nelle aree non ancora infette (Shearer e Tippett, 1989; Dunstan et al., 2010). P. cinnamomi è stata introdotta anche in Nord America dove ha causato danni gravi su castagno (Castanea dentata), rallentando tra l altro il processo di rigenerazione delle piante già attaccate dal cancro della corteccia. Ciò in quanto alcuni ibridi di castagno, appositamente selezionati per la resistenza a Cryphonectria parasitica, sono risultati suscettibili alle infezioni di P. cinnamomi (Crandall et al., 1945; Rhoades et al., 2003). In Europa P. cinnamomi è stata associata alle gravi morie di Quercus ilex e Q. suber verificatesi in Spagna e Portogallo sin dagli inizi degli anni 90 (Brasier, 1992; Brasier, 1996; Sánchez et al., 2002). Sebbene entrambi i mating types di questa specie siano presenti all interno delle popolazioni Europee, Nord Americane e Australiane in queste regioni è predominante il tipo A2. Un altro esempio eclatante è quello di Phytophthora ramorum. Questo patogeno è stato segnalato per la prima volta in California dove è considerato l agente causale del Sudden Oak Death, malattia che ha assunto ormai proporzioni epidemiche e causato la morte di migliaia di querce e gravi danni anche su altri ospiti (Rizzo et al., 2002). In Europa questa specie è stata rinvenuta principalmente in vivaio e meno frequentemente in ambienti forestali, 15
19 STATO DELL ARTE senza causare danni rilevanti come quelli verificatisi in California (Brasier e Jung, 2006). Tuttavia, a partire dalla fine del 2009 questo pericoloso patogeno sta mettendo in serio pericolo numerosi impianti di Larix kaempferi in Gran Bretagna (Brasier e Webber, 2010). L origine di questo patogeno sembrerebbe essere localizzata in alcune regioni dell Asia Centrale e della Cina (Goheen et al., 2007). Gli isolati Americani ed Europei di P. ramorum sono di differente mating type e mostrano differenze sia a livello fenotipico che molecolare, evidenziando come le invasioni nei due continenti non siano tra loro collegate (Werres et al., 2001; Brasier et al., 2006; Bonants et al., 2007). P. ramorum è un organismo da quarantena e le attività volte alla sua eradicazione sono previste sia in ambienti forestali che in vivaio. In nord America si sta recentemente diffondendo nelle foreste native di Chamaecyparis lawsoniana della costa Est dell Oregon e della California, un altra specie invasiva, Phytophthora lateralis. Questa specie è filogeneticamente vicina a P. ramorum e a Phytophthora foliorum, una nuova specie anch essa recentemente rinvenuta negli Sati Uniti (Donahoo et al., 2006). In Europa per contro, un ulteriore specie invasiva, Phytophthora kernoviae, isolata per la prima volta nella regione del Cornwall in Gran Bretagna, si sta rapidamente diffondendo in vari ecosistemi. L origine di questa specie è sconosciuta, tuttavia subito dopo la sua descrizione (Brasier et al., 2005), ulteriori nuove segnalazioni sono state riportate in Nuova Zelanda. Infine, un altra specie invasiva, recentemente descritta come Phytophthora pinifolia, sta devastando estesi rimboschimenti di Pinus radiata in Cile (Durán et al., 2008). Uno degli aspetti più preoccupanti è che alcune di queste specie hanno eluso i controlli fitosanitari attuati nei vari Paesi in quanto sconosciute alla scienza. Ciò di fatto dimostra la necessità di rivedere e perfezionare gli attuali sistemi di prevenzione e controllo dei materiali vegetali in fase di importazione ed esportazione. 16
20 STATO DELL ARTE Un altro problema fitosanitario inerente la movimentazione delle Phytophthorae è legato alla potenziale capacità di questi microrganismi di ibridarsi in modo interspecifico grazie al fatto che le zoospore mancanti di pareti cellulari sono prive di barriere precostituite (Brasier, 2000). Pertanto, l incontro di specie endemiche con specie esotiche può facilmente dar luogo a nuovi e pericolosi ibridi di Phytophthora che costituiscono una seria minaccia dagli esiti imprevedibili per gli ecosistemi sia agrari che forestali. Un esempio di ibrido tra specie di Phytophthora è rappresentato da P. alni, rinvenuta per la prima volta nel Sud dell Inghilterra. Questa specie mostra una forte somiglianza con Phytophthora cambivora, dalla quale si differenzia essenzialmente in quanto è omotallica (Brasier et al., 1995). Studi più approfonditi a livello sia morfologico che molecolare, lasciano intendere che P. alni possa essere il risultato di una ibridazione tra P. cambivora e probabilmente Phytophthora fragariae. P. alni include un gruppo di subspecie particolarmente aggressive su Alnus spp., a differenza delle due specie parentali che non sono patogene su questa pianta forestale. Ciò evidenzia come in seguito all ibridazione possa generarsi una nuova specie in grado di attaccare nuovi ospiti (Brasier, 2000). 17
21 STATO DELL ARTE 2.3 Specie di Phytophthora in Italia: natura e diffusione Il numero di specie Phytophthora rinvenute in Italia è aumentato progressivamente negli ultimi decenni. Le nuove segnalazioni hanno riguardato per lo più il settore vivaistico (Pane et al., 2006). Nei vivai, infatti, a seguito della globalizzazione dei mercati e della necessità di diversificare le produzioni, sono state importate molte specie vegetali esotiche provenienti da Paesi tropicali o subtropicali. Ovviamente, ciò può aver comportato anche l introduzione accidentale di specie esotiche di Phytophthora, sia con le piante e i substrati di coltivazione, ma anche attraverso il materiale di propagazione (semi, talee). Inoltre, il tipo di tecniche colturali adottate in vivaio e il continuo susseguirsi di specie e varietà di piante differenti in ambiti così ristretti, hanno senz altro favorito all interno dei vivai l incontro tra numerosi patogeni e nuovi ospiti potenziali. In passato, i danni causati dalle infezioni di Phytophthora spp. in vivaio sono stati spesso sottovalutati, sia per le scarse conoscenze al riguardo, sia per le difficoltà oggettive incontrate nell effettuare diagnosi corrette. Inoltre, è frequente il caso in cui le infezioni radicali da Phytophthora spp. risultino associate a quelle provocate da altri funghi terricoli che ne mascherano la presenza. Le specie di Phytophthora rispetto ad altri microrganismi del terreno hanno una scarsa capacità competitiva e spesso su alcuni substrati di coltura artificiali si sviluppano molto più lentamente dei funghi. Tra le specie esotiche di Phytophthora di recente introduzione nei vivai italiani, assume rilevanza P. taxon niederhauserii (Cacciola et al., 2009a, b). Questa specie, non ancora formalmente descritta, è ormai diffusa in tutti e cinque i continenti dove è in grado di attaccare sia piante di interesse agrario che forestale (Pérez Sierra et al., 2010). In ambito forestale, invece, i danni causati da specie di Phytophthora non hanno mai destato serie preoccupazioni; o meglio, finora non è stata mai posta la giusta attenzione sulle affezioni causate da questi patogeni. Solo di recente è emersa anche in ambito forestale tutta la loro pericolosità e capacità distruttiva. 18
22 STATO DELL ARTE Le principali infezioni di Phytophthora spp. in Italia sono state segnalate nei castagneti e in boschi di querce. Nei primi, causano la ben nota sindrome del mal dell inchiostro, una malattia che negli ultimi anni ha avuto una forte recrudescenza e attualmente sta creando problemi soprattutto nelle aree castanicole dell Italia centro meridionale (Anselmi et al., 1999; Vettraino et al., 2001). Fino a qualche anno fa erano ritenute responsabili di questa malattia due specie di Phytophthora: P. cambivora e P. cinnamomi; recenti studi, invece, hanno messo in evidenza come nell eziologia della malattia possano essere coinvolte anche altre specie dello stesso genere, in particolare P. citricola e P. cactorum (Vettraino et al., 2005). Per quanto riguarda i boschi di querce, in tutte le regioni italiane nel corso degli ultimi decenni si è verificata una costante espansione di quei gravi fenomeni, di cui si è accennato in premessa, noti col termine di deperimento delle querce (oak decline). In tali malattie ad eziologia complessa risultano coinvolti numerosi patogeni fungini ma anche varie specie afferenti al genere Phytophthora (Jung et al., 1996). Recenti indagini condotte in varie regioni italiane hanno evidenziato come ben 11 specie di Phytophthora: P. cactorum, P. cambivora, P. cinnamomi, P. citricola, P. cryptogea, P. gonapodyides, P. megasperma, P. quercina e P. syringae, e due specie non ancora identificate, siano diffuse nei querceti deperenti d Italia. Alcune specie sono risultate più frequenti nel Nord del Paese, mentre altre nel Centro-Sud. Tra tutte, P. quercina è risultata quella più direttamente coinvolta nell eziologia della malattia. Tuttavia, la sua diffusione sembrerebbe limitata per ora al Centro-Nord d Italia e, soprattutto, nelle aree con suoli acidi o subacidi (Vettraino et al., 2002). A tale proposito, bisogna sottolineare che tra le Regioni monitorate in quell indagine figurava anche la Sardegna, e che nelle aree indagate dell Isola non è stata mai riscontrata la presenza di specie di Phytophthora. 19
23 SCOPO DELLA RICERCA 3. SCOPO DELLA RICERCA Le indagini svolte nel corso degli ultimi 30 anni dal Dipartimento di Protezione delle Piante dell Università di Sassari, hanno messo in evidenza il progressivo peggioramento dello stato fitosanitario dei popolamenti forestali in Sardegna. In particolare, sono via via aumentati i casi di deperimento nei querceti e le morie di piante in castagneti e in ecosistemi ripari. Per quanto riguarda gli eventi di deperimento, le indagini effettuate in varie formazioni a Quercus spp. dell Isola hanno consentito di chiarire molti aspetti legati alla complessa eziologia di questi fenomeni, e di caratterizzare sotto il profilo fisiologico e patogenetico alcuni dei principali patogeni fungini che vi sono implicati (Franceschini et al., 1999; Evidente et al., 2003; Evidente et al., 2005; Linaldeddu et al., 2009; Linaldeddu et al., 2010b; Maddau et al., 2010). Tuttavia, nessuna ricerca specifica è stata mai effettuata per verificare il possibile coinvolgimento nella patogenesi di questa malattia di specie appartenenti al genere Phytophthora. Esse, in varie regioni forestali dell Europa centro meridionale sono considerate tra i fattori che maggiormente contribuiscono a favorire l insorgenza del deperimento del bosco e la conseguente evoluzione del degrado vegetativo delle piante verso un esito letale (Brasier, 1992; Jung et al., 1999; Jung et al., 2000; Vettraino et al., 2002). Allo stesso modo, nei castagneti sardi non è stata mai effettuata alcuna indagine specifica per approfondire le conoscenze sulla natura e distribuzione delle specie di Phytophthora associate al mal dell inchiostro, principale causa delle morie di piante riscontrate nei popolamenti. Recentemente in Europa sono state isolate diverse specie di Phytophthora sia dal suolo sia, in alcuni casi, dai tessuti sintomatici di piante di castagno colpite da mal dell inchiostro. Oltre a P. cinnamomi e P. cambivora, comunemente considerate come gli agenti causali di questa malattia, sono state rinvenute: P. cactorum, P. citricola, P. cryptogea, P. megasperma e P. syringae (Vettraino et al., 2005; Perlerou et al., 2010). Il ruolo patogenetico di queste specie non è ancora ben chiaro, anche perché l espressione della loro virulenza, così come la capacità di 20
24 SCOPO DELLA RICERCA sopravvivenza, può variare notevolmente nelle diverse condizioni edafiche e climatiche delle stazioni in cui vegeta il castagno. In ogni caso, è indubbio che il loro rinvenimento assume importanza alla luce dell acclarata recrudescenza del mal dell inchiostro nelle aree castanicole. Questa malattia in Sardegna dove peraltro spesso si manifesta insieme all altra grave affezione delle piante di castagno: il cancro della corteccia causato da Cryphonectria parasitica costituisce motivo di seria preoccupazione per i castanicoltori e richiede un maggiore impegno della ricerca per definirne i caratteri eziologici, epidemiologici e le strategie di prevenzione. Infine, altrettanto preoccupante nei sistemi ripari del Centro e del Nord della Sardegna è l aumento dei casi di progressivo disseccamento fino alla morte di piante di ontano nero (Alnus glutinosa) e di agrifoglio (Ilex aquifolium). Le cause di questi eventi sono ancora ignote; tuttavia, la sintomatologia manifestata dalle piante colpite ricorda da vicino quella indotta da varie specie di Phytophthora patogene, soprattutto da P. alni, su Alnus spp. in varie regioni dell Europa centrale (Brasier et al., 2004; Jung e Blaschke, 2004; Černy e Strnadova, 2010). Pertanto, alla luce di quanto finora esposto sui problemi sanitari dei boschi, con particolare riferimento alle emergenze appena richiamate e al fatto che nelle formazioni forestali della Sardegna non sono state mai effettuate indagini specifiche per verificare la presenza, diffusione e patogenicità di specie di Phytophthora, è parso opportuno, nell ambito di questa tesi di Dottorato, svolgere ricerche con l intento di: monitorare querceti, castagneti, sistemi ripari e vivai forestali della Sardegna per individuare in tali ambienti zone con probabili focolai infettivi di Phytophthora spp.; valutare il grado di malattia nei popolamenti di castagno e di leccio con riferimento, rispettivamente al mal dell inchiostro e al deperimento ; isolare, identificare e caratterizzare sotto il profilo morfologico, molecolare e patogenetico le specie di Phytophthora presenti nelle zone infette. 21
25 MATERIALI E METODI 4. MATERIALI E METODI 4.1 Siti d indagine Durante il primo anno del Corso di Dottorato è stata svolta una capillare attività di monitoraggio fitosanitario sia nelle principali aree boschive della Sardegna, sia in vivai forestali gestiti dall Ente Foreste della Regione. Ciò ha consentito di individuare varie realtà in castagneti, querceti, sistemi ripari e vivai con piante che manifestavano sintomi (marciumi radicali, necrosi corticali, rarefazione e ingiallimento della chioma) assimilabili a quelli tipici causati da attacchi di Phytophthora spp. Per effettuare le ricerche oggetto di questa tesi, tra tutte le emergenze rilevate ne sono state prescelte 5 in bosco e 3 in vivaio, come di seguito specificato: Castagneti Sono stati scelti due siti ubicati nel versante Nord-occidentale del massiccio del Gennargentu: uno ricade nel territorio di Aritzo (39 56 N, 9 11 E; 850 m s.l.m.) e l altro in quello di Desulo (40 02 N, 9 13 E; 1200 m s.l.m.) (Fig. 4). In entrambi insistono boschi di castagno (Castanea sativa), abbandonati o governati per lo più a ceduo, con numerose piante sintomatiche. a b c Figura 4. Ubicazione e ortofoto dei castagneti (in rosso i siti d indagine) in agro di Aritzo (a) e di Desulo (b); piante di castagno sintomatiche (c). 22
26 MATERIALI E METODI Querceti È stato scelto un sito ubicato nell Isola di Caprera (41 12 N, 9 27 E; 50 m s.l.m.) che ricade all interno del Parco Nazionale dell Arcipelago di La Maddalena (Fig. 5). Il bosco è costituito principalmente da piante disetanee di Quercus ilex, con elementi sparsi di Q. suber e Pinus spp., e da un folto sottobosco di specie caratteristiche della macchia mediterranea (Arbutus unedo, Cistus spp., Erica spp. Juniperus spp., Myrtus communis e Olea europaea var. sylvestris). a b c Figura 5. Ubicazione e ortofoto del bosco di leccio nell Isola di Caprera (a); folta vegetazione di macchia mediterranea (b); sintomi di deperimento (c). La gran parte delle piante di leccio mostravano sintomi di varia gravità (ingiallimenti della chioma più o meno estesi, rami epicormici, disseccamenti progressivi di branche, necrosi spesso umide su fusto e branche); numerose erano anche le piante ormai disseccate. Sistemi ripari Le indagini sono state effettuate in due sistemi ripari: uno ad ontano nero e agrifoglio ubicato nel Centro Sardegna in agro del Comune di Tonara (40 01 N, 9 12 E; 1300 m s.l.m.), l altro ad ontano nero situato nel Nord dell Isola nel territorio del Comune di Bortigiadas (40 51 N, 9 00 E; 100 m s.l.m.) (Fig. 6). 23
27 MATERIALI E METODI c a b d Figura 6. Ubicazione e ortofoto dei sistemi ripari a ontano nero a Bortigiadas (a), e a ontano nero e agrifoglio a Tonara (b); particolare di piante sintomatiche di ontano (c) e agrifoglio (d). In entrambi i casi, lungo i versanti dei corsi d acqua si riscontravano piante in precarie condizioni vegetative che manifestavano disseccamenti più o meno estesi della chioma, accanto ad altre ormai morte. Vivai forestali Sono stati individuati 3 vivai forestali, due situati in aree montane, rispettivamente nel territorio dei Comuni di Bono (40 25 N, 8 58 E; 850 m s.l.m.) e di Sorgono (40 01 N, 9 04 E; 750 m s.l.m.), e uno ubicato più vicino al livello del mare nel Centro Sardegna in agro di Oristano (39 57 N, 8 36 E; 20 m s.l.m.) (Fig. 7). a b c Figura 7. Ubicazione e ortofoto dei vivai forestali di Bono (a), Sorgono (b) e Oristano (c) 24
28 MATERIALI E METODI 4.2 Valutazione dello stato sanitario di popolamenti di castagno e di leccio La valutazione è stata effettuata con riferimento alla gravità del mal dell inchiostro delle piante di castagno nel bosco di Desulo e del deperimento delle piante di leccio nel bosco di Caprera. Per quanto riguarda il castagneto, i rilievi sono stati effettuati su 120 piante comprese in un transetto ipotetico di 20 m di larghezza e 250 m di lunghezza. In particolare, è stato rilevato il numero di piante malate e a ciascuna di esse è stata attribuita una classe di malattia compresa tra 0 e 4, in base alla percentuale di chioma sintomatica, come segue: 0 = <10%, 1 = 11-30%, 2 = 31-60%, 3 = 60-90% e 4 = >90%. I dati ottenuti sono stati utilizzati (Groth et al., 1999), per calcolare il grado di: - Diffusione (D%) della malattia, applicando la formula D=(N m N)x100, dove N m rappresenta il numero di alberi malati e N il numero totale di alberi esaminati; - Intensità (I%) della malattia, utilizzando la formula G=( (x i n i )/N m x 4)x100, dove x i rappresenta il valore della classe di malattia, n i il numero di alberi malati nella classe n i, N m il numero totale di alberi malati e 4 il valore della classe di malattia più elevata; - Incidenza della Malattia (IM%), definita dal prodotto del grado di diffusione (D) per il grado di intensità (I) della malattia. - Mortalità (M) delle piante, dividendo il numero di piante morte (d) per il numero totale di piante esaminate: M = d/n. Per valutare la gravità del deperimento delle piante di leccio è stata allestita nel bosco, con l ausilio di un GPS portatile (etrex, Garmin), una rete di 20 aree di saggio (ADS) circolari (Ø 10 m), scelte in modo da rappresentare tutte le situazioni vegetazionali ricomprese su una superficie complessiva di circa 100 ettari. In ciascuna ADS sono state esaminate tutte le piante di leccio presenti, rilevando il numero di quelle asintomatiche, di quelle deperenti (che mostravano trasparenza della chioma e/o necrosi, essudati, cancri, carie, rami epicormici su fusto e branche) e di quelle ormai disseccate. I dati ottenuti sono stati utilizzati per calcolare il grado di diffusione del deperimento. 25
29 MATERIALI E METODI 4.3 Campionamenti Nei due castagneti in esame sono state scelte at random in totale 47 piante sintomatiche (13 di queste disposte lungo un corso d acqua) e 22 piante asintomatiche (7 erano disposte lungo un corso d acqua). In prossimità di queste piante sono stati prelevati, a circa 50 cm dal fusto e lungo le 4 direzioni cardinali, campioni di suolo contenenti porzioni di radici ad una profondità compresa tra 5 e 15 cm. Ciascun campione è stato inserito in una busta di plastica, sul quale sono stati riportati i riferimenti del prelievo. Inoltre, da tutte le piante sintomatiche sono state asportate porzioni di tessuto corticale e xilematico a livello del colletto in corrispondenza del fronte di avanzamento della malattia. Ciascuno di questi campioni è stato messo in una busta di plastica sulla quale sono stati annotati i riferimenti del prelievo. Tutti i campioni prelevati sono stati infine trasferiti in giornata in laboratorio e conservati in frigorifero a 5 C fino al momento dell uso per l isolamento delle specie di Phytophthora. I campionamenti nel bosco di leccio sono stati effettuati nelle ADS allestite per valutare il grado di deperimento delle piante. In particolare, in ciascuna ADS sono state individuate at random da 1 a 5 piante deperenti e in prossimità di ognuna di esse (a circa 50 cm dal fusto) è stato prelevato un campione di suolo e uno di radici fini alla profondità di circa cm. Anche in questo caso i campioni sono stati trattati come i precedenti fino al momento dell uso. Nei sistemi ripari a ontano nero e ad agrifoglio sono stati prelevati tessuti corticali infetti da piante delle due specie scelte at random che mostravano cancri ed essudati al colletto, essudati nel fusto e disseccamenti della chioma. Oltre a questi campioni, trattati anch essi come sopra, sono stati effettuati ulteriori prelievi lungo i corsi d acqua dei due sistemi ripari, utilizzando la tecnica del baiting con foglie di rododendro (Reeser et al., 2007), meglio specificata più avanti. Infine, nei tre vivai monitorati sono state prelevate piantine coltivate in contenitori (vasi o fitocelle) o in piena terra delle diverse specie vegetali che mostravano disseccamenti e marciumi radicali. Una volta trasferite in 26
30 MATERIALI E METODI laboratorio, le piantine sono state prontamente esaminate con l ausilio di un microscopio stereoscopio per rilevare la presenza di segni di parassiti e successivamente utilizzate per l isolamento di eventuali patogeni. Per lo stesso fine sono state utilizzate anche porzioni di terreno prelevate dal campo in prossimità delle piantine oppure dai contenitori di ciascuna di esse. 27
31 MATERIALI E METODI 4.4 Substrati di crescita Per l isolamento e la caratterizzazione delle specie di Phytophthora sono stati utilizzati i seguenti substrati di crescita: Synthetic Mucor Agar (SMA) È un substrato selettivo specifico per Phytophthora (Brasier e Kirk, 2001b), costituito da diversi elementi nutrizionali e antimicrobici per inibire lo sviluppo di batteri e funghi: saccarosio, 10 g; L-asparagina, 1 g; solfato di magnesio, 0,25 g; tiamina HCl, 0,001 g; elementi minerali 1, 1 ml; agar technical n. 3, 15 g; potassio diidrogeno orto fosfato, 0,5 g; 4% MBC 2, 0,5 ml; pimaricina (2,5% w/v), 0,4 ml; rifamicina SV (1% w/v), 3 ml; acqua distillata 1 L. Dopo correzione del ph a 6,5 con NaOH 1 M, il substrato è stato sterilizzato in autoclave a 121 C per 15 minuti. I due antibiotici (pimaricina e rifamicina) sono stato aggiunti dopo la sterilizzazione ad una temperatura di circa 45 C. Carota-agar (CA) È un substrato idoneo sia per la crescita sia per la conservazione delle specie di Phytophthora. È costituito da: filtrato di carote 200 g; agar tecnico N g e acqua distillata 1000 ml. Il filtrato di carote è stato ottenuto per triturazione di 200 grammi di carote con 500 ml di acqua distillata. All omogenato, dopo filtrazione su garza, è stato aggiunto l agar (2% w/v) e 500 ml di acqua distillata. Il substrato è stato sterilizzato in autoclave a 121 C per 15 minuti. In alcuni casi il terreno è stato sterilizzato due volte. Patata-destrosio-agar (PDA). È il substrato di crescita standard, costituito da: Potato Dextrose Agar (PDA, Oxoid) 39 g; acqua distillata 1000 ml. Il substrato è stato sterilizzato in autoclave a 121 C per 15 minuti. 1 ) Elementi minerali: Na 2 B 4 O 7 10H 2 O 0,044 g; Fe 2 (SO 4 ) 3 9H 2 O 0,5035 g; CuSO 4 5H 2 O 0,1965 g; MnCl 2 4H 2 O 0,036 g; NaMoO 4 2H 2 O 0,025 g; ZnSO 4 7H 2 O 2,2015 g; EDTA 2,5 g; H 2 O 500 ml. 2 ) MBC 4%: Carbendazim 4 g; HCl 2,8 ml; H 2 O 47,2 ml. 28
32 MATERIALI E METODI 4.5 Metodi d isolamento delle specie di Phytophthora L isolamento diretto delle specie di Phytophthora da tessuti di organi infetti (foglie, fusto, radici) delle piante o dal suolo è estremamente difficile. Ciò a causa della scarsa capacità competitiva di questi microrganismi rispetto ai funghi e ai batteri. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi protocolli d isolamento al fine di superare questo problema. Ad oggi, la tecnica baiting, che sfrutta la capacità delle specie di Phytophthora di infettare i tessuti di alcune piante esca, risulta sicuramente una delle più efficaci e perciò una delle più utilizzate (Ribeiro, 1978). In questo studio gli isolamenti sono stati effettuati utilizzando due differenti tecniche di baiting e/o direttamente su piastre contenenti un substrato selettivo. Baiting con foglie di Rhododendron sp. I campioni prelevati in bosco e in vivaio sono stati analizzati in laboratorio entro le 24 ore successive al loro prelievo. In particolare, i campioni di suolo (circa 200 g) sono stati versati all interno di vaschette di plastica contenenti 500 ml di acqua distillata e frammenti di foglie fresche di Rhododendron sp. come trappola (Fig. 8 b). I campioni di radici, accuratamente separati dal suolo, sono stati lavati abbondantemente con acqua distillata e successivamente posti in vaschette contenenti acqua sterile e foglie di rododendro. Le vaschette sono state mantenute in laboratorio a una temperatura di circa 20 C. Dopo 5 e 7 giorni le foglie che presentavano maculature o aree necrotiche, sono state lavate in acqua sterile, asciugate su carta da filtro sterile e successivamente trasferite su piastre Petri contenenti SMA (Fig. 8 c). Le piastre sono state trasferite in termostato a C, controllate giornalmente e tutte le colonie con caratteristiche morfologiche tipiche del genere Phytophthora sono state asetticamente trapiantate in piastre Petri (90 mm Ø) contenenti CA e PDA. Le colonie ottenute in purezza sono state mantenute in termostato a 20 C al buio, per la differenziazione delle strutture morfologiche necessarie per l identificazione a livello di specie. 29
33 MATERIALI E METODI Baiting con mele Granny Smith Il metodo prevede l uso di mele della varietà Granny Smith come trappola. Nelle mele, previa sterilizzazione superficiale con alcool etilico al 70%, sono stati effettuati due fori di circa 13 mm di diametro e 25 mm di profondità e al loro interno sono state introdotte porzioni di radici, suolo e/o tessuti infetti. Le mele così trattate sono state mantenute in laboratorio per 5-6 giorni, a una temperatura di circa 20 C. Dal margine delle lesioni tipiche (superficiali, dure e di colore marrone-scuro) sviluppatesi sui tessuti superficiali delle mele (Fig. 8 a), sono stati effettuati gli isolamenti su SMA, e le colonie successivamente trapiantate su CA e PDA come descritto nel precedente metodo. a b c Figura 8. Tecniche di baiting: caratteristica necrosi da Phytophthora su mela (a); frammenti di foglie di rododendro impiegate come esca (b), frammenti di foglie trasferiti su piastra Petri contenente SMA (c). Isolamento dai tessuti infetti su terreno selettivo Gli isolamenti da campioni di tessuti sintomatici di radici, fusto, rami e foglie, talvolta sono stati effettuati direttamente su SMA. A tal fine, i campioni sono stati lavati con acqua distillata e alcool etilico al 70% ed asciugati su carta da filtro sterile. Successivamente, da ciascun campione (in prossimità del margine della lesione) sono stati prelevati frammenti di circa 3-4 mm 2 e trasferiti in piastre Petri (90 mm Ø) contenenti SMA. Le piastre sono state incubate in termostato a 20 C e al buio. Anche in questo caso le piastre sono state controllate giornalmente e tutte le colonie tipiche di Phytophthora sono state trapiantate asetticamente su CA e PDA in coltura pura. 30
34 MATERIALI E METODI 4.6 Identificazione degli isolati di Phytophthora L identificazione su base morfologica a livello di specie delle Phytophthorae risulta quasi sempre relativamente semplice. Tuttavia, esistono dei casi in cui le differenze morfologiche tra alcune specie sono minime per cui la loro corretta identificazione può essere fatta solo integrando i dati morfologici con quelli fisiologici e biomolecolari. Le specie isolate in questo studio sono state identificate su base morfologica utilizzando sia le chiavi di identificazione proposte da Chen e Zentmyer (1970) e Erwin e Ribeiro (1996), sia per confronto con isolati di Phytophthora spp. tester (Tab. 2). Inoltre, l identificazione di alcune specie è stata confermata con l ausilio di tecniche biomolecolari. Tabella 2. Isolati di specie di Phytophthora utilizzati come tester in questo studio. Isolato Specie Mating type Località Fornito da: P2089 P. cambivora A1 UK C.M. Brasier P904 P. cinnamomi A1 Australia C.M. Brasier P1889 P. cinnamomi A2 UK C.M. Brasier IMI P. cinnamomi var. parvispora A2 Itala (Sicilia) G. Magnano di San Lio STEU6265 P. cinnamomi var. parvispora A1 Sud Africa K. Bezuidenhout BS21 P. citricola Omotallica UK J.F. Webber P2088 P. citrophthora - Spagna C.M. Brasier P542 P. cryptogea A2 UK C.M. Brasier P537 P. dreschleri A1 UK C.M. Brasier P540 P. dreschleri A2 UK C.M. Brasier P897 P. gonapodyides - UK C.M. Brasier P. ilicis Omotallica UK J. Denton P540 P. pseudosyringae Omotallica UK J.F. Webber Caratterizzazione morfologica Lo studio dei caratteri morfo-colturali delle strutture riproduttive e di conservazione di ciascun isolato, è stato fatto su colonie coltivate in purezza su CA e PDA. Inizialmente gli isolati sono stati suddivisi in gruppi sulla base dell aspetto miceliare delle colonie (tessitura, voluminosità e tipo di crescita). 31
35 MATERIALI E METODI Per tutti gli isolati è stata verificata sia la capacità di produrre clamidospore e hyphal swelling sia la forma e le dimensioni delle medesime. Inoltre, è stata rilevata la forma e le dimensioni degli sporangi e, per le specie omotalliche, anche dell oospora. A tal fine, sono stati allestiti dei preparati per microscopia utilizzando blu di lattofenolo. I dati biometrici delle strutture riproduttive sono stati rilevati utilizzando il software in dotazione alla camera digitale Optika Vision Pro versione 2.7 connessa al microscopio ottico Leitz Diaplan (Leitz, Germany). Le osservazioni sono state effettuate su 25 sporangi per specie. Per alcune specie è stato necessario stimolare la differenziazione degli sporangi trasferendo dischetti di micelio di 1 cm di diametro in piastre Petri da 60 mm contenenti acqua distillata e/o acqua di stagno Accrescimento miceliare in funzione della temperatura L effetto della temperatura sullo sviluppo degli isolati è stato valutato attraverso l accrescimento diametrale. Un dischetto (5 mm Ø) è stato prelevato dal margine di colture di 5 giorni di età e posizionato in piastre Petri (90 mm Ø) contenenti 20 ml di CA. Le piastre sono state incubate per 4 o 7 giorni a seconda della specie, a diverse temperature, in un range compreso tra 5 e 40 C, con intervalli di 5 C. Ciascuna prova è stata allestita con 3 replicazioni e ripetuta due volte. Dopo il periodo di incubazione, è stato misurato il diametro delle colonie di ciascuna specie e calcolato l accrescimento diametrale giornaliero, dividendo la misura del diametro, previa sottrazione del diametro dell inoculo, per il numero dei giorni di incubazione Comportamento sessuale Per le specie eterotalliche sono stati effettuati dei saggi in coltura duale per determinare il mating type (A1 o A2) degli isolati ottenuti. Tale procedura è stata effettuata grazie all utilizzo di ceppi di Phytophthora di tipo sessuale A1 e A2 già noto 1 (Tab. 2). 1 )Il saggio permette di differenziare il tipo sessuale (mating type A1 o A2), ma non i caratteri morfo-biometrici dei gametangi che sono acquisiti da entrambe le specie. Ciò è possibile solo se vengono appaiati due isolati della stessa specie. 32
36 MATERIALI E METODI Dischetti di micelio di 5 mm di diametro, prelevati da giovani colonie (4-8 giorni età a seconda della specie), sono stati appaiati con isolati tester di mating type noto, in piastre Petri (90 mm Ø) contenenti CA. Il substrato per questi saggi è stato autoclavato due volte a 121 C per 15 minuti e versato in modo tale che esso formasse uno strato sottile in piastra. Le piastre sono state incubate al buio, per 10 giorni a 20 C e per ulteriori 5 giorni a 10 C, per stimolare la produzione delle strutture sessuali (Brasier e Kirk, 2004). La presenza dei gametangi è stata osservata lungo la linea di sovrapposizione miceliare al microscopio ottico capovolgendo le piastre Caratterizzazione biomolecolare Alcuni isolati rappresentativi di ciascuna delle specie di Phytophthora ottenute in questo studio, sono stati utilizzati per il sequenziamento e l analisi delle regioni ITS del rdna. Estrazione del DNA Frammenti di micelio di ciascun isolato sono stati posizionati su piastre Petri contenenti CA e una membrana in cellofan, al fine di evitare la penetrazione del micelio all interno dell agar. L estrazione del DNA è stata effettuata seguendo il metodo CTAB riportato da Doyle e Doyle (1987), leggermente modificato. Porzioni di micelio sono state prelevate dalla superficie della membrana in cellofan e trasferite all interno di tubetti eppendorf contenenti delle biglie d acciaio di 3 mm di diametro. I tessuti dei campioni sono stati triturati mediante un omogeneizzatore Mixer Mill (Qiagen), per 2,5 minuti ad una frequenza di 30 Hz per 2 volte; la prima volta senza tampone e la seconda con l aggiunta di 500 µl di tampone (Doyle e Doyle, 1987). Successivamente i campioni sono stati incubati a 55 C per 30 minuti. Dopo l incubazione è stato aggiunto un volume (500 µl) di cloroformio/alcool isoamilico (24:1 v/v). I campioni sono stati centrifugati per 10 min a 8000 rpm a 20 C. Il surnatante è stato trasferito in tubetti eppendorf ed è stato aggiunto un volume di isopropanolo (pre-raffreddato a 20 C), mescolati e incubati in ghiaccio per 10 minuti. I campioni sono stati ulteriormente 33
37 MATERIALI E METODI centrifugati a rpm per 15 minuti a 4 C e l isopropanolo è stato eliminato. Il pellet di DNA è stato asciugato e risospeso in 100 µl di TE buffer (Tris-HCl 10 mm e EDTA 1mM) a ph 8 e conservato a 4 C per le successive analisi. PCR (Polymerase Chain Reaction) L amplificazione delle regioni ITS1, 5.8S e ITS2 è stata ottenuta mediante PCR con l impiego dei primers universali ITS1 and ITS4 (White et al., 1990). La reazione è stata realizzata in un volume totale di 50 µl contenente i reagenti, come di seguito riportato: H 2 O, 22,3 μl; Buffer 5x, 10 μl; dntps (2 mm), 5 μl; MgCl 2 (25mM), 1,5 μl; Primer ITS1, 5 μl; Primer ITS4, 5 μl; Promega GoTaq polymerase, 0,2 μl; Template (50 ng/μl), 1 μl. I prodotti di amplificazione sono stati analizzati mediante elettroforesi su gel d agarosio (1,5% w/v), a 70V per 90 minuti. Successivamente il gel è stato visualizzato al GelDoc e il DNA è stato quantificato attraverso l impiego del software Quantity One (Biorad), mediante il confronto con il marcatore di peso molecolare 1kb plus DNA ladder (Invitrogen). Sequenziamento della regione ITS1-5.8S-ITS2 Gli amplificati sono stati purificati con il kit Charge Switch PCR Clean-Up Kit (Invitrogen), e sequenziati presso la BMR-Genomics, servizio di sequenziamento di DNA, Spin-off dell Università di Padova ( Analisi e deposito delle sequenze Le sequenze nucleotidiche sono state lette ed analizzate attraverso il programma FinchTV (Geospiza, Inc.; e i nucleotidi dedotti sono stati infine confrontati con i dati disponibili nel database online GenBank utilizzando il programma BLAST ( Infine, gli allineamenti delle sequenze sono stati eseguiti utilizzando il software ClustalW2 ( Le sequenze nucleotidiche della regione ITS1-5.8S-ITS2 dell rdna di alcune specie ottenute in questo studio, sono state depositate in GenBank utilizzando il sistema BankIt ( 34
38 MATERIALI E METODI 4.7 Saggi di patogenicità Per tutte le specie di Phytophthora isolate da ospiti non riportati in letteratura è stata saggiata la patogenicità e soddisfati i postulati di Koch attraverso tre differenti saggi. Inoculazione tramite ferita su fusto L inoculazione su fusto è stata effettuata su semenzali di 1 e/o 2 anni di età della stessa specie da cui le Phytophthorae erano state isolate. Tutti i semenzali sono stati coltivati in fitocella e tenuti in ambiente controllato ad una temperatura compresa tra 10 e 25 C. In particolare, è stata praticata con un bisturi sterile un incisione longitudinale di circa 1 cm sul fusto di ciascun semenzale. Nella ferita è stato quindi inoculato un dischetto di micelio di 5 mm, prelevato dal margine di colonie del patogeno di 5 giorni di età su CA. Per evitare la rapida disidratazione del micelio, il punto d inoculo è stato avvolto per una settimana con cotone sterile inumidito e protetto con carta stagnola o parafilm M. I testimoni sono stati inoculati con un dischetto di CA sterile. Ciascun isolato è stato saggiato su 5 semenzali e tre semenzali sono stati impiegati come testimoni. Alla fine della prova è stata rilevata su ciascun semenzale la lunghezza della lesione e il tipo di sintomo causato dal patogeno. Inoculazione tramite suolo infettato I saggi attraverso suolo infettato sono stati effettuati come riportato da Vettraino e coll. (2001) apportando leggere modifiche. I semenzali utilizzati sono stati ottenuti in serra attraverso la semina di castagne, previa sterilizzazione superficiale. Le piantine sono state coltivate in vasi di plastica da 0,5 L (Bamaplast), contenenti 60% di torba e 40% di sabbia. Una volta raggiunta l altezza di circa cm, le piantine sono state trasferite in vasi di plastica da 1 L contenenti suolo infettato da Phytophthora spp. L inoculo di Phytophthora è stato preparato come di seguito riportato: dischetti di 5 mm sono stati prelevati da colonie di 5 giorni di età e posizionati all interno di beute 35
39 MATERIALI E METODI da 250 ml contenenti 150 ml di semi di loliessa (Lolium italicum) e 100 ml di brodo di V8 (200 ml V8 Juice, 3 g CaCO 3 ; 800 ml di acqua distillata). Le beute sono state incubate in termostato ad una temperatura di 20 C per 4-6 settimane. Trascorso tale periodo la miscela ormai colonizzata dal micelio è stata lavata ripetutamente con acqua sterile al fine di ridurre l eccesso di nutrienti, e successivamente aggiunta (25 ml) al substrato (1 L). I vasi sono stati conservati in laboratorio e dopo 5 giorni dall inoculazione immersi per 24 ore in vaschette di plastica contenenti acqua distillata al fine di indurre la sporulazione degli isolati di Phytophthora. Due mesi dopo l inoculazione sono stati prelevati dai vasi campioni di suolo per verificare la presenza di Phytophthora spp. attraverso la tecnica del baiting. La gravità dei sintomi è stata valutata attraverso una scala empirica di valori da 0 a 4, dove: 0 = pianta sana; 1 = avvizzimento inferiore al 10%; 2 = avvizzimento del 50%; 3 = avvizzimento e necrosi fino al 100%; 4 = pianta morta. Alla fine della prova è stato calcolato l Indice della Malattia (IM), usando la seguente formula: IM = (g x n)/n, dove g = classe di danno, n = numero di piante appartenenti a ciascuna classe e N = numero totale di piante inoculate. Inoculazione su astoni di castagno Astoni di circa 5-8 cm di diametro e 1,5 m di lunghezza, sono stati tagliati da ceppaie di castagno e portati in laboratorio per l inoculazione (Brasier e Kirk, 2001). Prima dell inoculazione gli astoni sono stati disinfettati in superficie con alcool etilico al 70% e le due estremità e le eventuali ferite procurate durante il taglio delle branche laterali sono state trattate con mastice cicatrizzante. Successivamente sono stati individuati tre punti di inoculazione, equamente distribuiti sul tronco. Attraverso l ausilio di un bisturi è stata effettuata un incisione longitudinale di circa 1 cm asportando la corteccia, ed è stato quindi inoculato un dischetto di micelio di 5 mm 2 del patogeno da saggiare prelevandolo da culture giovani su CA. Il punto di inoculo è stato avvolto con del cotone idrofilo, inumidito con acqua distillata sterile, avvolto con carta stagnola e sigillato con del nastro 36
40 MATERIALI E METODI isolante. Ciascun astone è stato inoculato con due isolati Phytophthora e un dischetto di CA sterile (testimone). Per ciascun isolato saggiato sono state effettuate 5 repliche. Una volta inoculati gli astoni sono stati posizionati all interno di buste di plastica, sigillate e incubate ad una temperatura di circa 20 C per 2 mesi. Trascorso tale periodo gli astoni sono stati scortecciati intorno al punto di inoculazione ed è stata misurata la lunghezza delle lesioni causata da ciascuna specie di Phytophthora saggiata. 37
41 MATERIALI E METODI 4.8 Produzione in vitro di metaboliti secondari fitotossici Al fine di ampliare le conoscenze sulla biologia delle specie del genere Phytophthora, tre isolati rappresentativi delle specie P. cambivora (PH041), P. gonapodyides (PH038) e P. pseudosyringae (PH043), sono stati saggiati per la loro capacità di produrre in vitro metaboliti secondari fitotossici potenzialmente coinvolti nella patogenesi. Ottenimento dei filtrati colturali Gli isolati sono stati allevati in condizioni statiche su due differenti substrati liquidi. Il primo (substrato A) è stato preparato sulla base di quello proposto da Erwin e Katznelson (1961) e Clare e Zentmyer (1966), al quale sono state apportate leggere modifiche: D-glucosio, 30 g; L-asparagina, 1 g; FeSO 4 H 2 O, 1 mg; CaCl 2 2H 2 O, 10 mg; MgSO 4 7H 2 O, 0,1 g; KH 2 PO 4, 0,47 g; K 2 HPO 4, 0,26 g; tiamina, 1 mg; H 2 O distillata, 1 L; β-sitosterolo, 20 mg; 1ppm di Zn (ZnSO 4 7H 2 O); 0,02 ppm di Cu (CuSO 4 5H 2 O), Mo (NaMoO 4 2H 2 O), e Mn (MnCl 2 4H 2 O). Il secondo (substrato B) riportato da Cristinzio e coll. (1992), è composto da: L-asparagina, 1 g, saccarosio, 10 g; estratto di lievito, 5 g; tiamina 0,001 g; KH 2 PO 4 7H 2 O, 0,5 g; H 2 0 distillata, 1 L. 170 ml di ciascun substrato nutritivo sono stati versati in bottiglie di Roux (1 L) ed inoculati con 4 ml di una sospensione miceliare, ottenuta allevando ciascun isolato in beute (250 ml) contenenti brodo di carota e mantenute in agitazione a 150 rpm per 7 giorni a 25 C. Le bottiglie di Roux inoculate sono state mantenute per 30 giorni in una camera climatica a 25 C al buio. Al termine del periodo di incubazione, le colture sono state filtrate prima su garza e successivamente su filtri a membrana millipore (Express TM Plus) da 0,22 µm. Il filtrato colturale ottenuto è stato conservato in congelatore a -20 C fino al momento della successiva estrazione. 38
42 MATERIALI E METODI Ottenimento degli estratti organici Un aliquota di ciascun filtrato colturale è stata estratta esaustivamente con acetato di etile dopo correzione del ph iniziale a 4 con HCl 2N. Una seconda aliquota è stata estratta in modo analogo senza modificare il ph della soluzione. Le fasi organiche combinate sono state anidrificate con solfato di sodio anidro, concentrate a pressione ridotta in rotavapor a 40 C, evaporate a secchezza e successivamente pesate. Biosaggi L attività fitotossica dei filtrati colturali e degli estratti organici è stata valutata su piantine recise di pomodoro (Lycopersicum esculentum) di circa 21 giorni, coltivate in cella climatizzata a 25 C e umidità relativa del 70-80%. I recisi sono stati immersi nelle soluzioni di saggio (3 ml) per 48 ore, poi trasferiti in acqua distillata sterile fino alla comparsa dei sintomi. Il filtrato colturale è stato saggiato tal quale e diluito serialmente da 10-1 a L estratto organico è stato saggiato alla concentrazione di 0.25, 0.5 e 1 mg/ml. È stata saggiata anche l attività fitotossica degli esausti acquosi, sia tal quali che diluiti serialmente, per valutare la presenza di metaboliti idrofili e/o ad elevato peso molecolare non estraibili con l acetato di etile. Le tesi di controllo sono state allestite con i due substrati di crescita non inoculati, con una soluzione acquosa di metanolo allo 0,5% e con acqua sterile. Per tutta la durata dell esperimento i recisi sono stati mantenuti in una cella climatizzata alla temperatura di 25 C, ed umidità relativa del 60%. 39
43 MATERIALI E METODI 4.9 Conservazione delle specie di Phytophthora Gli isolati di Phytophthora ottenuti in questo studio sono stati conservati in coltura pura secondo tre differenti metodologie (Erwin e Ribeiro, 1996): a) dischetti di micelio sono stati posizionati all interno di vials di vetro da 16 ml contenenti CA, dopo circa 6 giorni dalle inoculazioni sono stati aggiunti 5 ml di olio di paraffina e quindi sigillati; b) dischetti di micelio posizionati all interno di vials come sopra ma senza aggiunta di olio di paraffina; c) dischetti di micelio sono stati trasferiti all interno di vials contenenti acqua sterile. In tutti e tre i metodi i vials sono stati conservati in termostato a 10 C e le colonie trapiantate dopo 2 anni di conservazione Elaborazione dei dati I dati relativi alla lunghezza dell area necrotica causata da ciascuna specie di Phytophthora nei saggi di patogenicità, sono stati sottoposti all analisi della varianza ANOVA e al test di confronto multiplo LSD per valutare la significatività delle differenze tra le medie per P 0,05, utilizzando il programma statistico XL- STAT 2008 (Addinsoft, Francia). 40
44 RISULTATI 5. RISULTATI 5.1 Indagine nei castagneti Stato sanitario dei popolamenti In entrambi i siti monitorati è stata rilevata la presenza di numerose piante che mostravano la sindrome tipica del mal dell inchiostro (Fig. 9). a b c d e f Figura 9. Sintomi di mal dell inchiostro rilevati nelle aree di studio: morie estese lungo le linee di compluvio (a); particolare di piante disseccate (b); necrosi nel colletto e nelle grosse radici (c); tipica fiammata su giovane pollone (d); particolare della fiammata a livello sotto-corticale (e); foglie persistenti sui rami disseccati durante il periodo invernale (f). 41
45 RISULTATI I sintomi erano rappresentati a livello di chioma da microfillia, rarefazione, clorosi e disseccamenti (Fig. 9 a, b) spesso i ricci e le foglie persistevano nei rami anche durante la stagione invernale (Fig. 9 f) a livello di colletto da vaste aree necrotiche di colore marrone scuro tendente al nero, a contorno definito e dalla caratteristica forma a fiamma. Anche le grosse radici spesso mostravano aree necrotiche da cui fuoriuscivano essudati nerastri (Fig. 9 c). Tali sintomi sono stati riscontrati sopratutto durante la stagione autunnale e primaverile sia su fustaie sia su giovani polloni di ceppaia. Questi ultimi mostravano in particolare ampie necrosi corticali a livello del colletto (Fig. 9 d, e) e repentini disseccamenti della chioma. Spesso le ceppaie colpite esaurivano la loro capacità pollonifera a causa della distruzione dell'apparato radicale. Dai rilievi effettuati nel sito di Desulo (Tab. 3), è emersa l elevata gravità di questa malattia in termini sia di diffusione (l 85% delle piante erano sintomatiche), sia di intensità, valutata pari all 87,8%, sia di mortalità (69 piante morte su 120 esaminate). Nel complesso l incidenza della malattia è risultata del 75,4%. Tabella 3. Valutazione dell incidenza del mal dell inchiostro nel castagneto di Desulo. N piante esaminate N piante per classe di malattia
46 RISULTATI Isolamento, identificazione e caratterizzazione delle specie di Phytophthora L isolamento è stato effettuato da campioni di rizosfera e/o di tessuti corticali di 69 piante di castagno: 34 sintomatiche, 15 asintomatiche e 20 dislocate lungo corsi d acqua. Il risultato di isolamenti da più campioni per pianta è qui inteso come risultato di un unico isolamento per pianta (Tab. 4). In tal modo emerge che dal 73,5% delle piante sintomatiche sono state isolate specie di Phytophthora, mentre dalle piante asintomatiche la percentuale di isolamenti positivi è stata solo del 26,7%. Inoltre, emerge che colonie di Phytophthora spp. sono state isolate dal 90% delle piante disposte lungo i corsi d acqua, a dimostrazione della diffusione di questi microrganismi prevalentemente lungo le linee di compluvio. Complessivamente sono stati ottenuti 80 isolati di Phytophthora, appartenenti a 3 differenti specie: P. cambivora, P. gonapodyides e P. pseudosyringae. Tabella 4. Frequenza di isolamento di Phytophthora spp. da piante di castagno asintomatiche e sintomatiche situate in bosco e lungo corsi d acqua. Piante in bosco Piante lungo corsi d acqua Sintomatiche Asintomatiche Sintomatiche Asintomatiche Totale N totale isolamenti N isolamenti positivi di Phytophthora spp. Phytophthora cambivora Phytophthora gonapodyides Phytophthora pseudosyringae 25 (73,5) 4 (26,7%) 13 (100%) 5 (71,4%) 20 (58,8%) 2 (13,3%) 8 (61,5%) 0 4 (11,8%) 1 (6,7%) 5 (38,5%) 5 (71,4%) 16 (47%) 2 (13,3%) 13 (100%) 4 (57,1%) 47 (68,1%) 30 (43,5%) 15 (21,7%) 35 (50,7%) 43
47 RISULTATI Phytophthora cambivora Sono stati ottenuti 30 isolati di P. cambivora da tessuti corticali, suolo e radici di piante sintomatiche e asintomatiche (Tab. 4). Tali isolati su CA formano colonie con abbondante micelio aereo di colore bianco-niveo (Fig. 10 a) e differenziano sporangi non papillati (Fig. 10 b), di forma ovale, misuranti 44 ± 3,2 x 27,5 ± 2,2 m (media ± deviazione standard), intervallo di confidenza al 95% 42,7 45,3 x 26,6 28,4 m, con un rapporto lunghezza/larghezza di 1,6:1. Tutti gli isolati non producono clamidospore e sono di tipo A2; dopo l appaiamento in coltura duale con i ceppi tester P2089, P904 e P537 (Tab. 2) formano oogoni a parete verrucosa e anteridi anfigini bicellulari (Fig. 10 c). In relazione alle esigenze termiche, le loro migliori condizioni di sviluppo si hanno tra 20 e 25 C, con optimum di 22 C (Fig. 11). La temperature minima di crescita è <5 C mentre la massima è compresa tra 30 e 35 C. L identificazione degli isolati è stata confermata dall analisi delle sequenze delle regioni ITS1 e ITS2 dell rdna di un isolato rappresentativo. L analisi BLAST mostra il % di similarità con le sequenze di P. cambivora depositate in GenBank (numero di accesso: EU e EF194775). Phytophthora gonapodyides P. gonapodyides è stata isolata solo da campioni di suolo prelevati da piante situate lungo i corsi d acqua (Tab. 4). I 15 isolati ottenuti formano tutti una caratteristica colonia a rosetta ad accrescimento molto lento (Fig. 10 d). Gli sporangi non papillati di forma ovale e/o ellissoidale si producono in coltura liquida (Fig. 10 e). Le loro dimensioni sono di 47,4 ± 4,2 x 30 ± 2,7 m (media ± deviazione standard), intervallo di confidenza al 95% 45,8 49,1 x 28,9 31 m, con un rapporto lunghezza/larghezza di 1,6:1. Tutti gli isolati sono incapaci di differenziare oogoni in coltura duale con i ceppi di mating type di riferimento, a conferma della ben nota sterilità di questa specie. La temperatura minima di crescita è <5 C e quella massima è compresa tra 30 C e 35 C, con optimum di 25 C (Fig. 11). L analisi delle sequenze nucleotidiche delle regioni ITS1 e ITS2 44
48 RISULTATI dell rdna di un isolato rappresentativo mostrano il % di similarità con le sequenze di P. gonapodyides depositate in GenBank (numero di accesso: EU e EU194417). Phytophthora pseudosyringae I 35 isolati di P. pseudosyringae sono stati ottenuti da piante sia sintomatiche sia asintomatiche e soprattutto lungo i corsi d acqua (Tab. 4). Tale specie è stata isolata dal suolo e dalle radici sottili; in alcuni casi è stata isolata anche dai tessuti corticali delle grosse radici. Tutti gli isolati su CA hanno formato colonie stellate (Fig. 10 f) e leggermente raggiate, con micelio aereo cotonoso e margine irregolare su PDA. Sia su substrati liquidi che su quelli solidi, formano hyphal swelling unite in catenelle semplici o ramificate (Fig. 10 i). Gli sporangi si sono differenziati soprattutto nei substrati liquidi; sono semipapillati, raramente bipapillati, da limoniformi a ovoidali (Fig. 10 g), occasionalmente decidui con un corto pedicello (<5 m). Le loro dimensioni sono di 46,3 ± 7,2 x 31,9 ± 3,4 m (media ± deviazione standard), intervallo di confidenza al 95% 43,4 49,2 x 30,5 33,3 m, con rapporto lunghezza / larghezza di 1,5:1. Tutti gli isolati in coltura singola producono su CA oogoni sub-sferici con parete liscia e diametro variabile da 23 a 31 µm, con oospore plerotiche e anteridi paragini (Fig. 10 h). La temperatura ottimale per la crescita è compresa tra 15 e 20 C, con un minimo e un massimo rispettivamente di 2 e 26 C (Fig. 11). L identificazione degli isolati è stata confermata dall analisi delle sequenze delle regioni ITS1 e ITS2 dell rdna. Esse mostrano il % di similarità con le sequenze di isolati di P. pseudosyringae presenti in GenBank (numero di accesso: AY e EU074793). Le sequenze delle regioni ITS di un ceppo rappresentativo ottenuto in questo studio è stato depositato in GenBank (numero di accesso: GU460375). Di seguito si riferisce sui risultati delle indagini effettuate per saggiare l attività patogenetica e fitotossica delle specie di Phytophthora isolate. 45
49 RISULTATI a b c d e f g h i Figura 10. Aspetto delle colonie di 4 giorni di età su CA di Phytophthora cambivora (a), P. gonapodyides (d) e P. pseudosyringae (f); sporangio non papillato (b) e oogonio ornamentato (c) di P. cambivora; sporangio non papillato (e) di P. gonapodyides ; sporangio semi-papillato (g), oogonio (h) e hyphal swelling (i) di P. pseudosyringae. Barra = 20 m. 46
50 RISULTATI Figura 11. Accrescimento diametrale giornaliero su CA a differenti temperature delle colonie di Phytophthora cambivora, P. gonapodyides e P. pseudosyringae. 47
51 RISULTATI Attività patogenetica Inoculazione tramite ferita su fusto Tutti i semenzali di castagno inoculati con P. cambivora e P. pseudosyringae mostravano sintomi 20 giorni dopo l inoculazione. Entrambe le specie hanno causato sia lesioni necrotiche sul fusto, sia l avvizzimento delle foglie dei semenzali. Tuttavia, sono emerse differenze statisticamente significative tra le specie in relazione alla lunghezza delle lesioni necrotiche (Fig. 13). L isolato di P. cambivora è risultato il più virulento e ha causato la comparsa di una vasta area necrotica su tutta la circonferenza del fusto (Fig. 12 b). P. pseudosyringae ha causato lesioni necrotiche depresse che oltre alla corteccia interessavano anche i tessuti xilematici (Fig. 12 c). I semenzali inoculati con P. gonapodyides mostravano solo un piccolo imbrunimento della corteccia limitato al punto di inoculazione e nessun sintomo a livello fogliare. Tutte le specie di Phytophthora inoculate sono state re-isolate con successo dai tessuti infetti. I semenzali utilizzati come testimoni sono rimasti asintomatici. Inoculazione tramite suolo infettato Anche in questo saggio gli isolati di P. cambivora e P. pseudosyringae hanno causato necrosi e avvizzimenti un mese dopo l inoculazione (Fig. 12 a). P. pseudosyringae ha causato lesioni necrotiche e depresse a livello del colletto, differenti rispetto a quelle di P. cambivora (Fig. 12 d). P. cambivora ha confermato una maggiore aggressività rispetto a P. pseudosyringae, mentre P. gonapodyides è risultata poco aggressiva su castagno (Fig. 14). Tutte le specie di Phytophthora saggiate sono state re-isolate con successo dal suolo dei semenzali inoculati. Alla fine della prova le piante testimoni non hanno manifestato nessun sintomo di malattia. Inoculazione su astoni di castagno Tutte le specie di Phytophthora saggiate causavano lesioni più o meno estese in corrispondenza del punto di inoculazione; solo P. gonapodyides 48
52 RISULTATI induceva una lesione più limitata (Fig. 12 e, f, g, h, i). Tra gli isolati saggiati sono emerse differenze statisticamente significative in relazione alla lunghezza delle lesioni causate (Fig. 15). L isolato di P. cinnamomi è risultato il più aggressivo, causando lesioni mediamente superiori a 280 mm. Tra i due isolati di P. pseudosyringae saggiati è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa in termini di aggressività: l isolato sardo è risultato più virulento di quello inglese. Tutte le specie di Phytophthora inoculate sono state re-isolate dal margine delle lesioni. Sugli astoni di castagno inoculati con il testimone sono stati osservati degli imbrunimenti, probabilmente dovuti all ossidazione dei tessuti legnosi in seguito alla ferita. Figura 12. Esito dei saggi di patogenicità su castagno effettuati attraverso: impiego di suolo infettato (a) con particolare di lesioni al colletto causate da P. pseudosyringae (d); inoculazione sul fusto con Phytophthora cambivora (b) e P. pseudosyringae (c); inoculazione di astoni con P. gonapodyides (e), P. cinnamomi (f), P. cambivora (g), P. pseudosyringae (h); testimone (i). Barra = 40 mm. 49
53 RISULTATI Figura 13. Lunghezza media (mm) delle lesioni causate da specie di Phytophhtora sul fusto di semenzali di castagno. Istogrammi con lettere uguali non differiscono in modo statisticamente significativo al test LSD per P 0,05. La barra verticale rappresenta l errore standard. Figura 14. Indice di malattia causata dalle differenti specie di Phytophthora su semenzali di castagno inoculati con suolo infetto. Figura 15. Lunghezza media (mm) delle lesioni necrotiche causate da specie di Phytophthora su astoni di castagno. Istogrammi con lettere uguali non differiscono in modo statisticamente significativo al test LSD per P 0,05. La barra verticale rappresenta l errore standard. 50
Epidemiologia della peronospora del pomodoro
 M. COLLINA R. BUGIANI Centro di Fitofarmacia Dipartimento di Scienze Agrarie Servizio Fitosanitario Regione Emilia - Romagna Epidemiologia della peronospora del pomodoro Incontro tecnico: Difesa da peronospora
M. COLLINA R. BUGIANI Centro di Fitofarmacia Dipartimento di Scienze Agrarie Servizio Fitosanitario Regione Emilia - Romagna Epidemiologia della peronospora del pomodoro Incontro tecnico: Difesa da peronospora
IL CANCRO DEL CIPRESSO P. Capretti, L. Zamponi DiBA - Firenze Marco Bagnoli Studio RDM
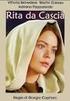 IL CANCRO DEL CIPRESSO P. Capretti, L. Zamponi DiBA - Firenze Marco Bagnoli Studio RDM META Seiridium cardinale, patogeno introdotto in Italia negli anni 50, è il parassita fungino agente del cancro del
IL CANCRO DEL CIPRESSO P. Capretti, L. Zamponi DiBA - Firenze Marco Bagnoli Studio RDM META Seiridium cardinale, patogeno introdotto in Italia negli anni 50, è il parassita fungino agente del cancro del
Corso. Patologia forestale" Marzo Luglio, 2016
 Corso Patologia forestale" Marzo Luglio, 2016 Scopo del corso: La comprensione dei problemi sanitari delle piante forestali Prevenzione dei danni Individuazione di strategie di monitoraggio [Suggerimenti
Corso Patologia forestale" Marzo Luglio, 2016 Scopo del corso: La comprensione dei problemi sanitari delle piante forestali Prevenzione dei danni Individuazione di strategie di monitoraggio [Suggerimenti
Bilancio fitosanitario campagna 2014: Situazione Fitopatologica in Capitanata
 Bilancio fitosanitario campagna 2014: Situazione Fitopatologica in Capitanata Prof. Francesco Lops Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente - Università di Foggia Le precipitazioni
Bilancio fitosanitario campagna 2014: Situazione Fitopatologica in Capitanata Prof. Francesco Lops Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente - Università di Foggia Le precipitazioni
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia
 REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia Il cancro batterico dell actinidia è stato segnalato per
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Le Batteriosi dell Actinidia Il cancro batterico dell actinidia è stato segnalato per
Malattie a eziologia monofattoriale o malattie monofattoriali
 Malattie a eziologia monofattoriale o malattie monofattoriali Sono generate da una causa talmente forte da essere capace da sola, di provocare tutti gli eventi che conducono alla comparsa e allo sviluppo
Malattie a eziologia monofattoriale o malattie monofattoriali Sono generate da una causa talmente forte da essere capace da sola, di provocare tutti gli eventi che conducono alla comparsa e allo sviluppo
IPP. Problematiche fitosanitarie del castagno: criteri per interventi di difesa T. TURCHETTI
 IPP Problematiche fitosanitarie del castagno: criteri per interventi di difesa T. TURCHETTI Istituto Per la Protezione delle Piante, CNR Firenze, Area della Ricerca di Firenze Via Madonna del Piano 10
IPP Problematiche fitosanitarie del castagno: criteri per interventi di difesa T. TURCHETTI Istituto Per la Protezione delle Piante, CNR Firenze, Area della Ricerca di Firenze Via Madonna del Piano 10
Correlazione dei cambiamenti climatici con l attività di Phytophthora cinnamomi in Europa
 Correlazione dei cambiamenti climatici con l attività di Phytophthora cinnamomi in Europa Categories : Anno 2016, N. 236-15 giugno 2016 di Matteo Fabbri Il declino delle querce dell Europa Centro-Mediterranea
Correlazione dei cambiamenti climatici con l attività di Phytophthora cinnamomi in Europa Categories : Anno 2016, N. 236-15 giugno 2016 di Matteo Fabbri Il declino delle querce dell Europa Centro-Mediterranea
I cancri sono lesioni localizzate, di origine infettiva che interessano gli organi legnosi
 I cancri sono lesioni localizzate, di origine infettiva che interessano gli organi legnosi Le necrosi interessano porzioni di corteccia e di alburno (= cioè lo strato più esterno del legno che ha la funzione
I cancri sono lesioni localizzate, di origine infettiva che interessano gli organi legnosi Le necrosi interessano porzioni di corteccia e di alburno (= cioè lo strato più esterno del legno che ha la funzione
LE MALATTIE RICORRENTI NELLE ALBERATE ORNAMENTALI
 PADOVA 16 FEBBRAIO 2007 LE MALATTIE RICORRENTI NELLE ALBERATE ORNAMENTALI Naldo ANSELMI Università della Tuscia, Viterbo anselmi@unitus.it I GRANDI CAMBIAMENTI del SECOLO PASSATO nelle ALBERATURE ORNAMENTALI
PADOVA 16 FEBBRAIO 2007 LE MALATTIE RICORRENTI NELLE ALBERATE ORNAMENTALI Naldo ANSELMI Università della Tuscia, Viterbo anselmi@unitus.it I GRANDI CAMBIAMENTI del SECOLO PASSATO nelle ALBERATURE ORNAMENTALI
BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS PWN = PINE WOOD NEMATODE
 BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS PWN = PINE WOOD NEMATODE PIANTE OSPITI Pinus Abies Larix Picea Cedrus Tsuga Pseudotsuga Chamaecyparis SPECIE MAGGIORMENTE SENSIBILI Pinus nigra, Pinus sylvestris e Pinus pinaster
BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS PWN = PINE WOOD NEMATODE PIANTE OSPITI Pinus Abies Larix Picea Cedrus Tsuga Pseudotsuga Chamaecyparis SPECIE MAGGIORMENTE SENSIBILI Pinus nigra, Pinus sylvestris e Pinus pinaster
messa a punto di metodi diagnostici in real time pcr per malattie delle piante da oomiceti del genere phytophthora
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTA DI AGRARIA DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE MATERIA DI TESI: PATOLOGIA FORESTALE CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNOLOGIE FITOSANITARIE (Classe
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTA DI AGRARIA DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE MATERIA DI TESI: PATOLOGIA FORESTALE CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNOLOGIE FITOSANITARIE (Classe
GLI EFFETTI DEL FUOCO SUGLI ECOSISTEMI
 GLI EFFETTI DEL FUOCO SUGLI ECOSISTEMI Flora e vegetazione Le piante della vegetazione mediterranea posseggono una sorprendente capacità di reazione alla distruzione operata da un incendio. La ripresa
GLI EFFETTI DEL FUOCO SUGLI ECOSISTEMI Flora e vegetazione Le piante della vegetazione mediterranea posseggono una sorprendente capacità di reazione alla distruzione operata da un incendio. La ripresa
Stato di alcune specie arboree del Comune di Firenze: analisi fitosanitaria ed economica
 Stato di alcune specie arboree del Comune di Firenze: analisi fitosanitaria ed economica Categories : Anno 2015, N. 211-1 maggio 2015 di Matteo Fabbri Gli alberi in ambiente urbano sono un patrimonio importante
Stato di alcune specie arboree del Comune di Firenze: analisi fitosanitaria ed economica Categories : Anno 2015, N. 211-1 maggio 2015 di Matteo Fabbri Gli alberi in ambiente urbano sono un patrimonio importante
Recenti acquisizioni su Cancro Batterico dell'actindia
 Recenti acquisizioni su Cancro Batterico dell'actindia Categories : Anno 2011, N. 135-1 dicembre 2011 Proseguono a tutto campo, e a ritmo serrato, i differenti studi condotti da Balestra e collaboratori
Recenti acquisizioni su Cancro Batterico dell'actindia Categories : Anno 2011, N. 135-1 dicembre 2011 Proseguono a tutto campo, e a ritmo serrato, i differenti studi condotti da Balestra e collaboratori
Gestione dei popolamenti ittici selvatici
 Gestione dei popolamenti ittici selvatici Argomenti Importanza della gestione Ripopolamenti Introduzione di specie ittiche non indigene (NIS) Inquinamento genetico Recupero dei ceppi autoctoni Gestione
Gestione dei popolamenti ittici selvatici Argomenti Importanza della gestione Ripopolamenti Introduzione di specie ittiche non indigene (NIS) Inquinamento genetico Recupero dei ceppi autoctoni Gestione
Incubazione e manifestazione dei sintomi evasione. Pg
 Incubazione e manifestazione dei sintomi evasione Pg. 32-34 MOMENTO POST INFEZIONALE: penetrazione Il patogeno entra in parte o completamente nel corpo dell ospite secondo diverse modalità PENETRAZIONE
Incubazione e manifestazione dei sintomi evasione Pg. 32-34 MOMENTO POST INFEZIONALE: penetrazione Il patogeno entra in parte o completamente nel corpo dell ospite secondo diverse modalità PENETRAZIONE
L albero nell ambiente urbano
 Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
Il monitoraggio degli organismi assoggettati a lotta obbligatoria e di cui è temuta l introduzione
 Il monitoraggio degli organismi assoggettati a lotta obbligatoria e di cui è temuta l introduzione Iris Bernardinelli Monitoraggio esotici Monitoraggio Nessun sintomo Presenza di sintomi Compilazione scheda
Il monitoraggio degli organismi assoggettati a lotta obbligatoria e di cui è temuta l introduzione Iris Bernardinelli Monitoraggio esotici Monitoraggio Nessun sintomo Presenza di sintomi Compilazione scheda
LaRAF: Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica. Sede di Sanremo: Istituto Regionale per la Floricoltura
 LaRAF: Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica Sede di Sanremo: Istituto Regionale per la Floricoltura Servizio di Patologia da Funghi e Batteri e di Diagnosi Fitopatologica martini@regflor.it
LaRAF: Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica Sede di Sanremo: Istituto Regionale per la Floricoltura Servizio di Patologia da Funghi e Batteri e di Diagnosi Fitopatologica martini@regflor.it
L albero nell ambiente urbano
 Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
Consiglio di Quartiere 4 Assessorato all Ambiente Assessorato alla Partecipazione democratica e ai rapporti con i Quartieri In collaborazione con ARSIA L albero nell ambiente urbano Firenze 31 Maggio 1
SCHEDA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA (DIRETTIVA CEE 77/93)
 SCHEDA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA (DIRETTIVA CEE 77/93) Avversità: avvizzimento batterico o marciume bruno Organismo nocivo: Pseudomonas solanacearum (Rastonia solanacearum)
SCHEDA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA (DIRETTIVA CEE 77/93) Avversità: avvizzimento batterico o marciume bruno Organismo nocivo: Pseudomonas solanacearum (Rastonia solanacearum)
Fattori predisponenti la comparsa di alcune malattie delle piante ornamentali
 Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Fattori predisponenti la comparsa di alcune malattie delle piante ornamentali Giovanni Minuto Indicazioni epidemiologiche Da un punto di vista generale,
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Fattori predisponenti la comparsa di alcune malattie delle piante ornamentali Giovanni Minuto Indicazioni epidemiologiche Da un punto di vista generale,
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Protocollo diagnostico per il Phytophthora ramorum' agente di deperimento e moria di piante ornamentali o deperimento della quercia (SOD) Descrizione estesa del risultato
Risultati della Ricerca Titolo Protocollo diagnostico per il Phytophthora ramorum' agente di deperimento e moria di piante ornamentali o deperimento della quercia (SOD) Descrizione estesa del risultato
Incontro tecnico la frutticoltura: PSA-Batteriosi dell actinidia: sintomi, diagnosi e situazione in provincia di Brescia Martedì 17 Dicembre 2013
 Incontro tecnico la frutticoltura: PSA-Batteriosi dell actinidia: sintomi, diagnosi e situazione in provincia di Brescia Martedì 17 Dicembre 2013 Francesca Gaffuri-Laboratorio Fitopatologico Regione Lombardia-
Incontro tecnico la frutticoltura: PSA-Batteriosi dell actinidia: sintomi, diagnosi e situazione in provincia di Brescia Martedì 17 Dicembre 2013 Francesca Gaffuri-Laboratorio Fitopatologico Regione Lombardia-
Phytophthora ramorum
 REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA AREA SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE Phytophthora ramorum La phytophthora ramorum è un fungo responsabile della malattia delle
REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA AREA SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE Phytophthora ramorum La phytophthora ramorum è un fungo responsabile della malattia delle
Chiara Ferracini, Alberto Alma. Castagni a frutto
 paolo La lotta inglese al cinipide del castagno Il Chiara destino Ferracini, una promessa 98 01 paolo La lotta inglese al cinipide del castagno Il Chiara destino Ferracini, una promessa 02 99 La lotta
paolo La lotta inglese al cinipide del castagno Il Chiara destino Ferracini, una promessa 98 01 paolo La lotta inglese al cinipide del castagno Il Chiara destino Ferracini, una promessa 02 99 La lotta
SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO. SS Ambiente e Natura VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO SS 22.04 - VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE Componenti biotiche vegetazione e suolo Fase Corso d opera 2015 - Terzo anno
SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO SS 22.04 - VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE Componenti biotiche vegetazione e suolo Fase Corso d opera 2015 - Terzo anno
Epidemiologia alternariosi del pomodoro
 M. COLLINA R. BUGIANI Centro di Fitofarmacia Servizio Fitosanitario Dipartimento di Scienze Agrarie Regione Emilia - Romagna Epidemiologia alternariosi del pomodoro Incontro tecnico: Difesa da peronospora
M. COLLINA R. BUGIANI Centro di Fitofarmacia Servizio Fitosanitario Dipartimento di Scienze Agrarie Regione Emilia - Romagna Epidemiologia alternariosi del pomodoro Incontro tecnico: Difesa da peronospora
GRAFIOSI 3.0: Un altra epidemia di grafiosi sta colpendo gli olmi italiani. Alberto Santini*, Leonardo Marianelli**, Fabrizio Pennacchio***
 GRAFIOSI 3.0: Un altra epidemia di grafiosi sta colpendo gli olmi italiani. Alberto Santini*, Leonardo Marianelli**, Fabrizio Pennacchio*** * Istituto per la Protezione delle Piante C.N.R. ** Regione Toscana
GRAFIOSI 3.0: Un altra epidemia di grafiosi sta colpendo gli olmi italiani. Alberto Santini*, Leonardo Marianelli**, Fabrizio Pennacchio*** * Istituto per la Protezione delle Piante C.N.R. ** Regione Toscana
Le malattie delle piante. Classificazione e riconoscimento
 Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
Le malattie delle piante Classificazione e riconoscimento MALATTIA: è una deviazione, uno sconvolgimento, delle normali funzioni vitali (di ricambio o di sviluppo) dell organismo; può essere causata da
oomiceti: peronospore
 oomiceti: peronospore sezione di una foglia parassitizzata Le PERONOSPORE appartenenti alla famiglia delle PERONOSPORACEE del Taxa OOOMICETI sono PARASSITI BIOTROFI il micelio vive all interno dell ospite
oomiceti: peronospore sezione di una foglia parassitizzata Le PERONOSPORE appartenenti alla famiglia delle PERONOSPORACEE del Taxa OOOMICETI sono PARASSITI BIOTROFI il micelio vive all interno dell ospite
Il cancro rameale del noce e non solo. Legnaro, 25 giugno Lucio Montecchio, Dip. TeSAF, UniPD
 Il cancro rameale del noce e non solo Legnaro, 25 giugno 2014 - Lucio Montecchio, Dip. TeSAF, UniPD Il cancro rameale del noce La malattia è nota negli USA dal 2001 come Thousand Cankers Disease (malattia
Il cancro rameale del noce e non solo Legnaro, 25 giugno 2014 - Lucio Montecchio, Dip. TeSAF, UniPD Il cancro rameale del noce La malattia è nota negli USA dal 2001 come Thousand Cankers Disease (malattia
Biodiversità e salute. Flavia Caretta
 Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Biodiversità e salute Flavia Caretta Biodiversità e salute salute degli ecosistemi salute umana Effetti della perdita di biodiversità sulla salute umana Ricerca epidemiologica Rivolta a fattori singoli
Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica la replicazione dell agente nell ospite.
 Infezione Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica la replicazione dell agente nell ospite. Malattia Infettiva È l espressione clinica dell infezione.
Infezione Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica la replicazione dell agente nell ospite. Malattia Infettiva È l espressione clinica dell infezione.
I grandi biomi terrestri
 I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
I grandi biomi terrestri BIOMA: complesso di ecosistemi di un area geografica caratterizzato dalla vegetazione dominate. Si distinguono per alcune caratteristiche delle piante quali struttura (le forme
6-9 marzo 2018 Chianciano Terme (SI) Servizio Fitosanitario Centrale
 6-9 marzo 2018 Chianciano Terme (SI) Servizio Fitosanitario Centrale Principali emergenze fitosanitarie Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis Coleoptera, Cerambycidae Nome Comune: Tarlo asiatico
6-9 marzo 2018 Chianciano Terme (SI) Servizio Fitosanitario Centrale Principali emergenze fitosanitarie Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis Coleoptera, Cerambycidae Nome Comune: Tarlo asiatico
Microbiologia clinica
 Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
Microbiologia clinica Docente : Prof. Ubaldo Scardellato Testo: MICROBIOLOGIA CLINICA Eudes Lanciotti Cea ed. 2001 Temi cardine del programma 1. Lo sviluppo della microbiologia come scienza. 2. La natura
DIFESA DEL VERDE URBANO: COME, QUANDO, PERCHE
 DIFESA DEL VERDE URBANO: COME, QUANDO, PERCHE Nicoletta Vai Servizio fitosanitario, Regione Emilia-Romagna DIFESA DEL VERDE URBANO: PERCHE? Difesa del verde urbano: perché? Per mantenere belle le piante
DIFESA DEL VERDE URBANO: COME, QUANDO, PERCHE Nicoletta Vai Servizio fitosanitario, Regione Emilia-Romagna DIFESA DEL VERDE URBANO: PERCHE? Difesa del verde urbano: perché? Per mantenere belle le piante
può essere scelto dagli studenti del Corso di laurea Magistrale in Medicina delle Piante (ordinamento 2011)
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in MEDICINA DELLE PIANTE Lo studente, oltre agli insegnamenti offerti nell ambito dei Corsi di Laurea Magistrale dell'università degli Studi di Bari, purché riconosciuti coerenti,
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in MEDICINA DELLE PIANTE Lo studente, oltre agli insegnamenti offerti nell ambito dei Corsi di Laurea Magistrale dell'università degli Studi di Bari, purché riconosciuti coerenti,
I boschi del Monte dell Ascensione in inverno
 I boschi del Monte dell Ascensione in inverno Contrariamente a quanto si può pensare, il periodo migliore per apprezzare e fotografare il bosco è proprio l inverno, a maggior ragione se c è neve. Il Monte
I boschi del Monte dell Ascensione in inverno Contrariamente a quanto si può pensare, il periodo migliore per apprezzare e fotografare il bosco è proprio l inverno, a maggior ragione se c è neve. Il Monte
Organismi dannosi alle porte
 Organismi dannosi alle porte Rivera- 10 gennaio 2019 08:00-12:30 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell Economia e delle Finanze Sezione dell Agricoltura Servizio fitosanitario Tarlo asiatico (Anoplophora
Organismi dannosi alle porte Rivera- 10 gennaio 2019 08:00-12:30 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell Economia e delle Finanze Sezione dell Agricoltura Servizio fitosanitario Tarlo asiatico (Anoplophora
PRINCIPALI MALATTIE PARASSITARIE DEGLI AGRUMI
 PRINCIPALI MALATTIE PARASSITARIE DEGLI AGRUMI VIRUS CTV tristezza degli agrumi - Trasmesso da afidi (Toxoptera citricidus) VIROIDI CEVd (citrus exocortite viroid) Exocortite degli agrumi Trasmesso dagli
PRINCIPALI MALATTIE PARASSITARIE DEGLI AGRUMI VIRUS CTV tristezza degli agrumi - Trasmesso da afidi (Toxoptera citricidus) VIROIDI CEVd (citrus exocortite viroid) Exocortite degli agrumi Trasmesso dagli
Halyomorpha halys e Popillia japonica: due nuovi insetti dannosi per il nocciolo. Possibili danni e prospettive di difesa.
 Halyomorpha halys e Popillia japonica: due nuovi insetti dannosi per il nocciolo. Possibili danni e prospettive di difesa. Asti, 17 Marzo 2017 Giovanni Bosio Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
Halyomorpha halys e Popillia japonica: due nuovi insetti dannosi per il nocciolo. Possibili danni e prospettive di difesa. Asti, 17 Marzo 2017 Giovanni Bosio Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
Millefoglio americano Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verd.
 CARATTERI DIAGNOSTICI Forma biologica idrofita radicante Forma di crescita rizomatosa acquatica Modalità di propagazione solo per via vegetativa Dimensioni Foglie, fiori, frutti e semi da qualche cm ad
CARATTERI DIAGNOSTICI Forma biologica idrofita radicante Forma di crescita rizomatosa acquatica Modalità di propagazione solo per via vegetativa Dimensioni Foglie, fiori, frutti e semi da qualche cm ad
LA QUARANTENA: STRUMENTO PER PREVENIRE LE EMERGENZE - presente e futuro
 ACCADEMIA DEI GEORGOFILI Firenze, 24 maggio 2015 LA QUARANTENA: STRUMENTO PER PREVENIRE LE EMERGENZE - presente e futuro Franco Finelli Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Vito Savino, Università
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI Firenze, 24 maggio 2015 LA QUARANTENA: STRUMENTO PER PREVENIRE LE EMERGENZE - presente e futuro Franco Finelli Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Vito Savino, Università
Gabriele Loris Beccaro Maria Gabriella Mellano Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Università degli Studi di Torino
 Gabriele Loris Beccaro Maria Gabriella Mellano Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Università degli Studi di Torino Centro Regionale di Castanicoltura, istituito presso il vivaio regionale
Gabriele Loris Beccaro Maria Gabriella Mellano Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Università degli Studi di Torino Centro Regionale di Castanicoltura, istituito presso il vivaio regionale
Boschi indeboliti. Pinete
 Boschi indeboliti - situazione favorevole per la colonizzazione di numerose specie di insetti - gli insetti riconoscono sostanze emesse dalle piante in condizioni di stress - le piante in tali condizioni
Boschi indeboliti - situazione favorevole per la colonizzazione di numerose specie di insetti - gli insetti riconoscono sostanze emesse dalle piante in condizioni di stress - le piante in tali condizioni
Xylella fastidiosa (Well e Raju) Complesso del disseccamento rapido dell olivo
 Xylella fastidiosa (Well e Raju) Complesso del disseccamento rapido dell olivo Xylella fastidiosa è un batterio appartenente alla famiglia delle Xanthomonadaceae, gram-negativo non sporigeno. La presenza
Xylella fastidiosa (Well e Raju) Complesso del disseccamento rapido dell olivo Xylella fastidiosa è un batterio appartenente alla famiglia delle Xanthomonadaceae, gram-negativo non sporigeno. La presenza
Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Funghi mitosporici,
 sistematica Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Un Divisione a parte è costituita dai Deuteromiceti, detti anche Ifomiceti o più precisamente Funghi mitosporici, di questi miceti non si
sistematica Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Un Divisione a parte è costituita dai Deuteromiceti, detti anche Ifomiceti o più precisamente Funghi mitosporici, di questi miceti non si
La gravità di questa patologia è legata soprattutto al fatto che attualmente non esiste alcun prodotto in grado di contrastare la malattia.
 Mal dell esca Si tratta di una malattia complessa, causata dall'attività spesso combinata o consecutiva di più patogeni fungini Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum Fomitiporia mediterranea
Mal dell esca Si tratta di una malattia complessa, causata dall'attività spesso combinata o consecutiva di più patogeni fungini Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum Fomitiporia mediterranea
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione di Actinidia spp. Descrizione estesa del risultato La legislazione fitosanitaria attualmente vigente a livello nazionale
Risultati della Ricerca Titolo Stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione di Actinidia spp. Descrizione estesa del risultato La legislazione fitosanitaria attualmente vigente a livello nazionale
Corso Bausinve Base 2015
 Corso base Si occupa di individuare: le cause delle malattie i meccanismi attraverso i quali questi agenti inducono la malattia l interazione tra patogeno e pianta ospite l epidemiologia le strategie per
Corso base Si occupa di individuare: le cause delle malattie i meccanismi attraverso i quali questi agenti inducono la malattia l interazione tra patogeno e pianta ospite l epidemiologia le strategie per
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive
 Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
IL RISCHIO BIOLOGICO N. 1. FORMAZIONE GENERALE STUDENTI EQUIPARATI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
 IL RISCHIO BIOLOGICO Unità didattica N. 1 FORMAZIONE GENERALE STUDENTI EQUIPARATI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Versione 1.0 27/10/2016 LA CELLULA Le cellule sono
IL RISCHIO BIOLOGICO Unità didattica N. 1 FORMAZIONE GENERALE STUDENTI EQUIPARATI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Versione 1.0 27/10/2016 LA CELLULA Le cellule sono
Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici
 Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici a cura di Michele Aleffi Dipartimento di Scienze Ambientali Sezione di Botanica ed Ecologia Università di Camerino L opera d arte d o un qualsiasi reperto
Il biodeterioramento dei manufatti storico-artistici a cura di Michele Aleffi Dipartimento di Scienze Ambientali Sezione di Botanica ed Ecologia Università di Camerino L opera d arte d o un qualsiasi reperto
Manta, 29 Aprile 2011
 Biologia ed epidemiologia di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Marco Scortichini C.R.A. Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma Manta, 29 Aprile 2011 A) Kiwi (Actinidia deliciosa cv Hayward) Giappone
Biologia ed epidemiologia di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Marco Scortichini C.R.A. Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma Manta, 29 Aprile 2011 A) Kiwi (Actinidia deliciosa cv Hayward) Giappone
Chalara fraxinea. Ospiti, sintomi e norme di prevenzione
 Regione Toscana Chalara fraxinea Ospiti, sintomi e norme di prevenzione Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Sviluppo rurale - Servizio Fitosantario Regionale
Regione Toscana Chalara fraxinea Ospiti, sintomi e norme di prevenzione Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Sviluppo rurale - Servizio Fitosantario Regionale
Primi risultati di una prova sperimentale sulla risposta al diradamento di un popolamento forestale in fase di deperimento da stress idrico.
 Primi risultati di una prova sperimentale sulla risposta al diradamento di un popolamento forestale in fase di deperimento da stress idrico. Luigi Portoghesi, Naldo Anselmi, Gianluca Piovesan, Annamaria
Primi risultati di una prova sperimentale sulla risposta al diradamento di un popolamento forestale in fase di deperimento da stress idrico. Luigi Portoghesi, Naldo Anselmi, Gianluca Piovesan, Annamaria
Il complesso del Mal dell Esca
 Finest Grape Tech Il complesso del Mal dell Esca Principali caratteristiche e sintomi della malattia www.finestgrapetech.com Finest Grape Tech - 2019 Il Mal dell Esca Il Mal dell Esca Il complesso del
Finest Grape Tech Il complesso del Mal dell Esca Principali caratteristiche e sintomi della malattia www.finestgrapetech.com Finest Grape Tech - 2019 Il Mal dell Esca Il Mal dell Esca Il complesso del
Situazione nel 2017 in Emilia-Romagna
 Parma, 28 Febbraio 2018 SEMINARIO TECNICO: Gestione di Ralstosnia solanacearum su pomodoro e patata Situazione nel 2017 in Emilia-Romagna Anna Piana, Clelia Tosi - Servizio Fitosanitario Regione Emilia-
Parma, 28 Febbraio 2018 SEMINARIO TECNICO: Gestione di Ralstosnia solanacearum su pomodoro e patata Situazione nel 2017 in Emilia-Romagna Anna Piana, Clelia Tosi - Servizio Fitosanitario Regione Emilia-
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RAVA, CAPITELLI, DAMERI, PENNA, VOGLINO
 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6301 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAVA, CAPITELLI, DAMERI, PENNA, VOGLINO Disposizioni in favore delle produzioni viticole
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6301 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAVA, CAPITELLI, DAMERI, PENNA, VOGLINO Disposizioni in favore delle produzioni viticole
EVOLUZIONE DELLE PATOLOGIE
 COMMITTENTE: Bosco del Rugareto Comune di Cislago Piazza E. Toti, 1 21040 Cislago (VA) TITOLO: STUDIO FITOSOCIOLOGICO DEL P.L.I.S. DEL BOSCO DEL RUGARETO STUDIO INTEGERIVO EVOLUZIONE DELLE POLOGIE DEL
COMMITTENTE: Bosco del Rugareto Comune di Cislago Piazza E. Toti, 1 21040 Cislago (VA) TITOLO: STUDIO FITOSOCIOLOGICO DEL P.L.I.S. DEL BOSCO DEL RUGARETO STUDIO INTEGERIVO EVOLUZIONE DELLE POLOGIE DEL
Caratterizzazione molecolare del batterio ed interventi di prevenzione e difesa. Responsabile scientifico: Dott. Marco Scortichini
 Caratterizzazione molecolare del batterio ed interventi di prevenzione e difesa Responsabile scientifico: Dott. Marco Scortichini 1) Analisi proteomica durante la migrazione sistemica di PSA nel ramo di
Caratterizzazione molecolare del batterio ed interventi di prevenzione e difesa Responsabile scientifico: Dott. Marco Scortichini 1) Analisi proteomica durante la migrazione sistemica di PSA nel ramo di
La Nutria in provincia di Ferrara. C. Castagnoli R. Finco
 La Nutria in provincia di Ferrara C. Castagnoli R. Finco Corpo Polizia Provinciale P.O. Agricoltura Sostenibile Caccia e Aree Protette PROVINCIA DI FERRARA Nutria Parte specifica L entrata in vigore legge
La Nutria in provincia di Ferrara C. Castagnoli R. Finco Corpo Polizia Provinciale P.O. Agricoltura Sostenibile Caccia e Aree Protette PROVINCIA DI FERRARA Nutria Parte specifica L entrata in vigore legge
Il cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilusyasumatsu
 Il cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilusyasumatsu Giovanni Bosio Regione Piemonte, Settore Fitosanitario Il cinipede galligeno Drycosmus kuriphilusyasumatsu è considerato uno degli insetti
Il cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilusyasumatsu Giovanni Bosio Regione Piemonte, Settore Fitosanitario Il cinipede galligeno Drycosmus kuriphilusyasumatsu è considerato uno degli insetti
Caratterizzazione del deperimento dei querco-carpineti planiziali: sintomi e possibili cause
 Caratterizzazione del deperimento dei querco-carpineti planiziali: sintomi e possibili cause Paolo Gonthier Università degli Studi di Torino DIVAPRA Patologia Vegetale Parco del Ticino: luglio 2003 Sintomi
Caratterizzazione del deperimento dei querco-carpineti planiziali: sintomi e possibili cause Paolo Gonthier Università degli Studi di Torino DIVAPRA Patologia Vegetale Parco del Ticino: luglio 2003 Sintomi
DISPAA. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell Ambiente (DISPAA) - Università di Firenze. Simone Orlandini
 DISPAA Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell Ambiente (DISPAA) - Università di Firenze Simone Orlandini Piazzale delle Cascine 18. 50144, Firenze E-mail: simone.orlandini@unifi.it
DISPAA Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell Ambiente (DISPAA) - Università di Firenze Simone Orlandini Piazzale delle Cascine 18. 50144, Firenze E-mail: simone.orlandini@unifi.it
GENERALITA DELLA RIPRODUZIONE NELLE PIANTE
 GENERALITA DELLA RIPRODUZIONE NELLE PIANTE LA RIPRODUZIONE E QUEL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE UN INDIVIDUO DA ORIGINE AD UNO O PIU DISCENDENTI A LUI SIMILI ED ESSI STESSI IN GRADO DI RIPRODURSI LA RIPRODUZIONE
GENERALITA DELLA RIPRODUZIONE NELLE PIANTE LA RIPRODUZIONE E QUEL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE UN INDIVIDUO DA ORIGINE AD UNO O PIU DISCENDENTI A LUI SIMILI ED ESSI STESSI IN GRADO DI RIPRODURSI LA RIPRODUZIONE
Le PIANTE ALIENE nel Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline
 Le PIANTE ALIENE nel Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline Puddu S. 1, Papoff C. M. 2, Massa L. 2, Durante L. 2, Bacchetta G. 1 1 Centro Conservazione Biodiversità (CCB), Dipartimento di Scienze
Le PIANTE ALIENE nel Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline Puddu S. 1, Papoff C. M. 2, Massa L. 2, Durante L. 2, Bacchetta G. 1 1 Centro Conservazione Biodiversità (CCB), Dipartimento di Scienze
Il cancro corticale del castagno
 Chestnut blight/canker Cryphonectria parasitica Chancre de l écorce du châtaigner Kastanienkrebs Chancro del castaño La malattia è importante per i suoi riflessi economici, ecologici, sociali e biologici.
Chestnut blight/canker Cryphonectria parasitica Chancre de l écorce du châtaigner Kastanienkrebs Chancro del castaño La malattia è importante per i suoi riflessi economici, ecologici, sociali e biologici.
IL MATERIALE VIVAISTICO. Paolo Camerano IPLA S.p.A Piero Belletti UniTO
 IL MATERIALE VIVAISTICO Paolo Camerano IPLA S.p.A Piero Belletti UniTO ALCUNE NOTIZIE STORICHE 1873 Primi vivai forestali in Italia (2 ha) 1886 35 ha di superficie di vivai forestali 2,5 milioni di piante
IL MATERIALE VIVAISTICO Paolo Camerano IPLA S.p.A Piero Belletti UniTO ALCUNE NOTIZIE STORICHE 1873 Primi vivai forestali in Italia (2 ha) 1886 35 ha di superficie di vivai forestali 2,5 milioni di piante
ECOLOGIA DELLE PIANTE DI TASSO DELL ISOLA D ELBA. Dott.ssa Francesca Anselmi
 ECOLOGIA DELLE PIANTE DI TASSO DELL ISOLA D ELBA Dott.ssa Francesca Anselmi Portoferraio, 08 ottobre 2009 Perché lo studio del tasso Taxus baccata L.: pianta estremamente antica, con complessa biologia;
ECOLOGIA DELLE PIANTE DI TASSO DELL ISOLA D ELBA Dott.ssa Francesca Anselmi Portoferraio, 08 ottobre 2009 Perché lo studio del tasso Taxus baccata L.: pianta estremamente antica, con complessa biologia;
Piacenza, 11 Novembre 2013 Convegno su
 Piacenza, 11 Novembre 2013 Convegno su Il Pioppo: una risorsa ecosostenibile per il futuro. La PAC ed I PSR 2014-2020 I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA DIFESA FITOSANITARI DEL PIOPPO (1)Università della Tuscia,
Piacenza, 11 Novembre 2013 Convegno su Il Pioppo: una risorsa ecosostenibile per il futuro. La PAC ed I PSR 2014-2020 I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA DIFESA FITOSANITARI DEL PIOPPO (1)Università della Tuscia,
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3 DELIBERAZIONE 12 gennaio 2015, n. 8
 DELIBERAZIONE 12 gennaio 2015, n. 8 Approvazione schema di protocollo d intesa tra Regione Toscana, Distretto rurale vivaistico ornamentale e Organizzazioni professionali agricole regionali relativo al
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2015, n. 8 Approvazione schema di protocollo d intesa tra Regione Toscana, Distretto rurale vivaistico ornamentale e Organizzazioni professionali agricole regionali relativo al
Il nematode galligeno del riso Meloidogyne graminicola: caratteristiche e sintomatologia
 ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Il nematode galligeno del riso Meloidogyne graminicola: caratteristiche e sintomatologia
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Il nematode galligeno del riso Meloidogyne graminicola: caratteristiche e sintomatologia
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. IL TARLO ASIATICO DEL FUSTO Anoplophora glabripennis
 Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici IL TARLO ASIATICO DEL FUSTO Anoplophora glabripennis Cuneo, 3 ottobre 2018 Primi ritrovamenti in Piemonte 2018-30 luglio 2018 a Vaie (TO) in un viale
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici IL TARLO ASIATICO DEL FUSTO Anoplophora glabripennis Cuneo, 3 ottobre 2018 Primi ritrovamenti in Piemonte 2018-30 luglio 2018 a Vaie (TO) in un viale
 Marciume bruno e Avvizzimento batterico di patata da Ralstonia solanacearum. Attacco in campo. L infezione ha spesso origine dai tuberi-seme infetti, ma il batterio ha ottime attitudini saprofitarie ed
Marciume bruno e Avvizzimento batterico di patata da Ralstonia solanacearum. Attacco in campo. L infezione ha spesso origine dai tuberi-seme infetti, ma il batterio ha ottime attitudini saprofitarie ed
RISULTATI RELATIVI ALL IMPIEGO DI BIO AKSXTER
 AXS M31 di Zambanini Silvana bio-formulazione avanzata per l agricoltura RISULTATI RELATIVI ALL IMPIEGO DI BIO AKSXTER Relazione Tecnica 2004-2010 Azienda Agricola Scandola Riccardo - Emiliano tecnologia
AXS M31 di Zambanini Silvana bio-formulazione avanzata per l agricoltura RISULTATI RELATIVI ALL IMPIEGO DI BIO AKSXTER Relazione Tecnica 2004-2010 Azienda Agricola Scandola Riccardo - Emiliano tecnologia
Impatto del rilascio intenzionale di un virus altamente patogeno in relazione alla mobilità internazionale
 Impatto del rilascio intenzionale di un virus altamente patogeno in relazione alla mobilità internazionale 16 aprile 2014 Introduzione Negli ultimi anni è cresciuto il rischio dell utilizzo di armi biologiche
Impatto del rilascio intenzionale di un virus altamente patogeno in relazione alla mobilità internazionale 16 aprile 2014 Introduzione Negli ultimi anni è cresciuto il rischio dell utilizzo di armi biologiche
Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità
 Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità 11 GIUGNO 2016 Città di Cherasco PALAEXPO PIAZZA DEGLI ALPINI Il settore nocicolo nel comparto della frutta in guscio Dr. Alberto Manzo Coordinatore Tavolo
Nocciolo Noce e Castagno Tecnica e opportunità 11 GIUGNO 2016 Città di Cherasco PALAEXPO PIAZZA DEGLI ALPINI Il settore nocicolo nel comparto della frutta in guscio Dr. Alberto Manzo Coordinatore Tavolo
Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 28 novembre 2002
 Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 28 novembre 2002 Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum
Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 28 novembre 2002 Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum
Risultati della Ricerca
 Risultati della Ricerca Titolo Conservazione e gestione dei popolamenti di origine agamica a prevalenza di leccio della Sardegna Descrizione estesa del risultato Nel bacino del Mediterraneo il leccio (Quercus
Risultati della Ricerca Titolo Conservazione e gestione dei popolamenti di origine agamica a prevalenza di leccio della Sardegna Descrizione estesa del risultato Nel bacino del Mediterraneo il leccio (Quercus
Phillyrea angustifolia L. Arbutus unedo L. Pistacia lentiscus L. Ruscus aculeatus L.
 Le specie mediterranee presentano diversi ritmi fenologici Specie sclerofille sempreverdi (es. Arbutus unedo L., Phillyrea spp., Pistacia lentiscus L., Ruscus aculeatus L.) che limitano la loro attività
Le specie mediterranee presentano diversi ritmi fenologici Specie sclerofille sempreverdi (es. Arbutus unedo L., Phillyrea spp., Pistacia lentiscus L., Ruscus aculeatus L.) che limitano la loro attività
CORSO DI BIOLOGIA, ANATOMIA E MORFOLOGIA DEI VEGETALI Dr. Nicola Olivieri
 FACOLTA DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI CORSO DI STUDI IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA CORSO DI BIOLOGIA, ANATOMIA E MORFOLOGIA DEI VEGETALI Dr. Nicola Olivieri ARGOMENTO: VITACEAE parte
FACOLTA DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI CORSO DI STUDI IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA CORSO DI BIOLOGIA, ANATOMIA E MORFOLOGIA DEI VEGETALI Dr. Nicola Olivieri ARGOMENTO: VITACEAE parte
Aspetti fitosanitari
 Convegno Conclusivo Progetto VIS Vivaismo Sostenibile Task4: Riutilizzo dei substrati esausti recuperati Task leader: Prof. Giovanni Vannacci Collaboratori: Susanna Pecchia, Sabrina Sarrocco, Maurizio
Convegno Conclusivo Progetto VIS Vivaismo Sostenibile Task4: Riutilizzo dei substrati esausti recuperati Task leader: Prof. Giovanni Vannacci Collaboratori: Susanna Pecchia, Sabrina Sarrocco, Maurizio
LA CONOSCENZA DEL FENOMENO
 LA CONOSCENZA DEL FENOMENO Il processo di combustione L incendio è il prodotto della rapida combinazione di tre elementi fondamentali: il combustibile, l ossigeno e la temperatura necessaria per innescare
LA CONOSCENZA DEL FENOMENO Il processo di combustione L incendio è il prodotto della rapida combinazione di tre elementi fondamentali: il combustibile, l ossigeno e la temperatura necessaria per innescare
Il malsecco degli agrumi: Phoma tracheiphila
 Il malsecco degli agrumi: Phoma tracheiphila SINTOMI Sintomi visibili soprattutto in autunno e primavera : - disseccamenti basipeti e settoriali - filloptosi ESITI DI INFEZIONI DELLA CHIOMA Altri sintomi:
Il malsecco degli agrumi: Phoma tracheiphila SINTOMI Sintomi visibili soprattutto in autunno e primavera : - disseccamenti basipeti e settoriali - filloptosi ESITI DI INFEZIONI DELLA CHIOMA Altri sintomi:
Recinzioni elettrificate per la difesa dei vigneti dagli ungulati
 Recinzioni elettrificate per la difesa dei vigneti dagli ungulati Categories : Anno 2014, N. 189-1 maggio 2014 di Alessandro Cerofolini Vigneto nel Chianti In questi ultimi anni si è verificato un notevole
Recinzioni elettrificate per la difesa dei vigneti dagli ungulati Categories : Anno 2014, N. 189-1 maggio 2014 di Alessandro Cerofolini Vigneto nel Chianti In questi ultimi anni si è verificato un notevole
SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO. SS Ambiente e Natura VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
 SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO SS 22.04 - VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE Componenti biotiche vegetazione e suolo Fase Corso d opera 2016 - Quarto anno
SC22 - DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E DISSESTO SS 22.04 - VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE Componenti biotiche vegetazione e suolo Fase Corso d opera 2016 - Quarto anno
Il metodo di rilievo: la scheda VTA
 1 Il metodo di rilievo: la scheda VTA FAUSTO NASI DOTTORE AGRONOMO Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali - La Spezia 9 giugno 2016 2 Il metodo VTA: cos è Il metodo VTA (Visual Tree Assessment), attraverso
1 Il metodo di rilievo: la scheda VTA FAUSTO NASI DOTTORE AGRONOMO Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali - La Spezia 9 giugno 2016 2 Il metodo VTA: cos è Il metodo VTA (Visual Tree Assessment), attraverso
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA CDL IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante all esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) Presidente: Prof.
DISPENSA DI BIOLOGIA APPLICATA IPSAA CORSO SERALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: PROF.SSA ELENA ANGOTTI ANNO SCOLASTICO
 DISPENSA DI BIOLOGIA APPLICATA IPSAA CORSO SERALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: PROF.SSA ELENA ANGOTTI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 PATOGENESI DELLE MALATTIE INFETTIVE LE MALATTIE INFETTIVE SONO IL RISULTATO
DISPENSA DI BIOLOGIA APPLICATA IPSAA CORSO SERALE CLASSE III SEZ. A DOCENTE: PROF.SSA ELENA ANGOTTI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 PATOGENESI DELLE MALATTIE INFETTIVE LE MALATTIE INFETTIVE SONO IL RISULTATO
Piano di Gestione area SIC Foresta di Monte Arcosu
 VALUTAZIONE GENERALE E IDENTIFICAZIONE DELLE MINACCE L analisi delle caratteristiche del SIC ha permesso di procedere ad una valutazione generale dello stato del territorio e alla identificazione delle
VALUTAZIONE GENERALE E IDENTIFICAZIONE DELLE MINACCE L analisi delle caratteristiche del SIC ha permesso di procedere ad una valutazione generale dello stato del territorio e alla identificazione delle
Globalizzazione e protezione delle biomasse legnose da organismi alieni nocivi
 Globalizzazione e protezione delle biomasse legnose da organismi alieni nocivi Riccardo Russu Pio Federico Roversi "La Valorizzazione delle Produzioni Legnose Nazionali 16 giugno 2016 EcoSMA RT Valore
Globalizzazione e protezione delle biomasse legnose da organismi alieni nocivi Riccardo Russu Pio Federico Roversi "La Valorizzazione delle Produzioni Legnose Nazionali 16 giugno 2016 EcoSMA RT Valore
IMPATTO DELLA PHTHORIMEA OPERCULELLA SULLA COLTURA DELLA PATATA
 IMPATTO DELLA PHTHORIMEA OPERCULELLA SULLA COLTURA DELLA PATATA BOLOGNA 22-10- 2013 Dr. D. D Ascenzo Servizio Fitosanitario Abruzzo Per poter inquadrare correttamente la problematica della tignola è importante
IMPATTO DELLA PHTHORIMEA OPERCULELLA SULLA COLTURA DELLA PATATA BOLOGNA 22-10- 2013 Dr. D. D Ascenzo Servizio Fitosanitario Abruzzo Per poter inquadrare correttamente la problematica della tignola è importante
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale Corpo forestale della Valle d Aosta
 ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale Corpo forestale della Valle d Aosta RAPPORTO SUI DANNI DA DEFOGLIAZIONE CAUSATI DALLA PROCESSIONARIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale Corpo forestale della Valle d Aosta RAPPORTO SUI DANNI DA DEFOGLIAZIONE CAUSATI DALLA PROCESSIONARIA
Malattie da vettore e Zika virus: Prevenzione e comunicazione Perugia 21 aprile 2016 Zanzare invasive in Italia: Caratteristiche e diffusione
 Malattie da vettore e Zika virus: Prevenzione e comunicazione Perugia 21 aprile 2016 Zanzare invasive in Italia: Caratteristiche e diffusione Dott. Fabrizio Montarsi Lab. di Parassitologia Cosa vuol dire
Malattie da vettore e Zika virus: Prevenzione e comunicazione Perugia 21 aprile 2016 Zanzare invasive in Italia: Caratteristiche e diffusione Dott. Fabrizio Montarsi Lab. di Parassitologia Cosa vuol dire
