Occorrenze iconografiche della patera nelle emissioni a nome delle Auguste
|
|
|
- Anna Viola Testa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Occorrenze iconografiche della patera nelle emissioni a nome delle Auguste I tipi monetali, uniti alle leggende e spesso in stretta connessione tra dritto e rovescio, possono costituire, se opportunamente letti ed interpretati, apporti decisivi per la comprensione di una linea politica, di un regno o di un imperatore. In epoca romana imperiale l autorità politica esprime, attraverso le monete, valori nei quali si riconosce e attraverso i quali essa trova giustificazione, perciò l analisi delle emissioni consente di individuare diverse linee ideologiche, all interno delle quali emerge il ruolo delle Auguste e dei valori ad esse collegati. Questo filone di indagine costituisce l oggetto della Unità di ricerca locale intrapresa dall Università di Bologna (sul tema: Il ruolo femminile nell immaginario del potere) nell ambito di un più vasto progetto sulla iconografia monetale, coordinato a livello nazionale dall Università di Messina (L immaginario e il potere. Per un Lessico Iconografico Numismatico - LIN). Le analisi condotte in questo ambito hanno consentito di affermare che ogni particolare dell immagine è l esito di nessi e sintesi concettuali, a cui corrisponde un preciso significato, all interno di un sistema segnico, la cui efficacia è garantita da regole e convenzioni. (Caccamo Caltabiano, 2004, 11-40; Morelli, 2004, ). La corretta interpretazione di immagini con un significato complesso può essere raggiunta solo attraverso la definizione di un lessico universalmente valido e di un metodo interpretativo obiettivo: aspetti dell abito, dell acconciatura, degli ornamenti e degli attributi concorrono ad esprimere specifiche qualità e funzioni del soggetto rappresentato e contribuiscono alla formazione di modelli di riferimento. L esemplificazione che qui si presenta ha lo scopo di evidenziare uno dei percorsi di ricerca che si stanno sviluppando, mettendo a fuoco alcuni aspetti che hanno suggerito approfondimenti specifici. Nel corso del lavoro di analisi iconografica, relativamente all ambito femminile, è parsa di notevole interesse la figura in trono che emerge con particolare risalto nelle emissioni di Galba; questa iconografia è stata analizzata risalendo ai precedenti, mettendola in relazione con la leggenda e con gli elementi del dritto ed integrandola con le fonti letterarie, allo scopo di delineare il contesto ideologico ed il linguaggio formale con cui si esprime. L esito di questa analisi ha consentito di formulare l ipotesi che tale immagine, introdotta nella primissima età imperiale ed utilizzata con grande risalto nelle emissioni successive di Tiberio, Claudio e Galba, sia un richiamo ideologico, una sorta di parola d ordine riferibile ad una precisa linea politica, espressa attraverso una scelta iconografica di significato pregnante, comprensibile anche in assenza di una leggenda esplicativa (Morelli, 2001). Si è delineato così un quadro che ha permesso di individuare, alla base di questa raffigurazione monetale, precise motivazioni ufficiali ed un preciso filone di affermazione del potere personale dell imperatore attraverso l allusione ad un personaggio femminile, in questo caso, Livia. Questa figura, se inizialmente incarna la sintesi delle virtù che connotano l immagine pubblica dell Augusta, in seguito diventa il modello di riferimento per le scelte degli imperatori successivi nel richiamarsi apertamente alla linea politica augustea. Nella sequenza delle emissioni, l immagine femminile presenta la stessa costruzione complessiva, è connotata dalla medesima postura e da alcuni elementi fissi, quali il trono e lo scettro, simboli del potere, tuttavia tramite l utilizzo di piccole varianti, sostanzialmente rappresentate da differenti attributi, la figura assume diverse connotazioni. Lo studio degli attributi che si alternano a definire l immagine in questione ha permesso di individuare vere e proprie formule tipologico-epigrafiche e di evidenziare uno stretto legame tra questa figura e le linee della propaganda imperiale. 567
2 Tuttavia, una corretta lettura dei particolari accessori, che consenta il riconoscimento della loro diversa valenza simbolica, richiede innanzi tutto una verifica, e in qualche caso una revisione, delle descrizioni riportate dai repertori numismatici, che spesso non risultano né univoche né omogenee, inoltre necessita di un confronto il più possibile allargato con altre categorie di fonti. Dall esame di questa iconografia, condotta sia attraverso la produzione ufficiale che attraverso la emissioni provinciali (Morelli, 2001 e Morelli, in corso di stampa [a]) è emerso un quadro che ha indotto a proseguire la ricerca sviluppando l analisi dei diversi attributi in senso diacronico, allo scopo di assegnare a ciascuno di essi un preciso valore sintattico-lessicale, nell ambito del linguaggio iconografico, derivato dall esame delle sue occorrenze in campo numismatico. Tra gli attributi ricorrenti della figura femminile analizzata, quello che compare con maggiore frequenza, sia nelle emissioni ufficiali che nelle province, è senza dubbio la patera, lo strumento-simbolo del rituale della libagione. In questa sede si propone una registrazione di dati, preliminare alla loro ricomposizione in una visione unitaria e ad una interpretazione esaustiva del dato iconografico, ricavabile dai tipi di rovescio delle emissioni ufficiali a nome delle Auguste, emissioni caratterizzate, cioè, dal ritratto di un personaggio femminile della famiglia imperiale al dritto. La patera è un attributo appartenente alla sfera religiosa, capace di esprimere sia qualità divine che prerogative sacerdotali, perciò una prima analisi in questa direzione, nell ambito della ricerca condotta sul ruolo femminile nell ideologia del potere, ha cercato di verificare l adozione e l evoluzione di questo attributo come elemento qualificativo delle stesse Auguste (Morelli, in corso di stampa [b]). Da questo studio sono emersi dati interessanti che rivelano come l esclusione della donna dalla pratica dei sacrifici abbia in realtà numerose eccezioni, da un lato legate a realtà istituzionali, anche se marginali (si pensi, ad esempio, al ruolo delle Vestali o delle Flaminicae), ma dall altro connesse piuttosto a situazioni specifiche e personali di alcune Auguste, per le quali risulta verosimile una partecipazione concreta ad atti sacrificali, legati a particolari occasioni o onori o ancora alla peculiarità di taluni ruoli (Morelli, in corso di stampa [b]). Accanto a queste prerogative eccezionali, l attributo della patera trova una utilizzazione assai frequente nelle raffigurazioni di divinità e di personificazioni che compaiono nei tipi di rovescio delle emissioni a nome delle Auguste. L analisi di queste raffigurazioni ha evidenziato una precisa volontà di collegamento delle immagini presenti sui due lati della moneta, infatti tra i tipi di rovescio compaiono con l attributo della patera divinità nel cui culto è attestata una concreta partecipazione femminile. Si tratta essenzialmente di Giunone, Vesta e Venere, tutte divinità tipicamente matronali, strettamente connesse ai molteplici aspetti della vita della donna e, in particolare, all elemento della fecondità, al ruolo della Augusta come moglie del Pontifex Maximus, e quindi custode della tradizione religiosa più antica e venerata dello Stato, o al tema della coesione e della stabilità trasmesso dall unione della coppia imperiale. Tra le divinità recanti la patera compare con la frequenza maggiore Giunone. Nell iconografia monetale, relativa alle emissioni a nome delle Auguste, in cui reca questo attributo, Giunone è sempre rappresentata stante, con il velo sul capo, con lungo scettro e spesso è affiancata dal pavone; in questa rappresentazione essa viene connotata dalla leggenda come Regina, ma anche Conservatrix e Lucina. Giunone, rappresenta l ambito femminile nella sua complessità, ma riguarda anche l aspetto della unione matrimoniale, a cui si connette il parallelo consolidato tra la coppia coniugale Iuppiter-Iuno e la coppia imperiale; la raffigurazione della consorte dell imperatore al dritto caratterizza il messaggio, ponendo l accento sul sentimento di concordia che anima la coppia imperiale e che si traduce, a livello sociale, in un auspicio di coesione all interno della collettività (Mikocki, 1995, 23). Giunone infatti è anche protettrice ed amministratrice della città; in particolare quello di Iuno Regina è uno dei culti più antichi dei romani: evocata da Camillo nel 396 e venerata nel tempio sull Aventino, da lui voluto, e successivamente anche in quello votato da M. Emilio Lepido in circo Flaminio, oltre che venerata con lo stesso epiteto all interno della Triade Capitolina nel tempio sul Campidoglio; come protettrice della castità delle matrone, essa era celebrata durante le feste dei Matronalia e delle Nonae Caprotinae, nel corso delle quali le matrone offrivano sacrifici non cruenti (La Rocca, 1990; Turcan, 1988; Dury Moyaers-Renard, 1981). 568
3 OCCORRENZE ICONOGRAFICHE DELLA PATERA NELLE EMISSIONI A NOME DELLE AUGUSTE L iconografia di Giunone in associazione all immagine delle Auguste, con l attributo della patera e con l appellativo di Regina nella leggenda, ricorre con Sabina (BMCRE V, lxxi, nota 3), che lo introduce per prima (Fig.1), seguita da Faustina I e successivamente da altre donne degli Antonini e poi dei Severi fino a Giulia Domna (Fig.2); con gli stessi attributi, ma con l appellativo di Conservatrix, epiteto più comunemente applicato a Giove, ricorre con Giulia Mamea (Fig.3), mentre come Iuno, senza altre connotazioni, compare con Giulia Mesa (Fig.5) e con Giulia Soemia; alle fasi della vita della donna e in particolare all aspetto della fecondità è solitamente riferito l epiteto Lucina che compare invece con Faustina II (Fig.4), in stretta relazione con l aspetto della prole, sottolineato in altre tipologie monetali. Infine è da segnalare la probabile raffigurazione della dea in associazione alla leggenda Æternitas nelle emissioni di consacrazione per Faustina I (Fig.6), con la leggenda Diva Faustina al dritto; del resto, data la forte correlazione con la vita della donna, Giunone si caratterizza come divinità strettamente individuale, legata perciò anche alla conclusione della vita stessa. Il confronto con iconografie in ambiti diversi da quello numismatico non consente una identificazione di attributi specifici per questa dea (con l eccezione della presenza caratterizzante del pavone, frequente, ma non determinante), probabilmente perché essa risponde a funzioni differenziate: protettrice della fecondità delle donne e quindi dei nascituri, ma anche della gioventù, quindi delle armi e, per traslato, della attività politica. Mi sembra perciò di poter dire che la sua qualificazione, nella documentazione numismatica esaminata, emerga più dall epiteto che dalla associazione del ritratto femminile al dritto: l attributo della patera non connota tanto una prerogativa delle dea quanto piuttosto un atto di culto, cioè l invocazione e la richiesta di protezione in quella specifica accezione, di cui si fa tramite la Augusta, nel ruolo ufficiale che le compete. Vesta è la dea matronale per eccellenza e al suo culto, tipicamente femminile, attendevano le sei sacerdotes vestales (Martini, 1997); il culto di Vesta, connesso a quello dei Penati, rivestiva un importanza fondamentale sia nell ambito familiare che in quello pubblico e attraverso di esso si custodivano e si tramandavano le memorie più antiche e venerate dello Stato. Il suo culto si addice alle imperatrici nella loro qualità di mogli del Pontifex Maximus; le iconografie ricorrenti durante l impero vedono come attributi il simpulum o la patera e, in alternativa, il Palladio (BMCRE V, cxcvii). Relativamente all immagine di Vesta, l attributo della patera si connette con assoluta evidenza agli aspetti del culto; l assenza di un tipo iconografico originale anteriore all età imperiale rende riconoscibile la divinità attraverso il contesto, individuato da scene di culto in cui la figura femminile con il capo velato è rappresentata in atto di libare sul fuoco acceso oppure seduta in trono, sempre con il capo coperto, tiene lo scettro e la patera (Fischer- Hansen 1990). L iconografia con questo attributo è probabilmente da collegare alla statua posta da Augusto nella sua dimora sul Palatino, ma, isolata dalle scene di culto, nell iconografia ufficiale, la dea ricorre anche con il Palladio al posto della patera nella destra, mentre nella sinistra, in alternativa allo scettro, compare anche il cornucopia. Nella tipologia monetale sono presenti numerose iconografie di Vesta, con varianti caratterizzate da diversi attributi. Nelle emissioni a nome delle Auguste la divinità ricorre assai frequentemente, ma, in particolare con l attributo della patera, compare nelle monete per Faustina I, per Giulia Domna e Giulia Mamea (Fig.7), in varie raffigurazioni associate a diverse leggende: la figura femminile, sempre con il capo velato, è presente nell immagine seduta o stante in cui reca, oltre alla patera, lo scettro, ma anche in scene di sacrificio presso un altare acceso, con la patera associata al Palladio, in entrambi i casi con leggenda Augusta; infine compare stante, con la patera e una lunga torcia e leggenda Consecratio. In assenza di una identificazione attraverso l iscrizione, quest ultima immagine femminile è univocamente riconosciuta dai repertori come Vesta, tuttavia nell iconografia con la torcia non è da escludere, a mio avviso, l ipotesi identificativa con Demetra/Ceres, in stretta relazione con la morte, nell evidente richiamo al mito ellenico di Demetra e Kore, mentre nell iconografia in trono con patera e scettro si può forse riconoscere la stessa Augusta, come suggerisce la leggenda e come iconografie del tutto simili in epoche precedenti possono confermare (Morelli, 2001). Diversa appare la scelta tipologica nella emissione a nome di Giulia Domna, in cui la leggenda Vestæ Sanctæ rende inequivocabile l identificazione, anche se l appellativo, piuttosto inusuale nell ambito romano, connota una sfumatura orientale del suo culto: la divinità è stante, con il capo velato, regge la patera e un lungo scettro. Con Giulia Domna ricorre anche la leggenda Vesta Mater con il tipo raffigurante la scena di sacrificio davanti al tempio, che probabilmente rappresenta il momento del culto pubblico in cui la stessa imperatrice, con le Vestali, scioglieva i vota (BMCRE V, cxxxiii e cicviii). 569
4 L altra divinità recante l attributo della patera nelle emissioni a nome delle Auguste è Venere, il cui culto, già in epoca repubblicana, era tra quelli celebrati dalle matrone, in riferimento ad episodi legati alle origini di Roma, a cui si richiamano nel I secolo a.c. i capi militari, durante le guerre civili, allo scopo di avocare a sé i favori della dea come rafforzativo e giustificativo del loro potere personale. Patrona di Silla, venerata da Pompeo, poi rivendicata come antenata da Cesare, la dea viene investita di connotazioni specifiche espresse attraverso gli epiteti di Felix, Victrix e Genetrix, quest ultimo associato alla sua funzione universale e popolare, legata alla fecondità femminile e riconducibile alla discendenza da Enea. L associazione o, meglio, l assimilazione di Venere con le Auguste ha una tradizione consolidata, nota soprattutto da rilievi, a partire già da Livia (Mikocki, 1995): il suo ruolo all interno della dinastia giulio-claudia caratterizza la trasmissione del potere secondo l ordine dinastico e in questa prospettiva l imperatrice è Genetrix (Barrett, 2002, ). Oltre a Livia, anche Giulia, figlia di Augusto, poi Agrippina e Drusilla vengono identificate con Venere e, successivamente, la divinità si trova accostata a Giulia di Tito e a Domizia, poi a Faustina Minore e a Sabina (Pera, 1978, 93-94). Da queste numerose raffigurazioni monetali emerge però, analogamente a Giunone, la non riconoscibilità di una iconografia specifica legata ai diversi epiteti di Venere, da cui deriva che i differenti attributi utilizzati caratterizzano varianti probabilmente da connettere al repertorio della statuaria, in particolare di quella greca (Schmidt, 1997). Nella tipologia monetale l attributo della patera è associato allo scettro e, in particolare, all appellativo di Genetrix, quindi in stretta connessione con il ritratto della Augusta al dritto; l iconografia mostra sia la variante con l immagine stante (Fig.8) che quella con la figura in trono, entrambe presenti nelle emissioni a nome di Giulia Domna (Ghedini, 1984, ). Complessivamente, la assenza di elementi ricorrenti e univoci nella iconografia di queste divinità sembra suggerire che l attributo della patera non sia elemento qualificante, né identificativo, ma che, associata ad altri attributi che hanno la funzione di illustrare una specializzazione, rappresenti piuttosto una connotazione legata al culto, al rituale con cui ci si rivolge alla divinità, con un atto di sacrificio connesso all invocazione. Il mezzo monetale veicola in tal modo un messaggio di tipo religioso: la stretta connessione tra il tipo del dritto e quello del rovescio sottolinea il legame tra la divinità e l Augusta e sancisce la superiorità morale ed intellettuale di quest ultima, che si caractterizza come tramite tra la comunità e la dea. Nelle emissioni a nome delle Auguste la patera connota anche le immagini di alcune personificazioni. In una iconografia, quella romana, che possiamo definire parlante, gli attributi delle personificazioni, spesso derivati dall arte greca, ubbidiscono ad un preciso linguaggio, finalizzato alla rappresentazione di specifiche virtutes (Panvini Rosati, 1996). La moltiplicazione di allegorie e personificazioni, osservabile in epoca imperiale, ma già prefigurata in età repubblicana, risponde principalmente alle necessità della ideologia politica e dinastica, delineando un preciso sistema di valori su si fonda la realtà istituzionale: il favore delle varie divinità, per il tramite della autorità, potrà garantire la realizzazione nella comunità e nello Stato di quelle particolari condizioni di cui le entità soprannaturali sono portatrici e dispensatrici (Fears, 1981, ). In questa prospettiva la stabilità figurativa, finalizzata alla leggibilità immediata, che connota l iconografia religiosa si estende alla divinizzazione di concetti astratti e alle raffigurazioni allegoriche che esprimono virtutes, comprese quelle che gli dei manifestano in particolare attraverso determinati uomini o donne e che si concretizzano nelle vicende della vita o negli eventi della storia (Turcan, 1988, 10-12). La scelta delle personificazioni nella tipologia monetale delle emissioni a nome delle Auguste evidenzia la volontà di enfatizzare, anche per le figure femminili della casa imperiale, le qualità individuali che promanano da un particolare favore divino; emerge così, innanzi tutto, il ruolo fondamentale della figura muliebre nel caratterizzare la stabilità dell impero attraverso quello della coppia imperiale e nel concretizzare, attraverso la prole, la continuità del potere connessa alla discendenza. La promanazione del favore divino, che già Augusto aveva sottolineato, ad esempio, attraverso i concetti di Pax, Pietas e Iustitia, emerge con grande evidenza durante il regno di Caligola che vede il primo tentativo di instaurazione a Roma di una monarchia teocratica di tipo orientale; questo spiega bene, infatti, come le stesse sorelle dell imperatore siano state rese partecipi della natura divina, sottolineata proprio dall utilizzo di specifici attributi (Barrett, 1992, ). 570
5 OCCORRENZE ICONOGRAFICHE DELLA PATERA NELLE EMISSIONI A NOME DELLE AUGUSTE Nella nota emissione di sesterzi in cui Agrippina, Drusilla e Iulia sono rappresentate rispettivamente come Securitas, Concordia e Fortuna, l attributo della patera connota l immagine di Drusilla. Tra le personificazioni è proprio Concordia quella maggiormente ricorrente con l attributo della patera nelle emissioni a nome delle Auguste; l iconografia di questa divinità non appare fortemente caratterizzata, adattandosi a varie accezioni legate sia al concetto dell unione e dell armonia della casa imperiale, e quindi politica, che della fedeltà dell esercito (Zanzarri, 1997). In particolare l attributo della patera caratterizza la figura femminile seduta, accompagnata da piccola statua di Spes e con il cornucopia posato sotto il trono che compare al rovescio di una emissione di Sabina durante il regno di Adriano e successivamente ricorre con una certa frequenze nell età degli Antonini con Faustina II e poi con i Severi. Con Plautilla, Iulia Paula (Fig.9) e Orbiana la figura femminile in trono regge la patera ed il doppio cornucopia; la leggenda semplicemente identificativa (Concordia o Concordiae) si modifica solo per Orbiana (Concordia Augustorum), ricordando l occasione della emissione, legata al matrimonio con Severo Alessandro. Infine, in una emissione a nome di Aquilia Severa, Concordia, sempre con il doppio cornucopia, è rappresentata con la patera nell atto della libagione su di un altare acceso. L attributo della patera ricorre anche nell iconografia di Fortuna, originariamente dea della fecondità, poi, identificandosi con la Tyke ellenistica, diventata arbitra dei destini umani per il tramite dell imperatore al quale di devono la sicurezza ed il benessere che ne scaturiscono (Fears, 1981, 931; De Ranieri, 2001, ); da questo ampio spettro di valenze deriva una grande varietà di forme di culto e di epiteti qualificanti. La maggioranza delle testimonianze iconografiche si concentra nel II secolo d.c., in accordo con la documentazione numismatica; l immagine di Fortuna con la patera è presente al rovescio di due emissioni per Faustina I divinizzata: la figura è stante e regge, oltre allo strumento per la libagione, l oggetto che meglio la connota, cioè il timone sul globo, al quale si affida la identificazione, poichè le leggende richiamano Æternitas o il semplice epiteto Augusta, mentre al dritto compare il ritratto di Faustina; in questi casi la patera sostituisce il cornucopia, l altro attributo ricorrente di questa personificazione, anche se meno caratterizzante rispetto al timone. La patera compare anche per Felicitas in coniazioni a nome di Giulia Domna e di Giulia Mesa che ricordano la celebrazione dei Ludi Saeculares; in entrambi i casi la leggenda Sæculi Felicitas suona come l auspicio per una nuova età dell oro e non lascia dubbi sull identificazione già suggerita dall altro attributo, cioè il caduceo (BMCRE, IV, ccix). Tra le emissioni a nome delle Auguste appare piuttosto sorprendente la presenza in un solo caso, con Sabina al dritto, ma sia su sesterzi che su denari, della patera nella iconografia di Pietas, raffigurata in trono, velata, con cornucopia; in effetti la scelta di questa personificazione, a cui si addice particolarmente il gesto della libagione, risulta assai più frequente in associazione alla figura dell imperatore, mentre per le imperatrici, soprattutto a partire dall età flavia, l iconografia, con uno o più fanciulli, fa piuttosto riferimento ad una pietas familiare con una forte connotazione dinastica (Manson, 1975, 21-80). Analogamente, solo in un caso, nell ambito delle coniazioni per le imperatrici, la patera connota l iconografia di Salus: si tratta di una moneta per Giulia di Tito, in cui la leggenda (Salus Avg) supplisce alla assenza, nella identificazione, dell elemento maggiormente caratterizzante di questa personificazione, cioè il serpente. In conclusione (cfr. Prospetto riassuntivo), l analisi condotta sembra confermare che la religione romana ufficiale non ha mutamenti sostanziali per i primi tre secoli dell impero, così pure la celebrazione dei riti ed anche l iconografia religiosa connessa; la molteplicità degli attributi tende a connotare le divinità quasi come potenze universali ed evidenzia la progressiva tendenza della religione romana verso la sintesi e la integrazione, anche se rimangono i segni di specializzazioni funzionali (Turcan, 1988, 10-11). La patera, come attributo, sembra associarsi ad altri elementi maggiormente significanti, iconograficamente equivalenti alla puntualità verbale degli indigitamenta nelle invocazioni (Turcan, 1988, 12), tuttavia la sua presenza, pur non essendo identificativa, fa assumere all immagine una sua specificità, illustrando il momento in cui l essere divino e la comunità, o, meglio, chi la rappresenta, entrano in contatto. Da questo contatto deriva una reciprocità che racchiude, a mio avviso, l aspetto che meglio caratterizza la documentazione numismatica relativamente alla patera, in particolare, come attributo connesso all iconografia femminile. 571
6 Prospetto della occorrenza della patera nelle emissioni a nome delle Auguste DIVINITÁ Giunone, con velo, stante, tiene patera e lungo scettro, accanto pavone (Iuno Regina): Sabina (Adriano) Faustina I (Antonino Pio) Lucilla (M. Aurelio e L. Vero) Salonina (Gallieno) Crispina (Commodo) Manlia Scantilla (Didio Giuliano) Giulia Domna (Settimio Severo e Caracalla) (Iuno Conservatrix): Giulia Mamea (Severo Alessandro) (Iuno Lucina): Faustina II (Antonino Pio) (Iuno): Giulia Domna (Settimio Severo e Caracalla) Giulia Soemia (Elagabalo) Giulia Mesa (Elagabalo) (Æternitas): Diva Faustina (Antonino Pio) Vesta, con velo, seduta, tiene patera e corto scettro (Augusta) Faustina (Antonino Pio) Vesta, con velo, stante, sacrifica da patera su altare acceso e tiene Palladio (Augusta) Faustina (Antonino Pio) Vesta, con velo, stante, sacrifica da patera su altare acceso e tiene lunga torcia (Consecratio) Faustina (Antonino Pio) Vesta, con velo, stante, tiene patera e lungo scettro (Vestæ Sanctæ) Giulia Domna (zecche orientali, Settimio Severo e Caracalla) (Vesta) Giulia Mamea (Severo Alessandro) Venere, stante tiene patera e lungo scettro (Veneri Genetrici) Giulia Domna (Caracalla) PERSONIFICAZIONI Concordia, seduta a s. tiene patera e posa il braccio su statuetta di Spes, sotto il trono cornucopia (Concordia Aug) Sabina (Adriano) Faustina II (Antonino Pio) Concordia, seduta a s. tiene patera e doppio cornucopia (Concordia Aug) Otacilia (Filippo l Arabo) (Concordiae) Plautilla (Settimio Severo e Caracalla) (Concordia) Iulia Paula (Elagabalo) (Concordia Augustorum) Orbiana (Severo Alessandro) (Concordia Aug) Giulia (Tito) Concordia, stante, sacrifica con patera su altare acceso e tiene doppio cornucopia (Concordia) Aquilia Severa (Elagabalo) Fortuna, stante, tiene patera e timone su globo (Æternitas) Diva Faustina (Antonino Pio) (Augusta) Faustina (Antonino Pio) Felicitas, stante, sacrifica con patera su altare acceso e tiene lungo caduceo (Saeculi Felicitas) Giulia Domna (Caracalla) Giulia Mesa (Elagabalo) Pietas, con velo, seduta a s., tiene patera e scettro (Pietas) Sabina (Adriano) Salus, seduta a s. tiene patera e l altro braccio appoggiato (Salus Avg) Giulia (Tito) 572
7 OCCORRENZE ICONOGRAFICHE DELLA PATERA NELLE EMISSIONI A NOME DELLE AUGUSTE Bibliografia AA.VV Duby, G. e Pierrot, M. (1997): Storia delle donne. L Antichita, I, a cura di Schmitt Pantel P., trad. it. Roma-Bari, III ed. AA. VV Enciclopedia delle Religioni, vol. 2, Il rito. Oggetti, atti, cerimonie, edizione tematica europea a cura di Cosi D.M., Saibene L., Scagno R., Milano Barrett, A. A. (1992): Caligola. L ambiguità di un tiranno, Londra, 1989, trad. it. Milano Barrett, A. A. (2002): Livia. First Lady of Imperial Rome, London. Bauman, R. A. (1992): Women and Politics in Ancient Rome. London. BMCRE - Coins of the Roman Empire in the British Museum, 6 voll., London ; rist. London Caccamo Caltabiano, M. (2004): Comunicare per immagini: grammatica e sintessi di un lessico iconografico monetale, Società Numismatica Italiana, 5, p Daremberg, C. et Saglio E.: Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, s.v. PATERA, Paris De Ranieri, C. (2001): Salus, Felicitas, Fortuna: le virtutes di un imperatore romano. Analisi di alcune monete commodiane, RIN, 102, p Dury Moyaers, G. et Renard, M. (1981): Aperçu critique relatif au culte de Junon, ANRW, II, 17.2, Berlin- New York, p Fears, J. R. (1981): The cult of Virtues and Roman imperial ideology, ANRW, II, 17.2, Berlin-NewYork, p Fischer-Hansen, T. (1990): s.v. HESTIA / VESTA, in LIMC (Lexicon Iconographycum Mythologiae Classicae), V, 1, Zurich-München, p Ghedini, F. (1984): Giulia Domna tra oriente e occidente. Le fonti archeologiche, Roma. La Rocca, E. (1990): s.v. IUNO, in LIMC (Lexicon Iconographycum Mythologiae Classicae), V, 1, Zurich- München, p Manson, M. (1975): La Pietas et le sentiment de l enfance à Rome d après les monnaies, RBN, 121, p Martini, M. C. (1997): Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico religioso, Latomus, 56, p e Mikocki, T. (1995): Sub specie deæ. Les impératrices et princesses romaines assimilées à des déesses, Rivista di Archeologia, Suppl. 14, Roma. Morelli, A.L. (2001): La rappresentazione di Livia nella monetazione di Galba, RSA, XXXI, p Morelli, A.L. (2004): Gli attributi delle Auguste nei primi due secoli dell impero: una ricerca per el LIN, Società Numismatica Italiana, 5, p Morelli, A. L., in corso di stampa [a]: Ancora sull iconografia di Livia: le emissioni provinciali. Morelli, A. L., in corso di stampa[b]: L attributo della patera ed il ruolo religioso delle Auguste: la documentazione numismatica. Panvini Rosati, F. (1996): Ricerche sulla tipologia monetale romana. Le personificazioni, RIN, 97, p Pera, R. (1978): Venere sulle monete da Vespasiano agli Antonini: aspetti storico-politici, RIN, 80. Sfameni Gasparro G. (1991): Ruolo cultuale della donna in Grecia e a Roma: per una tipologia storico-religiosa, Donna e culture. Studi e documenti nel III anniversario della Mulieris dignitatem, a cura di Mattioli U., Genova, p Schmidt, E. (1997): s.v. VENUS, in LIMC (Lexicon Iconographycum Mythologiae Classicae), V, 1, Zurich- Dusseldorf, p Turcan R. (1988): Religion Romaine. 1. Les dieux, Leiden- New York-Kobenhavn-Koln. Zanzarri, P. (1997): La Concordia romana. Politica e ideologia nella monetazione dalla tarda repubblica ai Severi, Roma. Wood, S.E. (1999): Imperial Women. A Study in Public Image, 40 BC-AD 68, Leiden. 573
8 Elenco delle illustrazioni (in rapporto 1:1) Fig.1. Denario a nome di Sabina; BMCRE III, p.359, n.936, tav.65,16 R/ IVNONI REGINÆ Giunone stante, drappeggiata e velata, con diadema, tiene patera e lungo scettro; a s. pavone. Fig.2. Asse a nome di Giulia Domna; BMCRE V, p.308, n.769, tav.46,18 R/ IVNO REGINA; S-C Giunone stante, drappeggiata e velata, con diadema, tiene patera e lungo scettro; a s. pavone. Fig.3. Aureo a nome di Giulia Mamea; BMCRE VI, p.119, n. 42, tav.2,42 R/ IVNO CONSERVATRIX Giunone stante, drappeggiata e velata, con diadema, tiene patera e lungo scettro; a s. pavone. Fig.4. Aureo a nome di Faustina II; BMCRE IV, p.159, n.1045, tav.22,14 R/ IVNONI LVCINÆ Giunone stante, drappeggiata, con diadema, tiene patera e lungo scettro. Fig.5. Denario a nome di Giulia Mesa; BMCRE V, p.577, n.295, tav.91,17 R/ IVNO Giunone stante, drappeggiata e velata, con diadema, tiene patera e lungo scettro; a s. pavone. Fig.6 Aureo a nome di Faustina I; BMCRE IV, p.43, n.284*, tav.9,1 R/ ÆTERNITAS Giunone stante, drappeggiata e velata, con diadema, tiene patera e lungo scettro. Fig.7. Denario a nome di Giulia Mamea; BMCRE VI, p.156, n.445, tav.15,445 R/ VESTA Vesta stante, drappeggiata e velata, tiene patera e scettro trasversale. Fig.8. Denario a nome di Giulia Domna; BMCRE V, p.433, n.20, tav.68,1 R/ VENERI GENETRICI Venere stante, con diadema tiene patera e lungo scettro. Fig.9. Sesterzio a nome di Giulia Paola; BMCRE V, p.604, n.414, tav.96,2 R/ CONCORDIA; in es. SC Concordia seduta in trono tiene patera e doppio cornucopia. Fig.10.Aureo a nome di Faustina I; BMCRE IV, p.43, n.285, tav.7,7 R/ ÆTERNITAS Fortuna stante, con velo, tiene patera e timone su globo. Fig.11.Sesterzio a nome di Giulia Domna; BMCRE V, p.470, n.215, tav.74,3 R/ SÆCVLI FELICITAS Felicitas sacrifica con patera su altare acceso e tiene lungo caduceo. Fig.12.Sesterzio a nome di Sabina; BMCRE III, p.536, n.1871, tav.98,15. R/ PIETAS; in es. SC Pietas velata, seduta a s., tiene patera e scettro. 574
9 OCCORRENZE ICONOGRAFICHE DELLA PATERA NELLE EMISSIONI A NOME DELLE AUGUSTE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig
336 Denario - Testa laureata a d. - R/ La Pace stante a s. con ramo d olivo e scettro - C. 314; RIC 368 (AG g. 3,61) SPL+ 100
 329 330 331 329 Giulia Domna (moglie di S. Severo) Denario - Busto drappeggiato a d. - R/ La Pietà stante a s. presso un altare con le mani alzate - C. 156; RIC S574 (AG g. 3,22) SPL+/SPL 110 330 Denario
329 330 331 329 Giulia Domna (moglie di S. Severo) Denario - Busto drappeggiato a d. - R/ La Pietà stante a s. presso un altare con le mani alzate - C. 156; RIC S574 (AG g. 3,22) SPL+/SPL 110 330 Denario
ROMANE IMPERIALI E BIZANTINE
 ROMANE IMPERIALI E BIZANTINE 151. AUGUSTO (27 a.c. 14 d.c.) C. 265 Ag gr. 3,72 R BB 150 152. TIBERIO (14 37 d.c.) Aureo C. 15 Au gr. 7,75 BB 2.000 153. DRUSO (+ 23 d.c.) Sesterzio C. 1 Ae gr. 26,74 R Q.BB
ROMANE IMPERIALI E BIZANTINE 151. AUGUSTO (27 a.c. 14 d.c.) C. 265 Ag gr. 3,72 R BB 150 152. TIBERIO (14 37 d.c.) Aureo C. 15 Au gr. 7,75 BB 2.000 153. DRUSO (+ 23 d.c.) Sesterzio C. 1 Ae gr. 26,74 R Q.BB
AUGUSTO E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
 AUGUSTO E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 1 I 1 AUGUSTO, PRIMO IMPERATORE sconfitta di Antonio e Cleopatra fine della Repubblica Ottaviano rifiuto della dittatura custode della tradizione repubblicana titolo
AUGUSTO E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 1 I 1 AUGUSTO, PRIMO IMPERATORE sconfitta di Antonio e Cleopatra fine della Repubblica Ottaviano rifiuto della dittatura custode della tradizione repubblicana titolo
ROMANE IMPERIALI M.MB C. 252 AE GR. 13,75 MB BB AGRIPPA (+ 12 A.C.) C. 3 AE GR. 11,20 BB 150
 ROMANE IMPERIALI 557. AUGUSTO (27 A.C. 14 D.C.) SESTERZIO (SERIE LIONESE) C. 524 AE GR. 25,08 RR LA ZECCA DI LUGDUNUM NELLA SECONDA FASE PRODUTTIVA, NEL 9 10 D.C., NELL EMISSIONE DEI NOMINALI, SESTERZIO,
ROMANE IMPERIALI 557. AUGUSTO (27 A.C. 14 D.C.) SESTERZIO (SERIE LIONESE) C. 524 AE GR. 25,08 RR LA ZECCA DI LUGDUNUM NELLA SECONDA FASE PRODUTTIVA, NEL 9 10 D.C., NELL EMISSIONE DEI NOMINALI, SESTERZIO,
255 Sesterzio - Testa laureata a d. - R/ Giove seduto a s. con vittoriola e scettro - C. 315 (AE g. 23,65) - Patina verde con qualche ritocco BB 450
 255 256 255 Sesterzio - Testa laureata a d. - R/ Giove seduto a s. con vittoriola e scettro - C. 315 (AE g. 23,65) - Patina verde con qualche ritocco BB 450 256 Asse - Testa laureata a d. - R/ La Moneta
255 256 255 Sesterzio - Testa laureata a d. - R/ Giove seduto a s. con vittoriola e scettro - C. 315 (AE g. 23,65) - Patina verde con qualche ritocco BB 450 256 Asse - Testa laureata a d. - R/ La Moneta
677 Denario - Testa laureata a d. - R/ Il Genio stante a s. presso un altare con patera e spighe - C. 140 (AG g. 2,79) qfdc/spl+ 120
 669 Denario - Busto giovanile laureato e drappeggiato a d. - R/ La Felicità stante a s. con caduceo e cornucopia - C. 64; RIC 127 (AG g. 3,19) BB 30 670 Denario - Testa laureata a d. - R/ Caracalla in
669 Denario - Busto giovanile laureato e drappeggiato a d. - R/ La Felicità stante a s. con caduceo e cornucopia - C. 64; RIC 127 (AG g. 3,19) BB 30 670 Denario - Testa laureata a d. - R/ Caracalla in
vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com
 Elisa Marroni - Mario Torelli L Obolo di Persefone Immaginario e ritualità dei pinakes di Locri vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Volume pubblicato con un
Elisa Marroni - Mario Torelli L Obolo di Persefone Immaginario e ritualità dei pinakes di Locri vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Volume pubblicato con un
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
 PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE 2EI Docente Disciplina Prof.ssa SARA ZUPPANI STORIA Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE Periodo: settembre dicembre LE ORIGINI DI ROMA Tra storia
PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO CLASSE 2EI Docente Disciplina Prof.ssa SARA ZUPPANI STORIA Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE Periodo: settembre dicembre LE ORIGINI DI ROMA Tra storia
IMPERIALI Sesterzio. D/ Testa laureata R/ Arco di trionfo con statua equestre. RIC 114 Ae g 28,37 Bel modulo BB 1.000
 24 IMPERIALI 109 109. NERO CLAUDIO DRUSO ( 9 a.c.) Sesterzio, coniato sotto Claudio. D/ Testa nuda R/ Claudio, togato, seduto su sedia curule reggendo un ramoscello d'ulivo. RIC (Claudio) 93 Ae g 26,50
24 IMPERIALI 109 109. NERO CLAUDIO DRUSO ( 9 a.c.) Sesterzio, coniato sotto Claudio. D/ Testa nuda R/ Claudio, togato, seduto su sedia curule reggendo un ramoscello d'ulivo. RIC (Claudio) 93 Ae g 26,50
L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE
 L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE LA SCULTURA IN EPOCA ROMANA RITRATTISTICA STATUA ONORARIA RILIEVO STORICO CELEBRATIVO COLONNA TRAIANA ARA PACIS STATUA BARBERINI AUGUSTO DI PRIMA PORTA LA SCULTURA
L ARTE NELLA ROMA REPUBBLICANA E IMPERIALE LA SCULTURA IN EPOCA ROMANA RITRATTISTICA STATUA ONORARIA RILIEVO STORICO CELEBRATIVO COLONNA TRAIANA ARA PACIS STATUA BARBERINI AUGUSTO DI PRIMA PORTA LA SCULTURA
ROMANE IMPERIALI. 189 Denario - Testa diademata di Venere a s. - R/ Due prigionieri di fianco ad un trofeo - B. 11; Cr. 468/1 (AG g.
 ROMANE IMPERIALI 185 186 185 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Aureo - Testa velata e laureata a d. - R/ Lituo, praefericulum e ascia - C. 3 (60 Fr.) (AU g. 7,56) R - Segno sul collo BB/BB+ 1650 186 Aureo - Testa
ROMANE IMPERIALI 185 186 185 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Aureo - Testa velata e laureata a d. - R/ Lituo, praefericulum e ascia - C. 3 (60 Fr.) (AU g. 7,56) R - Segno sul collo BB/BB+ 1650 186 Aureo - Testa
Sesterzio - Busto laureato e drappeggiato a d. - R/ L imperatore a cavallo verso s. - C.? (AE g. 23,1) Patina e frattura qbb 150
 1573 1569 1570 1571 1572 1574 1576 1582 1586 1587 1588 1577 1583 1578 1579 1581 1569 Sesterzio - Busto laureato e drappeggiato a d. - R/ L imperatore a cavallo verso s. - C.? (AE g. 23,1) Patina e frattura
1573 1569 1570 1571 1572 1574 1576 1582 1586 1587 1588 1577 1583 1578 1579 1581 1569 Sesterzio - Busto laureato e drappeggiato a d. - R/ L imperatore a cavallo verso s. - C.? (AE g. 23,1) Patina e frattura
ROMANE IMPERIALI. 87 Denario - Testa a d. - R/ Capricorno a d. con globo tra le zampe - C. 147; RIC 330 (AG g. 3,5) R qspl/spl 300
 ROMANE IMPERIALI 85 86 87 85 Marc Antonio ( 30 a.c.) Denario - Galea pretoriana - R/ LEG VI - Aquila legionaria tra due insegne - B. 111; Cr. 544/19 (AG g. 3,4) SPL 200 86 Augusto (27 a.c.-14 d.c.) Denario
ROMANE IMPERIALI 85 86 87 85 Marc Antonio ( 30 a.c.) Denario - Galea pretoriana - R/ LEG VI - Aquila legionaria tra due insegne - B. 111; Cr. 544/19 (AG g. 3,4) SPL 200 86 Augusto (27 a.c.-14 d.c.) Denario
MODULO 1: La grande espansione di Roma nel Mediterraneo UD 1:: Le guerre contro Cartagine
 PROGRAMMA SVOLTO DI - GEOSTORIA Liceo Classico Vitruvio Pollione, Formia Classe IIG sez. F - a.s. 2016-2017 prof. Bianca Paola Leone MODULO 1: La grande espansione di Roma nel Mediterraneo UD 1:: Le guerre
PROGRAMMA SVOLTO DI - GEOSTORIA Liceo Classico Vitruvio Pollione, Formia Classe IIG sez. F - a.s. 2016-2017 prof. Bianca Paola Leone MODULO 1: La grande espansione di Roma nel Mediterraneo UD 1:: Le guerre
MONETE ROMANE IMPERIALI DI UN UNICO CONFERENTE
 MONETE ROMANE IMPERIALI DI UN UNICO CONFERENTE 336. GNEO POMPEO JUNIOR (+ 45 A.C.) S. 1384 AG GR. 3,90 R CONTROMARCA AL DIRITTO, SEGNO AL ROVESCIO. PATINA DI VECCHIA RACCOLTA M.BB 300 337. GIULIO CESARE
MONETE ROMANE IMPERIALI DI UN UNICO CONFERENTE 336. GNEO POMPEO JUNIOR (+ 45 A.C.) S. 1384 AG GR. 3,90 R CONTROMARCA AL DIRITTO, SEGNO AL ROVESCIO. PATINA DI VECCHIA RACCOLTA M.BB 300 337. GIULIO CESARE
ROMANE IMPERIALI 315. GIULIO CESARE (+ 44 A.C.) DENARIO V. 657 AG GR. 3,84 SPL 250 V. 657 AG GR. 3,93 SPL 200 V. 657 AG GR. 3,72 PATINA IRIDESCENTE.
 ROMANE IMPERIALI 315. GIULIO CESARE (+ 44 A.C.) V. 657 AG GR. 3,84 SPL 250 316. V. 657 AG GR. 3,93 SPL 200 317. V. 657 AG GR. 3,72 PATINA IRIDESCENTE. M.BB 200 318. V. 658 AG GR. 3,79 BELL ESEMPLARE. M.SPL
ROMANE IMPERIALI 315. GIULIO CESARE (+ 44 A.C.) V. 657 AG GR. 3,84 SPL 250 316. V. 657 AG GR. 3,93 SPL 200 317. V. 657 AG GR. 3,72 PATINA IRIDESCENTE. M.BB 200 318. V. 658 AG GR. 3,79 BELL ESEMPLARE. M.SPL
ROMANE IMPERIALI 218. CASSIO (43 42 A.C.) DENARIO B. 18 AG GR. 4,09 R BELL ESEMPLARE CORREDATO DA SPLENDIDA PATINA IRIDESCENTE. SPL 1.
 ROMANE IMPERIALI 218. CASSIO (43 42 A.C.) B. 18 AG GR. 4,09 R BELL ESEMPLARE CORREDATO DA SPLENDIDA PATINA IRIDESCENTE. SPL 1.000 219. MARC ANTONIO (+ 30 A.C.) (LEGIONE VI) C. 33 AG GR. 3,83 PATINA IRIDESCENTE
ROMANE IMPERIALI 218. CASSIO (43 42 A.C.) B. 18 AG GR. 4,09 R BELL ESEMPLARE CORREDATO DA SPLENDIDA PATINA IRIDESCENTE. SPL 1.000 219. MARC ANTONIO (+ 30 A.C.) (LEGIONE VI) C. 33 AG GR. 3,83 PATINA IRIDESCENTE
CARACALLA MARCUS AURELIUS ANTONINUS
 461 462 463 461 462 DENARIO - D/Busto drappeggiato a d. IVLIAAVGVSTA - Ar - C.246 R/Venere stante a s. con patera e scettro VESTASANCTAE DENARIO - D/Busto drappeggiato a d. IVLIAAVGVSTA C.156 R/La Pietas
461 462 463 461 462 DENARIO - D/Busto drappeggiato a d. IVLIAAVGVSTA - Ar - C.246 R/Venere stante a s. con patera e scettro VESTASANCTAE DENARIO - D/Busto drappeggiato a d. IVLIAAVGVSTA C.156 R/La Pietas
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA. Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo
 CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
CORSO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA Prof. Andrea Potestio Università degli studi di Bergamo 1 Ellenismo Fine delle polis greche Impero di Alessandro Magno Dissoluzione del suo Impero (323 a.c. data della sua
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2016/ 2017
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2016/ 2017 Materia d insegnamento: STORIA Classe 2^ sezione B Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2016/ 2017 Materia d insegnamento: STORIA Classe 2^ sezione B Prof.ssa Linda Billi LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
ROMANE IMPERIALI 460. SESTO POMPEO (+ 45 A.C.) DENARIO S AG GR. 3,11 RR Q.BB GIULIO CESARE (49 48 A.C.)
 ROMANE IMPERIALI 460. SESTO POMPEO (+ 45 A.C.) S. 1391 AG GR. 3,11 RR Q.BB 1.000 461. GIULIO CESARE (49 48 A.C.) V. 657 AG GR. 3,89 PATINA IRIDESCENTE. SPL 350 462. (47 46 A.C.) V. 658 AG GR. 3,77 PATINA
ROMANE IMPERIALI 460. SESTO POMPEO (+ 45 A.C.) S. 1391 AG GR. 3,11 RR Q.BB 1.000 461. GIULIO CESARE (49 48 A.C.) V. 657 AG GR. 3,89 PATINA IRIDESCENTE. SPL 350 462. (47 46 A.C.) V. 658 AG GR. 3,77 PATINA
La Fortuna nell antica Roma: raffigurazioni, proverbi e miti sulla dea più capricciosa dell antichità.
 La Fortuna nell antica Roma: raffigurazioni, proverbi e miti sulla dea più capricciosa dell antichità. Analisi lessicale: il nome della dea Fortuna. Il sostantivo fortuna, -ae, il cui primo significato
La Fortuna nell antica Roma: raffigurazioni, proverbi e miti sulla dea più capricciosa dell antichità. Analisi lessicale: il nome della dea Fortuna. Il sostantivo fortuna, -ae, il cui primo significato
ISTITUTO SUPERIORE MAZZINI DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA CLASSE II MECCANICI INSEGNANTE: PROF.
 ISTITUTO SUPERIORE MAZZINI DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA CLASSE II MECCANICI INSEGNANTE: PROF. CRISTIANA ROSSI MODULO 1 Recupero del programma svolto e ripasso terminologia
ISTITUTO SUPERIORE MAZZINI DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA CLASSE II MECCANICI INSEGNANTE: PROF. CRISTIANA ROSSI MODULO 1 Recupero del programma svolto e ripasso terminologia
Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
 Storia CLASSE II A INDIRIZZO AFM UdA n. Titolo: Dalla repubblica all'impero Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato
Storia CLASSE II A INDIRIZZO AFM UdA n. Titolo: Dalla repubblica all'impero Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato
Una selezione di denari imperiali
 Una selezione di denari imperiali 83. Denario, Caesaraugusta (?),19-18 a.c. (AR 3,93gr.) D: CAESAR AVGVSTVS, testa nuda a d. R: S P Q R, CL V iscritto in due linee su di uno scudo rotondo, R.I.C. 42a/S,
Una selezione di denari imperiali 83. Denario, Caesaraugusta (?),19-18 a.c. (AR 3,93gr.) D: CAESAR AVGVSTVS, testa nuda a d. R: S P Q R, CL V iscritto in due linee su di uno scudo rotondo, R.I.C. 42a/S,
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA
 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi - Tempo Spazio, vol. 2 - Einaudi Scuola U8 Il mondo
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI - FOGGIA CLASSE II SEZIONE H PROGRAMMA di GEOGRAFIA Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi - Tempo Spazio, vol. 2 - Einaudi Scuola U8 Il mondo
I.I.S. G. Veronese G. Marconi Chioggia (VE)
 I.I.S. G. Veronese G. Marconi Chioggia (VE) PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO A. S. 2016/2017 DOCENTE: PEPE ALESSANDRO - CLASSE: 1^ - SEZIONE: D SCIENZE APPLICATE - DISCIPLINA: GEOSTORIA LIBRO DI TESTO: Zanette,
I.I.S. G. Veronese G. Marconi Chioggia (VE) PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO A. S. 2016/2017 DOCENTE: PEPE ALESSANDRO - CLASSE: 1^ - SEZIONE: D SCIENZE APPLICATE - DISCIPLINA: GEOSTORIA LIBRO DI TESTO: Zanette,
Liceo scientifico Castelnuovo. Programma di Storia e Geografia. Classe II Sez. G A.S. 2016/2017
 Liceo scientifico Castelnuovo Programma di Storia e Geografia Classe II Sez. G A.S. 2016/2017 STORIA Le origini di Roma tra storia e leggenda: gli anni della monarchia -La leggendaria fondazione di Roma
Liceo scientifico Castelnuovo Programma di Storia e Geografia Classe II Sez. G A.S. 2016/2017 STORIA Le origini di Roma tra storia e leggenda: gli anni della monarchia -La leggendaria fondazione di Roma
Le donne della famiglia imperiale nella monetazione romana della collezione Classense di Ravenna
 QUAD. PREH. ARQ. CAST. 20, 1999 Le donne della famiglia imperiale nella monetazione romana della collezione Classense di Ravenna Carmen Gamberini* Resumen L articolo determina le modifiche e le evoluzioni
QUAD. PREH. ARQ. CAST. 20, 1999 Le donne della famiglia imperiale nella monetazione romana della collezione Classense di Ravenna Carmen Gamberini* Resumen L articolo determina le modifiche e le evoluzioni
Programma svolto A.S. 2016/2017. (Scienze umane) Materia GEOSTORIA Prof.ssa Maria Scidone/Vanessa Micco*
 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO CLASSICO MUSICALE SCIENZE UMANE CHRIS CAPPELL COLLEGE Viale Antium n 5 00042 Anzio (RM) Succursale Via XXI Aprile-Anzio
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO CLASSICO MUSICALE SCIENZE UMANE CHRIS CAPPELL COLLEGE Viale Antium n 5 00042 Anzio (RM) Succursale Via XXI Aprile-Anzio
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CRESCENZI PACINOTTI PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2016-2017 Classe 1CFM Materia: STORIA Docente: Mazzacuva Eleonora OBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO UNITA DIDATTICA N. 1
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CRESCENZI PACINOTTI PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2016-2017 Classe 1CFM Materia: STORIA Docente: Mazzacuva Eleonora OBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO UNITA DIDATTICA N. 1
LA MONETAZIONE DI ROMA
 ATELIER VISUAL E MULTIMEDIA DESIGN - Prof. Luca De Mata IL VALORE DI CAMPO MARZIO : LE MONETE - Mehnoush Bahreini CAMPO MARZIO è il quarto rione di Roma, indicato con R. IV. Dal punto di vista orografico
ATELIER VISUAL E MULTIMEDIA DESIGN - Prof. Luca De Mata IL VALORE DI CAMPO MARZIO : LE MONETE - Mehnoush Bahreini CAMPO MARZIO è il quarto rione di Roma, indicato con R. IV. Dal punto di vista orografico
Lotti - Greche Lire 12/09/ Gav. 87 Azzolini/Urbini Piccole pieghe diffuse SPL 210
 3335 3322 3320 100 Lire 12/09/1938 - Gav. 87 Azzolini/Urbini Piccole pieghe diffuse SPL 210 3336 3321 50 Lire 12/09/1938 - Gav. 85 Azzolini/Urbini Piega centralee macchiolinne BB 75 3322 Cassa Mediterranea
3335 3322 3320 100 Lire 12/09/1938 - Gav. 87 Azzolini/Urbini Piccole pieghe diffuse SPL 210 3336 3321 50 Lire 12/09/1938 - Gav. 85 Azzolini/Urbini Piega centralee macchiolinne BB 75 3322 Cassa Mediterranea
Programma svolto anno scolastico Classe: 2^AL
 Programma svolto anno scolastico 2018-2019 Classe: 2^AL Docente: Antonella Filippini Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA Classe: 2^ AL STORIA MODULO: 1. Roma e Cartagine in lotta per l'egemonia nel Mediterraneo
Programma svolto anno scolastico 2018-2019 Classe: 2^AL Docente: Antonella Filippini Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA Classe: 2^ AL STORIA MODULO: 1. Roma e Cartagine in lotta per l'egemonia nel Mediterraneo
Guida alla compilazione 2
 Quale soggetto rappresenta il Monumento ai Caduti? Il tema della Grande Guerra si amalgama e si scontra spesso con temi dell iconografia tradizionale, acquisendo e rielaborando da essa numerosi soggetti.
Quale soggetto rappresenta il Monumento ai Caduti? Il tema della Grande Guerra si amalgama e si scontra spesso con temi dell iconografia tradizionale, acquisendo e rielaborando da essa numerosi soggetti.
476 Denario - Testa di Roma a d. - R/ La Vittoria. su biga verso d. regge una frusta - B. 7; Cr. 228/2. (AG g. 4,04) qspl 65
 482 C. Vibius C. f C. n. Pansa Caetronianus (48 a.c.) Denario - Testa di Pan a d. - R/ Giove seduto a s. con patera e lancia - B. 18; Cr. 449/1a (AG g. 4,01) qspl 75 469 Semisse - Testa di Saturno a d.
482 C. Vibius C. f C. n. Pansa Caetronianus (48 a.c.) Denario - Testa di Pan a d. - R/ Giove seduto a s. con patera e lancia - B. 18; Cr. 449/1a (AG g. 4,01) qspl 75 469 Semisse - Testa di Saturno a d.
Studi storici, storico-religiosi e antropologici A.A. 2010/2011 FSU
 Studi storici, storico-religiosi e antropologici A.A. 2010/2011 FSU Il Corso di laurea magistrale in Studi storici, storico-religiosi e antropologici si articola in cinque curricula: 1. Antichità 2. Medioevo
Studi storici, storico-religiosi e antropologici A.A. 2010/2011 FSU Il Corso di laurea magistrale in Studi storici, storico-religiosi e antropologici si articola in cinque curricula: 1. Antichità 2. Medioevo
CLASSE TERZA INDIRIZZO TURISTICO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento. Competenze attese a livello di UdA
 MATERIA ARTE e TERRITORIO CLASSE TERZA INDIRIZZO TURISTICO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA COMPLESSITÀ DELL OPERA D ARTE E I BENI CULTURALI Competenze attese a livello di UdA Saper
MATERIA ARTE e TERRITORIO CLASSE TERZA INDIRIZZO TURISTICO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA COMPLESSITÀ DELL OPERA D ARTE E I BENI CULTURALI Competenze attese a livello di UdA Saper
Lo scettro quale attributo nelle tipologie monetali romane (Età repubblicana - I secolo d.c.)
 Lo scettro quale attributo nelle tipologie monetali romane (Età repubblicana - I secolo d.c.) Lo scettro, come è noto, viene considerato una delle insegne della regalità, e compare con il fulmine nelle
Lo scettro quale attributo nelle tipologie monetali romane (Età repubblicana - I secolo d.c.) Lo scettro, come è noto, viene considerato una delle insegne della regalità, e compare con il fulmine nelle
473 Denario - Elefante a d. calpesta il dragone - R/ Berretto a punta, scure, aspersorio e simpulum - B. 9; Cr. 443/1 (AG g.
 468 Denario - Testa di Libero a d. - R/ Cerere su carro trainato da due serpenti verso d., dietro un elmo - B. 3; Cr. 385/3 (AG g. 3,6) qbb 50 ROMANE IMPERIALI 472 Denario - Testa laureata a d. - R/ Globo
468 Denario - Testa di Libero a d. - R/ Cerere su carro trainato da due serpenti verso d., dietro un elmo - B. 3; Cr. 385/3 (AG g. 3,6) qbb 50 ROMANE IMPERIALI 472 Denario - Testa laureata a d. - R/ Globo
IMPERATORI E PERSONAGGI EFFIGIATI SULLE MONETE IMPERIALI DA OTTAVIANO AUGUSTO
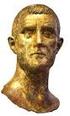 IMPERATORI E PERSONAGGI EFFIGIATI SULLE MONETE IMPERIALI DA OTTAVIANO AUGUSTO OTTAVIANO AUGUSTO (27 a. C. 14 d. C.) LIVIA (moglie di Augusto) AGRIPPA (27-12 a. C.) (genero di Augusto) GIULIA (figlia di
IMPERATORI E PERSONAGGI EFFIGIATI SULLE MONETE IMPERIALI DA OTTAVIANO AUGUSTO OTTAVIANO AUGUSTO (27 a. C. 14 d. C.) LIVIA (moglie di Augusto) AGRIPPA (27-12 a. C.) (genero di Augusto) GIULIA (figlia di
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. : 2018/2019 CLASSE: 2C INFO MATERIA: STORIA DOCENTE: CERNIGLIA ANTONINO
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. : 2018/2019 CLASSE: 2C INFO MATERIA: STORIA DOCENTE: CERNIGLIA ANTONINO Il docente di storia concorrerà a far conseguire all alunno conoscenze relative ai principali eventi
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. : 2018/2019 CLASSE: 2C INFO MATERIA: STORIA DOCENTE: CERNIGLIA ANTONINO Il docente di storia concorrerà a far conseguire all alunno conoscenze relative ai principali eventi
Il baratto I problemi del baratto Le prime forme di monete Creazione prime monete Dalla fusione alla coniazione Etimologia parola moneta La
 Il baratto I problemi del baratto Le prime forme di monete Creazione prime monete Dalla fusione alla coniazione Etimologia parola moneta La monetazione greca Il periodo arcaico Il periodo classico Il periodo
Il baratto I problemi del baratto Le prime forme di monete Creazione prime monete Dalla fusione alla coniazione Etimologia parola moneta La monetazione greca Il periodo arcaico Il periodo classico Il periodo
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROTTO TERME SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Creatore, sui dati fondamentali della vita di Gesù. Individuare i tratti essenziali della
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA: RELIGIONE - CLASSE PRIMA L alunno riflette su Dio Creatore, sui dati fondamentali della vita di Gesù. Individuare i tratti essenziali della
INDICE. 1. Imperialismo e romanizzazione 21 2. La politica imperialista romana in Oriente nell epoca repubblicana 23
 INDICE Premessa 7 Introduzione 9 PARTE PRIMA INQUADRAMENTO STORICO 11 1. LA CONQUISTA ROMANA DELL ORIENTE 13 1. Quadro storico generale (I sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
INDICE Premessa 7 Introduzione 9 PARTE PRIMA INQUADRAMENTO STORICO 11 1. LA CONQUISTA ROMANA DELL ORIENTE 13 1. Quadro storico generale (I sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
ROMANE IMPERIALI. 45 Denario - Testa a d. - R/ Scritta - Syd. 1209; Cr. 542/2 (AG g. 3,88) - Contromarca al D/ BB+ 800
 ROMANE IMPERIALI 39 40 41 39 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise sulla spalla e regge il Palladium - B. 10; Cr. 458/1 (AG g. 3,85) SPL-FDC 550 40 Denario
ROMANE IMPERIALI 39 40 41 39 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise sulla spalla e regge il Palladium - B. 10; Cr. 458/1 (AG g. 3,85) SPL-FDC 550 40 Denario
Siamo sempre interessati all acquisto di singole monete ed intere collezioni. Contattateci per maggiori informazioni.
 126 127 128 126 Denario - Testa del Re Sabino Tatius a d.; davanti, ramo di palma - R/ Due guerrieri uccidono Tarpeia; sopra, crescente - B. 4; Cr. 344/1b (AG g. 3,93) SPL/SPL+ 140 127 VETURIA - Ti. Veturius
126 127 128 126 Denario - Testa del Re Sabino Tatius a d.; davanti, ramo di palma - R/ Due guerrieri uccidono Tarpeia; sopra, crescente - B. 4; Cr. 344/1b (AG g. 3,93) SPL/SPL+ 140 127 VETURIA - Ti. Veturius
Liceo G.B. Vico Corsico a.s
 Liceo G.B. Vico Corsico a.s. 2018-19 Programma svolto durante l anno scolastico Classe: 2C Materia: Geostoria Insegnante: Sara Bramuzzo Testo utilizzato: L. Pepe, V. Novembri, E. Galimberti, Mirabilia.
Liceo G.B. Vico Corsico a.s. 2018-19 Programma svolto durante l anno scolastico Classe: 2C Materia: Geostoria Insegnante: Sara Bramuzzo Testo utilizzato: L. Pepe, V. Novembri, E. Galimberti, Mirabilia.
564 Asse - Testa di Giano - R/ Tre prue di nave a d. - Cr. 342/7b (AE g. 9,69) meglio di MB 20
 555 Asse - Testa di Giano - R/ Prua di nave a d.; davanti, Vittoria - Cr. 344/4c (AE g. 9,01) meglio di MB 20 556 TULLIA - M. Tullius (120 a.c.) Denario - Testa di Roma a d. - R/ La Vittoria su quadriga
555 Asse - Testa di Giano - R/ Prua di nave a d.; davanti, Vittoria - Cr. 344/4c (AE g. 9,01) meglio di MB 20 556 TULLIA - M. Tullius (120 a.c.) Denario - Testa di Roma a d. - R/ La Vittoria su quadriga
1. Le diverse tipologie di fonti. 2. Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.
 Curricolo DISCIPLINARE essenziale: STORIA CLASSE: 1^ - TUTTI GLI INDIRIZZI MODULI Contenuti Risultati di apprendimento (Competenze) Conoscenze Abilità (Capacità) TEMPI 1 Avvio allo studio della Storia
Curricolo DISCIPLINARE essenziale: STORIA CLASSE: 1^ - TUTTI GLI INDIRIZZI MODULI Contenuti Risultati di apprendimento (Competenze) Conoscenze Abilità (Capacità) TEMPI 1 Avvio allo studio della Storia
ISTITUTO SUPERIORE ENRICO FERMI. PROGRAMMAZIONE DEL GRUPPO DISCIPLINARE a.s. 2016/2017 INDIRIZZO SCOLASTICO: BIENNIO IT ORE SETTIMANALI: 3
 ISTITUTO SUPERIORE ENRICO FERMI PROGRAMMAZIONE DEL GRUPPO DISCIPLINARE a.s. 2016/2017 INDIRIZZO SCOLASTICO: BIENNIO IT LST (TRIENNIO LICEO) TRIENNIO IT LSSA (BIENNIO LICEO) DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
ISTITUTO SUPERIORE ENRICO FERMI PROGRAMMAZIONE DEL GRUPPO DISCIPLINARE a.s. 2016/2017 INDIRIZZO SCOLASTICO: BIENNIO IT LST (TRIENNIO LICEO) TRIENNIO IT LSSA (BIENNIO LICEO) DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA
Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola.
 Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola. Denotazione è la caratteristica che identifica il significato di base di ogni parola,
Denotazione e connotazione sono termini con i quali si designano due diversi valori del significato di una parola. Denotazione è la caratteristica che identifica il significato di base di ogni parola,
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi)
 Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof. Luca
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi) Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742 http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it PIANO DI LAVORO Prof. Luca
ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 MATERIA: STORIA INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO. CLASSE: 2C SC cp
 ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 MATERIA: STORIA INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO CLASSE: 2C SC cp FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): OBIETTIVI FORMATIVI Far comprendere
ANNO SCOLASTICO: 2017 / 2018 MATERIA: STORIA INSEGNANTE: LUCIA FENOGLIO CLASSE: 2C SC cp FINALITA DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): OBIETTIVI FORMATIVI Far comprendere
Programmazione di Storia Classe V A
 Programmazione di Storia Classe V A Anno scolastico 2017-18 FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui
Programmazione di Storia Classe V A Anno scolastico 2017-18 FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui
LOTTI. Monete Greche Lotto di 18 piccoli e medi bronzi greci Lotto da studio B 50
 LOTTI Monete Greche 1869 Lotto di 18 piccoli e medi bronzi greci Lotto da studio B 50 1870 Lotto di 20 piccoli e medi bronzi greci B 40 1871 Lotto di 20 piccoli e medi bronzi greci B 40 1872 Lotto di dieci
LOTTI Monete Greche 1869 Lotto di 18 piccoli e medi bronzi greci Lotto da studio B 50 1870 Lotto di 20 piccoli e medi bronzi greci B 40 1871 Lotto di 20 piccoli e medi bronzi greci B 40 1872 Lotto di dieci
MONETE ANTICHE GRECHE EUROPA CENTRALE. 1. CELTI DEL DANUBIO (iii sec. a.c.) BRUTTIUM. 2. LEGA DEI BRETTII ( a.c.)
 MONETE ANTICHE GRECHE EUROPA CENTRALE 1. CELTI DEL DANUBIO (iii sec. a.c.) Tetradracma Ag gr. 13,86 RR Patina uniforme di vecchia raccolta. SPL 700 BRUTTIUM 2. LEGA DEI BRETTII (215 208 a.c.) Ae 27 S.
MONETE ANTICHE GRECHE EUROPA CENTRALE 1. CELTI DEL DANUBIO (iii sec. a.c.) Tetradracma Ag gr. 13,86 RR Patina uniforme di vecchia raccolta. SPL 700 BRUTTIUM 2. LEGA DEI BRETTII (215 208 a.c.) Ae 27 S.
INDIRIZZO Liceo Classico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE A.S. 2015/ 2016
 Istituto Statale d'istruzione Superiore R.FORESI LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE FORESI LICEO SCIENZE UMANE FORESI ISTITUTO PROFESSIONALE PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO
Istituto Statale d'istruzione Superiore R.FORESI LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE FORESI LICEO SCIENZE UMANE FORESI ISTITUTO PROFESSIONALE PER L INDUSTRIA E L ARTIGIANATO
STORIA CLASSE PRIMA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE
 STORIA - Riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita e comprendere l importanza del patrimonio artistico e culturale - Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando
STORIA - Riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita e comprendere l importanza del patrimonio artistico e culturale - Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando
I.S.I.I. ISTITUTO SUPERIORE D ISTRUZIONE INDUSTRIALE G. Marconi - Piacenza PROGRAMMA DI STORIA
 I.S.I.I. ISTITUTO SUPERIORE D ISTRUZIONE INDUSTRIALE G. Marconi - Piacenza ANNO SCOLASTICO 2016-2017 CLASSE: 2ª O Meccanica DOCENTE: Prof. Giuseppe Proiti PROGRAMMA DI STORIA Vol. 1 - Testo in uso: G.
I.S.I.I. ISTITUTO SUPERIORE D ISTRUZIONE INDUSTRIALE G. Marconi - Piacenza ANNO SCOLASTICO 2016-2017 CLASSE: 2ª O Meccanica DOCENTE: Prof. Giuseppe Proiti PROGRAMMA DI STORIA Vol. 1 - Testo in uso: G.
Falsi (da studio, moderni, ecc.)
 6158 Tessere e sigilli Lotto di 10 tessere e sigilli in piombo da catalogare MB BB 65 Falsi (da studio, moderni, ecc.) 6165 Lotto di due monete cinesi in rame qspl OFF. 6166 Dollaro 1851 AG BB OFF. 6159
6158 Tessere e sigilli Lotto di 10 tessere e sigilli in piombo da catalogare MB BB 65 Falsi (da studio, moderni, ecc.) 6165 Lotto di due monete cinesi in rame qspl OFF. 6166 Dollaro 1851 AG BB OFF. 6159
INDICE. 1. Imperialismo e romanizzazione La politica imperialista romana in Oriente nell epoca repubblicana 23
 INDICE Premessa 7 Introduzione 9 Parte prima Inquadramento storico 11 1. La conquista romana dell Oriente 13 1. Quadro storico generale (i sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
INDICE Premessa 7 Introduzione 9 Parte prima Inquadramento storico 11 1. La conquista romana dell Oriente 13 1. Quadro storico generale (i sec. a.e.v.-74 e.v.) 13 2. La conquista dell Oriente 15 3. Il
Programmazione di Storia Classe IV
 Programmazione di Storia Classe IV Anno scolastico 2017-18 FINALITA' 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui il nostro presente affonda
Programmazione di Storia Classe IV Anno scolastico 2017-18 FINALITA' 1) Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui il nostro presente affonda
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA. PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 2015
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: STORIA Classe 2^ sezione D Prof.ssa Linda Billi DEFINIZIONE DEI CONTENUTI: RECUPERO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO ENRICO FERMI MODENA PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2014/ 201 Materia d insegnamento: STORIA Classe 2^ sezione D Prof.ssa Linda Billi DEFINIZIONE DEI CONTENUTI: RECUPERO
Milano, 5/6/2019 Prot. n. Art. 4 e 6 D.P.R. 416/74 Art. 3 D.P.R. 417/74. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE a.s.
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
ROMANE IMPERIALI. 147 Lepido e Augusto Denario - Testa di Lepido a d. - R/ Testa di Augusto a d. - Cr. 495/2; B. 35 (AG g.
 ROMANE IMPERIALI 141 142 143 141 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Cerere a d. - R/ Strumenti sacrificali - B. 16; Cr. 467/1 (AG g. 3,78) R - Gradevole patina SPL 500 142 Denario - Testa della
ROMANE IMPERIALI 141 142 143 141 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Cerere a d. - R/ Strumenti sacrificali - B. 16; Cr. 467/1 (AG g. 3,78) R - Gradevole patina SPL 500 142 Denario - Testa della
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI
 1 LA CIVILTA GRECA ARTICOLAZIONE DELL 1. Ricavare informazioni da documenti utili alla comprensione di un 2. Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale. 3. Ricavare informazioni
1 LA CIVILTA GRECA ARTICOLAZIONE DELL 1. Ricavare informazioni da documenti utili alla comprensione di un 2. Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale. 3. Ricavare informazioni
PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe II Storia Pagina 1 di 7 COMPETENZE PRIMO BIENNIO Le competenze chiave del primo biennio
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA AGRARIA Mario Rigoni Stern Bergamo PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE Classe II Storia Pagina 1 di 7 COMPETENZE PRIMO BIENNIO Le competenze chiave del primo biennio
ROMANE IMPERIALI Denario - Testa di Cerere a d. - R/ Strumenti sacrificali - B. 16 (AG g. 3,6) Ossidazioni MB/qBB 50
 ROMANE IMPERIALI 1103 1105 1103 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise sulla spalla e regge il Palladium - B. 10;Cr. 458/1 (AG g. 3,8) R D/ decentrato
ROMANE IMPERIALI 1103 1105 1103 Giulio Cesare ( 44 a.c.) Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise sulla spalla e regge il Palladium - B. 10;Cr. 458/1 (AG g. 3,8) R D/ decentrato
Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico
 Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE a.s. 2016/17 1^ AS CLASSE Liceo Scientifico Indirizzo di studio Docente Disciplina Prof.ssa Gardi Francesca
Liceo Marie Curie (Meda) Scientifico Classico Linguistico PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE a.s. 2016/17 1^ AS CLASSE Liceo Scientifico Indirizzo di studio Docente Disciplina Prof.ssa Gardi Francesca
STORIA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
 STORIA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI A USO DELLE FONTI L alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora,
STORIA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI A USO DELLE FONTI L alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora,
IPSSCTP M. PANTALEONI V. Brigida Postorino, 27 0044 FRASCATI
 IPSSCTP M. PANTALEONI V. Brigida Postorino, 27 0044 FRASCATI VERIFICA DEL DI COMPETENZE CAPACITA - CONOSCENZE NEL BIENNIO DELL OBBLIGO PER LA DISCIPLINA DI STORIA DELL ARTE PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI SECONDE
IPSSCTP M. PANTALEONI V. Brigida Postorino, 27 0044 FRASCATI VERIFICA DEL DI COMPETENZE CAPACITA - CONOSCENZE NEL BIENNIO DELL OBBLIGO PER LA DISCIPLINA DI STORIA DELL ARTE PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI SECONDE
I.T.T. "Francesco Algarotti" di Venezia Anno Scolastico 2018/2019
 classe I SERALE PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA I suoni e le lettere dell Italiano. Come evitare gli errori ortografici. Le sillabe. L accento. Punteggiatura, segni grafici, maiuscole.
classe I SERALE PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA I suoni e le lettere dell Italiano. Come evitare gli errori ortografici. Le sillabe. L accento. Punteggiatura, segni grafici, maiuscole.
Curricolo per Competenze: RELIGIONE
 Scuola dell Infanzia COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A.. 1. Identificare manifestazioni
Scuola dell Infanzia COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A.. 1. Identificare manifestazioni
Famiglia di Augusto. Successori designati di Augusto, mediante adozione, premorti. (m. 12 a.c.) (m. 23 a.c.) 1 3 (6 a.c. 2 d.c.
 Famiglia di Augusto Successori designati di Augusto, mediante adozione, premorti Virgilio e Orazio: sogno di nuova età dell Oro: fine delle guerre civili, pace nell Impero, ritorno ai puri valori repubblicani
Famiglia di Augusto Successori designati di Augusto, mediante adozione, premorti Virgilio e Orazio: sogno di nuova età dell Oro: fine delle guerre civili, pace nell Impero, ritorno ai puri valori repubblicani
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE
 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto d Istruzione Superiore Severi-Correnti IIS Severi-Correnti 02-318112/1 via Alcuino 4-20149 Milano 02-33100578 codice fiscale E-Mail:
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI DI BAGNOLO CREMASCO CURRICOLO DI STORIA
 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI BAGNOLO CREMASCO ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI BAGNOLO CREMASCO ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI
UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA. Competenze attese a livello di UdA
 MATERIA STORIA CLASSE I INDIRIZZO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA Competenze attese a livello di UdA Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
MATERIA STORIA CLASSE I INDIRIZZO DESCRIZIONE Unità di Apprendimento UdA n. 1 Titolo: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA Competenze attese a livello di UdA Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
Piano di lavoro annuale Storia e Geografia
 Anno scolastico 2015/2016 Classe 1^ SA Piano di lavoro annuale Storia e Geografia Finalità Al termine del primo biennio lo studente: - sarà stato abituato a usare in maniera appropriata il lessico e le
Anno scolastico 2015/2016 Classe 1^ SA Piano di lavoro annuale Storia e Geografia Finalità Al termine del primo biennio lo studente: - sarà stato abituato a usare in maniera appropriata il lessico e le
DAL REPERTORIO AL DATABASE: IL PROGETTO MONETE AL FEMMINILE L ICONOGRAFIA MONETALE DELL AUGUSTA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE
 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA (indirizzo Storia Antica) Ciclo XXV Settore concorsuale di afferenza Settore scientifico disciplinare 10/A1 Archeologia L-ANT/04
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA (indirizzo Storia Antica) Ciclo XXV Settore concorsuale di afferenza Settore scientifico disciplinare 10/A1 Archeologia L-ANT/04
La disciplina nel corso dell anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:
 I.S.S. J. TORRIANI CREMONA Anno Scolastico: 2018/2019 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Classe: 2 Sezione: B Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Materia: STORIA Docente: BRAGA RICCARDO Il docente di storia
I.S.S. J. TORRIANI CREMONA Anno Scolastico: 2018/2019 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Classe: 2 Sezione: B Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Materia: STORIA Docente: BRAGA RICCARDO Il docente di storia
RELIGIONE CATTOLICA. Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione
 Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
Curricolo di base per la classe prima del Primo Ciclo di istruzione Individuare differenze di caratteristiche esteriori, atteggiamenti, pensieri tra compagni di scuola. Dimostrare disponibilità all accoglienza
Lo scavo archeologico di Poggio Colla,Valle del Mugello Un insediamento etrusco antico di 2600 anni fa
 Lo scavo archeologico di Poggio Colla,Valle del Mugello Un insediamento etrusco antico di 2600 anni fa a cura di Lara Ferrara Una sorprendente scoperta è avvenuta a Poggio Colla, a pochi km da Firenze,
Lo scavo archeologico di Poggio Colla,Valle del Mugello Un insediamento etrusco antico di 2600 anni fa a cura di Lara Ferrara Una sorprendente scoperta è avvenuta a Poggio Colla, a pochi km da Firenze,
Curricolo di Storia Scuola Primaria Classi Prima-Seconda
 Curricolo di Storia Scuola Primaria Classi Prima-Seconda Traguardi per lo sviluppo delle competenze (fine V) L alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e
Curricolo di Storia Scuola Primaria Classi Prima-Seconda Traguardi per lo sviluppo delle competenze (fine V) L alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e
Istituto Statale d'istruzione Superiore R.FORESI
 PROGRAMMAZIONE A.S. 2015-2016 Classe/sez. Docente Materia Ore settimanali 2 BS Riccardo Rapposelli STORIA E GEOGRAFIA 3 SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: la classe 2 B Scientifico è composta da 19 alunni.
PROGRAMMAZIONE A.S. 2015-2016 Classe/sez. Docente Materia Ore settimanali 2 BS Riccardo Rapposelli STORIA E GEOGRAFIA 3 SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: la classe 2 B Scientifico è composta da 19 alunni.
UNITA DI APPRENDIMENTO N 1
 ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 SCUOLA PRIMARIA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CIRCOLO ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO VIBO VALENTIA Piazza Martiri d Ungheria
ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 SCUOLA PRIMARIA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CIRCOLO ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO VIBO VALENTIA Piazza Martiri d Ungheria
Divina ispirazione L ARCO DI COSTANTINO
 Divina ispirazione L ARCO DI COSTANTINO L arco di Costantino è un arco a tre fornici ed è il più grande giunto sino a noi. E alto circa 25 metri; il fornice centrale è alto 11,45 metri e largo 6,50 metri
Divina ispirazione L ARCO DI COSTANTINO L arco di Costantino è un arco a tre fornici ed è il più grande giunto sino a noi. E alto circa 25 metri; il fornice centrale è alto 11,45 metri e largo 6,50 metri
Progettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, asse storico sociale, Unità di apprendimento 1
 Progettazione per unità di apprendimento Unità di apprendimento 1 MODULO N.1: Dalla preistoria all'ellenismo DURATA PREVISTA 40 4 Competenza di asse Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
Progettazione per unità di apprendimento Unità di apprendimento 1 MODULO N.1: Dalla preistoria all'ellenismo DURATA PREVISTA 40 4 Competenza di asse Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
Sabetta Ciani. MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede
 Sabetta Ciani MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede Il libro è una ricerca storica sulle origini di Minervino e insieme un cammino di fede che risponde ad una profonda devozione
Sabetta Ciani MINERVA E L ARCANGELO A MINERVINO MURGE Itinerari di storia e di fede Il libro è una ricerca storica sulle origini di Minervino e insieme un cammino di fede che risponde ad una profonda devozione
406 Denario - Testa della Pietà a d. - R/ Trofeo con scudo e tromba gallica; a d. una scure - B. 26; Cr. 452/2; C. 26 (AG g.
 400 VARGUNTEIA - M. Vargunteius (130 a.c.) Denario - Testa di Roma a d. - R/ Giove in quadriga a d. - B. 1; Cr. 257/1 (AG g. 3,49) SPL 130 405 Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise
400 VARGUNTEIA - M. Vargunteius (130 a.c.) Denario - Testa di Roma a d. - R/ Giove in quadriga a d. - B. 1; Cr. 257/1 (AG g. 3,49) SPL 130 405 Denario - Testa di Venere a d. - R/ Enea porta il padre Anchise
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
Lettura di un opera d arte. Lettura formale di un opera d arte
 Lettura di un opera d arte Per leggere un opera d arte, 1) si analizzano i materiali e la tecnica con cui è stata creata; 2) si effettua la LETTURA FORMALE, analizzando gli elementi fondamentali di quella
Lettura di un opera d arte Per leggere un opera d arte, 1) si analizzano i materiali e la tecnica con cui è stata creata; 2) si effettua la LETTURA FORMALE, analizzando gli elementi fondamentali di quella
STORIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
 STORIA TRAGUARDI DI COMPETENZE DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L alunno: a. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. b. Riconosce e esplora in modo via via
STORIA TRAGUARDI DI COMPETENZE DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA L alunno: a. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. b. Riconosce e esplora in modo via via
