Prove ufficiali con svolgimento guidato
|
|
|
- Elvira Eva Bellucci
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Prove ufficiali con svolgimento guidato I. Svevo, La coscienza di Zeno, a.s L. Pirandello, Il piacere dell onestà, a.s E. Montale, Casa sul Mare, a.s
2 ESAME DI STATO Per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali. PRIMA PROVA COMPITO DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. Tipologia A - Analisi del testo Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599 Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s intende, sa dove piazzare l antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch egli ha qui accumulate! Dottor S. Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 1. Comprensione del testo Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. Ricorda che, per fare un buon riassunto, è opportuno eseguire con attenzione tutte le fasi necessarie: la lettura integrale del testo, l individuazione delle idee o dei fatti principali, l identificazione delle eventuali sequenze (nel caso di questo brano, si tratterà dei diversi momenti dello sviluppo dell argomentazione), la stesura vera e propria (che deve sempre osservare i criteri di ordine e consequenzialità). 2 il Novecento
3 2. Analisi del testo Per rispondere esattamente alle prime quattro domande dell Analisi del testo ti sarà sufficiente rileggere attentamente il brano, concentrandoti sulle informazioni che ti sono richieste. 2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? il Novecento 3
4 2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: novella (r. 1), autobiografia (r. 4), memorie (r. 9). Il Dottor S. utilizza tre definizioni diverse per indicare gli scritti di Zeno: ciò rivela da subito il particolare carattere del resoconto del protagonista e consente di entrare nel vivo del romanzo. Partiamo da novella: il Dottor S. avrebbe potuto utilizzare al suo posto il termine romanzo, ma non lo ha fatto, forse per sottovalutare il manoscritto in maniera provocatoria. Si scopre così che paziente e dottore appaiono come protagonista e antagonista della vicenda narrata. Prosegui nel ragionamento, riflettendo sugli altri due termini. 2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. Risposta libera. 3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. Ricorda che il brano proposto costituisce la breve Prefazione al romanzo La coscienza di Zeno, testo che rivoluziona gli schemi narrativi e la tecnica del racconto di tutta la letteratura del Novecento. Inserisci l opera all interno della produzione narrativa sveviana, ponendone in luce l evoluzione dai primi romanzi, incentrati sul tema dell inettitudine, al capolavoro, nella cui composizione risulta fondamentale la conoscenza da parte dell autore della psico-analisi di Sigmund Freud e della scoperta dell inconscio. Importante, inoltre, può essere la citazione dell Ulisse di James Joyce, in cui lo scrittore irlandese (di cui Svevo fece diretta conoscenza) inaugura la tecnica narrativa del monologo interiore, alla quale l autore triestino si ispira. 4 il Novecento
5 ESAME DI STATO Per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali. PRIMA PROVA COMPITO DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. Tipologia A - Analisi del testo L. Pirandello, Il piacere dell onestà Atto primo - Scena ottava Baldovino, Fabio Baldovino (seduto, s insella le lenti su la punta del naso e, reclinando indietro il capo) Le chiedo, prima di tutto, una grazia. Fabio Dica, dica... Baldovino Signor marchese, che mi parli aperto. Fabio Ah, sì, sì... Anzi, non chiedo di meglio. Baldovino Grazie. Lei forse però non intende questa espressione aperto, come la intendo io. Fabio Ma... non so... aperto... con tutta franchezza... E poiché Baldovino, con un dito, fa cenno di no:...e come, allora? Baldovino Non basta. Ecco, veda, signor marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte a lei, quello che devo essere, quello che posso essere mi costruisco cioè, me le presento¹ in una forma adatta alla relazione che debbo contrarre con lei. E lo stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe così di fronte, dietro le gelosie² e le imposte, restano poi ben nascosti i pensieri nostri più segreti, i nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per noi stessi, fuori delle relazioni che vogliamo stabilire. Mi sono spiegato? Fabio Sì, sì, benissimo... Ah, benissimo! [...] Baldovino Comincio io, allora, se permette, a parlarle aperto. Provo da un pezzo, signor marchese dentro un disgusto indicibile delle abiette costruzioni di me, che debbo mandare avanti nelle relazioni che mi vedo costretto a contrarre coi miei... diciamo simili, se lei non s offende. Fabio No, prego... dica, dica pure... Baldovino Io mi vedo, mi vedo di continuo, signor marchese; e dico: Ma quanto è vile, ma com è indegno questo che tu ora stai facendo! Fabio (sconcertato, imbarazzato) Oh Dio... ma no... perché? Baldovino Perché sì, scusi. Lei, tutt al più, potrebbe domandarmi perché allora lo faccio? Ma perché... molto per colpa mia, molto anche per colpa d altri, e ora, per necessità di cose, non posso fare altrimenti. Volerci in un modo o in un altro, signor marchese, è presto fatto: tutto sta, 1. mi presento a lei. 2. le persiane. il Novecento 5
6 poi, se possiamo essere quali ci vogliamo. [...] Ora, scusi, debbo toccare un altro tasto molto delicato. Fabio Mia moglie? Baldovino Ne è separato. Per torti... lo so, lei è un perfetto gentiluomo e chi non è capace di farne, è destinato a riceverne. Per torti, dunque, della moglie. E ha trovato qua una consolazione. Ma la vita trista usuraja si fa pagare quell uno di bene che concede, con cento di noje e di dispiaceri. Fabio Purtroppo! Baldovino Eh, l avrei a sapere! Bisogna che ella sconti la sua consolazione, signor marchese! Ha davanti l ombra minacciosa d un protesto senza dilazione. Vengo io a mettere una firma d avallo, e ad assumermi di pagare la sua cambiale. Non può credere, signor marchese, quanto piacere mi faccia questa vendetta che posso prendermi contro la società che nega ogni credito alla mia firma. Imporre questa mia firma; dire: Ecco qua: uno ha preso alla vita quel che non doveva e ora pago io per lui, perché se io non pagassi, qua un onestà fallirebbe, qua l onore d una famiglia farebbe bancarotta; signor marchese, è per me una bella soddisfazione: una rivincita! Creda che non lo faccio per altro. [...] Fabio Ecco, bene! E allora, questo. Benissimo! Io non vado cercando altro, signor Baldovino. L onestà! La bontà dei sentimenti! [...] Baldovino Ma le conseguenze, signor marchese, scusi! [...] Fabio Ecco... caro signore... capirà... già lei stesso l ha detto non... non mi trovo in condizione di seguirla bene, in questo momento [...] Baldovino È facilissimo. Che debbo fare io? Nulla. Rappresento la forma. L azione e non bella la commette lei: l ha già commessa, e io gliela riparo; seguiterà a commetterla, e io la nasconderò. Ma per nasconderla bene, nel suo stesso interesse e nell interesse soprattutto della signorina, bisogna che lei mi rispetti; e non le sarà facile nella parte che si vuol riserbare! Rispetti, dico, non propriamente me, ma la forma la forma che io rappresento: l onesto marito d una signora perbene. Non la vuol rispettare? Fabio Ma sì, certo! Baldovino E non comprende che sarà tanto più rigorosa e tiranna, questa forma, quanto più pura lei vorrà che sia la mia onestà? Perciò le dicevo di badare alle conseguenze. [...] Fabio Come... perché, scusi? Io non vedo tutte codeste difficoltà che vede lei! Baldovino Credo mio obbligo fargliee vedere, signor marchese. Lei è un gentiluomo. Necessità di cose, di condizioni, la costringono a non agire onestamente. Ma lei non può fare a meno dell onestà! Tanto vero che, non potendo trovarla in ciò che fa, la vuole in me. Devo rappresentarla io, la sua onestà: - esser cioè, l onesto marito d una donna, che non può essere sua moglie; l onesto padre d un nascituro che non può essere suo figlio. È vero questo? Fabio Sì, sì, è vero. Baldovino Ma se la donna è sua, e non mia; se il figliuolo è suo, e non mio, non capisce che non basterà che sia onesto soltanto io? Dovrà essere onesto anche lei, signor marchese, davanti a me. Per forza! Onesto io, onesti tutti. Per forza! Fabio Come come? Non capisco! Aspetti... Luigi PIRANDELLO (Girgenti Roma 1936) ebbe il premio Nobel nel Tutta la sua produzione è percorsa dal filo rosso dell assurdo e del tragico della condizione umana, dal contrasto tra apparenza e realtà e dallo sfaccettarsi della verità. Il testo proposto è tratto da Il piacere dell onestà, commedia in tre atti, rappresentata per la prima volta a Torino il 25 novembre La vicenda è collocata ai primi del Novecento in una città delle Marche. 6 il Novecento
7 Un nobile (il marchese Fabio), separato dalla moglie, ha una relazione con una giovane (Agata), che aspetta da lui un bambino. Il marchese e la madre della giovane pensano di trovare ad Agata (riluttante, ma poi consenziente), un finto marito per «salvare le apparenze». Accetta di assumere questo ruolo un altro aristocratico, Baldovino, uomo dalla vita dissipata, pieno di debiti di gioco, che non sa come pagare e che vengono pagati dal marchese. Ma Baldovino, molto accorto e sottile intenditore dei raggiri altrui, intuisce che Fabio, dopo aver fatto di lui un finto padre del nascituro, cercherà di scacciarlo dalla famiglia, magari facendolo apparire un truffatore in qualche affare finanziario. Per prevenire questo inganno, Baldovino fonda tutto il suo rapporto col marchese su un patto di onestà di pura forma: chiede che tutti debbano apparire sempre e in ogni cosa onesti, anche se non lo sono. Infatti, Baldovino, per tutta la vita imbroglione e sregolato, accetta questo vile patto solo per provare il piacere di apparire onesto, in una società che non rende affatto facile l essere onesti. Ma alla fine giunge il colpo di scena: quando si scoprono l inganno del marchese e la disonestà sua e degli altri, Baldovino confessa la propria intima disonestà e conquista in questo modo, involontariamente, la stima e l amore di Agata, che decide di andare a vivere con lui, portando con sé anche il bambino. Nella Scena ottava dell Atto primo si incontrano e discutono per la prima volta il puntiglioso Baldovino e l incauto Fabio. - Le parole in neretto nel testo sono evidenziate già dall Autore. 1. Analisi del testo A. La figura di Baldovino 1. Cerca e commenta nelle battute di Baldovino le parole e le espressioni che meglio rivelano le sue posizioni e intenzioni nella trattativa. Ricorda che in ogni testo teatrale, a differenza di quanto accade in un testo narrativo, tutti gli elementi, dall intreccio all ambientazione, alla caratterizzazione dei personaggi, devono essere desunti dalle battute e da eventuali didascalie. In questo caso, ti vengono richieste informazioni sull intreccio, in relazione alla vicenda della trattativa tra Baldovino e Fabio. Leggi più volte il testo, concentrandoti sulle battute pronunciate da Baldovino (e sulle espressioni in neretto) e tieni anche ben a mente la trama della commedia, che ti viene fornita. 2. Nel brano dalla riga 17 alla riga 39 quali esperienze affiorano della precedente vita di Baldovino? Leggendo le righe indicate, ti accorgerai che Baldovino non racconta fatti concreti della sua vita precedente, ma delinea piuttosto un suo particolare stato d animo. Quale? È da questo stato d animo che puoi dedurre le sue trascorse esperienze. il Novecento 7
8 3. In quale brano emerge più chiaramente il quadro delle apparenze da salvare? Individualo e commentalo. Il motivo delle apparenze attraversa un po tutto il testo, sebbene in alcuni punti emerga in maniera esplicita. Concentra la tua lettura sulla parte iniziale del testo e su quella finale, poi stendi il tuo commento alla luce della visione pirandelliana della realtà (opposizione vita-forma). B. La figura di Fabio 1. Come si caratterizza il linguaggio di Fabio rispetto a quello di Baldovino? Prima di rispondere a questa domanda, rifletti innanzitutto sulla diversa esperienza di vita dei due personaggi e sulle intenzioni di ciascuno riguardo al patto che stanno per stringere. 2. Quando Fabio (righe 40 e 41) parla di onestà e bontà dei sentimenti da parte di Baldovino, a che cosa sembra riferirsi? Se trovi difficoltà a rispondere a questo quesito prova a rileggere la trama della commedia. 3. In questo dialogo, Fabio fa finta di non capire i discorsi di Baldovino o non li comprende davvero? Argomenta la tua risposta. Rifletti, prima di formulare la tua risposta, sulla caratterizzazione dei due personaggi 2. Interpretazione complessiva e approfondimenti 1. Da questa vicenda, che per lungo tratto ci presenta personaggi pieni di ipocrisia e abituati al raggiro, si ricava alla fine anche una morale positiva? In che modo il pessimismo di Pirandello, quale si riscontra in questa ed in altre sue opere a te note, vuole aiutarci a trovare il filo per una condotta onesta nella vita, così piena di difficoltà per tutti? Per elaborare una risposta adeguata devi innanzitutto conoscere ed esporre le linee fondamentali della complessa poetica dell autore (la perdita di identità dell uomo moderno, l opposizione vita-forma, la frammentazione dell io, la legge di estrema instabilità che governa la vita), magari facendo riferimento a una parte 8 il Novecento
9 significativa della sua vasta produzione. Riflettendo su di essa in relazione al brano che hai letto, potrai riuscire a individuare con una certa facilità anche l eventuale presenza di una morale positiva sottesa alla commedia. 2. Pirandello è tra i nostri scrittori moderni che propongono per primi una lingua finalmente di uso medio, cioè di tipo parlato. Cerca e commenta le espressioni vicine al parlato di oggi. Puoi spiegare, ad esempio, il significato dell avverbio allora qui più volte usato. L uso medio della lingua nel testo di Pirandello è rinvenibile, oltre che nell utilizzo di alcuni termini, anche nel ricorso a particolari strutture sintattiche, che richiamano l uso parlato. Nota, ad esempio, al rigo 19 l espressione mi vedo costretto a contrarre coi miei... diciamo simili, se lei non s offende. Cerca altri termini e costrutti di uso medio. 3. Nel rispondere alle domande che ti sono state poste, riferisciti anche al contesto culturale europeo dell epoca. La produzione letteraria di Pirandello abbraccia grosso modo il primo trentennio del Novecento. Contemporaneamente in Europa si diffondono le avanguardie storiche, la storia del pensiero è scossa dalla scoperta della relatività di Einstein e dall avvento della psicoanalisi di Freud, il genere narrativo è rivoluzionato dalla nascita del romanzo modernista (Joyce, Proust, Kafka). Parla di tutti questi fenomeni e cerca di inserire l esperienza di Pirandello nel quadro generale della cultura del primo Novecento. il Novecento 9
10 10 il Novecento
11 ESAME DI STATO Per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali. PRIMA PROVA COMPITO DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. Tipologia A - Analisi del testo E. Montale, Casa sul Mare Il viaggio finisce qui: nelle cure meschine che dividono l anima che non sa più dare un grido. Ora i minuti sono uguali e fissi 5 come i giri di ruota della pompa. Un giro: un salir d acqua che rimbomba. Un altro, altr acqua, a tratti un cigolio. Il viaggio finisce a questa spiaggia che tentano gli assidui e lenti flussi. 10 Nulla disvela se non pigri fumi la marina che tramano di conche i soffi leni: ed è raro che appaia nella bonaccia muta tra l isole dell aria migrabonde 15 la Corsica dorsuta o la Capraia. Tu chiedi se così tutto vanisce in questa poca nebbia di memorie; se nell ora che torpe o nel sospiro del frangente si compie ogni destino. 20 Vorrei dirti che no, che ti s appressa l ora che passerai di là dal tempo; forse solo chi vuole s infinita, e questo tu potrai, chissà, non io. Penso che per i più non sia salvezza, 25 ma taluno sovverta ogni disegno, passi il varco, qual volle si ritrovi. Vorrei prima di cedere segnarti codesta via di fuga labile come nei sommossi campi 30 del mare spuma o ruga. Ti dono anche l avara mia speranza. A nuovi giorni, stanco, non so crescerla: il Novecento 11
12 l offro in pegno al tuo fato, che ti scampi. Il cammino finisce a queste prode 35 che rode la marea col moto alterno. Il tuo cuore vicino che non m ode salpa già forse per l eterno. Eugenio Montale (Genova, Milano, 1981) è il maggiore esponente della poesia italiana del pieno Novecento. Le sue varie raccolte sono apparse tra il 1925 (Ossi di seppia) e il 77. Nel 1975 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Nella sua poesia è molto presente il paesaggio della costa ligure. Già nelle prime liriche Montale esprime il suo forte pessimismo e al contempo la sua tensione all assoluto, l ansia di una salvezza, che di solito è affidata all opera di una donna, con la quale il poeta dialoga intensamente. L impianto delle sue liriche è spesso narrativo ed evoca luoghi, persone, eventi e oggetti della vita quotidiana, perfino congegni meccanici, che si caricano di significati metaforici e simbolici. 1. Comprensione del testo Dopo una o più letture dell intero testo, esponi (in non più di quindici righe) il contenuto informativo della lirica: con quale scena questa si apre, quali scene o situazioni si susseguono strofa per strofa, quale tema è svolto nel dialogo tra il poeta e la persona (una donna) che gli sta accanto. Leggi attentamente i versi, cercando di comprenderne il significato letterale; ricorda che è opportuno ricorrere alla consultazione di un dizionario se non conosci il significato di uno o più termini. Per individuare il contenuto informativo del testo, dunque, procedi con una parafrasi: ricostruisci innanzitutto il lineare ordine sintattico dei periodi e delle proposizioni (nel caso di questa lirica l operazione ti risulterà semplice), sostituisci le parole difficili con parole di uso comune e integra il testo con gli elementi sottintesi. Ora puoi procedere alla stesura del riassunto, rispettando la suddivisione per strofe e la lunghezza delle righe che ti viene indicata; l individuazione del tema svolto nel dialogo tra il poeta e la donna che gli sta accanto dovrebbe a questo punto esserti chiaro. 12 il Novecento
13 2. Analisi del testo 2.1 Molte parole indicano il viaggio (o il movimento) e il tempo (o l immobilità, la fine): sono come due fili che s intrecciano per esprimere il tema di fondo della lirica. Cerca (e sottolinea in modo diverso) le parole dell uno e quelle dell altro filo e commenta il contrasto che ne deriva. Rileggi il testo per individuare i termini appartenenti ai due diversi campi semantici che vengono indicati. In riferimento ai primi cinque versi, a parte la parola iniziale viaggio, se ne possono evidenziare già due: minuti, al v. 4, e giri, al v. 5, riconducibili il primo al tema del tempo, il secondo a quello del viaggio. Prosegui nella ricerca. Ora rifletti sul contrasto derivante dal diverso significato dei due campi semantici. 2.2 Qual è l elemento dominante del paesaggio? Raccogli e commenta brevemente i vocaboli che si riferiscono a questo elemento. C è anche un secondo elemento che lo accompagna? Questo secondo elemento ha anche un significato metaforico? L elemento dominante del paesaggio è palesato addirittura dal titolo della lirica. Il secondo è strettamente legato al primo. Quanto al significato metaforico, ricorda che la metafora è una figura di pensiero consistente nella sostituzione di un termine con un altro termine legato al primo da un rapporto di somiglianza. La metafora, quindi, può generalmente considerarsi una sorta di similitudine abbreviata, nella quale manchi il secondo termine di paragone. Per individuare il significato metaforico degli elementi in questione, può esserti utile ripensare anche ai due campi semantici individuati precedentemente. 2.3 Che effetto produce, in questo scenario così ampio, l immagine della pompa idraulica con il suo monotono ritmo? E il riferimento così preciso dato dal titolo? L immagine della pompa idraulica è utilizzata per sottolineare una caratteristica peculiare del tempo, esplicitata tra l altro dalla similitudine con i minuti uguali e fissi. In contrapposizione si pone l immagine del mare. Perché? il Novecento 13
14 2.4 Nella terza e nella quarta strofa si svolge un fitto dialogo con l altra persona: sottolinea tutti gli elementi linguistici (pronomi, aggettivi possessivi, forme verbali) che indicano il tu e l io e interpreta il significato di questo confronto tra due destini. Dopo le immagini relative al paesaggio marino che occupano la seconda strofa, nella terza strofa il poeta introduce in modo indiretto un tu generico, che formula una drammatica domanda sulla vita: quale? Prova a evidenziare in che modo si collega il senso di questa domanda a quello più generale della lirica. 2.5 Spiegazioni puntuali del testo. Che cosa sono le conche del v. 11 e le isole dell aria migrabonde del v. 14. Che cosa significano le espressioni: l ora che torpe del v. 18; prima di cedere del v. 27; solo chi vuole s infinita del v. 22; l avara mia speranza; A nuovi giorni, stanco, non so crescerla dei vv Avendo ormai chiaro il significato letterale e metaforico del testo, non dovrebbe risultarti difficile rispondere a questo quesito. Ad ogni modo, ricorda che in certi casi può essere illuminante l aiuto del dizionario. 2.6 I versi sono quasi tutti di una stessa misura: quale? Ce ne sono di sdruccioli? Riconosci degli enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. Per individuare il verso adoperato, basta contarne le sillabe, stando sempre attenti alla presenza di eventuali dieresi (figura metrica per cui due vocali, che generalmente costituiscono un unica sillaba, sono invece computate come due sillabe distinte). Ricorda che si dicono sdruccioli i versi che terminano con una parola accentata sulla terz ultima sillaba. L enjambement, invece, si ha quando la fine di un verso non coincide con la fine di una frase, che pertanto continua nel verso successivo. Ancora, la rima è l identità di suono di due o più parole a partire dall ultima sillaba accentata; l assonanza è la somiglianza di suono tra le ultime sillabe di due parole aventi vocali uguali, ma consonanti diverse, mentre la consonanza è la somiglianza di suono tra le sillabe finali di due parole aventi consonanti uguali, ma vocali diverse. 14 il Novecento
15 3. Interpretazione complessiva e approfondimenti Esponi il significato complessivo della lirica montaliana, rifacendoti ad altri testi dell Autore, se ti sono noti, alle caratteristiche della situazione generale, sociale e politica, dell Italia dell epoca, alle tendenze che si manifestavano allora nella letteratura italiana e, se possibile, in quella europea. Per individuare il significato complessivo della lirica, devi innanzitutto indicare a quale raccolta appartiene e le caratteristiche generali dell opera stessa, anche in relazione alla restante produzione poetica di Montale. Quanto all inquadramento nel contesto storico, ricorda che l autore visse nel pieno Novecento e, pertanto, sperimentò in prima persona i grandi eventi di quel secolo, come le due guerre mondiali. La poesia degli anni Venti e Trenta, dove è collocabile l esperienza montaliana, è invece contraddistinta, in Italia, dal diffondersi dell ermetismo e, in Europa, dalle avanguardie storiche. Parla diffusamente di tutti questi avvenimenti, cercando di cogliere i nessi logici e di pensiero che li collegano. il Novecento 15
2 Ascolta tutta la conversazione e verifica le risposte al punto 1.
 1 Ascolta e rispondi alle domande. 12 1. Chi sono le persone che parlano? a. Madre e figlio. b. Fratello e sorella. c. Marito e moglie. 2. Qual è l argomento della conversazione? a. Lasciare la vecchia
1 Ascolta e rispondi alle domande. 12 1. Chi sono le persone che parlano? a. Madre e figlio. b. Fratello e sorella. c. Marito e moglie. 2. Qual è l argomento della conversazione? a. Lasciare la vecchia
Freud e Svevo Filosofia e letteratura
 Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo videoanimazioni interdisciplinari Freud e Svevo Filosofia e letteratura Comprensione del testo 1. Qual è la formazione di Sigmund Freud? 2. Quali sono i romanzi
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE Anno Scolastico: 2018-2019 Dipartimento (1) : ITALIANO Coordinatore (1) : Prof.ssa Leproux Fernanda Classe: V Indirizzo: Servizi Commerciali Ore di insegnamento settimanale:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE Anno Scolastico: 2018-2019 Dipartimento (1) : ITALIANO Coordinatore (1) : Prof.ssa Leproux Fernanda Classe: V Indirizzo: Servizi Commerciali Ore di insegnamento settimanale:
Verifica di italiano
 Verifica di italiano Cognome Nome Classe Data Rispondere alle seguenti domande scegliendo una sola risposta: 1. L età del Romanticismo è: tra la fine del secolo X e la metà del secolo XIX tra la fine del
Verifica di italiano Cognome Nome Classe Data Rispondere alle seguenti domande scegliendo una sola risposta: 1. L età del Romanticismo è: tra la fine del secolo X e la metà del secolo XIX tra la fine del
Ambito di contenuto. Poesia FARE POESIA
 Destinatari Competenza Ambito di contenuto Contenuto Classe II Scuola Secondaria di primo grado Ricercare strategie per comporre testi poetici Poesia Fare poesia FARE POESIA Introduzione Tra la Prosa e
Destinatari Competenza Ambito di contenuto Contenuto Classe II Scuola Secondaria di primo grado Ricercare strategie per comporre testi poetici Poesia Fare poesia FARE POESIA Introduzione Tra la Prosa e
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO
 PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
PER UN ANALISI DEL TESTO NARRATIVO TRAMA PERSONAGGI TEMPO TESTO NARRATIVO SPAZIO NARRATORE TESTO NARRATIVO: un testo è narrativo quando è caratterizzato dallo sviluppo di una trama, dalla presenza di un
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE QUARTA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto di fantasia Testo realistico
COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
COMPETENZA ITALIANO COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Definizione: è la capacità di esprimere e interpretare pensieri,sentimenti e fatti in forma sia in forma orale che scritta (comprensione
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE Anno Scolastico: 2018-2019 Dipartimento (1) : ITALIANO Coordinatore (1) : Prof.ssa Leproux Fernanda Classe: V Indirizzo: Servizi Sociali Ore di insegnamento settimanale:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE Anno Scolastico: 2018-2019 Dipartimento (1) : ITALIANO Coordinatore (1) : Prof.ssa Leproux Fernanda Classe: V Indirizzo: Servizi Sociali Ore di insegnamento settimanale:
ITALO SVEVO. prof.ssa Bosisio Laura
 Nacque a Trieste nel 1861, il suo vero nome è Aron Hector Schmitz; Genitori ebrei; Settimo di otto fratelli; Studiò in un collegio tedesco; 1887: Rientra a Trieste ed inizia studi tecnici ma coltiva grande
Nacque a Trieste nel 1861, il suo vero nome è Aron Hector Schmitz; Genitori ebrei; Settimo di otto fratelli; Studiò in un collegio tedesco; 1887: Rientra a Trieste ed inizia studi tecnici ma coltiva grande
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classe 3 ^ B D e Amicis
 Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classe 3 ^ B D e Amicis a.s. 2018-2019 FILONE N 1 : COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA, PRODUZIONE E COMPRENSIONE INDICATORE: ASCOLTARE E PARLARE
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classe 3 ^ B D e Amicis a.s. 2018-2019 FILONE N 1 : COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA, PRODUZIONE E COMPRENSIONE INDICATORE: ASCOLTARE E PARLARE
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classi 3^A/B Don Milani a.s
 Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classi 3^A/B Don Milani a.s.2018-2019 FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA, PRODUZIONE E COMPRENSIONE INDICATORE: ASCOLTARE E PARLARE
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA PRIMARIA classi 3^A/B Don Milani a.s.2018-2019 FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA, PRODUZIONE E COMPRENSIONE INDICATORE: ASCOLTARE E PARLARE
Leggere per studiare
 Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
Leggere per studiare A cura di Silvana Loiero Che cosa vuol dire leggere per studiare? Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni per capire il testo letto: rielaborare le
Programma svolto d Italiano. Classe 5^E A.S. 2017/2018
 Programma svolto d Italiano Classe 5^E A.S. 2017/2018 Unità 1. L età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo Una nuova fiducia nella scienza La nascita dell evoluzionismo Il Naturalismo e il Verismo
Programma svolto d Italiano Classe 5^E A.S. 2017/2018 Unità 1. L età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo Una nuova fiducia nella scienza La nascita dell evoluzionismo Il Naturalismo e il Verismo
Umberto Saba
 Umberto Saba 1883-1957 Vita e opere scelta dello pseudonimo Saba origine triestina matrimonio e lavoro rapporto conflittuale con la famiglia (abbandonato dal padre) memoria della balia (di cognome Sabaz)
Umberto Saba 1883-1957 Vita e opere scelta dello pseudonimo Saba origine triestina matrimonio e lavoro rapporto conflittuale con la famiglia (abbandonato dal padre) memoria della balia (di cognome Sabaz)
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA
 Mod.: DID 39.04 PQ12 Rev.: 2 data: 10.09.2014 pag.: 1 di 5 NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DISCIPLINA ITALIANO BIENNIO A. F. M - ITER TRIENNIO A.F. M - ITER SERALE Elaborazione collegiale del dipartimento
Mod.: DID 39.04 PQ12 Rev.: 2 data: 10.09.2014 pag.: 1 di 5 NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DISCIPLINA ITALIANO BIENNIO A. F. M - ITER TRIENNIO A.F. M - ITER SERALE Elaborazione collegiale del dipartimento
III Circolo di Rho. Programmazione annuale. Lingua Italiana. Classe III
 III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
III Circolo di Rho Programmazione annuale Lingua Italiana Classe III ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende le informazioni principali di un messaggio Interviene nel dialogo e nella conversazione in modo
Verso l invalsi. Allora... in un tempo assai lunge felice fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora!
 Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
Invalsi Allora Allora... in un tempo assai lunge fui molto; non ora: ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d allora! 5 Quell anno! per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero,
Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA SECONDARIA
 Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA SECONDARIA FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE CLASSE 1^: ascolta e comprende testi utilizzando
Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA SECONDARIA FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE CLASSE 1^: ascolta e comprende testi utilizzando
LE OPERAZIONI DA COMPIERE PER ANALIZZARE UN TESTO POETICO VANNO DIVISE NEI TRE MOMENTI DELLA COMPRENSIONE, ANALISI/ INTERPRETAZIONE, APPROFONDIMENTI
 LE OPERAZIONI DA COMPIERE PER ANALIZZARE UN TESTO POETICO VANNO DIVISE NEI TRE MOMENTI DELLA COMPRENSIONE, ANALISI/ INTERPRETAZIONE, APPROFONDIMENTI COMPRENSIONE Leggi il testo in modo orientativo. Leggi
LE OPERAZIONI DA COMPIERE PER ANALIZZARE UN TESTO POETICO VANNO DIVISE NEI TRE MOMENTI DELLA COMPRENSIONE, ANALISI/ INTERPRETAZIONE, APPROFONDIMENTI COMPRENSIONE Leggi il testo in modo orientativo. Leggi
Metàloghi e Minotauri
 Metàloghi e Minotauri Metalogo di Giuseppe O. Longo Padre - Ah, stai disegnando... Figlia - Sì... ma non è finito, non dovresti guardare ancora. P - Ormai ho guardato... Un Minotauro!... Be, sei proprio
Metàloghi e Minotauri Metalogo di Giuseppe O. Longo Padre - Ah, stai disegnando... Figlia - Sì... ma non è finito, non dovresti guardare ancora. P - Ormai ho guardato... Un Minotauro!... Be, sei proprio
IIS Crescenzi Pacinotti Sirani ITALIANO: PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 CLASSE: II CFM DOCENTE: Agnese Benedetta Maria Arena
 IIS Crescenzi Pacinotti Sirani ITALIANO: PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 CLASSE: II CFM DOCENTE: Agnese Benedetta Maria Arena CONOSCENZE EDUCAZIONE LINGUISTICA MODULO 1 Fonetica, ortografia e punteggiatura
IIS Crescenzi Pacinotti Sirani ITALIANO: PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 CLASSE: II CFM DOCENTE: Agnese Benedetta Maria Arena CONOSCENZE EDUCAZIONE LINGUISTICA MODULO 1 Fonetica, ortografia e punteggiatura
COMPETENZE. INVALSI Sviluppare la competenza testuale e grammaticale con la Prova INVALSI
 PROGRAMMAZIONE SECONDO ANNO Unità 1 Il testo narrativo Conoscere la differenza tra fabula e intreccio Conoscere l analessi e la prolessi Conoscere i tipi di discorso diretto e indiretto, il monologo interiore
PROGRAMMAZIONE SECONDO ANNO Unità 1 Il testo narrativo Conoscere la differenza tra fabula e intreccio Conoscere l analessi e la prolessi Conoscere i tipi di discorso diretto e indiretto, il monologo interiore
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/2016 CLASSE 5^ B RIM DISCIPLINA ITALIANO. DOCENTE CASTAGNINO N. 110 ore svolte sul totale delle ore previste 132
 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/2016 CLASSE 5^ B RIM DISCIPLINA ITALIANO DOCENTE CASTAGNINO N. 110 ore svolte sul totale delle ore previste 132 MODULO E/O UNITA DIDATTICA CONTENUTI 1) Positivismo, Naturalismo
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2015/2016 CLASSE 5^ B RIM DISCIPLINA ITALIANO DOCENTE CASTAGNINO N. 110 ore svolte sul totale delle ore previste 132 MODULO E/O UNITA DIDATTICA CONTENUTI 1) Positivismo, Naturalismo
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA. Classe quarta
 PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
PROGRAMMAZIONE LINGUA ITALIANA Classe quarta ASCOLTARE E PARLARE 1. Strategie essenziali dell'ascolto. 2. Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto. 3. Interazioni fra testo e contesto.
Curricolo di Italiano- classe prima. Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti
 Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
Curricolo di Italiano- classe prima Competenze Descrittori di competenza descrittori minimi I Testi tematiche portanti Ascoltare 1. Presta attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 3^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE)
 Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 3^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende testi utilizzando
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 3^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende testi utilizzando
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 2^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE)
 Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 2^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende testi utilizzando
Programmazione didattico-educativa di classe SCUOLA SECONDARIA - CLASSE 2^ FILONE N 1: COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA (PRODUZIONE E COMPRENSIONE) ASCOLTARE E PARLARE Ascolta e comprende testi utilizzando
Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche
 Il romanzo Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche ORIGINI STRUTTURA Genere antico, nato dalle letterature orientali; nel medioevo furono creati romanzi in
Il romanzo Testo narrativo in prosa di una certa ampiezza che narra vicende reali o fantastiche ORIGINI STRUTTURA Genere antico, nato dalle letterature orientali; nel medioevo furono creati romanzi in
Io non temo il tema!!!!
 Io non temo il tema!!!! 1. sviluppo i contenuti principali Penso a tutte le cose possibili che potrei dire: le appunto sulla brutta così come mi vengono in mente, senza preoccuparmi di come scriverle inizio
Io non temo il tema!!!! 1. sviluppo i contenuti principali Penso a tutte le cose possibili che potrei dire: le appunto sulla brutta così come mi vengono in mente, senza preoccuparmi di come scriverle inizio
L analisi del testo come prova di scrittura D.M. 389/1998 <Analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letter
 L analisi del testo L analisi del testo come prova di scrittura D.M. 389/1998
L analisi del testo L analisi del testo come prova di scrittura D.M. 389/1998
La maschera del cuore
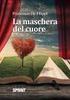 La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
La maschera del cuore Francesco De Filippi LA MASCHERA DEL CUORE romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Francesco De Filippi Tutti i diritti riservati Al mio prof Renato Lo Schiavo che ha permesso
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE TERZA
 CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE TERZA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto Testo realistico racconto
CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE TERZA CONTENUTI ABILITA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI LINGUA PER NARRARE Testo fantastico fiaba favola mito leggenda racconto Testo realistico racconto
Comprensione - Analisi - Contestualizzazione
 Appunti Italiano Tipologia A: analisi del testo - Narrativo - Poetico - Teatrale Tipologia B: saggio breve/articoli di giornale - Artistico letterari - Socio-economico - Storico politico - Tecnico scientifico
Appunti Italiano Tipologia A: analisi del testo - Narrativo - Poetico - Teatrale Tipologia B: saggio breve/articoli di giornale - Artistico letterari - Socio-economico - Storico politico - Tecnico scientifico
PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE PROGETTAZIONE ANNUALE DIDATTICA:
 PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Docente PICCHI MARIA LETIZIA Plesso Scuola dell'infanzia Giuseppe Giusti Classe.. Sezione A e B (anni 5) Disciplina/Macroarea/Campo d esperienza I DISCORSI E LE PAROLE Tavola
PROGETTAZIONE FORMATIVA ANNUALE Docente PICCHI MARIA LETIZIA Plesso Scuola dell'infanzia Giuseppe Giusti Classe.. Sezione A e B (anni 5) Disciplina/Macroarea/Campo d esperienza I DISCORSI E LE PAROLE Tavola
L Ermetismo Italia anni comune atteggiamento critico Francesco Flora difficoltà comprendere dio greco Ermes
 L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
L Ermetismo In Italia, tra gli anni 20 e 30 del XX secolo, si affermò l Ermetismo, non un movimento letterario ma un comune atteggiamento assunto da poeti. La denominazione fu coniata dal critico Francesco
LICEO SCIENTIFICO STATALE
 LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
LICEO STATALE SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CLASSICO GALILEO GALILEI - LEGNANO PdQ - 7.06 Ediz.: 1 Rev.: 0 Data 02/09/05 Alleg.: D01 PROG. M2 PROCEDURA della QUALITA' Programma Didattico Annuale Anno Scolastico
ITALO SVEVO VITA OPERE PENSIERO
 ITALO SVEVO VITA OPERE PENSIERO VITA Nasce a Trieste nel 1861 da una famiglia della borghesia commerciale di origine ebraica: suo nonno visse in Renania (Germania). Il suo vero nome è Ettore Schmitz: scelse
ITALO SVEVO VITA OPERE PENSIERO VITA Nasce a Trieste nel 1861 da una famiglia della borghesia commerciale di origine ebraica: suo nonno visse in Renania (Germania). Il suo vero nome è Ettore Schmitz: scelse
Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1)
 Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1) 1. Rispondi con una x Il testo è : un racconto realistico perché personaggi, luoghi e fatti sono reali o verosimili. una fiaba perché c è un incantesimo un
Analisi e comprensione del testo ( GRUPPO 1) 1. Rispondi con una x Il testo è : un racconto realistico perché personaggi, luoghi e fatti sono reali o verosimili. una fiaba perché c è un incantesimo un
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado LICEO ARTISTICO A. FRATTINI Via Valverde, 2-21100 Varese tel: 0332820670 fax: 0332820470
Vasco Rossi - Brava. La Canzone. 2. I seguenti titoli di giornale si riferiscono ad un cantante. Sapete dire di chi si tratta?
 Vasco Rossi - Brava La Canzone 1. Quali cantanti italiani conoscete? 2. I seguenti titoli di giornale si riferiscono ad un cantante. Sapete dire di chi si tratta? Grande talento, ironico, con i suoi contrasti
Vasco Rossi - Brava La Canzone 1. Quali cantanti italiani conoscete? 2. I seguenti titoli di giornale si riferiscono ad un cantante. Sapete dire di chi si tratta? Grande talento, ironico, con i suoi contrasti
ASCOLTARE E PARLARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
 ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
ASCOLTARE E PARLARE - Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti
SCUOLA PRIMARIA CRITERI DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CLASSE PRIMA
 SCUOLA PRIMARIA CRITERI DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CLASSE PRIMA NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO DIO E L UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI L allievo scopre che per
SCUOLA PRIMARIA CRITERI DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CLASSE PRIMA NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO DIO E L UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI L allievo scopre che per
Curriculo Verticale I.C. Artena
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Curriculo Verticale I.C. Artena TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA DALLA FINE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Curriculo Verticale I.C. Artena TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA DALLA FINE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Monica Ricciardi L UOMO DELLE FAVOLE
 L uomo delle favole Monica Ricciardi L UOMO DELLE FAVOLE www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Monica Ricciardi Tutti i diritti riservati Prefazione dell autore Questo racconto nasce circa dieci anni
L uomo delle favole Monica Ricciardi L UOMO DELLE FAVOLE www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Monica Ricciardi Tutti i diritti riservati Prefazione dell autore Questo racconto nasce circa dieci anni
I DISCORSI E LE PAROLE
 TRE ANNI Il/La bambino/a usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta
TRE ANNI Il/La bambino/a usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta
Programmazione annuale a. s
 Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Programmazione annuale a. s. 2016-2017 MATERIA: CLASSE: ITALIANO SECONDA LIBRO/I DI TESTO: AUTORE: TITOLO: EDITORE: AUTORE: TITOLO: EDITORE: MARCELLO SENSINI L ITALIANO DA SAPERE IN TEORIA E IN PRATICA
Disciplina:italiano C.D Il sé e l altro - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Traguardo: Obiettivi di apprendimento:
 Disciplina:italiano C.D Il sé e l altro - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Traguardo: sviluppa il senso dell identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
Disciplina:italiano C.D Il sé e l altro - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Traguardo: sviluppa il senso dell identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
10 Scegli la felicità con Ho oponopono
 Introduzione N el giugno 2009, dopo che tenni i miei primi corsi in Israele, Yael, il mio editore in quel Paese, venne da me e disse: «Mabel, il tuo libro Scopri Ho oponopono. La via più semplice è fantastico,
Introduzione N el giugno 2009, dopo che tenni i miei primi corsi in Israele, Yael, il mio editore in quel Paese, venne da me e disse: «Mabel, il tuo libro Scopri Ho oponopono. La via più semplice è fantastico,
ITALIANO COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE
 ITALIANO COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura e Quando ascolta, al termine del
ITALIANO COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura e Quando ascolta, al termine del
Il progetto Che carattere! ha il preciso scopo di creare collegamenti diretti, anzi, di interscambio tra lettura, scrittura e vita dei ragazzi.
 Il progetto Che carattere! ha il preciso scopo di creare collegamenti diretti, anzi, di interscambio tra lettura, scrittura e vita dei ragazzi. narrazione, ma si sottovaluta l aspetto psicologico dei personaggi,
Il progetto Che carattere! ha il preciso scopo di creare collegamenti diretti, anzi, di interscambio tra lettura, scrittura e vita dei ragazzi. narrazione, ma si sottovaluta l aspetto psicologico dei personaggi,
ITALIANO CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI NARRATIVI.
 ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
ITALIANO OB. FORMATIVI COMPETENZE CLASSE 1 1. ASCOLTARE E COMPRENDERE TESTI 1.1 Ascoltare una semplice narrazione individuando personaggi, luoghi, successione temporale. 1.2 Ascoltare una semplice descrizione
PIANO DI LAVORO INIZIALE A.S SEDE: CATELNOVO NE MONTI INDIRIZZO: ALBERGHIERO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI CLASSE DEL NOVEMBRE2014
 PIANO DI LAVORO INIZIALE A.S. 2014-2015 SEDE: CATELNOVO NE MONTI INDIRIZZO: ALBERGHIERO DOCENTE: TARASCONI CRISTIANA CLASSE: VB MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI CLASSE DEL NOVEMBRE2014
PIANO DI LAVORO INIZIALE A.S. 2014-2015 SEDE: CATELNOVO NE MONTI INDIRIZZO: ALBERGHIERO DOCENTE: TARASCONI CRISTIANA CLASSE: VB MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI CLASSE DEL NOVEMBRE2014
ITET AULO CECCATO - THIENE (VI)
 ITET AULO CECCATO - THIENE (VI) Anno scolastico 2017/2018 Programma finale Classe: 5^ A RIM Materia: Letteratura e lingua italiana Docente: Claudia Balasso LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LETTERATURA PIU Vol
ITET AULO CECCATO - THIENE (VI) Anno scolastico 2017/2018 Programma finale Classe: 5^ A RIM Materia: Letteratura e lingua italiana Docente: Claudia Balasso LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LETTERATURA PIU Vol
Sicurezza Insicurezza/cambiamento/mistero Riconoscimento/identità/importanza Amore/appartenenza Crescita Contributo
 2 BISOGNI EMOZIONI Prologo Non c è un bisogno senza un emozione (tranne i bisogni primari o fisiologici di cui parleremo a parte). I bisogni psicologici dell uomo, facendo una sintesi fra più autori
2 BISOGNI EMOZIONI Prologo Non c è un bisogno senza un emozione (tranne i bisogni primari o fisiologici di cui parleremo a parte). I bisogni psicologici dell uomo, facendo una sintesi fra più autori
Programmazione di Italiano Classe V A Anno scolastico
 Programmazione di Italiano Classe V A Anno scolastico 2016-2017 Competenze Finalità Il percorso didattico è incentrato sul potenziamento delle competenze testuali e, insieme, sul perfezionamento della
Programmazione di Italiano Classe V A Anno scolastico 2016-2017 Competenze Finalità Il percorso didattico è incentrato sul potenziamento delle competenze testuali e, insieme, sul perfezionamento della
I DISCORSI E LE PAROLE 3 ANNI. I diversi linguaggi verbali e non. I diversi codici di comunicazione
 I DISCORSI E LE PAROLE 3 ANNI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce
I DISCORSI E LE PAROLE 3 ANNI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITÀ COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce
Competenze relative agli assi culturali. Discipline concorrenti. Disciplina di riferimento. Conoscenze UDA UDA. Abilità UDA
 PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA : ITALIANO SETTORE TECNOLOGICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE Monte ore complessivo: 132, 66 per quadrimestre PIANO DELLE UDA 2 ANNO UDA Competenze relative agli assi culturali
PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA : ITALIANO SETTORE TECNOLOGICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE Monte ore complessivo: 132, 66 per quadrimestre PIANO DELLE UDA 2 ANNO UDA Competenze relative agli assi culturali
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO
 ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
ASCOLTARE E PARLARE Istituto Comprensivo Rignano Incisa PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO Classe V 1 Quadrimestre Obiettivi Attività Cogliere l argomento principale dei discorsi altrui; Prendere la parola
Frasi Celebri di Albert Einstein. "Matematicandoinsieme"
 La Fantasia è più importante del sapere Frasi Celebri di Albert Einstein Se solamente avessi saputo, sarei diventato un orologiaio. L educazione è quello che rimane quando si dimentica tutto ciò che si
La Fantasia è più importante del sapere Frasi Celebri di Albert Einstein Se solamente avessi saputo, sarei diventato un orologiaio. L educazione è quello che rimane quando si dimentica tutto ciò che si
CURRICOLO DI SCRITTURA. Competenza: Saper scrivere un testo corretto nell ortografia
 CURRICOLO DI SCRITTURA Competenza: Saper scrivere un testo corretto nell ortografia ABILITÀ COMPETENZE Uscita scuola dell infanzia - Riconoscere fonemi iniziali, finali, in corpo di parola (comincia con
CURRICOLO DI SCRITTURA Competenza: Saper scrivere un testo corretto nell ortografia ABILITÀ COMPETENZE Uscita scuola dell infanzia - Riconoscere fonemi iniziali, finali, in corpo di parola (comincia con
TEATRO CONTEMPORANEO
 TEATRO TEATRO CONTEMPORANEO Il dramma borghese La società costringe gli individui ad apparire rispettabili, obbedendo a precisi codici di comportamento; ma in realtà tutto è permesso, purché si salvino
TEATRO TEATRO CONTEMPORANEO Il dramma borghese La società costringe gli individui ad apparire rispettabili, obbedendo a precisi codici di comportamento; ma in realtà tutto è permesso, purché si salvino
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANO - PRIMO BIENNIO
 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANO - PRIMO BIENNIO Obiettivi specifici L insegnamento della Lingua italiana mira a promuovere e sviluppare: le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANO - PRIMO BIENNIO Obiettivi specifici L insegnamento della Lingua italiana mira a promuovere e sviluppare: le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla
Il percorso è pensato per alunni di una classe Seconda Media, in un attività di tipo modulare.
 LA SELVA OSCURA INDICAZIONI PER L INSEGNANTE DESTINATARI Il percorso è pensato per alunni di una classe Seconda Media, in un attività di tipo modulare. PREREQUISITI DI CONTENUTO Conoscenza del testo poetico:
LA SELVA OSCURA INDICAZIONI PER L INSEGNANTE DESTINATARI Il percorso è pensato per alunni di una classe Seconda Media, in un attività di tipo modulare. PREREQUISITI DI CONTENUTO Conoscenza del testo poetico:
Diocesi di Milano. Con Te! Cristiani SUSSIDIO 4. Itinerario di Iniziazione Cristiana
 Diocesi di Milano Con Te! Cristiani SUSSIDIO 4 Itinerario di Iniziazione Cristiana Ciao, sono Madre Teresa, una piccola matita nelle mani di Dio, una povera suora che vive tra i più poveri dei poveri.
Diocesi di Milano Con Te! Cristiani SUSSIDIO 4 Itinerario di Iniziazione Cristiana Ciao, sono Madre Teresa, una piccola matita nelle mani di Dio, una povera suora che vive tra i più poveri dei poveri.
ITALIANO. RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati. VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
 ITALIANO UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascoltare e parlare. Conoscenze: Lessico attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Rapporti di significato tra le parole. Natura e funzione delle parole.
ITALIANO UNITA DI APPRENDIMENTO 1 Ascoltare e parlare. Conoscenze: Lessico attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Rapporti di significato tra le parole. Natura e funzione delle parole.
LICEO CLASSICO E MUSICALE A.MARIOTTI PERUGIA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/2019
 LICEO CLASSICO E MUSICALE A.MARIOTTI PERUGIA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/2019 CLASSE: V SEZ.: B MATERIA : ITALIANO Finalità 1. Consolidare le competenze espressive e comunicative (ricchezza e articolazione
LICEO CLASSICO E MUSICALE A.MARIOTTI PERUGIA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2018/2019 CLASSE: V SEZ.: B MATERIA : ITALIANO Finalità 1. Consolidare le competenze espressive e comunicative (ricchezza e articolazione
Natale. Ho tanta stanchezza sulle spalle
 Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
Natale Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto
1.2. Inserisci nel testo le parole che hai trovato con il cruciverba. Le parole sono elencate qui sotto in ordine alfabetico.
 da Caro Michele 1 Attività introduttiva 1.1 Completa il cruciverba. ORIZZONTALI 1 20.000 in lettere. 5 Participio passato del verbo incominciare. 7 Mattina, pomeriggio e 8 Articolo femminile. 9 6 in lettere.
da Caro Michele 1 Attività introduttiva 1.1 Completa il cruciverba. ORIZZONTALI 1 20.000 in lettere. 5 Participio passato del verbo incominciare. 7 Mattina, pomeriggio e 8 Articolo femminile. 9 6 in lettere.
