Equine Herpesviruses 1 & 4: Agenti patogeni economicamente significativi nel cavallo
|
|
|
- Gianpiero Bonelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Equine Herpesviruses 1 & 4: Agenti patogeni economicamente significativi nel cavallo Introduzione P.J. Timoney Department of Veterinary Science 108 Gluck Equine Research Center Lexington, KY , USA Gli herpesvirus attualmente conosciuti nel cavallo sono cinque, due dei quali, l equid herpesvirus 1 (EHV 1) e 4 (EHV 4), entrambi alfaherpesvirus, sono di grandissima importanza medica veterinaria ed economica. Questi virus erano stati precedentemente considerati come varianti o sottotipi di un singolo virus e chiamati rispettivamente sottotipo 1 e sottotipo 2 dell EHV 1. La definizione di questi due virus distinti ma geneticamente ed antigenicamente correlati ha permesso di chiarire i loro rispettivi ruoli nel determinismo della forma respiratoria, abortigena, della polmonite neonatale e meno frequentemente della mieloencefopatia. Ci sono differenze significative nella patogenesi dei ceppi di EHV 1 e di EHV 4. Mentre le infezioni da EHV 4 interessano essenzialmente l epitelio del tratto respiratorio e i linfonodi tributari, i ceppi di EHV 1 prediligono l epitelio vascolare, specialmente a livello di mucosa nasale, polmone, surrene, tiroide e utero e, in caso di ceppi neuropatogeni, anche del SNC. Una viremia leucocito-associata è tipica delle infezioni da EHV 1 ma è rara nelle ifezioni da EHV 4. L herpesvirus equino 1, precedentemente chiamato "virus dell aborto equino", è ampiamente riconosciuto come primariamente responsabile degli aborti a termine. L herpesvirus equino 4, frequentemente chiamato "virus della rinopolmonite equina", d altro canto, è considerato primariamente responsabile delle patologie respiratorie. Nonostante le precedenti generalizzazioni, dovrebbe essere sottolineato che EHV 1 come EHV 4 possono causare patologie respiratorie febbrili acute specialmente nei cavalli giovani. Anche se questi i virus presentano molte glicoproteine di superficie in comune, è possibile differenziare la risposta sierologica verso ogni virus usando un test ELISA tipo-specifico. Distribuzione/Manifestazione della malattia Gli herpesvirus equini 1 e 4 sono ubiquitari ed endemici in varie popolazioni equine nel mondo. Entrambi sono di grande importanza nel causare epidemie di patologie respiratorie in animali giovani. L herpesvirus equino 1 è molto frequentemente implicato in epidemie abortigene in allevamento, alcune delle quali possono essere estensive ("abortion storms") ed economicamente dannose. Altre fonti di perdita economica legate a EHV 1 sono lo stato di malattia e le complicazioni neurologiche presenti in cavalli di ogni età infettatisi con certi ceppi neuropatogeni. La frequenza dell occorrenza dei focolai di mieloencefalopatia sembra essere in aumento negli ultimi anni. Alcuni di questi focolai sono stati associati con un alto tasso di mortalità. Importanza Clinica La patologia respiratoria causata da EHV 1 o da EHV 4 è clinicamente indistinguibile. E caratterizzata da rinofaringite e tracheobronchite. La forma respiratoria clinicamente rilevabile si osserva raramente nei cavalli più vecchi infettati con entrambi i virus. Anche se la maggioranza delle forme respiratorie sono causate da EHV 4, anche alcuni ceppi di EHV 1 possono determinare delle forme simili in puledri svezzati e in cavalli in allenamento di 2 o 3 anni. Spesso alla forma virale è complicata da un infezione batterica secondaria, con lo sviluppo di uno scolo nasale mucoso/mucopurulento e tosse. In assenza di gravi complicazioni batteriche, i cavalli affetti guariscono completamente in poche settimane.
2 La maggior parte dei focolai di aborto da herpesvirus nelle cavalle è il risultato di un infezione da EHV 1. Benchè anche EHV 4 possa causare aborto, questi casi sono infrequenti e sporadici. L aborto è raramente preceduto da segni clinici premonitori. Nella maggior parte dei casi l aborto avviene tra il 7 e l 11 mese di gestazione. I feti abortiti non sono solitamente autolitici al momento dell espulsione e presentano frequentemente lesioni macroscopiche tipiche da herpesvirus. L aborto è l esito di un infezione o di una re-infezione da EHV 1 o 4, o forse di una riattivazione di una infezione latente. Le cavalle esposte al virus in gravidanza molto avanzata possono non abortire e dare alla luce un puledro con infezione congenita che viene a morte entro pochi giorni di vita a causa di una polmonite virale fulminante, frequentemente complicata da un infezione batterica secondaria. E da notare che le cavalle che presentano un aborto da herpesvirus 1 o 4 non presentano conseguenze sulla loro fertilità futura. Focolai di infezione con alcuni stipiti di EHV 1 con proprietà neuropatogene possono essere associate allo sviluppo di una sindrome neurologica o di una mieloencefalopatia in una certa percentuale di cavalli infetti. C è evidenza crescente che i ceppi neuropatogeni di EHV1 siano geneticamente distinti dai ceppi che non hanno queste proprietà. La neuropatogenicità è stata collegata ad una variante della subunità catalitica della polimerasi DNA virale. La sindrome neurologica è stata osservata nelle fattrici in seguito all aborto da EHV1 e anche in cavalli di ogni età, maschi o femmine, nel corso di un focolaio di malattia respiratoria. C è una certa evidenza che, in rare occasioni, alcuni ceppi di EHV4 siano stati associate a sporadici casi di patologia neurologica. La gravità clinica della sindrome neurologica e la prognosi nel caso di singoli individui sono dipendenti dalla localizzazione e dalla severità delle lesioni a livello dell encefalo e del midollo spinale. Il ventaglio di sintomi neurologici nei cavalli affetti si sviluppa in breve tempo dopo la comparsa della malattia. Sebbene alcuni cavalli vadano incontro a guarigione clinica completa in un periodo variabile fra pochi giorni e parecchi mesi, altri possono rimanere con deficit neurologici residui. L infezione con EHV1 è stata anche molto raramente collegata ad una sindrome non-neurologica fatale. Ne sono stati riportati finora solo pochi casi isolati, tutti caratterizzati da vasculite multisistemica, severo edema polmonare, e una variabile entero-tiflocolite. Molto raramente, alcuni ceppi di EHV1 sono stati associati allo sviluppo di lesioni herpetiche sui genitali esterni della fattrice. Epidemiologia Fattori importanti che risultano coinvolti nella epidemiologia delle infezioni da EHV1 e 4 sono: stipiti virali, modalità di trasmissione, stato immunitario dell individuo o di gruppi di cavalli, lo stato di portatore sano, lo stato di gravidanza, e una serie di pratiche gestionali che possono influenzare l incidenza e la gravità della malattia causata da ognuno dei virus. La trasmissione di EHV1 e EHV4 avviene attraverso la via respiratoria attraverso il contatto diretto o indiretto con le secrezioni nasali infette, i feti abortiti, le placente o i liquidi placentari. Entrambi i virus sono molto contagiosi e si diffondono rapidamente fra i soggetti sensibili. E considerata anche la trasmissione transplacentare dei ceppi di EHV1 e, molto meno frequentemente di EHV4. L immunità che consegue all infezione da EHV 1 o EHV 4 è relativamente corta e i cavalli possono essere soggetti a re-infezioni ogni 3-6 mesi. Mentre una immunità crociata molto scarsa si stabilisce in seguito all infezione primaria con entrambi i virus, una immunità crociata significativa viene stimolata da ripetute infezioni con uno o entrambi i virus. Sebbene le reinfezioni siano quasi sempre asintomatiche, una seppur limitata moltiplicazione virale avviene, con diffusione del virus nelle secrezioni respiratorie e, limitatamente ad EHV1, una viremia cellulo-associata. Il cavallo è la riserva naturale di EHV1 e EHV4. E stato dimostrato che lo stato di portatore latente per tutta la vita del cavallo è possibile in entrambe le infezioni. Lo stesso animale può essere portatore di uno o entrambi i virus. I siti di latenza del virus sono i tessuti linforeticolari del tratto respiratorio e i gangli del trigemino. Persistenza del virus si può avere nel 40%-60% dei cavalli che hanno contratto l infezione precedentemente. Fattori estrinseci o intrinseci che determinano stress nel cavallo possono risultare in riattivazione del virus, viremia e eliminazione virale attraverso il tratto respiratorio. Prevention & Control
3 Una effettiva prevenzione per le infezioni da EHV 1 and EHV 4 pone una varietà di sfide. L adozione di pratiche di gestione corrette in combinazione con un programma regolare di vaccinazione profilattica dei soggetti, sono le chiavi di ogni riuscito programma di controllo delle malattie. Attività correlate alla gestione che possano ridurre il rischio di introduzione dell infezione includono il ridurre al minimo le circostanze o le pratiche che sono stressanti per gruppi di cavalli: sovraffollamento, trasporto per lunghe distanze, vaccinazione o il mischiare cavalli di diversa provenienza, sono esempi di fattori di stress estrinseci. La riduzione dello stress riduce il rischio di riattivazione dell infezione latente nei soggetti portatori. L importanza dell isolamento di tutti I cavalli al loro arrivo per un periodo di almeno 3-4 settimane non dovrebbe essere trascurato. Le cavalle gravide dovrebbero essere divise in gruppi piccoli lontano da altri cavalli, come puledri svezzati o cavalli in allenamento, e mantenute negli stessi gruppi fino al parto. Ove possibile, le fattrici primipare non dovrebbero essere mischiate con quelle pluripare piu anziane. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle fattrici con puledro, che possono essere fonte di infezione, introdotte ex novo in un ambiente dove sono presenti cavalle gravide. Sono disponibili sia il vaccino a virus vivo modificato che a virus inattivato, alcuni contengono i ceppi di entrambi i virus EHV1-4. Purtroppo, la ampiezza e la durata dell immunità vaccinale sono scarse. I vaccini disponibili, sebbene non proteggano in toto contro la malattia, riducono la gravità dei sintomi clinici, la durata dell eliminazione virale, e la quantità di virus eliminato. La vaccinazione, se correttamente impiegata, riduce il rischio di aborto e di malattia respiratoria. Al momento attuale, non ci sono vaccini disponibili che si possano considerare protettivi verso gli stipiti neuropatogeni di EHV1. Deve essere enfatizzato che tutte le categorie di cavalli presenti sullo stesso luogo dovrebbero essere inclusi in un regolare programma di vaccinazione contro EHV1 e EHV4. La cosa più importante però in ogni programma di controllo e prevenzione è l accettazione del principio che la vaccinazione per se non è un sostituto efficace all osservanza di pratiche gestionali corrette.. Virus West Nile: l esperienza Nord Americana P.J. Timoney, Gluck Equine Research Center Lexington, KY, USA Grugliasco 29/4/2005 Introduzione Il virus West Nile (WNV) deve il suo nome alla regione ugandese West Nile, dove fu isolato per la prima volta nel 1937 dal sangue di una donna in fase febbrile. E un Arbovirus ( Artropode born ), che si trasmette principalmente attraverso diverse specie di insetti. Prima della sua iniziale scoperta nella città di New York nell estate del 1999, WNV non era mai stato segnalato in America. Per molti anni è stato considerato il membro della famiglia virale Flaviviridae maggiormente diffuso nel vecchio mondo; era infatti segnalato in Africa, Medio Oriente, Asia sud-occidentale ed in alcuni paesi europei. A cinque anni dalla sua introduzione negli Stati Uniti nord-orientali, WNV ha dimostrato una grande adattabilità. E stata infatti provata la sua grande capacità di superare i mesi freddi (overwintering) senza attività vettoriale, e di adattarsi ad una ampia gamma di ospiti vertebrati ed invertebrati. Non è stata solo confermata la sua importanza come patogeno umano ed equino, ma si è dimostrata la sua alta patogenicità per una grande varietà di specie di uccelli selvatici liberi o tenuti in cattività. Nell arco di pochi anni, WNV è diventato endemico nella maggior parte degli Stati Uniti (47 stati su 50) diffondendosi anche in Canada, Messico ed in un numero crescente di paesi del centro america e dei Caraibi. E molto probabile che con il tempo WNV si diffonderà nella maggior parte dell emisfero occidentale, analogamente a quanto avvenuto in passato in altre parti del mondo. Eziologia Il virus West Nile è un membro della famiglia Flaviviridae, genere flavivirus, gruppo antigenico dell encefalite giapponese, che include molti altri importanti agenti patogeni dell uomo e del cavallo, in particolare i virus dell encefalite di St. Louis, encefalite giapponese ed encefalite della Murray valley. Allo stato attuale, tre membri di questo gruppo di agenti sono stati segnalati in Europa: WNV, Usutu virus e Rabensburg virus, dei quali WNV risulta patogeno per uomo e cavallo. Sulla base delle analisi
4 filogenetiche del gene codificante per la glicoproteina E dell envelope, gli stipiti di WNV vengono classificati in due genotipi, 1 e 2; membri del genotipo 1 sono stati identificati in corso di focolai di encefalite WN in uomo, cavallo ed uccelli in Europa e Nord America; stipiti appartenenti al genotipo 2 sono stati isolati in Africa e Madagascar ma non rappresentano importanti patogeni in mammiferi od uccelli. Importanza clinica Il virus West Nile è visto con crescente interesse quale agente di zoonosi. Focolai di encefalite WN nell uomo sono stati segnalati in Algeria, Canada, Francia, Israele, Marocco, Romania, Russia, Sudafrica e Stati Uniti. I sintomi clinici dell infezione variano da una infezione in apparente, ad una lieve forma febbrile, fino ad una malattia grave e morte. L indice di morbilità e mortalità sono maggiori in persone anziane o giovani. Sono state osservate una varietà di sindromi cliniche, incluso encefalite, mielite, meningoencefalite, miocarditi, pancreatite, epatite, e disturbi gastrointestinali. Storicamente, prima dell introduzione di WNV in USA, i focolai di malattia nell uomo hanno avuto una frequenza non prevedibile. Nei cavalli, l infezione da WNV è subclinica nella maggior parte dei casi. Focolai di malattia sono stati segnalati in popolazioni equine in Egitto, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Canada e Stati Uniti. Focolai localizzati si possono presentare con morbilità e mortalità elevata. I casi clinici nel cavallo si presentano spesso come una poliomielite o encefalomielite. I cavalli infetti possono presentare febbre, atassia, disturbi del comportamento, paralisi dell anca, fascicolazioni muscolari, paresi/paralisi degli arti posteriori, quadriplegia, decubito e morte. La percentuale di casi mortali nei focolai segnalati in USA variava dal 32% al 45%. Al di la dell impatto che WNV da avuto sull uomo e su popolazioni di animali domestici e selvatici in USA dal 1999, va ricordato l effetto devastante che il virus ha avuto su una grande varietà di uccelli selvatici o in cattività. Grandi perdite si sono avute nei corvi e in altri membri della famiglia corvidae, con percentuali di mortalità che variavano fra l 85% ed il 95%. Oltre al cavallo, il cane rappresenta l altra specie di animali domestico che può infettarsi con il WNV. Nonostante l encefalite sia stata osservata in un piccolo numero di casi, i cani sono sensibili al virus e l infezioni può esitare in una forma severa di malattia ed anche la morte. Epidemiologia Retrospettivamente vi sono evidenze di un cambiamento dell epidemiologia globale del virus WN da metà degli anni novanta. Ciò si riflette con un aumento del numero di focolai nell uomo e nel cavallo e dalla emergenza di tale virus come patogeno aviare in alcuni paesi. La gravità della malattia nell uomo e nel cavallo è andata aumentando. Elevati tassi di morbilità e mortalità negli uccelli sono stati registrati associati recentemente in USA, Canada e Israele. Il VWN è mantenuto in natura dal ciclo uccelli/insetti vettori. Il ciclo di trasmissione naturale del virus può coinvolgere una ampia varietà di ospiti vertebrati, con specie di uccelli selvatici, specialmente della famiglia dei passeriformi, che giocano un ruolo principale per la sua amplificazione e diffusione. Dalla sua iniziale scoperta in USA nel 1999, evidenze dell infezione sono state confermate in almeno 284 specie di uccelli (domestici ed esotici), 34 specie di mammiferi e 2 specie di rettili. Una ampia gamma di insetti ( generi Culex, Ochlerotatus, Stegomyia, Aedes e Anopheles) possono fungere da vettori biologici. Sebbene VWN sia stato isolato da zecche, queste ultime sembrano rivestire un ruolo marginale nella trasmissione del virus. Non potrà mai essere dimostrato come il VWN sia giunto in Nord America. Si ipotizza che potrebbe essere arrivato con gabbie per uccelli contaminate dal medio oriente, attraverso vettori all interno di container o attraverso uccelli migratori viremici provenienti dall Africa occidentale attraverso l oceano Atlantico. E opportuno notare che gli isolato di WNV in New York nel 1999 era geneticamente virtualmente identico ad uno stipite isolato da una oca domestica in Israele del Da un piccolo focolaio iniziale nel nord est degli Stati Uniti nel 1999, WNV si è diffuso lungo la costa orientale nel 2000, estendendosi a sud, fino in Florida e ad ovest fino in Iowa nel Dal 2002, il virus si è diffuso in tutti gli stati continentali degli USA tranne 5, estendendosi successivamente nei mesi successivi lungo tutto il paese ad eccezione dell Alaska e delle Hawaii
5 Impatto sulla salute umana ed equina WNV ha assunto una notevole importanza sulla salute umana ed equina dalla sua prima introduzione nel Il numero di casi confermati di infezione nell uomo è variato da 62 casi nel 1999 fino ad un picco di 9858 casi nel 2003, scendendo nel 2004 a 2470 casi. No. of cases gerc 3/05 Figura 1: Casi confermati di infezione da virus WN nell uomo in USA ( ) La situazione del cavallo mostra un andamento simile, con 25 casi confermati nel 1999, un aumento nel 2002 con casi ed una diminuzione nel 2004 con 1341 casi No. of cases gerc 3/05 Figura 2: Casi confermati di infezione da virus WN nel cavallo in USA ( ) Diagnosi In virtù della notevole variabilità dei segni clinici manifestati da cavalli infetti da WNV, non è possibile basare una diagnosi di questa infezione solo su base clinica. Esistono infatti un ampia gamma di malattie del cavallo di origine infettiva e non che possono essere prese in considerazione per una diagnosi differenziale. Un sospetto clinico deve quindi essere confermato da accertamenti di laboratorio. Su animali vivi, il test ELISA per la ricerca di IgM ed IgG specifiche ed il test di sieroneutralizzazione si sono dimostrati utili per la conferma della diagnosi. Nella diagnostica post-mortem, i test di elezione sono la RT-PCR (amplificazione genica) su tessuto cerebrale o liquido cefalo rachidiano, l isolamento virale su colture di tessuto o topini neonati, la ricerca dell antigene virale mediante immunoistochimica su sezioni di tessuto cerebrale. Prevenzione e Controllo
6 Misure preventive che possono essere considerate per ridurre l impatto economico del WNV sulla economia equina si basano sulla riduzione del rischio di esposizione dei cavalli verso gli insetti vettori ed implementando un regolare programma di vaccinazione contro WNV. La lotta agli insetti vettori viene attuata mediante uso di disinfestanti specialmente all interno ed in vicinanza di aree ad elevata densità equina. E importante ridurre il rischio di esposizione attraverso il ricovero notturno dei cavalli all interno delle scuderie ed utilizzando repellenti sugli animali. Attualmente sono disponibili vaccini per i cavalli sicuri ed efficaci da utilizzare nelle aree endemiche su base annuale, effettuando uno o più richiami prima o durante la stagione di maggiore densità di insetti vettori. La vaccinazione si è dimostrata molto efficace nel ridurre l incidenza delle forme cliniche se utilizzata secondo il protocollo di immunizzazione raccomandato. L esperienza maturata dal 1999 ha chiaramente dimostrato che WNV si è adattato con successo ad un ampio range di ecosistemi negli Stati Uniti. Non sono è diventato endemico nel paese, ma si è diffuso in altri stati dell emisfero occidentale. Nei cinque anni dalla sua introduzione, è stato responsabile delle principali epidemie nell uomo, nei cavalli e in diverse specie di uccelli con tassi significativi di morbilità e mortalità. Fortunatamente gli anni dei picchi epidemici sembrano passati e le perdite nella popolazione equina del paese possono essere ridotte in futuro attraverso l adozione di misure appropriate di prevenzione e controllo. Introduzione Arterite Virale Equina : Aspetti Caratteristici di una Patologia Frequentemente Incompresa P.J. Timoney Department of Veterinary Science 108 Gluck Equine Research Center Lexington, KY , USA Per alcuni proprietari di cavalli, allevatori e veterinari, l arterite virale equina o EVA come è chiamata più comunemente, rappresenta una malattia che può avere conseguenze disastrose per l industria equina. E percepita come un affezione seria e potenzialmente mortale in una percentuale di cavalli colpiti. L agente eziologico, il virus dell arterite virale equina (EAV), che è un RNA virus appartenente al genere Arterivirus, famiglia Arteriviridae, è considerato capace di diffondersi rapidamente nella popolazione di equini suscettibili e si pensa che sia un importante causa di aborto nelle fattrici gravide. Sorprendentemente all interno dell industria equina in pochi conoscono effettivamente il significato medico veterinario reale dell infezione e la natura e l estensione dell impatto economico. L Arterite virale equina è la malattia virale che colpisce i membri della famiglia equina che più frequentemente viene diffusa per contatto diretto con un individuo affetto dalla forma acuta. Molti cavalli esposti al virus EAV per la prima volta, tuttavia, non manifestano la forma clinica. Questa forma di infezione asintomatica rappresenta la maggioranza dei casi che si verificano naturalmente. Solo i cavalli che sviluppano la sindrome o alcuni segni clinici caratteristici dell infezione con EVA possono essere considerati bona fide casi di EVA. Tra i più importanti virus capaci di infettare l apparato respiratorio del cavallo, l EVA tipicamente non è contagioso come I virus dell influenza equina o gli Herpesvirus 1 e 4. Inoltre, si differenzia dagli ultimi per la sua abilità di diffondersi sia per via venerea che per via aerogena attraverso il contatto con il seme infetto o le secrezioni del tratto riproduttivo di una fattrice affetta dalla forma acuta. Identificato la prima volta come una patologia eziologicamente distinta del cavallo in occasione di un grosso focolaio di malattie respiratorie e aborti presso un allevamento di Trottatori vicino a Bucyrus, Ohio in 1953, EVA ha colpito popolazione equine in varie parti del mondo per un periodo molto lungo di tempo. Per anni dopo il primo isolamento dell agente causale, l EVA ha attirato poco l attenzione internazionale. Questo atteggiamento è cambiato radicalmente, tuttavia, in seguito ad una grossa epidemia che ha interessato numerosi allevamenti di Purosangue Inglese nello stato del Kentucky nel In quella occasione la paura dilagante era che un ceppo piu patogeno del virus dell EAV fosse stato selezionato, e potesse essere disseminato in modo diffuso provocando focolai estesi e economicamente rovinosi di arterite, incluse le epidemie di aborti negli equini non protetti. La comunità
7 internazionale equina rispose rapidamente di fronte alla percezione di questa minaccia e impose rigorose restrizioni all importazione di equini infetti o vaccinati contro questa patologia. L esperienze successive hanno mostrato che le paure e le attenzioni di molti nel settore equino a questo proposito erano infondate. Il virus dell Arterite virale non diventò ampiamente prevalente nel Purosangue o in altre razze equine come era avvenuto nell epidemia del Kentucky del 1984, nè ci fu un aumento della frequenza degli aborti da EVA. Distribuzione del Virus/Manifestazione delle malattia La presenza dell infezione da EAV si è trovata nella maggior parte delle popolazioni equine nelle quali si è cercata, in tutto il mondo. Eccezioni degne di nota sono il Giappone e l Islanda, entrambe confermate esenti dal virus. Gli ultimi 20 anni hanno visto un aumento delle epidemie registrate di EAV, quasi tutte avvenute in Nord America ed Europa. In parte questo riflette una maggiore conoscenza dell EAV, una migliore capacità di controllo, e migliorate tecniche di laboratorio in grado di diagnosticare la malattia. Inoltre questo aumento è stato anche influenzato da un considerevole aumento del commercio internazionale di equini e seme equino e da una maggiore diffusione dell utilizzo dell inseminazione artificiale in questo periodo di tempo. Sebbene molta della notorietà che circonda l EAV si riferisce alla manifestazione della malattia nei cavalli in riproduzione, esiste anche il potenziale per una ampia e diffusa trasmissione dell EAV con presenza di focolai di EAV in popolazioni suscettibili di animali concentrati in spazi delimitati come ippodromi,eventi sportivi,ecc Stranamente, finora, situazioni di questo tipo si sono manifestate piuttosto infrequentemente. Significato Clinico Il vero significato clinico dell EVA è ancora fonte di notevole confusione per molte persone coinvolte nell industria del cavallo. Descrizioni della malattia in vecchi testi di medicina veterinaria che riportano un tasso di mortalità del 40-60% non hanno alcuna relazione con ciò che succede nel corso di epidemie naturali di arterite virale. Tali precedenti descrizioni si basavano su studi mirati effettuati con delle varianti altamente patogene derivate sperimentalmente dal ceppo di referenza Bucyrus del virus. Un ceppo virale di tale patogenicità non è mai stato isolato da una situazione di campo. In realtà, la mortalità è una sequela molto infrequente nelle infezioni da EAV. A parte l essere stato identificato come agente causale di morte fetale e aborto nelle cavalle gravide, il virus è causa non comune di polmonite fulminante o pneumoenterite nei puledri neonati o nei puledri fino ad alcuni mesi di vita. Deve essere ri-enfatizzato che la vasta maggioranza di casi di infezione da EAV è asintomatica. Dove si manifesta la sintomatologia clinica, i cavalli colpiti, quasi invariabilmente hanno un decorso della malattia con totale recupero anche senza trattamento sintomatico. Il virus dell Arterite virale è stato riconosciuto come agente abortigeno per molti anni. Percentuali di aborti dal 10% anche fino all 80% sono state registrate in alcuni focolai di infezione naturali o in studi sperimentali. Paradossalmente, EAV non è una causa frequentemente confermata di aborto equino, nonostante la sua ampia distribuzione in alcune razze equine in determinate regioni e il potenziale abortigeno di alcuni ceppi virali. Un altra fonte di confusione riguarda la via e il tempo di esposizione delle fattrici all EAV e il potenziale manifestarsi dell aborto. Le fattrici infatti devono essere già gravide al momento del contagio affinché sopravvenga l aborto sia alla fine della fase acuta che all inizio della fase di convalescenza dell infezione. La situazione tipica in cui si può verificare una simile circostanza è quando una fattrice non protetta viene servita con uno stallone eliminatore e inavvertitamente portata al pascolo con una o più cavalle gravide suscettibili all infezione. Quest ultima verrà esposta al virus attraverso contatto diretto con le secrezioni respiratorie nebulizzate infettive della cavalla recentemente coperta, infettata in modo acuto. Non c è evidenza che fattrici coperte con seme EAV infetto possano ospitare il virus per un periodo di settimane o mesi e abortire ad uno stadio più tardivo della loro propria gravidanza Epidemiologia L epidemiologia dell EVA è influenzata da una serie di fattori correlati al virus, all ospite e all ambiente. Fra quelli considerati importanti c è la variazione nella patogenicità e altre in proprietà
8 fenotipiche fra i ceppi che si manifestano naturalmente, modalità di trasmissione durante le fasi acuta e cronica dell infezione, il verificarsi dello stato di eliminatore nello stallone, la natura e la longevità dell immunità acquisita all infezione, le tendenze economiche con l industria equina. (and economic trends with the horse industry). Focolai di EVA sono più frequentemente associati alla movimentazione dei cavalli o all uso di seme infetto, fattori direttamente implicati nella diffusione internazionale dell EVA in numerose occasioni negli anni recenti. Lo stallone portatore sano Lo stato di portatore sano per l EVA è stato dimostrato solo nello stallone o nel puledro maschio post-puberale in cui lo stabilirsi e permanere del virus è stato dimostrato essere androgeno-dipendente. Molti studi sia di campo che sperimentali hanno confermato che lo stallone portatore sano è la riserva naturale del virus. Lo stallone cronicamente infetto ospita il virus in alcune delle ghiandole sessuali accessorie dalle quali è rilasciato nel seme al momento dell eiaculazione. Se lo stallone portatore elimini il virus dell EVA costantemente o in modo intermittente è stata causa di alcune controversie. Alcuni sostengono che determinati stalloni sono eliminatori intermittenti, specialmente fuori dalla stagione di monta quando il livello di testosterone circolante può essere ridotto. Nessuna dimostrazione convincente tuttavia è stata fornita finora per supportare questa teoria. Dall altra parte ci sono molti dati sia di campo che sperimentali che dimostrano che gli stalloni portatori sani sono eliminatori costanti di seme dell EVA, anche durante la stagione non riproduttiva. Gli stalloni portatori non presentano il rischio di trasmissione dell infezione se non attraverso la monta. La disseminazione del virus può quindi avvenire solo per via venerea o attraverso materiali contaminati dal virus. La persistenza del virus EVA nel tratto riproduttivo dello stallone non sembra determinare effetti negativi sullo stato generale di salute ne sulla fertilità dello stesso. Una percentuale variabile di stalloni portatori sani eliminano il virus spontaneamente dai loro organi e cessano di essere portatori. Tali individui non si sono mai visti tornare allo stato di eliminatore in un periodo successivo della loro carriera di riproduttore. Importanza Economica Perdite economiche che derivano da un infezione da EVA comprendono quelle legate a : 1) Focolai di aborti e morte di puledri giovani; 2) Diminuzione delle prestazioni agonistiche durante focolai che avvengono negli ippodromi o durante eventi equestri; 3) Diminuzione del valore commerciale degli stalloni portatori sani 4) mercati di esportazione vietati per stalloni eliminatori e seme EVA-infetto e, in alcuni paesi, per ogni cavallo sierologicamente positivo per anticorpi al virus EVA.; 5) Ridotta domanda commerciale per la monta con stalloni eliminatori. Le conseguenze economiche date dai focolai di aborto e dalla perdita dei mercati di esportazione per gli stalloni eliminatori e il seme infetto hanno un grosso impatto economico sull industria equina. Prevenzione & Controllo L Arterite virale equina si può sia prevenire che controllare. Lo scopo degli attuali programmi di controllo è di ridurre la diffusione di EVA nei soggetti in allevamento, con l obiettivo di prevenire eventuali epidemie di aborto virale o la malattia e la morte dei giovani puledri ed evitare lo stabilirsi dello stato di portatore nello stallone e nel puledro maschio post-puberale. Sebbene l EAV abbia raramente causato focolai estesi di infezione in ippodromi, aste e altre manifestazioni ippiche dove i cavalli fossero concentrati in piccoli spazi, nessun programma è stato mai messo in atto per prevenire la disseminazione del virus in tali situazioni. L esperienza ottenuta in seguito all epidemia di EVA del 1984 in Kentucky ha sottolineato il significato di una corretta gestione pratica unita ad un programma prestabilito di vaccinazione, nell ottenimento del controllo della malattia. Di importanza rilevante nell assicurare il
9 successo di ogni programma di controllo contro questa patologia è il ridurre al minimo o eliminare il contatto diretto o indiretto di individui suscettibili con animali infetti. Di grande aiuto nel facilitarne il controllo è la disponibilità di vaccini sicuri e efficaci contro il virus EVA. Un vaccino inattivato, adiuvato è approvato ad uso commerciale in un numero limitato di paesi della CEE. E altamente raccomandato che tutti gli stalloni usati a fini riproduttivi siano rivaccinati annualmente contro l EVA, sia per ottenere protezione clinica che per prevenire lo stabilirsi dello stato di portatore. Puledri maschi immaturi sessualmente fra i 6 e i 12 mesi di età dovrebbero essere immunizzati per le stesse ragioni. In vista del rischio potenziale di introdurre l EVA in un un allevamento attraverso seme infetto, è importante stabilire lo stato virologico del seme usato per l inseminazione artificiale, specialmente se importato dall estero. Uno sforzo maggiore sarà richiesto dalle associazioni di allevatori, ai veterinari e agli ufficiali sanitari affinchè molta dell ignoranza e della disinformazione che ancora prevale sull Arterite virale equine possa essere eliminata.
West Nile Disease. Seminario 20 maggio LINK nile/emergenze.htm Raffaella Baldelli DSPVPA
 West Nile Disease Seminario 20 maggio 2009 LINK http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_ nile/emergenze.htm Cenni storici 1937: 1 isolamento nel distretto di West Nile, Uganda, da una donna con sintomatologia
West Nile Disease Seminario 20 maggio 2009 LINK http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_ nile/emergenze.htm Cenni storici 1937: 1 isolamento nel distretto di West Nile, Uganda, da una donna con sintomatologia
LE VACCINAZIONI DEL CAVALLO
 LE CONOSCENZE VETERINARIE ARRICCHISCONO L ALLEANZA RELAZIONALE UOMO-ANIMALE VERONA, FIERCAVALLI 6 Novembre 2015 LE VACCINAZIONI DEL CAVALLO Marco Martini Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e
LE CONOSCENZE VETERINARIE ARRICCHISCONO L ALLEANZA RELAZIONALE UOMO-ANIMALE VERONA, FIERCAVALLI 6 Novembre 2015 LE VACCINAZIONI DEL CAVALLO Marco Martini Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive
 Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive INFEZIONE MALATTIA INFETTIVA ASPETTI GENERALI Interazione di un agente biologico (microrganismo) e un ospite recettivo (uomo, animale). Implica
Alda Natale - Soave, 30 novembre 2010
 Febbre Q -Uomo Estrema virulenza Bastano 1-10 particelle per avviare l infezione Alta concentrazione nei tessuti infetti (annessi fetali), nei secreti (latte) e negli escreti (feci, urine) No associazione
Febbre Q -Uomo Estrema virulenza Bastano 1-10 particelle per avviare l infezione Alta concentrazione nei tessuti infetti (annessi fetali), nei secreti (latte) e negli escreti (feci, urine) No associazione
Influenza Aviaria. La malattia
 1 INFLUENZA AVIARIA La malattia Influenza Aviaria L influenza aviaria è causata da virus appartenenti alla famiglia Orthomyxoviridae, genere Influenzavirus A. Si distinguono stipiti a bassa patogenicità
1 INFLUENZA AVIARIA La malattia Influenza Aviaria L influenza aviaria è causata da virus appartenenti alla famiglia Orthomyxoviridae, genere Influenzavirus A. Si distinguono stipiti a bassa patogenicità
Il Controllo Ufficiale della riproduzione animale Franco Corrias. La gestione degli accertamenti diagnostici
 Il Controllo Ufficiale della riproduzione animale Franco Corrias La gestione degli accertamenti diagnostici Empoli, Mercoledì 11 Novembre 2015 IL CONTROLLO UFFICIALE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE la gestione
Il Controllo Ufficiale della riproduzione animale Franco Corrias La gestione degli accertamenti diagnostici Empoli, Mercoledì 11 Novembre 2015 IL CONTROLLO UFFICIALE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE la gestione
Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE
 Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE Blue tongue - 2015 In data 21 Agosto 2015 è stato segnalato un sospetto clinico di BT in un allevamento nella regione di Allier, nella Francia
Blue tongue aggiornamenti epidemiologici LEBANA BONFANTI IZSVE Blue tongue - 2015 In data 21 Agosto 2015 è stato segnalato un sospetto clinico di BT in un allevamento nella regione di Allier, nella Francia
Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia. Epidemiologia delle malattie infettive
 Obiettivi dell igiene CONTENUTI CORSO DI Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia Epidemiologia delle malattie infettive IGIENE Catena di contagio, sorgenti e serbatoi di infezione,
Obiettivi dell igiene CONTENUTI CORSO DI Definizione ed obiettivi dell Igiene. Concetto di salute e malattia Epidemiologia delle malattie infettive IGIENE Catena di contagio, sorgenti e serbatoi di infezione,
Bollettino epidemiologico 2016
 Bollettino epidemiologico 2016 1 Situazione epidemiologica 2 Piano di sorveglianza 3 Risultati delle attività di sorveglianza 4 Definizione di caso negli equidi 28 luglio 2016 n. 4 1 Situazione epidemiologica
Bollettino epidemiologico 2016 1 Situazione epidemiologica 2 Piano di sorveglianza 3 Risultati delle attività di sorveglianza 4 Definizione di caso negli equidi 28 luglio 2016 n. 4 1 Situazione epidemiologica
Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
 Scuola di Specializzazione di atologia suina Situazione attuale della Malattia di Aujeszky Salone polifunzionale S. Giovanni Moretta (TO) 23 ovembre 2007 Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
Scuola di Specializzazione di atologia suina Situazione attuale della Malattia di Aujeszky Salone polifunzionale S. Giovanni Moretta (TO) 23 ovembre 2007 Eziologia e diagnosi della malattia di Aujeszky
SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA
 SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale
SCHMALLENBERG: DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI CONTROLLO IN ITALIA MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL ASL DI BRESCIA. - anno 2010 -
 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL ASL DI BRESCIA - anno 2010 - Malattie infettive nell ASL di Brescia anno 2010- Pag. 1 MALATTIE INFETTIVE NELL ASL DI BRESCIA - ANNO 2009 - L attività
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL ASL DI BRESCIA - anno 2010 - Malattie infettive nell ASL di Brescia anno 2010- Pag. 1 MALATTIE INFETTIVE NELL ASL DI BRESCIA - ANNO 2009 - L attività
per alcune malattie causate da prodotti tossici dell agente (ad es. tossine batteriche) non si può parlare di trasmissibilità Raffaella Baldelli DSMV
 Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
il rapporto sessuale è la via preminente di contagio sono guaribili (eccetto AIDS ed epatite C) se vengono riconosciute il più presto possibile
 LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE il rapporto sessuale è la via preminente di contagio sono guaribili (eccetto AIDS ed epatite C) se vengono riconosciute il più presto possibile alcune possono essere
LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE il rapporto sessuale è la via preminente di contagio sono guaribili (eccetto AIDS ed epatite C) se vengono riconosciute il più presto possibile alcune possono essere
L efficacia dei sistemi di sorveglianza
 L efficacia dei sistemi di sorveglianza Dr. Angelo Ferrari IZS Piemonte, Liguria e Valle d'aosta 9 Giugno 2010 Migliorare con l esperienza La pandemia influenzale A (H1N1) 2009: Modello di gestione delle
L efficacia dei sistemi di sorveglianza Dr. Angelo Ferrari IZS Piemonte, Liguria e Valle d'aosta 9 Giugno 2010 Migliorare con l esperienza La pandemia influenzale A (H1N1) 2009: Modello di gestione delle
IL MORBILLO. Morbillo. Morbillo
 IL MORBILLO Ufficio del medico cantonale Ufficio del medico Servizio cantonale di medicina scolastica Morbillo Malattia virale virus della famiglia dei Paramyxovirus, genere Morbillivirus serbatoio = uomo
IL MORBILLO Ufficio del medico cantonale Ufficio del medico Servizio cantonale di medicina scolastica Morbillo Malattia virale virus della famiglia dei Paramyxovirus, genere Morbillivirus serbatoio = uomo
per alcune malattie causate da prodotti tossici dell agente (ad es. tossine batteriche) non si può parlare di trasmissibilità Raffaella Baldelli DSMV
 Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
Malattie trasmissibili Malattie sostenute da un agente biologico (agente eziologico), che si trasmette da un individuo ad un altro (ospiti) in natura in modo diretto o indiretto per alcune malattie causate
West Nile Disease. Situazione epidemiologica. N Ottobre 2008 ore 17:00
 West Nile Disease N. 13 7 Ottobre 2008 ore 17:00 Situazione epidemiologica 7 Ottobre 2008 Ad oggi sono stati segnalati 20 cavalli che hanno avuto sintomatologia clinica riferibile a West Nile disease (WND)
West Nile Disease N. 13 7 Ottobre 2008 ore 17:00 Situazione epidemiologica 7 Ottobre 2008 Ad oggi sono stati segnalati 20 cavalli che hanno avuto sintomatologia clinica riferibile a West Nile disease (WND)
Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA
 Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA Il sistema di sorveglianza nazionale - dal 2005 D.M. del 14 ottobre 2004: a partire dal 1 gennaio 2005, l infezione
Sistema di sorveglianza nazionale della ROSOLIA IN GRAVIDANZA e della ROSOLIA CONGENITA Il sistema di sorveglianza nazionale - dal 2005 D.M. del 14 ottobre 2004: a partire dal 1 gennaio 2005, l infezione
IL CONCETTO DI ZOONOSI CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI. Zoonosi dirette. Ciclozoonosi. Metazoonosi. Saprozoonosi
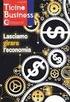 IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
IL CONCETTO DI ZOONOSI Malattie ed infezioni che si trasmettono naturalmente dagli animali vertebrati all uomo e viceversa (O.M.S.) CLASSIFICAZIONE DELLE ZOONOSI Zoonosi dirette Trasmissione dall animale
PESTE SUINA CLASSICA
 PESTE SUINA CLASSICA Caratteristiche della patologia Informazioni E.1 Malattia E.1.1 Nome patologia Peste Suina Classica (Classical Swine Fever). E.1.2 Agente/i eziologico/i Flavivirus. E.1.3 Breve descrizione
PESTE SUINA CLASSICA Caratteristiche della patologia Informazioni E.1 Malattia E.1.1 Nome patologia Peste Suina Classica (Classical Swine Fever). E.1.2 Agente/i eziologico/i Flavivirus. E.1.3 Breve descrizione
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014
 AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014 MORBILLO Il presente rapporto mostra i risultati del Sistema di Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia
AGGIORNAMENTO SULL ANDAMENTO DEL MORBILLO IN EMILIA-ROMAGNA 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2014 MORBILLO Il presente rapporto mostra i risultati del Sistema di Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia
Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte-
 Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte- Dr. Enrico Francione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Folgaria, 04-03-2015 Vet Neve - La diarrea virale del bovino (BVD-MD) è una
Il Piano BVD in provincia di Trento -Stato dell arte- Dr. Enrico Francione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Folgaria, 04-03-2015 Vet Neve - La diarrea virale del bovino (BVD-MD) è una
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni )
 Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2005) Prefazione Il sistema di notifica della tubercolosi, elemento indispensabile al programma di controllo della malattia stessa, ha tra gli obiettivi
Bordetellosi. Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II
 Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II Patologia infettiva altamente contagiosa che colpisce prevalentemente il tacchino EZIOLOGIA Inizialmente identificato
Prof. Alessandro FIORETTI Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II Patologia infettiva altamente contagiosa che colpisce prevalentemente il tacchino EZIOLOGIA Inizialmente identificato
Marco Martini Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova ARTERITE VIRALE EQUINA
 Marco Martini Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova ARTERITE VIRALE EQUINA A. V. E. - Malattia virale caratterizzata da sintomatologia respiratoria, edemi sottocutanei,
Marco Martini Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova ARTERITE VIRALE EQUINA A. V. E. - Malattia virale caratterizzata da sintomatologia respiratoria, edemi sottocutanei,
INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA
 VARICELLA SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA VARICELLA? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA RICORDA CHE: La varicella contratta in età adulta può comportare
VARICELLA SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA VARICELLA? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA RICORDA CHE: La varicella contratta in età adulta può comportare
CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER
 CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER Crimean-Congo haemorrhagic fever Riconosciuta per la prima volta in Crimea nel 1944, poi più tardi in Congo nel 1969. Infezione virale di ruminanti ed erbivori domestici
CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER Crimean-Congo haemorrhagic fever Riconosciuta per la prima volta in Crimea nel 1944, poi più tardi in Congo nel 1969. Infezione virale di ruminanti ed erbivori domestici
Le malattie emergenti correlate ai flussi migratori
 Le malattie emergenti correlate ai flussi migratori XVIII Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale Sanitario C.R.I. Verona 22 25 settembre 2016 Cenni Storici La dimensione del fenomeno
Le malattie emergenti correlate ai flussi migratori XVIII Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale Sanitario C.R.I. Verona 22 25 settembre 2016 Cenni Storici La dimensione del fenomeno
14/04/2014. EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, nm sprovvisto di envelope molto resistente
 Malattia Vescicolare del Suino EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, 28-30 nm sprovvisto di envelope molto resistente 1 sierotipo 4 gruppi Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Il virus
Malattia Vescicolare del Suino EZIOLOGIA Fam. Picornaviridae gen. Enterovirus RNA 1, 28-30 nm sprovvisto di envelope molto resistente 1 sierotipo 4 gruppi Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Il virus
VIRUS terminologia 2
 1 VIRUS terminologia 2 invasività capacità di un microrganismo a superare i dispositivi di difesa dell'ospite e moltiplicarsi attivamente in essi. virulenza attitudine a realizzare danno tissutale. patogenicità
1 VIRUS terminologia 2 invasività capacità di un microrganismo a superare i dispositivi di difesa dell'ospite e moltiplicarsi attivamente in essi. virulenza attitudine a realizzare danno tissutale. patogenicità
Epatite infettiva del cane (Malattia di Rubarth, Rubarth 1947)
 Epatite infettiva del cane (Malattia di Rubarth, Rubarth 1947) Causata dall adenovirus canino tipo (CAdV1) antigenicamente correlato all adenovirus canino tipo 2 (CAdV2) responsabile di infezioni respiratorie
Epatite infettiva del cane (Malattia di Rubarth, Rubarth 1947) Causata dall adenovirus canino tipo (CAdV1) antigenicamente correlato all adenovirus canino tipo 2 (CAdV2) responsabile di infezioni respiratorie
LA BIOSICUREZZA. nell allevamento equino
 LA BIOSICUREZZA nell allevamento equino CONCETTI INIZIALI Biosicurezza: evitare l introduzione di agenti patogeni Biocontenimento: limitare il diffondersi di agenti patogeni Legame stretto tra questi due
LA BIOSICUREZZA nell allevamento equino CONCETTI INIZIALI Biosicurezza: evitare l introduzione di agenti patogeni Biocontenimento: limitare il diffondersi di agenti patogeni Legame stretto tra questi due
Materiale didattico validato da: Il Rischio Biologico. Rev. 2 ott Rischio biologico slide 1 di 16
 Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
Il Rischio Biologico Rev. 2 ott. 2009 Rischio biologico slide 1 di 16 Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe),
L impatto della stagione influenzale 2014/2015 in Italia.
 L impatto della stagione influenzale 2014/2015 in Italia. Caterina Rizzo e Antonino Bella (Istituto Superiore di Sanità) Premessa L influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa
L impatto della stagione influenzale 2014/2015 in Italia. Caterina Rizzo e Antonino Bella (Istituto Superiore di Sanità) Premessa L influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa
Piverone, Ruolo di Scaphoideus titanus nell epidemiologia della Flavescenza dorata
 Piverone, 28-01-2017 Ruolo di Scaphoideus titanus nell epidemiologia della Flavescenza dorata Scaphoideus titanus Ball (Hemiptera: Cicadellidae) Specie originaria dell areale neartico (USA e Canada), diffusa
Piverone, 28-01-2017 Ruolo di Scaphoideus titanus nell epidemiologia della Flavescenza dorata Scaphoideus titanus Ball (Hemiptera: Cicadellidae) Specie originaria dell areale neartico (USA e Canada), diffusa
VACCINI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE: COSA I GENITORI DEVONO SAPERE
 VACCINI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE: COSA I GENITORI DEVONO SAPERE GENOVA 25 SETTEMBRE 2004 Epidemiologia delle infezioni prevenibili con vaccinazione: la realtà ligure, la situazione nell area
VACCINI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE: COSA I GENITORI DEVONO SAPERE GENOVA 25 SETTEMBRE 2004 Epidemiologia delle infezioni prevenibili con vaccinazione: la realtà ligure, la situazione nell area
WEST NILE: La sorveglianza integrata: un successo Italiano
 WEST NILE: La sorveglianza integrata: un successo Italiano Caterina Rizzo, MD LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE VIRALI EMERGENTI E RIEMERGENTI IN ITALIA: FOCUS SU ZIKA, WESTNILE E ALTRE ARBOVIROSI 19 Aprile
WEST NILE: La sorveglianza integrata: un successo Italiano Caterina Rizzo, MD LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE VIRALI EMERGENTI E RIEMERGENTI IN ITALIA: FOCUS SU ZIKA, WESTNILE E ALTRE ARBOVIROSI 19 Aprile
Corso di Laurea Scienze Ostetriche. Neonato fisiologico e processi di adattamento alla vita neonatale. Facoltà di Medicina
 Facoltà di Medicina Corso di Laurea Scienze Ostetriche Neonato fisiologico e processi di adattamento alla vita neonatale Dott.ssa Maria Serenella Pignotti T = toxoplasmosi O = other (sifilide) R = rosolia
Facoltà di Medicina Corso di Laurea Scienze Ostetriche Neonato fisiologico e processi di adattamento alla vita neonatale Dott.ssa Maria Serenella Pignotti T = toxoplasmosi O = other (sifilide) R = rosolia
MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA (MPR) SCHEDA INFORMATIVA PER PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO
 MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA (MPR) SCHEDA INFORMATIVA PER PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO WHAT YOU NEED TO KNOW SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DAL MORBILLO, DALLA
MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA (MPR) SCHEDA INFORMATIVA PER PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO WHAT YOU NEED TO KNOW SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DAL MORBILLO, DALLA
INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 29 Ottobre 2010
 INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 29 Ottobre 2010 Si comunica che a seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo di Prevenzione
INFLUENZA UMANA PANDEMICA - A/H1N1p Aggiornamento al 29 Ottobre 2010 Si comunica che a seguito degli ultimi comunicati emessi dall Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo di Prevenzione
West Nile Disease. Situazione epidemiologica. N Novembre 2008 ore 16:00. hanno permesso di evidenziare ulteriori 98 focolai d infezione.
 West Nile Disease N. 45 24 Novembre 28 ore 6: Situazione epidemiologica 24 Novembre 28 I focolai confermati fino ad oggi sono 7, distribuiti in 8 province (Figura e Tabella ). Le seguenti azioni di sorveglianza
West Nile Disease N. 45 24 Novembre 28 ore 6: Situazione epidemiologica 24 Novembre 28 I focolai confermati fino ad oggi sono 7, distribuiti in 8 province (Figura e Tabella ). Le seguenti azioni di sorveglianza
RINOTRACHEITE INFETTIVA. Marco Martini - Dipartimento di Medicina animale, Produzioni, Salute - Università di Padova
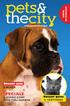 RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL GATTO (FHV-1) Marco Martini - Dipartimento di Medicina animale, Produzioni, Salute - Università di Padova RINOTRACHEITE INFETTIVA (FHV-1) FHV-1: alphaherpesvirus, isolato per
RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL GATTO (FHV-1) Marco Martini - Dipartimento di Medicina animale, Produzioni, Salute - Università di Padova RINOTRACHEITE INFETTIVA (FHV-1) FHV-1: alphaherpesvirus, isolato per
Malattia Vescicolare del Suino
 1 MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO La malattia Malattia Vescicolare del Suino La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale (genere Enterovirus appartenente
1 MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO La malattia Malattia Vescicolare del Suino La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale (genere Enterovirus appartenente
cosa ci aspetta P. Crovari Prof. Emerito di Igiene e Medicina Preventiva Università di Genova
 Workshop Migliorare con l esperienza Sala Ordine dei Medici 9giugno 2010 cosa ci aspetta P. Crovari Prof. Emerito di Igiene e Medicina Preventiva Università di Genova Che cosa si intende per pandemia influenzale
Workshop Migliorare con l esperienza Sala Ordine dei Medici 9giugno 2010 cosa ci aspetta P. Crovari Prof. Emerito di Igiene e Medicina Preventiva Università di Genova Che cosa si intende per pandemia influenzale
FORTEMENTE RACCOMANDATO;
 CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2015/2016 L Influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l attuazione delle misure di controllo
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2015/2016 L Influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l attuazione delle misure di controllo
REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica
 REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica Marzo 2010 La bluetongue (BT), malattia della lingua blu o febbre catarrale ovina, è una malattia di origine virale che colpisce bovini,
REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità Direzione Sanità Pubblica Marzo 2010 La bluetongue (BT), malattia della lingua blu o febbre catarrale ovina, è una malattia di origine virale che colpisce bovini,
INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA:
 CENTRO REGIONALE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA: 1999 2003 Stefano Marangon Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
CENTRO REGIONALE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA: 1999 2003 Stefano Marangon Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
LE MALATTIE DEGLI EQUIDI. Il D.P.R 320/54 all art. 1 contempla tra le malattie denunciabili sul territorio nazionale:
 LE MALATTIE DEGLI EQUIDI Le malattie degli equidi soggette a denuncia. Il D.P.R 320/54 all art. 1 contempla tra le malattie denunciabili sul territorio nazionale: A) AFFEZIONI INFLUENZALI DEGLI EQUINI
LE MALATTIE DEGLI EQUIDI Le malattie degli equidi soggette a denuncia. Il D.P.R 320/54 all art. 1 contempla tra le malattie denunciabili sul territorio nazionale: A) AFFEZIONI INFLUENZALI DEGLI EQUINI
RIFT VALLEY FEVER. Santino Prosperi. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale
 Santino Prosperi Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale malattia virale trasmessa da zanzare Grave zoonosi con sindrome influenzale disturbi visivi Negli animali si caratterizza
Santino Prosperi Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale malattia virale trasmessa da zanzare Grave zoonosi con sindrome influenzale disturbi visivi Negli animali si caratterizza
PESTE SUINA AFRICANA. African Swine Fever. Peste suina africana. Peste suina africana
 PESTE SUINA AFRICANA African Swine Fever Peste suina africana Grave malattia infettiva virale e contagiosa del suino domestico e selvatico trasmessa anche da zecche caratterizzata da febbre e coinvolgimento
PESTE SUINA AFRICANA African Swine Fever Peste suina africana Grave malattia infettiva virale e contagiosa del suino domestico e selvatico trasmessa anche da zecche caratterizzata da febbre e coinvolgimento
Infezione da Herpesvirus degli equidi EHV1, EHV4
 Infezione da Herpesvirus degli equidi EHV1, EHV4 Infezione da Herpesvirus degli equidi EHV1, EHV4 malattia infettiva altamente contagiosa, tipica del cavallo e caratterizzata da: Rinopolmonite (EHV1 EHV4)
Infezione da Herpesvirus degli equidi EHV1, EHV4 Infezione da Herpesvirus degli equidi EHV1, EHV4 malattia infettiva altamente contagiosa, tipica del cavallo e caratterizzata da: Rinopolmonite (EHV1 EHV4)
LA LARINGOTRACHEITE. profonde (polmoni e sacchi aerei) micoplasmosi, colibacillosi, bronchite infettiva, pseudopeste
 LA LARINGOTRACHEITE INFETTIVA Le malattie respiratorie sono patologie molto importanti negli allevamenti Possono essere distinte superficiali corizza, laringotracheite profonde (polmoni e sacchi aerei)
LA LARINGOTRACHEITE INFETTIVA Le malattie respiratorie sono patologie molto importanti negli allevamenti Possono essere distinte superficiali corizza, laringotracheite profonde (polmoni e sacchi aerei)
Stele votiva tempio di Astarte a Menfi. Museo Glypotek Copenaghen
 POLIOMIELITE DEFINIZIONE Grave malattia infettiva virale, contagiosa Etiologia: Poliovirus 1, 2, 3 Polyos = grigio - Myelos = midollo Colpisce i motoneuroni delle corna anteriori (sostanza grigia) del
POLIOMIELITE DEFINIZIONE Grave malattia infettiva virale, contagiosa Etiologia: Poliovirus 1, 2, 3 Polyos = grigio - Myelos = midollo Colpisce i motoneuroni delle corna anteriori (sostanza grigia) del
INFEZIONE DA VIRUS DELLA DIARREA VIRALE BOVINA NELLA BUFALA MEDITERRANEA
 INFEZIONE DA VIRUS DELLA DIARREA VIRALE BOVINA NELLA BUFALA MEDITERRANEA Dr.ssa Alessandra Martucciello Portici, 4-5 novembre 2008 BVDV Nel bovino determina: INFEZIONI SUBCLINICHE IMMUNODEPRESSIONE FORME
INFEZIONE DA VIRUS DELLA DIARREA VIRALE BOVINA NELLA BUFALA MEDITERRANEA Dr.ssa Alessandra Martucciello Portici, 4-5 novembre 2008 BVDV Nel bovino determina: INFEZIONI SUBCLINICHE IMMUNODEPRESSIONE FORME
Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche. Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche
 Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche L Istituto Zooprofilattico Sperimentale Si occupa di diagnostica
Un Piano per il controllo della Leishmaniosi canina nelle Marche Stefano Gavaudan Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche L Istituto Zooprofilattico Sperimentale Si occupa di diagnostica
MORBILLO, IN CAMPANIA OLTRE 9 MILA BAMBINI NATI NEL 2012 NON VACCINATI
 MORBILLO, IN CAMPANIA OLTRE 9 MILA BAMBINI NATI NEL 2012 NON VACCINATI Nei primi tre mesi del 2016 sono stati segnalati 61 casi. Allerta dei medici campani: senza vaccinazione si rischia una epidemia simile
MORBILLO, IN CAMPANIA OLTRE 9 MILA BAMBINI NATI NEL 2012 NON VACCINATI Nei primi tre mesi del 2016 sono stati segnalati 61 casi. Allerta dei medici campani: senza vaccinazione si rischia una epidemia simile
Charvensod 12/02/2001
 Charvensod 12/02/2001 1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Gruppo di malattie degenerative che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale dell uomo e degli animali 2 Forme nell uomo Malattia di Creutzfeldt-
Charvensod 12/02/2001 1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Gruppo di malattie degenerative che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale dell uomo e degli animali 2 Forme nell uomo Malattia di Creutzfeldt-
SDO e malattie trasmissibili. Marta Ciofi degli Atti CNESP Reparto Epidemiologia Malattie Infettive
 SDO e malattie trasmissibili Marta Ciofi degli Atti CNESP Reparto Epidemiologia Malattie Infettive Utilità delle SDO nel campo delle malattie trasmissibili Ottenere informazioni non disponibili da altre
SDO e malattie trasmissibili Marta Ciofi degli Atti CNESP Reparto Epidemiologia Malattie Infettive Utilità delle SDO nel campo delle malattie trasmissibili Ottenere informazioni non disponibili da altre
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Epidemiologia dell infezione da HPV e del carcinoma della cervice
 Epidemiologia dell infezione da HPV e del carcinoma della cervice I PAPILLOMAVIRUS Sono virus a DNA a doppia elica contenuti in un capside icosaedrico di 55 nm di diametro Ne esistono oltre 200 tipi di
Epidemiologia dell infezione da HPV e del carcinoma della cervice I PAPILLOMAVIRUS Sono virus a DNA a doppia elica contenuti in un capside icosaedrico di 55 nm di diametro Ne esistono oltre 200 tipi di
ARTERITE VIRALE EQUINA
 ARTERITE VIRALE EQUINA Caratteristiche della patologia Informazioni E.1 Malattia E.1.1 Nome patologia Arterite Virale Equina (Epizootic lymphangitis, pinkeye fièvre typhoide) E.1.2 Agente/i eziologico/i
ARTERITE VIRALE EQUINA Caratteristiche della patologia Informazioni E.1 Malattia E.1.1 Nome patologia Arterite Virale Equina (Epizootic lymphangitis, pinkeye fièvre typhoide) E.1.2 Agente/i eziologico/i
Marco Martini - Università di Padova
 Marco Martini - Università di Padova CALICIVIRUS Virus a ssrna, sferici, depressioni a forma di calice sulla superficie capsidica (Norwalk virus umano, Malattia emorragica virale del coniglio) Privi di
Marco Martini - Università di Padova CALICIVIRUS Virus a ssrna, sferici, depressioni a forma di calice sulla superficie capsidica (Norwalk virus umano, Malattia emorragica virale del coniglio) Privi di
WEST NILE, segnalato un decesso a Modena
 WEST NILE, segnalato un decesso a Modena Dopo Reggio Emilia anche a Modena si sarebbe registrato il 5 settembre un decesso per West Nile, la malattia neuroinvasiva che nelle province di Modena, Reggio
WEST NILE, segnalato un decesso a Modena Dopo Reggio Emilia anche a Modena si sarebbe registrato il 5 settembre un decesso per West Nile, la malattia neuroinvasiva che nelle province di Modena, Reggio
I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
 I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni MinisterodellaSalute Dipartimento della sanità
LE INFEZIONI DA PARVOVIRUS CANINI
 LE INFEZIONI DA PARVOVIRUS CANINI GENERALITA SUI PARVOVIRUS DNA monocatenario Dimensioni 20-30 nm Forma icosaedrica Assenza di envelope Resistenza al ph, ai solventi dei lipidi e ai disinfettanti Non sono
LE INFEZIONI DA PARVOVIRUS CANINI GENERALITA SUI PARVOVIRUS DNA monocatenario Dimensioni 20-30 nm Forma icosaedrica Assenza di envelope Resistenza al ph, ai solventi dei lipidi e ai disinfettanti Non sono
Epidemiologia della rosolia nel contesto nazionale e internazionale
 Rosolia congenita e nuove strategie di prevenzione Epidemiologia della rosolia nel contesto nazionale e internazionale SEDE Indicazioni OMS Ogni programma di prevenzione della SRC ha come priorità la protezione
Rosolia congenita e nuove strategie di prevenzione Epidemiologia della rosolia nel contesto nazionale e internazionale SEDE Indicazioni OMS Ogni programma di prevenzione della SRC ha come priorità la protezione
HERPESVIRUS schema del virione
 HERPESVIRUS schema del virione Dimensioni relativamente grandi grande genoma a DNA doppia elica gran numero di geni Capside icosaedrico Tegumento proteico Involucro pericapsidico CICLO REPLICATIVO α β
HERPESVIRUS schema del virione Dimensioni relativamente grandi grande genoma a DNA doppia elica gran numero di geni Capside icosaedrico Tegumento proteico Involucro pericapsidico CICLO REPLICATIVO α β
CAMPAGNA ANTI-INFLUENZALE
 SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA CAMPAGNA ANTI-INFLUENZALE 2015-2016 Inizia il prossimo 9 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale della ASL di Carbonia-Iglesias. L'influenza ogni anno colpisce
SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA CAMPAGNA ANTI-INFLUENZALE 2015-2016 Inizia il prossimo 9 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale della ASL di Carbonia-Iglesias. L'influenza ogni anno colpisce
Osservatorio per le Politiche Sociali - Terzo Rapporto
 1 STRUTTURA E DINAMICA DEMOGRAFICA Il capitolo si articola in due paragrafi. Nel primo sono riportati i dati e i commenti riguardanti la struttura demografica della popolazione della Valle d Aosta. Nel
1 STRUTTURA E DINAMICA DEMOGRAFICA Il capitolo si articola in due paragrafi. Nel primo sono riportati i dati e i commenti riguardanti la struttura demografica della popolazione della Valle d Aosta. Nel
Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II
 Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II PBFD Una delle principali patologie infettive ad eziologia
Malattia del Becco e delle Penne degli Psittacidi (PBFD) Dr. Ludovico Dipineto Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Napoli Federico II PBFD Una delle principali patologie infettive ad eziologia
Infezioni da Pneumovirus aviari
 Infezioni da Pneumovirus aviari Rinotracheite Aviare (ART) del Pollo o Sindrome della Testa Gonfia (SHS) Rinotracheite del Tacchino (TRT) (malattia clinicamente indistinguibile dalla Bordetellosi da B.avium)
Infezioni da Pneumovirus aviari Rinotracheite Aviare (ART) del Pollo o Sindrome della Testa Gonfia (SHS) Rinotracheite del Tacchino (TRT) (malattia clinicamente indistinguibile dalla Bordetellosi da B.avium)
La gravidanza nella salute globale
 La gravidanza nella salute globale MALATTIE PREVENIBILI CON VACCINO: Morbillo, parotite, rosolia, varicella Nadia Gussetti VERONA 15 16 Dicembre 2016 Lettera Circolare del 20/02/2013 Obiettivi della sorveglianza
La gravidanza nella salute globale MALATTIE PREVENIBILI CON VACCINO: Morbillo, parotite, rosolia, varicella Nadia Gussetti VERONA 15 16 Dicembre 2016 Lettera Circolare del 20/02/2013 Obiettivi della sorveglianza
Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita
 Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita Bianca Maria Borrini Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della Rosolia congenita. Corso ROSOLIA CONGENITA
Sistema di sorveglianza nazionale della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita Bianca Maria Borrini Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della Rosolia congenita. Corso ROSOLIA CONGENITA
Popolazione migrante e malattie sessualmente trasmissibili
 Popolazione migrante e malattie sessualmente trasmissibili I S S A E L - H A M A D Dipartimento di Malattie Infettive Spedali Civili di Brescia - ASL di Brescia Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST)
Popolazione migrante e malattie sessualmente trasmissibili I S S A E L - H A M A D Dipartimento di Malattie Infettive Spedali Civili di Brescia - ASL di Brescia Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST)
La mia vaccinazione La tua protezione contro il morbillo e la pertosse
 La mia vaccinazione La tua protezione contro il morbillo e la pertosse Morbillo Per proteggere i vostri lattanti, sia l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sia i medici raccomandano ai genitori
La mia vaccinazione La tua protezione contro il morbillo e la pertosse Morbillo Per proteggere i vostri lattanti, sia l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sia i medici raccomandano ai genitori
Meningite Cosa c è da sapere.
 Meningite Cosa c è da sapere www.salute.gov.it Ecco dieci cose da sapere sulla meningite in Italia, soprattutto sulla forma più aggressiva, quella di natura batterica, e sulle vaccinazioni disponibili
Meningite Cosa c è da sapere www.salute.gov.it Ecco dieci cose da sapere sulla meningite in Italia, soprattutto sulla forma più aggressiva, quella di natura batterica, e sulle vaccinazioni disponibili
La vaccinazione per l influenza stagionale
 La vaccinazione per l influenza stagionale Sigismondo Ferrante 1 12 settembre 2009 2 Roma, 23 luglio2009 1 Obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l influenza riduzione del rischio individuale
La vaccinazione per l influenza stagionale Sigismondo Ferrante 1 12 settembre 2009 2 Roma, 23 luglio2009 1 Obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l influenza riduzione del rischio individuale
4ª UNITA DIDATTICA Modello Nutrizionale metabolico
 4ª UNITA DIDATTICA Modello Nutrizionale metabolico Contenuti Modello Nutrizionale metabolico Sezione del modello: Equilibrio idro-elettrolitico e acido-base Assistenza alla persona con problemi relativi
4ª UNITA DIDATTICA Modello Nutrizionale metabolico Contenuti Modello Nutrizionale metabolico Sezione del modello: Equilibrio idro-elettrolitico e acido-base Assistenza alla persona con problemi relativi
Febbre del Nilo occidentale (West Nile Virus - WNV)
 FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) Febbre del Nilo occidentale (West Nile Virus - WNV) 95 West Nile Virus Foto: CNN Febbre del Nilo occidentale (West Nile Virus - WNV) DEFINIZIONE La febbre del Nilo
FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) Febbre del Nilo occidentale (West Nile Virus - WNV) 95 West Nile Virus Foto: CNN Febbre del Nilo occidentale (West Nile Virus - WNV) DEFINIZIONE La febbre del Nilo
CONCETTO DI SALUTE. La salute è uno stato di ottimale rendimento produttivo, ottenuto nel rispetto dell uomo, dell ambiente e degli animali stessi
 CONCETTO DI SALUTE La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità (Atto di Fondazione O.M.S., 1948) La salute è uno stato di ottimale
CONCETTO DI SALUTE La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità (Atto di Fondazione O.M.S., 1948) La salute è uno stato di ottimale
INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β
 EPATITE B SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALL EPATITE B? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β RICORDA CHE: L epatite B causa un infiammazione acuta del fegato,
EPATITE B SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALL EPATITE B? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β RICORDA CHE: L epatite B causa un infiammazione acuta del fegato,
Infezioni emergenti. Stefano Marangon. Bosco Chiesanuova, 24 marzo Convegno Una montagna di problemi o di opportunità
 Infezioni emergenti Stefano Marangon Bosco Chiesanuova, 24 marzo 2010 DEFINIZIONE DI INFEZIONE (RE)-EMERGENTE E un infezione non segnalata in precedenza ( nuova ) nota, ma con una nuova evoluzione: - aumento
Infezioni emergenti Stefano Marangon Bosco Chiesanuova, 24 marzo 2010 DEFINIZIONE DI INFEZIONE (RE)-EMERGENTE E un infezione non segnalata in precedenza ( nuova ) nota, ma con una nuova evoluzione: - aumento
Sorveglianza della West Nile Disease in Emilia-Romagna Bollettino n. 4/2009 del 04/08/2009
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
student_view0/chapter33/animation_quiz_1.html
 http://highered.mheducation.com/sites/0072556781/ student_view0/chapter33/animation_quiz_1.html Metti in ordine le reazioni per i due tipi di test ELISA Indirect ELISA Sandwich ELISA Ricostruisci il test
http://highered.mheducation.com/sites/0072556781/ student_view0/chapter33/animation_quiz_1.html Metti in ordine le reazioni per i due tipi di test ELISA Indirect ELISA Sandwich ELISA Ricostruisci il test
Il ginecologo e la gestione del partner maschile
 Il ginecologo e la gestione del partner maschile La condilomatosi colpisce il sesso maschile prevalentemente tra i 20-29 anni; questa malattia comporta un importante disagio psichico e richiede un trattamento
Il ginecologo e la gestione del partner maschile La condilomatosi colpisce il sesso maschile prevalentemente tra i 20-29 anni; questa malattia comporta un importante disagio psichico e richiede un trattamento
FAQ DOMANDE SULLA WND
 FAQ DOMANDE SULLA WND MALATTIA 1. Che cos è la West Nile Disease (WND)? La WND è una zoonosi ad eziologia virale, trasmessa da zanzare, che causa forme di meningo-encefalite negli uccelli, sia selvatici
FAQ DOMANDE SULLA WND MALATTIA 1. Che cos è la West Nile Disease (WND)? La WND è una zoonosi ad eziologia virale, trasmessa da zanzare, che causa forme di meningo-encefalite negli uccelli, sia selvatici
Parvovirosi suina. PPV - eziologia. Fabio Ostanello Dip. Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna 07/12/ di 5.
 Parvovirosi suina (PPV) - definizione Parvovirosi suina Malattia infettiva ad eziologia virale sostenuta da Porcine Parvovirus (PPV) Virus emoagglutinante di piccole dimensioni, a singolo filamento di
Parvovirosi suina (PPV) - definizione Parvovirosi suina Malattia infettiva ad eziologia virale sostenuta da Porcine Parvovirus (PPV) Virus emoagglutinante di piccole dimensioni, a singolo filamento di
Rassegna stampa. A cura dell Ufficio Stampa FIDAS Nazionale. Mercoledì 27 gennaio Rassegna associativa. Rassegna Sangue e emoderivati
 Rassegna stampa A cura dell Ufficio Stampa FIDAS Nazionale Mercoledì 27 gennaio 2016 Rassegna associativa 2 Rassegna Sangue e emoderivati 5 Rassegna sanitaria, medico-scientifica e Terzo settore 7 Prima
Rassegna stampa A cura dell Ufficio Stampa FIDAS Nazionale Mercoledì 27 gennaio 2016 Rassegna associativa 2 Rassegna Sangue e emoderivati 5 Rassegna sanitaria, medico-scientifica e Terzo settore 7 Prima
Sorveglianza della West Nile Disease in Emilia-Romagna Bollettino n. 1/12 del 21/08/2012
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) ------------------------------------- BRESCIA Via Bianchi, 9 25124 BRESCIA
Contiene il virus vivo attenuato ceppo Oka/Merck Contiene il virus vivo attenuato ceppo Oka Tra +2 e +8 Tra +2 e +8
 Varivax Varilrix Ditta Sanofi Pasteur MSD GlaxoSmithKline Ceppo virus varicella Temperatura di conservazione Immunogenicità Inizio della risposta immunitaria Durata della risposta immunitaria Efficacia
Varivax Varilrix Ditta Sanofi Pasteur MSD GlaxoSmithKline Ceppo virus varicella Temperatura di conservazione Immunogenicità Inizio della risposta immunitaria Durata della risposta immunitaria Efficacia
HERPESVIROSI DELLA CARPA KOI (KHVD)
 HERPESVIROSI DELLA CARPA KOI (KHVD) Herpesvirosi della Carpa Koi (KHVD) A cura di Dott.ssa Mariachiara Armani e Dott.ssa Karin Trevisiol, SCT6 Bolzano, IZSVe In collaborazione con il Servizio Veterinario
HERPESVIROSI DELLA CARPA KOI (KHVD) Herpesvirosi della Carpa Koi (KHVD) A cura di Dott.ssa Mariachiara Armani e Dott.ssa Karin Trevisiol, SCT6 Bolzano, IZSVe In collaborazione con il Servizio Veterinario
l'influenza e la vaccinazione antinfluenzale
 1 / 6 L'influenza e la vaccinazione antinfluenzale poche cose utili (...e risapute) da ricordare! L Influenza è una malattia molto contagiosa causata da virus che si trasmettono da persona a persona prevalentemente
1 / 6 L'influenza e la vaccinazione antinfluenzale poche cose utili (...e risapute) da ricordare! L Influenza è una malattia molto contagiosa causata da virus che si trasmettono da persona a persona prevalentemente
NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 11 Settembre 2009
 NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 11 Settembre 29 Dagli ultimi Comunicati emessi dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali dello Stato no, dall Organizzazione Mondiale della Sanità
NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 11 Settembre 29 Dagli ultimi Comunicati emessi dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali dello Stato no, dall Organizzazione Mondiale della Sanità
CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA
 Ordine Medici Veterinari di Verona 10 maggio 2011 CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA Loris Alborali, Mariagrazia Zanoni, Paolo Cordioli Istituto
Ordine Medici Veterinari di Verona 10 maggio 2011 CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI : UN RISCHIO o UN OPPORTUNITA Loris Alborali, Mariagrazia Zanoni, Paolo Cordioli Istituto
Di seguito è possibile scaricare una serie di brochoure informative: - Vaccinazione HPV. - Brochure Vaccino Antipneumococco
 Progetto VaccinarSì La società SItI (SOcietà Italiana di Igiene) sta realizzando il progetto "VaccinarSì" anche attraverso la promozione di un sito web rintracciabile all'indirizzo www.vaccinarsi.org.&
Progetto VaccinarSì La società SItI (SOcietà Italiana di Igiene) sta realizzando il progetto "VaccinarSì" anche attraverso la promozione di un sito web rintracciabile all'indirizzo www.vaccinarsi.org.&
SBV. Ministero della Salute. il virus di Schmallenberg. Aprile 2012
 Aprile 2012 Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
Aprile 2012 Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
 CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2012-2013 Informazioni sulla vaccinazione contro l'influenza stagionale Stampa settembre 2012 UOC Comunicazione - URP ASL 9 Premessa L influenza costituisce un importante
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2012-2013 Informazioni sulla vaccinazione contro l'influenza stagionale Stampa settembre 2012 UOC Comunicazione - URP ASL 9 Premessa L influenza costituisce un importante
Dal mese di maggio non è più stato possibile definire nuovi focolai in quanto l epidemia si è estesa sull intero territorio regionale.
 Focolai di morbillo in Piemonte: la situazione al 9 luglio 10 A distanza di soli 2 anni dalla precedente, si sta manifestando in Piemonte una nuova epidemia di morbillo, che è esordita a gennaio 10, a
Focolai di morbillo in Piemonte: la situazione al 9 luglio 10 A distanza di soli 2 anni dalla precedente, si sta manifestando in Piemonte una nuova epidemia di morbillo, che è esordita a gennaio 10, a
SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI
 SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi
SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi
