Reti per le telecomunicazioni Definizioni di particolare interesse Guida per l esame
|
|
|
- Vittore Pugliese
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Reti per le telecomunicazioni Definizioni di particolare interesse Guida per l esame INTRODUZIONE Ho preparato questa guida affinché lo studente non impazzisca in decine di lucidi e di definizioni superflue, ma possa cogliere gli argomenti di base ed essenziali Ho diviso i vari riassunti in capitoli in base alla suddivisione data da Andrea Palla nei suoi ottimi e fondamentali appunti (disponibili su Indicherò per ogni capitolo le definizioni e le nozioni minime da ricordare per superare l esame. Non vorrei essere ripetitivo, ma molta della roba che viene spiegata a lezione è esuberante per il superamento di questo corso. Tutto quanto non ho riportato nella mia guida è roba che potete tranquillamente saltare e che negli ultimi 3 anni nei vari appelli non è mai stata chiesta. Purtroppo non sono convinto di aver spiegato tutto con chiarezza, perché sono appunti basati sulla mia metodologia di studio che è abbastanza schematica, nel caso ci siano frasi o concetti poco chiari, contattatemi e vedrò di rielaborarli meglio. Comunque questi appunti devono servirvi più da guida che da testo, per quello consiglio vivamente gli appunti (già citati) di A.Palla, ma soprattutto di seguire le lezioni del Professore, perché né la mia guida né altri appunti possono sostituirlo, ma solo aiutarvi e velocizzarvi lo studio. Qualora qualcuno riscontri errori, inesattezze o particolari da correggere non esiti a contattarmi tramite il sito web Chiunque volesse collaborare con altri appunti, altro materiale può farlo caricando direttamente dal modulo di upload presente sul sito Invito tutti a pubblicizzare questo mio elaborato perché io quando ho sostenuto l esame di reti ho sentito proprio la mancanza di qualcuno o qualcosa che mi dicesse cosa fare e cosa saltare: è impossibile ricordarsi tutti i pacchetti e tutte le definizioni se non si fa un accurata selezione. Ringrazio per il fondamentale aiuto Andrea Palla (e le sue indispensabili dispense) e i miei amici e compagni di corso che mi hanno aiutato in questa selezione. Augurandomi di aver preparato qualcosa di utile a quante più persone vi faccio il mio più grande in bocca al lupo rinnovando la mia disponibilità per qualunque dubbio o domanda. Roberto Regazzoli Febbraio 2005 robyrega
2 CAPITOLO1 Reti e servizi di comunicazione Connection oriented (commutazione di circuito): cosi definite perché il servizio offerto è orientato alla connessione cioè si realizza un vero e proprio circuito fra un utente e l altro tramite la commutazione di circuito. CAS (segnalazione associata): permette nelle multitrame (trame composte da 16 trame normali da 30+2 slot l una) di trasportare (nei vari 16 i slot) le informazioni tra trasmittente e ricevente (es.linea telefonica = impegno linea; disimpegno linea (clear forward) ). PDH (multiplazioni successive): prendi 4 sistemi del livello inferiore e li multipli creando un unico grande sistema con 4 volte i canali di traffico del livello precedente. Sono sistemi asincroni per cui il MUX2 lavora a velocità superiore rispetto alla somma dei tributari (8.448 invece di 4*2.048 = 8.192) e necessitano perciò di memorie temporanee e dei bit di stuffing (uno per tributario più 3 di controllo a bit). SDH: velocità di trasmissione più elevate; maggiori possibilità di connessione e facilità di gestione dei flussi (drop-insert più semplice ed economico). Agisce a partire da 155 Mbit/s. La sua trama è una matrice di 270 colonne (*N) per 9 righe il tutto di durata sempre 125 µsec. Il drop-insert viene effettuato grazie ai puntatori presenti nelle prime 9 colonne (AU pointer) che indicano (giustif. Positiva o negativa) dove iniziano le varie trame (payload).» Cosa ricordare del capitolo1 (insieme alle definizioni sopra) Il segnale telefonico, cos è, come funziona La codifica PCM (importante!) Le varie tecniche di multiplazione (FDM, TDM): la prima solo la definizione; per la TDM invece tutto bene (la trama, sincronizzazione, allineamento, segnalazione ) La segnalazione associata CAS (vedi sopra) La multiplazione ai livelli superiori (PDH, con solo la tabella dei canali europei e la tecnica dei bit di stuffing) SDH: oltre a quanto detto sopra, anche la figura 1-10 (A.Palla) con le definizioni di contenitori, VC, AU in particolare il VC4 (come è fatto, da cosa è composto). Velocità di modulazione e teorema di Shannon CAPITOLO3 Commutazione a circuito e segnalazione di utente Matrici bloccanti: la commutazione nello spazio avviene attraverso l utilizzo di una matrice. Reti moderne si basano su più stadi (T-S-T). Una matrice è detta non bloccante se è in grado di effettuare tutti i collegamenti mentre è bloccante se manca anche un solo collegamento. Una matrice spazio, per essere non bloccante vige la relazione di Clos cioè k(uscite) O 2n(entrate) 1.» Cosa ricordare del capitolo3 (insieme alle definizioni sopra) Come avvengono le commutazioni a divisione di tempo e a divisione di spazio La commutazione TST e la relazione di Clos Saltate pure probabilità di blocco, segnalazione d utente e lo schema di una centrale telefonica Segnalazione tra centrali (potrebbe essere chiesta) robyrega
3 CAPITOLO4 Trasmissione dati Codici di linea: Commutazione a pacchetto: tecnica utilizzata per la trasmissione dati su linee dedicate e non su quella telefonica. Livelli OSI: architettura stratificata; gli oggetti che lavorano nei vari strati sono le entità e se appartengono allo stesso strato si dicono peer. Le entità cooperano tra loro tramite un protocollo e dialogano in due modalità: con connessione (logica non fisica perciò servono etichette; attivazione, fase dati, abbattimento) e senza connessione (serve indirizzo numerico, tipo Internet). PDU: sono le unità dati prodotte da ogni strato dell architettura OSI e vengono passate come SDU in modo trasparente allo stato sottostante inserendo in testa un informazione aggiuntiva (PCI) e dando vita alla nuova PDU. Polinomi generatori: (7,6) g(x)= x+1 (7,4) g(x)= x 3 +x+1 (7,3) g(x)= x 3 +x 2 +1 ARQ: per la protezione dagli errori. Meccanismo stop and wait. Riscontri ACK e time-out. Multiplazione statistica: il traffico proveniente da un numero elevato di sorgenti va incontro a congestione. È una multiplazione dinamica perché le risorse vengono affidate in base alle richieste utenti e traffico. Il canale fisico è diviso in canali logici. X25 Frame relay: il primo è rete affidabile e difficilmente congestionabile perché ci sono tecniche di controllo e rilevazione di errore. Il FR vuole una rete dati a pacchetto ma su canali virtuali in cui ogni utente prende solo la parte che gli serve. Niente correzione d errori né controllo congestione (tranne i bit di notifica dello stato + bit priorità) quindi no campo control perché si usano reti stabili. La gestione etichette avviene al data link che esegue anche l istradamento; servono le etichette perché sui canali fisici ci sono i pacchetti di vari utenti. Trame tutte informative e non numerate.» Cosa ricordare del capitolo4 (insieme alle definizioni sopra) È un capitolo molto importante DTE-DCE I vari codici di linea ed in particolare l HDB3 con la regola di come interpretarlo La modulazione QAM I modelli OSI (cosa sono, come funzionano ed operano) Differenza fra PDU SDU Il livello2 di datalink robyrega
4 I codici di rilevazione d errore ed in particolare il polinomio generatore (regole, esercizi su come calcolarlo ): è una domanda molto frequente La correzione d errore tramite ritrasmissione, il timeout Il protocollo stop and wait (come funzione, efficienza sia su canale ideale che su canale rumoroso, incluse dimostrazioni) X25 e frame relay: cosa sono, differenze (vedi sopra), come operano (vedi anche tabella in fondo alla guida), strutture di trama, pacchetto dati e pacchetto segnalazione. Definizione di multiplazione statistica CAPITOLO5 Teoria delle code Non ci sono definizioni da ricordare se non tutte le formule per l immancabile esercizio sulle code. Eventualmente la dimostrazione della formula B di Erlang e il teorema di Little. CAPITOLO6 ISDN Accesso d utente: U NT1 T NT2 S (TA-R-TE2) TE1 NT1: appartiene al livello1 vale a dire terminazione della linea trasmissiva, gestione del clock e multiplazione di più canali. NT2: consiste di funzionalità di livello 1,2,3. Ha i protocolli di segnalazione ed effettua funzioni di commutazione. Accesso base: 2B+D (2 canali a 64 kb/s con funzione principale di trasportare il flusso numerico a commutazione di circuito + 1 canale a 16 kb/s che trasporta un flusso informativo e quindi i messaggi di segnalazione utente rete). Capacità totale 144 kb/s. Accesso primario: 30B+D (tutti canali a 64 kb/s, usa linee apposite a 2 Mbit/s). Capacità totale 1984 kb/s. Interfaccia S (accesso base): trame che escono simultaneamente da TE e NT1. Hanno 48 bit l una (2 byte B1, 2 byte B2, 4 bit D, 4 bit E, 8 bit controllo). Durata 250 µsec e velocità 192 kbit/s. Offset di 2 bit e bit eco sono collegati con i bit D. È associato un codice bipolare alternato (V AMI). Dopo dieci 1 consecutivi nel LAPD si ritiene il canale libero. Accesso multiplo. SAPI: specifica se la trama è di segnalazione, gestione, manutenzione o rivolta a tutti. TEI: identifica un particolare terminale (nell accesso primario è nullo). SS7 (segnalazione a canale comune): segnalazione di rete, avviene fuori banda su linee apposite. Può essere associata (un solo link di collegamento) o quasi associata (più link di collegamento). Territorio diviso in regioni con 2 STP (signal transfer point) e alcuni SP (signal point). Messaggi su 4 livelli OSI trasferiti non in maniera trasparente. Il trasferimento avviene in transfert part (MTP), l elaborazione a livello 4 in user part (TUP ISUP). MTP: lavora connectionless. Livello fisico gestisce canali 64 kbit/s, livello due con trame HDLC (dette MSU che rilevano e correggono errori) e livello tre che s occupa di instradamento.» Cosa ricordare del capitolo6 (insieme alle definizioni sopra) È un capitolo molto importante Lo schema dell accesso d utente Accesso base e accesso primario Livello1 con l interfaccia S (solo per accesso base) e la sua struttura di trama L interfaccia U Il livello2 con la struttura di trama (LAPD), vedere anche tabella in fondo alla guida, e il livello3 di rete con il protocollo Q.931 (segnalazione d utente). robyrega
5 La procedura di chiamata con i messaggi scambiati e la differenza con una chiamata normale (non ISDN). La segnalazione SS7 a canale comune: come funziona, la sua architettura. MTP2, MTP3 con relativi messaggi Il riassunto di figura 6-21 (A.Palla) CAPITOLO7 Reti Nelle reti ATM siamo sganciati dal clock delle rete nel senso che possiamo iniziare a trasmettere quando vogliamo, infatti inseriamo i pacchetti in un buffer che poi in intervalli regolari viene svuotato. Pacchetti di lunghezza fissa 48+5 byte, trasmissione su SDH (155 Mbit/s), cella IDLE nel caso non si trasmetta niente. L ATM si basa su tre livelli: piano utente (U, provvede al trasferimento delle informazioni di utente e di controllo) piano controllo (C, provvede al trasferimento di informazioni per la segnalazione) piano di managment (M, contiene protocolli e procedure per la gestione dei livelli). VPI VCI: etichette dell header. VPI identifica la mia via virtuale mentre VCI i vari canali virtuali in cui io suddivido la mia via virtuale. Categorie di servizio: CBR: costant bit rate. Connessioni che richiedono quantità fissa di banda. PCR (V picco ) sempre disponibile per tutta la connessione: videoconferenza, TV, pay per view. VBR: variable. Sorgente non sempre attiva; mando celle a burst cioè a velocità media (tante poi zitto oppure un po mando un po zitto ). AVR: aumento o riduco il tasso di emissione in base allo stato della rete. Basso costo ma molto limitata. UBR: non dico niente e uso la banda lasciata libera in base a quello che trovo. AAL1: si usa nei servizi a circuito, prendo blocchi di 47 ottetti, ne aggiungo uno, sincronizzo il tutto (in lettura) con un buffer. AAL5: si usa per trasmissione dati, ai dati attacco 8 ottetti per la correzione d errore e alcuni di pudding per avere multipli di 48 poi li segmento.» Cosa ricordare del capitolo7 (insieme alle definizioni sopra) È un capitolo molto importante Ricordarsi che l ATM è sganciata dal clock di rete e che necessita di un buffer La cella ATM L header della cella ATM (interfacce UNI e NNI). Differenza fra canale virtuale e canale fisico Architettura ATM e i suoi livelli Meccanismi di controllo della congestione Importante: le categorie di servizio con i loro rispettivi descrittori (in particolare la CBR e le VBR). Definizioni e strutture dei livelli di adattamento, in particolare AAL5. Niente sulla segnalazione CAPITOLO8 Accesso Multiplo Bisogna fare in modo che diversi utenti comunichino senza infastidirsi. Si usa ALOHA puro e ALOHA slottato. Il secondo più efficiente perché ha intervallo di vulnerabilità (cioè dove rischio il fallimento) T e non 2T. Meglio ancora il CSMA: CSMA: ascolta prima di inviare (non persistente, se occupato riprovo dopo; P-persistente, se occupato riprovo subito in continuazione; persistente, aspetto che si liberi). CSMA/CD: ascolto prima e mentre invio cosi se trovo intasamento elimino il pacchetto appena inviato. La ritrasmissione si basa sul meccanismo di backoff cioè aspetto a inviare robyrega
6 con un tempo proporzionale esponenzialmente al numero del tentativo (cioè se è il primo rimando subito, se è il decimo aspetto tanto a rispedire).» Cosa ricordare del capitolo8 (insieme alle definizioni sopra) La differenza tra Aloha slottato e pure aloha (e loro efficienza) Categorie CSMA e vantaggi del CSMA/CD CAPITOLO9 Reti LAN Reti LAN possono essere CSMA/CD ad accesso casuale, la più diffusa (ethernet) con singolo canale condiviso e hub; oppure TOKEN RING cioè ad anello, chi ha il testimone manda i bit finchè ritornano a lui (accesso non casuale); oppure TOKEN BUS dove non tutti possono essere connessi ma solo ricevere. A livello fisico ho i ripetitori, a livello 2 i bridge (che quindi gestiscono anche MAC diversi, ma non i LLC) e poi a livello di rete i router» Cosa ricordare del capitolo9 (insieme alle definizioni sopra) Sulle reti LAN credo basti sapere le differenze fra bridge e router (livelli su cui operano e funzionalità) Meccanismo di assegnazione degli indirizzi MAC Per il resto è un capitolo che viene fatto velocemente e su cui non ci sono molte domande (vedere temi d esame degli anni precedenti) CAPITOLO10 Livello1 Livello2 Livello3 Livello4 Reti IP LAN IP Canale fisico MAC + LLC (logical link control che apre/chiude connessioni Lavori su trama corr.errori) Aggiungi IP al pacchetto Aggiungi TCP oppure UDP Per stabilire gli indirizzi MAC si utilizza il protocollo ARP che invia a tutti un pacchetto finchè arriva a quello giusto (con l indirizzo richiesto) che risponde inviando il suo indirizzo e può iniziare la connessione. Cioè non si fa su una rete geografica se no mandi milioni di pacchetti. Nei router l instradamento avviene conoscendo i vari MAC. È connectionless per cui ogni pacchetto deve essere instradato da capo e perciò pacchetti consecutivi dello stesso utente potrebbero seguire due percorsi completamente diversi per arrivare allo stesso posto.» Cosa ricordare del capitolo10 (insieme alle definizioni sopra) Etichetta IP ed etichetta TCP (differenze, livelli su cui operano ) Meccanismi di instradamento e loro algoritmi Tabelle di instradamento dei router Confronto fra TCP/IP e ISO/OSI (quali livelli sono interessati, end-to-end oppure link by link ). Differenze TCP e UDP Il meccanismo di trasmissione sliding windows e come funziona il sistema di riscontro (ACK). robyrega
7 » TABELLA RIASSUNTIVA X25 Frame relay ISDN Livello1 64 kbit/s max 3 Mbit/s min Dipende Livello2 LAPF: Multiplazione, routine, LAPD: come LAPB ma con più LAPB: Trame, errori, correzione, trame tutte informazione (non connessioni e address (SAPI e congestione numerate) TEI) Livello3 Pacchetti con gestione etichette - Q931 mantenere, stabilire, controllare connessioni + segnalazione d utente Segnalazione In banda nei pacchetti Non c è (circ. virtuali) Fuori banda (canale D) ATM SS7 (segnalazione) Livello1 SDH 155 Mbit/s 64 kbit/s Livello2 Header: UNI e NNI MTP2 (trame, correzione errori) Segmentazione e adattamento Livello3 AAL1 e AAL5 MTP3 (instradamento) Segnalazione Non ci interessa Fuori banda su canali appositi» TABELLA RIASSUNTIVA CHIAMATE Telefonata normale Telefonata ISDN In banda CAS In banda Fuori banda SS7 Fuori banda Impegno 1000 Setup dial tone setup ack IAM Numero 0 Info 2 call proceeding Setup 3 alert ACM Alert 5 connect ANM Connect PARLI ringing tone Ringing signal Disconnect REL Disconnect answer Release PARLI Rel.complete Clear forward 0010 clear back R. Complete release robyrega
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
 RETI DI TELECOMUNICAZIONE Analisi prestazioni protocolli Allocazione statica Confronto ritardo temporale multiplazione FDM e TDM Ipotesi Numero stazioni: N Capacità canale: C bps Lunghezza coda: infinita
RETI DI TELECOMUNICAZIONE Analisi prestazioni protocolli Allocazione statica Confronto ritardo temporale multiplazione FDM e TDM Ipotesi Numero stazioni: N Capacità canale: C bps Lunghezza coda: infinita
ATM Asynchronous Transfer Mode
 ATM Asynchronous Transfer Mode Generalità Esigenza: interoperabilità di apparati di rete indipendentemente dal servizio supportato su base mondiale Unica modalità di trasferimento dell informazione a pacchetti
ATM Asynchronous Transfer Mode Generalità Esigenza: interoperabilità di apparati di rete indipendentemente dal servizio supportato su base mondiale Unica modalità di trasferimento dell informazione a pacchetti
Commutazione di circuito e segnalazione
 Nopvembre 2003 Reti e sistemi telematici - 2 Commutazione di circuito e segnalazione Gruppo Reti TLC giancarlo.pirani@telecomitalia.it http://www.telematica.polito.it/ GIANCARLO PIRANI TELECOM ITALIA LAB
Nopvembre 2003 Reti e sistemi telematici - 2 Commutazione di circuito e segnalazione Gruppo Reti TLC giancarlo.pirani@telecomitalia.it http://www.telematica.polito.it/ GIANCARLO PIRANI TELECOM ITALIA LAB
Generalità sui protocolli Tecniche di multiplazione Tecniche di accesso Tecniche di commutazione
 Generalità sui protocolli Tecniche di multiplazione Tecniche di accesso Tecniche di commutazione Introduzione Introduzione La comunicazione tra due o più utenti avviene tramite un canale detto canale di
Generalità sui protocolli Tecniche di multiplazione Tecniche di accesso Tecniche di commutazione Introduzione Introduzione La comunicazione tra due o più utenti avviene tramite un canale detto canale di
Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione. Modelli Funzionali
 Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione Modelli Funzionali 2 Il servizio di comunicazione o Date due o più entità remote o Possiamo descrivere il servizio di comunicazione
Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione Modelli Funzionali 2 Il servizio di comunicazione o Date due o più entità remote o Possiamo descrivere il servizio di comunicazione
Reti locali. Protocolli di accesso per reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ PROTOCOLLI DI ACCESSO PER RETI LOCALI - 1 Caratteristiche reti locali Piccola estensione geografica
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO
 E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
E02 ESERCIZI SU MODI DI TRASFERIMENTO Esercizio 1 Un file di lunghezza F byte è trasferito in una rete a pacchetto, utilizzando n rami in cascata. I nodi attraversati possono essere ritenuti praticamente
Reti di Calcolatori:
 Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) Prof. Ing. Maurizio Casoni
 ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia GENERALITÀ Rete di telecomunicazioni in area
ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia GENERALITÀ Rete di telecomunicazioni in area
SDH Synchronous Digital Hierarchy
 SDH Synchronous Digital Hierarchy Principi della gerarchia SDH Si basa sulla rete SONET (Synchronous Optical Network) L elemento base si chiama STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1) Durata 125µs
SDH Synchronous Digital Hierarchy Principi della gerarchia SDH Si basa sulla rete SONET (Synchronous Optical Network) L elemento base si chiama STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1) Durata 125µs
1- Introduzione alle Reti di Telecomunicazione
 Università degli studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Metodi Matematici Fondamenti di Reti e Telecomunicazione prof. Fabio Martignon 1- Introduzione alle Reti di Telecomunicazione
Università degli studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria dell Informazione e Metodi Matematici Fondamenti di Reti e Telecomunicazione prof. Fabio Martignon 1- Introduzione alle Reti di Telecomunicazione
R. Cusani, F. Cuomo: Telecomunicazioni - DataLinkLayer: Gestione degli errori, Aprile 2010
 1 11. Data link layer: codici di rilevazione di errore, gestione degli errori La rilevazione di errore Un codice a rilevazione di errore ha lo scopo di permettere al ricevente di determinare se vi sono
1 11. Data link layer: codici di rilevazione di errore, gestione degli errori La rilevazione di errore Un codice a rilevazione di errore ha lo scopo di permettere al ricevente di determinare se vi sono
Dr. Greco Polito Silvana. LAN: Local Area Network
 LAN: Local Area Network Reti di accesso e di trasporto Topologie diverse nelle reti di accesso: ANELLO, BUS, STELLA Come viene regolata la condivisione delle risorse di accesso tra le varie stazioni???
LAN: Local Area Network Reti di accesso e di trasporto Topologie diverse nelle reti di accesso: ANELLO, BUS, STELLA Come viene regolata la condivisione delle risorse di accesso tra le varie stazioni???
Reti Locali LAN. Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni
 Reti Locali LAN Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Caratteristiche delle reti LAN Nelle reti locali tutte le stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo, generalmente
Reti Locali LAN Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Caratteristiche delle reti LAN Nelle reti locali tutte le stazioni condividono lo stesso canale trasmissivo, generalmente
Protocolli e Architetture. Dr. Greco Polito Silvana
 Protocolli e Architetture Cos è un protocollo? Insieme di regole che definiscono le modalità di interazione fra sistemi generalmente distanti Cos è un protocollo? Protocollo umano e protocollo di rete:
Protocolli e Architetture Cos è un protocollo? Insieme di regole che definiscono le modalità di interazione fra sistemi generalmente distanti Cos è un protocollo? Protocollo umano e protocollo di rete:
SERVIZI DI TRASFERIMENTO DELL INFORMAZIONE
 SERVIZI DI TRASFERIMENTO DELL INFORMAZIONE Trasparenza temporale Il tempo di trasporto delle diverse IU nella rete ha una variabilità che si può considerare nulla Trasparenza semantica Le diverse IU sono
SERVIZI DI TRASFERIMENTO DELL INFORMAZIONE Trasparenza temporale Il tempo di trasporto delle diverse IU nella rete ha una variabilità che si può considerare nulla Trasparenza semantica Le diverse IU sono
Indirizzi LAN (MAC) e IP
 Indirizzi LAN (MAC) e IP! Indirizzo IP: guida il pacchetto alla rete di destinazione! Indirizzo LAN (o MAC o fisico): indirizza il pacchetto all interfaccia di rete del nodo di destinazione sulla LAN locale!
Indirizzi LAN (MAC) e IP! Indirizzo IP: guida il pacchetto alla rete di destinazione! Indirizzo LAN (o MAC o fisico): indirizza il pacchetto all interfaccia di rete del nodo di destinazione sulla LAN locale!
RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO. Caratteristiche e principi di funzionamento
 RETI A COMMUTAZIOE DI PACCETTO Caratteristiche e principi di funzionamento VARIABILITA DEL BIT RATE DI U SEGALE R (Bit-Rate) VALORE DI PICCO DEL BIT-RATE S VALORE MEDIO DEL BIT-RATE E tempo CARATTERISTICE
RETI A COMMUTAZIOE DI PACCETTO Caratteristiche e principi di funzionamento VARIABILITA DEL BIT RATE DI U SEGALE R (Bit-Rate) VALORE DI PICCO DEL BIT-RATE S VALORE MEDIO DEL BIT-RATE E tempo CARATTERISTICE
Reti di Telecomunicazione Lezione 2
 Reti di Telecomunicazione Lezione 2 Marco Benini Corso di Laurea in Informatica marco.benini@uninsubria.it Programma della lezione Commutazione di circuito multiplexing divisione di frequenza divisione
Reti di Telecomunicazione Lezione 2 Marco Benini Corso di Laurea in Informatica marco.benini@uninsubria.it Programma della lezione Commutazione di circuito multiplexing divisione di frequenza divisione
MODELLI ISO/OSI e TCP/IP
 PARTE I - Reti di Calcolatori ed Internet MODELLI ISO/OSI e TCP/IP Reti di Calcolatori Livelli e Servizi Il modello OSI Il modello TCP/IP Un confronto tra OSI e TCP/IP ARPANET Ethernet Reti ATM reti wireless
PARTE I - Reti di Calcolatori ed Internet MODELLI ISO/OSI e TCP/IP Reti di Calcolatori Livelli e Servizi Il modello OSI Il modello TCP/IP Un confronto tra OSI e TCP/IP ARPANET Ethernet Reti ATM reti wireless
Internet (- working). Le basi.
 Internet (- working). Le basi. 1 GABRIELLA PAOLINI (GARR) 18 OTTOBRE 2011 Capire come funziona Internet 2 FACCIAMO UN PASSO INDIETRO Internet È un insieme di reti interconnesse fra di loro su tutto il
Internet (- working). Le basi. 1 GABRIELLA PAOLINI (GARR) 18 OTTOBRE 2011 Capire come funziona Internet 2 FACCIAMO UN PASSO INDIETRO Internet È un insieme di reti interconnesse fra di loro su tutto il
Reti di Calcolatori:
 Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
Reti di Calcolatori: Internet, Intranet e Mobile Computing a.a. 2007/2008 http://www.di.uniba.it/~lisi/courses/reti/reti0708.htm dott.ssa Francesca A. Lisi lisi@di.uniba.it Orario di ricevimento: mercoledì
Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A Pietro Frasca. Parte II Lezione 2
 Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A. 2013-14 Pietro Frasca Parte II Lezione 2 Giovedì 6-03-2014 1 Multiplazione (multiplexing) nelle reti
Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea triennale in Informatica Sistemi operativi e reti A.A. 2013-14 Pietro Frasca Parte II Lezione 2 Giovedì 6-03-2014 1 Multiplazione (multiplexing) nelle reti
RETI DI CALCOLATORI - Reti locali
 Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Protocolli di accesso per reti locali Gruppo Reti TLC nome.cognome@polito.it http://www.telematica.polito.it/ RETI DI CALCOLATORI Reti locali - 1 Copyright Quest opera è protetta dalla licenza Creative
Corso di Reti di Telecomunicazioni. Giovanni Schembra. Trasmissione trame su canale broadcast
 Indirizzi LAN e ARP Corso di Reti di Telecomunicazioni Giovanni Schembra 1 Trasmissione trame su canale broadcast I nodi di una LAN si scambiano trame su un canale broadcast: quando un nodo in una LAN
Indirizzi LAN e ARP Corso di Reti di Telecomunicazioni Giovanni Schembra 1 Trasmissione trame su canale broadcast I nodi di una LAN si scambiano trame su un canale broadcast: quando un nodo in una LAN
Reti di calcolatori. Rete di calcolatori
 Operatore informatico giuridico Informatica Giuridica A.A 2006/2007 II Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi hardware
Operatore informatico giuridico Informatica Giuridica A.A 2006/2007 II Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi hardware
la trasmissione è regolata solamente dall algoritmo per il controllo del flusso prima di inviare l ACK.
 1. Considerare il problema della stima del Round Trip Time. Supporre che inizialmente RTT valga 200 ms. Il mittente invia un segmento e riceve l ACK relativo dopo 100 ms, quindi invia un altro segmento,
1. Considerare il problema della stima del Round Trip Time. Supporre che inizialmente RTT valga 200 ms. Il mittente invia un segmento e riceve l ACK relativo dopo 100 ms, quindi invia un altro segmento,
Elementi di Informatica e Programmazione
 Elementi di Informatica e Programmazione Le Reti di Calcolatori (parte 2) Corsi di Laurea in: Ingegneria Civile Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Brescia Docente: Daniela
Elementi di Informatica e Programmazione Le Reti di Calcolatori (parte 2) Corsi di Laurea in: Ingegneria Civile Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Brescia Docente: Daniela
Prova di Esame - Rete Internet (ing. Giovanni Neglia) Lunedì 24 Gennaio 2005, ore 15.00
 Prova di Esame - Rete Internet (ing. Giovanni Neglia) Lunedì 24 Gennaio 2005, ore 15.00 NB: alcune domande hanno risposta multipla: si richiede di identificare TUTTE le risposte corrette. Cognome: Nome:
Prova di Esame - Rete Internet (ing. Giovanni Neglia) Lunedì 24 Gennaio 2005, ore 15.00 NB: alcune domande hanno risposta multipla: si richiede di identificare TUTTE le risposte corrette. Cognome: Nome:
Lezione 8. Modi di Trasferimento. Gianluca Reali
 Lezione 8 Modi di Trasferimento Gianluca Reali Servizi di Rete COMMUTAZIONE DI CIRCUITO COMMUTAZIONE DI PACCHETTO Commutazione di Circuito FASE DI INSTAURAZIONE FASE DI TRASFERIMENTO DATI FASE DI SVINCOLO
Lezione 8 Modi di Trasferimento Gianluca Reali Servizi di Rete COMMUTAZIONE DI CIRCUITO COMMUTAZIONE DI PACCHETTO Commutazione di Circuito FASE DI INSTAURAZIONE FASE DI TRASFERIMENTO DATI FASE DI SVINCOLO
Comunicazione tra Computer. Protocolli. Astrazione di Sottosistema di Comunicazione. Modello di un Sottosistema di Comunicazione
 I semestre 03/04 Comunicazione tra Computer Protocolli Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica 2
I semestre 03/04 Comunicazione tra Computer Protocolli Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica 2
ITIS G. Fauser. Classe 4^ BI. Materia: Sistemi. Anno Scolastico 2013-2014. Docenti: prof.ssa Manuela Cesa, prof. Pasquale Pietrangelo
 ITIS G. Fauser Classe 4^ BI Materia: Sistemi Anno Scolastico 2013-2014 Docenti: prof.ssa Manuela Cesa, prof. Pasquale Pietrangelo Numero ore di lezione settimanali: 4 Testi adottati: - Materiale didattico
ITIS G. Fauser Classe 4^ BI Materia: Sistemi Anno Scolastico 2013-2014 Docenti: prof.ssa Manuela Cesa, prof. Pasquale Pietrangelo Numero ore di lezione settimanali: 4 Testi adottati: - Materiale didattico
5.2 ETHERNET Versione 2.0
 61 5.2 ETHERNET Versione 2.0 Lo standard Ethernet si colloca nei primi due livelli della pila OSI senza seguire gli standard IEEE 802 ed in particolare senza adottare il protocollo IEEE 802.2 LLC. La differenza
61 5.2 ETHERNET Versione 2.0 Lo standard Ethernet si colloca nei primi due livelli della pila OSI senza seguire gli standard IEEE 802 ed in particolare senza adottare il protocollo IEEE 802.2 LLC. La differenza
Fondamenti di Reti di Telecomunicazioni Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010
 Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda 1 1 (svolgere su questo foglio e sul retro) (7 punti) Si consideri la rete a commutazione
Prof. Guido Maier IV appello 8 febbraio 2010 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda 1 1 (svolgere su questo foglio e sul retro) (7 punti) Si consideri la rete a commutazione
Mariarosaria Napolitano. Architettura TCP/IP. Corso di: Laboratorio di tecnologie informatiche e telematiche
 Mariarosaria Napolitano Architettura TCP/IP Corso di: Laboratorio di tecnologie informatiche e telematiche Contesto e Prerequisiti Contesto E' rivolto agli studenti del V anno degli Istituti Tecnici Industriali
Mariarosaria Napolitano Architettura TCP/IP Corso di: Laboratorio di tecnologie informatiche e telematiche Contesto e Prerequisiti Contesto E' rivolto agli studenti del V anno degli Istituti Tecnici Industriali
Sistemi distribuiti e reti di calcolatori
 Sistemi distribuiti e reti di calcolatori 1 Indice Modulazione e trasmissione dei dati Reti di calcolatori Topologia Messaggi e protocolli ISO/OSI Ethernet Architettura client/server Telefonia mobile 2
Sistemi distribuiti e reti di calcolatori 1 Indice Modulazione e trasmissione dei dati Reti di calcolatori Topologia Messaggi e protocolli ISO/OSI Ethernet Architettura client/server Telefonia mobile 2
Le Reti Informatiche
 Le Reti Informatiche modulo 2 Prof. Salvatore Rosta www.byteman.it s.rosta@byteman.it 1 Commutazione di Circuito Le reti telefoniche utilizzano la tecnica della commutazione di circuito. I commutatori
Le Reti Informatiche modulo 2 Prof. Salvatore Rosta www.byteman.it s.rosta@byteman.it 1 Commutazione di Circuito Le reti telefoniche utilizzano la tecnica della commutazione di circuito. I commutatori
Lan Ethernet. Appunti a cura del prof. Mario Catalano
 Lan Ethernet Appunti a cura del prof. Mario Catalano Concetti di base Trasmissione in banda base (non modulata in frequenza) Codifica Manchester Metodo d accesso CSMA/CD Cablaggio : Regola del 5-4-3 (5
Lan Ethernet Appunti a cura del prof. Mario Catalano Concetti di base Trasmissione in banda base (non modulata in frequenza) Codifica Manchester Metodo d accesso CSMA/CD Cablaggio : Regola del 5-4-3 (5
Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione
 Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione Sorgenti di informazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche
Qualità di Servizio nelle Reti di Telecomunicazione Sorgenti di informazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche
Programma del corso. Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori
 Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
Programma del corso Introduzione Rappresentazione delle Informazioni Calcolo proposizionale Architettura del calcolatore Reti di calcolatori Evoluzione dei sistemi informatici Cos è una rete? Insieme di
Corso di Laurea in Informatica Esame di Reti Prof. Panzieri frame con source address uguale a MAC_UNI X X X X X
 Corso di Laurea in Informatica Esame di Reti Prof. Panzieri ESERCIZI - - - - - - - - - - - - - Esercizio 1 Dato un host dotato di una scheda di rete (network adaptor) per (802.3 (Ethernet), e con uno stack
Corso di Laurea in Informatica Esame di Reti Prof. Panzieri ESERCIZI - - - - - - - - - - - - - Esercizio 1 Dato un host dotato di una scheda di rete (network adaptor) per (802.3 (Ethernet), e con uno stack
Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti. PARTE I Introduzione e modelli 1. Capitolo 1 Introduzione 3
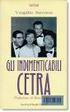 Prefazione Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti XIII XVII XIX PARTE I Introduzione e modelli 1 Capitolo 1 Introduzione 3 1.1 Comunicazione dati 3 1.2 Reti 6 1.3 Internet 12 1.4 Protocolli
Prefazione Prefazione all edizione italiana Descrizione dei contenuti XIII XVII XIX PARTE I Introduzione e modelli 1 Capitolo 1 Introduzione 3 1.1 Comunicazione dati 3 1.2 Reti 6 1.3 Internet 12 1.4 Protocolli
Test di verica per il corso di Reti di Telecomunicazioni
 Nome e Cognome Laurea Diploma in Test di verica per il corso di Reti di Telecomunicazioni 31/7/2003 1. La realizzazione asincrona di un servizio sincrono (segnare tutto ciò che è corretto) fa sì che l'allocazione
Nome e Cognome Laurea Diploma in Test di verica per il corso di Reti di Telecomunicazioni 31/7/2003 1. La realizzazione asincrona di un servizio sincrono (segnare tutto ciò che è corretto) fa sì che l'allocazione
Reti di Trasporto Ing. Stefano Salsano Slides - Blocco 5 La rete ISDN
 Reti di Trasporto Ing. Stefano Salsano Slides - Blocco 5 1 La rete ISDN 2 ISDN La ISDN è una rete digitale che, evolvendo dalla IDN di tipo telefonico, è in grado di offrire un'ampia gamma di applicazioni
Reti di Trasporto Ing. Stefano Salsano Slides - Blocco 5 1 La rete ISDN 2 ISDN La ISDN è una rete digitale che, evolvendo dalla IDN di tipo telefonico, è in grado di offrire un'ampia gamma di applicazioni
SUITE PROTOCOLLI TCP/IP ( I protocolli di Internet )
 PARTE 2 SUITE PROTOCOLLI TCP/IP ( I protocolli di Internet ) Parte 2 Modulo 1: Stack TCP/IP TCP/IP Protocol Stack (standard de facto) Basato su 5 livelli invece che sui 7 dello stack ISO/OSI Application
PARTE 2 SUITE PROTOCOLLI TCP/IP ( I protocolli di Internet ) Parte 2 Modulo 1: Stack TCP/IP TCP/IP Protocol Stack (standard de facto) Basato su 5 livelli invece che sui 7 dello stack ISO/OSI Application
Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE
 Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato su Datagram Algoritmi
Parte II - Reti di Calcolatori ed Internet IL LIVELLO RETE 3-1 Il Livello RETE Servizi del livello Rete Organizzazione interna Livello Rete basato su Circuito Virtuale Livello Rete basato su Datagram Algoritmi
Fondamenti di Internet e Reti. Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier
 Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier 4 - Livello Rete (parte ) Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier Strato di rete e strato di trasporto Lo strato di trasporto
Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier 4 - Livello Rete (parte ) Antonio Capone, Matteo Cesana, Ilario Filippini, Guido Maier Strato di rete e strato di trasporto Lo strato di trasporto
Introduzione. Il routing permette la comunicazione tra due nodi differenti anche se non sono collegati direttamente
 Routing Introduzione Il livello 3 della pila ethernet ha il compito di muovere i pacchetti dalla sorgente attraversando più sistemi Il livello di network deve quindi: Scegliere di volta in volta il cammino
Routing Introduzione Il livello 3 della pila ethernet ha il compito di muovere i pacchetti dalla sorgente attraversando più sistemi Il livello di network deve quindi: Scegliere di volta in volta il cammino
Reti di Calcolatori. Il software
 Reti di Calcolatori Il software Lo Stack Protocollare Application: supporta le applicazioni che usano la rete; Transport: trasferimento dati tra host; Network: instradamento (routing) di datagram dalla
Reti di Calcolatori Il software Lo Stack Protocollare Application: supporta le applicazioni che usano la rete; Transport: trasferimento dati tra host; Network: instradamento (routing) di datagram dalla
Elementi di Informatica e Programmazione
 Elementi di Informatica e Programmazione Le Reti di Calcolatori (parte 2) Corsi di Laurea in: Ingegneria Civile Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Brescia Docente: Daniela
Elementi di Informatica e Programmazione Le Reti di Calcolatori (parte 2) Corsi di Laurea in: Ingegneria Civile Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Università degli Studi di Brescia Docente: Daniela
Le Reti Informatiche
 Le Reti Informatiche modulo 4 Prof. Salvatore Rosta www.byteman.it s.rosta@byteman.it 1 Lo Standard TCP/IP: 1 Nasce dall esigenza di creare uno standard per le reti a livello mondiale che si possa adattare
Le Reti Informatiche modulo 4 Prof. Salvatore Rosta www.byteman.it s.rosta@byteman.it 1 Lo Standard TCP/IP: 1 Nasce dall esigenza di creare uno standard per le reti a livello mondiale che si possa adattare
Rete: classificazione in funzione della distanza fra due generici elementi
 Rete: classificazione in funzione della distanza fra due generici elementi WAN: Wide Area Network MAN: Metropolitan Area Network LAN: Local Area Network 1 Distanza - velocità 2 WAN Topologia tipica a maglia
Rete: classificazione in funzione della distanza fra due generici elementi WAN: Wide Area Network MAN: Metropolitan Area Network LAN: Local Area Network 1 Distanza - velocità 2 WAN Topologia tipica a maglia
Fondamenti di Reti di Telecomunicazioni Prof. Guido Maier III appello 4 settembre 2009
 Prof. Guido Maier III appello 4 settembre 2009 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda (svolgere su questo foglio e sul retro) (8 punti) Una sorgente, osservata nell intervallo
Prof. Guido Maier III appello 4 settembre 2009 Cognome e nome: Matricola: (stampatello) (firma leggibile) Domanda (svolgere su questo foglio e sul retro) (8 punti) Una sorgente, osservata nell intervallo
Internet protocol stack
 Protocolli stratificati (Intro III Parte) Le reti sono complesse! olte parti : host router Link su mezzi diversi protocol hardware, software Domanda: Che speranza abbiamo di organizzare la struttura della
Protocolli stratificati (Intro III Parte) Le reti sono complesse! olte parti : host router Link su mezzi diversi protocol hardware, software Domanda: Che speranza abbiamo di organizzare la struttura della
MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI
 MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia METODI DI MULTIPLAZIONE TDM
MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO NEI SISTEMI TRASMISSIVI Prof. Ing. Maurizio Casoni Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia METODI DI MULTIPLAZIONE TDM
Reti di Calcolatori: nozioni generali il modello a livelli
 Reti di Calcolatori: nozioni generali il modello a livelli Percorso di Preparazione agli Studi di Ingegneria Università degli Studi di Brescia Docente: Massimiliano Giacomin Elementi di Informatica e Programmazione
Reti di Calcolatori: nozioni generali il modello a livelli Percorso di Preparazione agli Studi di Ingegneria Università degli Studi di Brescia Docente: Massimiliano Giacomin Elementi di Informatica e Programmazione
RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE
 RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE Prof. PIER LUCA MONTESSORO Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine 1999 Pier Luca Montessoro (si veda la nota a pagina 2) 1 Nota di Copyright
RETI DI CALCOLATORI E APPLICAZIONI TELEMATICHE Prof. PIER LUCA MONTESSORO Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Udine 1999 Pier Luca Montessoro (si veda la nota a pagina 2) 1 Nota di Copyright
La tecnologia Ethernet
 Livello 1 Il livello 1 si occupa della trasmissione dei dati trasmormandoli in segnali fisici, a questo livello l'unità di informazione è di tipo binario, la codifica è di tipo Manchester. La sequenza
Livello 1 Il livello 1 si occupa della trasmissione dei dati trasmormandoli in segnali fisici, a questo livello l'unità di informazione è di tipo binario, la codifica è di tipo Manchester. La sequenza
5. Fondamenti di Internet e Reti Esercizi. 5. Esercizi sul Livello di Linea e Reti Locali Esercizio TDM
 5. sul Livello di Linea e Reti Locali 5.1. o TM Un sistema di multiplazione TM presenta una trama di N=10 slot e in ciascuno slot vengono trasmessi k=128 bit. Se il sistema è usato per multiplare 10 canali
5. sul Livello di Linea e Reti Locali 5.1. o TM Un sistema di multiplazione TM presenta una trama di N=10 slot e in ciascuno slot vengono trasmessi k=128 bit. Se il sistema è usato per multiplare 10 canali
Reti di calcolatori. Lezione del 17 giugno 2004
 Reti di calcolatori Lezione del 17 giugno 2004 TCP/IP e ISO/OSI Architettura TCP/IP APPLICATION TELNET FTP DNS NFS DNS RPC SNMP TRANSPORT TCP UDP NETWORK ARP RARP DATA LINK (LLC MAC) Protocollo IP Protocollo
Reti di calcolatori Lezione del 17 giugno 2004 TCP/IP e ISO/OSI Architettura TCP/IP APPLICATION TELNET FTP DNS NFS DNS RPC SNMP TRANSPORT TCP UDP NETWORK ARP RARP DATA LINK (LLC MAC) Protocollo IP Protocollo
Reti Geografiche. Silvano GAI
 Reti Geografiche Silvano GAI Silvano.Gai@polito.it http://www.polito.it/~silvano WAN - 1 Copyright: si veda nota a pag. 2 Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slides) è protetto
Reti Geografiche Silvano GAI Silvano.Gai@polito.it http://www.polito.it/~silvano WAN - 1 Copyright: si veda nota a pag. 2 Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slides) è protetto
Una definizione di rete
 Una definizione di rete Una moderna rete di calcolatori può essere definita come: UN INSIEME INTERCONNESSO DI CALCOLATORI AUTONOMI Componenti delle reti Come è fatta una rete di calcolatori? Componenti
Una definizione di rete Una moderna rete di calcolatori può essere definita come: UN INSIEME INTERCONNESSO DI CALCOLATORI AUTONOMI Componenti delle reti Come è fatta una rete di calcolatori? Componenti
RETI DI CALCOLATORI. Domande di riepilogo Quarta Esercitazione. Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway?
 RETI DI CALCOLATORI Domande di riepilogo Quarta Esercitazione Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway? Bridge, Router e Gateway servono ad interconnettere reti diverse (internetworking).
RETI DI CALCOLATORI Domande di riepilogo Quarta Esercitazione Quali sono le differenze tra Bridge, Router e Gateway? Bridge, Router e Gateway servono ad interconnettere reti diverse (internetworking).
Collegamento dati per accesso ad Internet. Informatica Generale (CdL in E&C), A.A Informatica Generale (CdL in E&C), A.A.
 Collegamento dati per accesso ad Internet Sono in uso due protocolli (supportati da Windows e da tutti i S.O. più diffusi) SLIP (Serial Line IP) è il più vecchio ed ha molti inconvenienti PPP (Point to
Collegamento dati per accesso ad Internet Sono in uso due protocolli (supportati da Windows e da tutti i S.O. più diffusi) SLIP (Serial Line IP) è il più vecchio ed ha molti inconvenienti PPP (Point to
Bit Rate = 8.000 * 8 = 64 kbit/s
 Voice over IP e Telephony over IP architetture, protocolli e quality of service B Codifica segnale nelle reti POTS Richiami sulle reti di TLC Convertitore A/D 10110000000000011111101001101101 Segnale analogico
Voice over IP e Telephony over IP architetture, protocolli e quality of service B Codifica segnale nelle reti POTS Richiami sulle reti di TLC Convertitore A/D 10110000000000011111101001101101 Segnale analogico
Sottolivello MAC - Medium Access Protocol
 Sottolivello MAC - Medium Access Protocol Sottolivello del data link Regola l accesso al mezzo per reti broadcast LAN e WAN satellitari allocazione statica - a priori allocazione dinamica - in base allo
Sottolivello MAC - Medium Access Protocol Sottolivello del data link Regola l accesso al mezzo per reti broadcast LAN e WAN satellitari allocazione statica - a priori allocazione dinamica - in base allo
Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni. Esercitazioni del corso di. Telecomunicazioni
 Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni Esercitazioni del corso di Telecomunicazioni Corso di laurea in Ingegneria Gestionale Anno Accademico 2013-2014 Ing. Alfonso
Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni Esercitazioni del corso di Telecomunicazioni Corso di laurea in Ingegneria Gestionale Anno Accademico 2013-2014 Ing. Alfonso
Reti. insieme di computer (host) interconnessi. Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile
 Reti Rete insieme di computer (host) interconnessi Tipologie interconnessioni Ad anello (token ring). Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile i pacchetti di dati possono girare
Reti Rete insieme di computer (host) interconnessi Tipologie interconnessioni Ad anello (token ring). Token evita conflitti di trasmissione Rete più o meno affidabile i pacchetti di dati possono girare
Mettiamo i puntini sulle i. 5 min. per pensare 5 min. per discutere la soluzione
 Mettiamo i puntini sulle i 5 min. per pensare 5 min. per discutere la soluzione 1. Ritardi di propagazione e trasmissione Trasmissione audio da A a B con link a 1Mbps A converte al volo la voce in un flusso
Mettiamo i puntini sulle i 5 min. per pensare 5 min. per discutere la soluzione 1. Ritardi di propagazione e trasmissione Trasmissione audio da A a B con link a 1Mbps A converte al volo la voce in un flusso
- Dispensa VI - RETI DI CALCOLATORI
 Elementi di Informatica e Programmazione - Dispensa VI - RETI DI CALCOLATORI Alessandro Saetti (email: alessandro.saetti@unibs.it) Università degli Studi di Brescia 1 Classificazione delle Reti Modalità
Elementi di Informatica e Programmazione - Dispensa VI - RETI DI CALCOLATORI Alessandro Saetti (email: alessandro.saetti@unibs.it) Università degli Studi di Brescia 1 Classificazione delle Reti Modalità
Funzioni di una rete di TLC Segnalazione Commutazione Trasmissione Gestione. Funzioni. Funzioni. Segalazione d utente.
 CCITT: in una rete tlc: operazioni svolte all interno di una rete al fine di offrire servizi di una rete di TLC Segnalazione Commutazione Trasmissione Gestione Segnalazione Segalazione d utente Definizione
CCITT: in una rete tlc: operazioni svolte all interno di una rete al fine di offrire servizi di una rete di TLC Segnalazione Commutazione Trasmissione Gestione Segnalazione Segalazione d utente Definizione
MULTIPLAZIONE PCM MULTIPLAZIONE PCM 2
 MULTIPLAZIONE PCM Discrete Pulse Modulation La discretizzazione dell asse temporale è effettuata mediante una serie di impulsi equispaziati nel tempo L ampiezza, la posizione o la durata degli impulsi
MULTIPLAZIONE PCM Discrete Pulse Modulation La discretizzazione dell asse temporale è effettuata mediante una serie di impulsi equispaziati nel tempo L ampiezza, la posizione o la durata degli impulsi
ISO- OSI e architetture Client-Server
 LEZIONE 9 ISO- OSI e architetture Client-Server Proff. Giorgio Valle Raffaella Folgieri giorgio.valle@unimi.it folgieri@dico.unimi.it Lez 10 modello ISO-OSI e architettura client-server 1 Nelle scorse
LEZIONE 9 ISO- OSI e architetture Client-Server Proff. Giorgio Valle Raffaella Folgieri giorgio.valle@unimi.it folgieri@dico.unimi.it Lez 10 modello ISO-OSI e architettura client-server 1 Nelle scorse
MODELLI ISO/OSI e TCP/IP
 D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 1 Reti di Calcolatori MODELLI ISO/OSI e TCP/IP D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 2 Reti di Calcolatori Livelli e Servizi Il modello OSI Il modello TCP/IP Un confronto
D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 1 Reti di Calcolatori MODELLI ISO/OSI e TCP/IP D. Talia RETI DI CALCOLATORI - UNICAL 2 Reti di Calcolatori Livelli e Servizi Il modello OSI Il modello TCP/IP Un confronto
Interconnessione di reti IP
 Interconnessione di reti IP Mario Baldi mario.baldi@polito.it staff.polito.it/mario.baldi Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slide) è protetto dalle leggi sul copyright
Interconnessione di reti IP Mario Baldi mario.baldi@polito.it staff.polito.it/mario.baldi Nota di Copyright Questo insieme di trasparenze (detto nel seguito slide) è protetto dalle leggi sul copyright
Il livello Data-Link e i suoi protocolli
 Il livello Data-Link e i suoi protocolli Modulo 5 (Integrazione) Livello Data-Link Abbiamo visto che il Livello Data link provvede a: o offrire servizi al livello network con un'interfaccia ben definita;
Il livello Data-Link e i suoi protocolli Modulo 5 (Integrazione) Livello Data-Link Abbiamo visto che il Livello Data link provvede a: o offrire servizi al livello network con un'interfaccia ben definita;
Lezione 2. Modi di Trasferimento. Gianluca Reali
 Lezione 2 Modi di Trasferimento Gianluca Reali Servizi di Rete COMMUTAZIONE DI CIRCUITO COMMUTAZIONE DI PACCHETTO Commutazione di Circuito FASE DI INSTAURAZIONE FASE DI TRASFERIMENTO DATI FASE DI SVINCOLO
Lezione 2 Modi di Trasferimento Gianluca Reali Servizi di Rete COMMUTAZIONE DI CIRCUITO COMMUTAZIONE DI PACCHETTO Commutazione di Circuito FASE DI INSTAURAZIONE FASE DI TRASFERIMENTO DATI FASE DI SVINCOLO
Reti SWITCHED LAN FULL DUPLEX (IEEE 802.3x)
 Reti SWITCHED LAN FULL DUPLEX (IEEE 02.3x) Docente: Vincenzo Eramo La Rete Logica/Fisica End Station I terminali della rete so deminati End Station I di di commutazione so deminati Page 1 E senza connessione
Reti SWITCHED LAN FULL DUPLEX (IEEE 02.3x) Docente: Vincenzo Eramo La Rete Logica/Fisica End Station I terminali della rete so deminati End Station I di di commutazione so deminati Page 1 E senza connessione
Introduzione alle Reti Telematiche Centro Multimediale Montiferru
 Domande di verifica: Standard IEEE 802.2, IEEE802.3 1. I protocolli di sottolivello MAC (Medium Access Control) hanno lo scopo A. di permettere la condivisione di un canale punto-punto B. di permettere
Domande di verifica: Standard IEEE 802.2, IEEE802.3 1. I protocolli di sottolivello MAC (Medium Access Control) hanno lo scopo A. di permettere la condivisione di un canale punto-punto B. di permettere
I modelli di riferimento ISO OSI e TCP-IP
 Gli Standards I modelli di riferimento ISO OSI e TCP-IP Dipartimento ICT Istituto e Liceo tecnico statale di Chiavari 2004 prof. Roberto Bisceglia ISO: International Standards Organization. ANSI: American
Gli Standards I modelli di riferimento ISO OSI e TCP-IP Dipartimento ICT Istituto e Liceo tecnico statale di Chiavari 2004 prof. Roberto Bisceglia ISO: International Standards Organization. ANSI: American
ISDN. Generalità. Anni 70 Utilizzare al meglio le strutture di rete disponibili Accesso unificato da parte degli utenti
 ISDN Generalità ISDN: Integrated Service Digital Network Anni 70 Utilizzare al meglio le strutture di rete disponibili Accesso unificato da parte degli utenti Fonia a commutazione di circuito Dati a bassa
ISDN Generalità ISDN: Integrated Service Digital Network Anni 70 Utilizzare al meglio le strutture di rete disponibili Accesso unificato da parte degli utenti Fonia a commutazione di circuito Dati a bassa
Reti di Calcolatori ed Internet. Reti di Calcolatori ed Internet. Reti di Calcolatori. Reti di Calcolatori. Architettura dei Servizi di Rete
 Reti di Calcolatori ed Internet Reti di Calcolatori ed Internet Corso di Informatica Generale (Roberto BASILI) Teramo, 13 Dicembre, 2000 Architettura dei Servizi di Rete Collegamenti Internet ed i Servizi
Reti di Calcolatori ed Internet Reti di Calcolatori ed Internet Corso di Informatica Generale (Roberto BASILI) Teramo, 13 Dicembre, 2000 Architettura dei Servizi di Rete Collegamenti Internet ed i Servizi
Protocolli di accesso multiplo
 Protocolli di accesso multiplo Quando l accesso ad una risorsa può avvenire da parte di più utenti indipendenti, si parla di risorsa condivisa ed è necessaria l implementazione di particolari protocolli
Protocolli di accesso multiplo Quando l accesso ad una risorsa può avvenire da parte di più utenti indipendenti, si parla di risorsa condivisa ed è necessaria l implementazione di particolari protocolli
LE RETI DI COMPUTER. Il modello ISO/OSI Prima parte
 LE RETI DI COMPUTER Il modello ISO/OSI Prima parte I MODELLI PER LE RETI All i izio dell era i for ati a, la gestio e delle comunicazioni tra sistemi si era rilevata uno dei problemi più grandi, soprattutto
LE RETI DI COMPUTER Il modello ISO/OSI Prima parte I MODELLI PER LE RETI All i izio dell era i for ati a, la gestio e delle comunicazioni tra sistemi si era rilevata uno dei problemi più grandi, soprattutto
Standard per Reti a Commutazione di Pacchetto Prof. Vincenzo Auletta Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
 I semestre 03/04 Standard per Reti a Commutazione di Pacchetto Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Standard per Reti a Pacchetto Principali standard
I semestre 03/04 Standard per Reti a Commutazione di Pacchetto Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Standard per Reti a Pacchetto Principali standard
Introduzione alle Reti di Telecomunicazione
 Sorgenti informazione Qualità Servizio nelle Reti Telecomunicazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche (o numerizzate):
Sorgenti informazione Qualità Servizio nelle Reti Telecomunicazione analogiche: voce, video caratterizzate dalle loro caratteristiche spettrali (occupazione in banda, correlazione,...) numeriche (o numerizzate):
Prestazioni di LAN. Parametri caratterizzanti la LAN
 Prestazioni di LAN N. 1 Parametri caratterizzanti la LAN F lunghezza della trama C velocità di trasmissione sul mezzo d massima distanza fra due stazioni della LAN v velocità di propagazione del segnale
Prestazioni di LAN N. 1 Parametri caratterizzanti la LAN F lunghezza della trama C velocità di trasmissione sul mezzo d massima distanza fra due stazioni della LAN v velocità di propagazione del segnale
M286 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE. Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI CORSO DI ORDINAMENTO. Tema di: TELECOMUNICAZIONI
 M286 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI CORSO DI ORDINAMENTO Tema di: TELECOMUNICAZIONI Traccia n 2 Sessione ordinaria 2000 Seconda prova scritta
M286 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI CORSO DI ORDINAMENTO Tema di: TELECOMUNICAZIONI Traccia n 2 Sessione ordinaria 2000 Seconda prova scritta
Capitolo 1 - parte 2. Corso Reti ed Applicazioni Mauro Campanella
 Capitolo 1 - parte 2 Corso Reti ed Applicazioni Mauro Campanella Modello a strati 5 4 applicazione trasporto Il modello che useremo prevede 5 strati che svolgono servizi per gli altri strati attraverso
Capitolo 1 - parte 2 Corso Reti ed Applicazioni Mauro Campanella Modello a strati 5 4 applicazione trasporto Il modello che useremo prevede 5 strati che svolgono servizi per gli altri strati attraverso
Reti di calcolatori. Rete di calcolatori
 Operatore Informatico Giuridico Informatica Giuridica di Base A.A 2004/2005 I Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi
Operatore Informatico Giuridico Informatica Giuridica di Base A.A 2004/2005 I Semestre Reti di calcolatori prof. Monica Palmirani Rete di calcolatori Le reti di calcolatori sono un insieme di dispositivi
Reti di Calcolatori Servizi di Rete Laboratorio di Didattica in Rete
 Reti di Calcolatori Servizi di Rete Laboratorio di Didattica in Rete Reti di calcolatori Protocolli di Trasmissione: Il modello ISO/OSI L architettura TCP/IP Protocolli di trasmissione Un protocollo di
Reti di Calcolatori Servizi di Rete Laboratorio di Didattica in Rete Reti di calcolatori Protocolli di Trasmissione: Il modello ISO/OSI L architettura TCP/IP Protocolli di trasmissione Un protocollo di
Commutazione di pacchetto
 Commutazione di pacchetto Tecniche di commutazione Le principali sono: Commutazione di circuito Rete telefonica Commutazione di pacchetto Servizio datagram Servizio orientato alla connessione Esempi di
Commutazione di pacchetto Tecniche di commutazione Le principali sono: Commutazione di circuito Rete telefonica Commutazione di pacchetto Servizio datagram Servizio orientato alla connessione Esempi di
LA RETE ISDN A BANDA STRETTA
 LA RETE ISDN A BANDA STRETTA La rete ISDN (Integrated Services Digital Network) e' una rete numerica integrata nelle tecniche e nei servizi. Consente all'utente di avere un unico tipo di accesso per tutti
LA RETE ISDN A BANDA STRETTA La rete ISDN (Integrated Services Digital Network) e' una rete numerica integrata nelle tecniche e nei servizi. Consente all'utente di avere un unico tipo di accesso per tutti
Corso di Alfabetizzazione Informatica
 Corso di Alfabetizzazione Informatica Lezione 8 Francesco Fontanella Una definizione di Rete Una moderna rete di calcolatori può essere definita come: UN INSIEME INTERCONNESSO DI CALCOLATORI AUTONOMI Tipi
Corso di Alfabetizzazione Informatica Lezione 8 Francesco Fontanella Una definizione di Rete Una moderna rete di calcolatori può essere definita come: UN INSIEME INTERCONNESSO DI CALCOLATORI AUTONOMI Tipi
LIVELLO DATA LINK (DI LINEA)
 LIVELLO DATA LINK (DI LINEA) 1 TRASMISSIONE 2 FRAMING 3 CONTROLLO DEGLI ERRORI 4 CONTROLLO DI FLUSSO 1 Asincrona 2 Sincrona 1 Orientata al byte 2 Orientata al bit 1 Codici correttori 2 Codici Rivelatori
LIVELLO DATA LINK (DI LINEA) 1 TRASMISSIONE 2 FRAMING 3 CONTROLLO DEGLI ERRORI 4 CONTROLLO DI FLUSSO 1 Asincrona 2 Sincrona 1 Orientata al byte 2 Orientata al bit 1 Codici correttori 2 Codici Rivelatori
Esercitazione. Livello di Trasporto [Capitolo 3]
![Esercitazione. Livello di Trasporto [Capitolo 3] Esercitazione. Livello di Trasporto [Capitolo 3]](/thumbs/39/19153082.jpg) Esercitazione Livello di Trasporto [Capitolo 3] 1 È possibile che un'applicazione che gira su UDP ottenga un trasferimento dati affidabile? Si. Lo sviluppatore dell'applicazione può inserire il trasferimento
Esercitazione Livello di Trasporto [Capitolo 3] 1 È possibile che un'applicazione che gira su UDP ottenga un trasferimento dati affidabile? Si. Lo sviluppatore dell'applicazione può inserire il trasferimento
Dispositivi di Rete. Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni
 Dispositivi di Rete Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Strumenti hardware per la realizzazione di reti locali Per risolvere le problematiche di interconnessione delle reti
Dispositivi di Rete Prof. Francesco Accarino IIS Altiero Spinelli Sesto San Giovanni Strumenti hardware per la realizzazione di reti locali Per risolvere le problematiche di interconnessione delle reti
1. Introduzione alle Reti di TLC
 Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 1 1. Introduzione alle Reti di TL Prof. Raffaele olla ompito della rete è: INTERONNETTERE più apparati o utenti per permettere
Università di Genova Facoltà di Ingegneria Reti di Telecomunicazioni e Telemedicina 1 1. Introduzione alle Reti di TL Prof. Raffaele olla ompito della rete è: INTERONNETTERE più apparati o utenti per permettere
Reti a Commutazione Tecniche di Commutazione
 I semestre 04/05 Reti a Commutazione Tecniche di Commutazione Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
I semestre 04/05 Reti a Commutazione Tecniche di Commutazione Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
Reti a Commutazione. Commutazione di Circuito. Esempio di Rete a Commutazione. Elementi di una Rete a Commutazione
 I semestre 03/04 Reti a Commutazione Commutazione di Circuito Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
I semestre 03/04 Reti a Commutazione Commutazione di Circuito Prof. Vincenzo Auletta auletta@dia.unisa.it http://www.dia.unisa.it/professori/auletta/ Università degli studi di Salerno Laurea in Informatica
