VITTORIO MELA LA DATAZIONE DELLA CERAMICA C O N OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO
|
|
|
- Erica Bellini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 VITTORIO MELA LA DATAZIONE DELLA CERAMICA C O N OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO
2
3 L argom ento è generale nel senso che non è che abbia a che fare esclusivam ente con la ceramica albisolese e savonese, ma si adatta alla ceramica in genere. Il problema della datazione della ceramica è sempre stato direi un problem a molto difficile da risolversi in quanto questi prodotti per la loro natura non prendono la patina dell antico: un oggetto di maiolica, qualunque esso sia, anche la semplice terracotta o la porcellana, o il gres, conserva per anni e per secoli se conservato bene le caratteristiche che aveva a ll atto della fabbricazione. Infatti appare come un oggetto attuale, con nessuna differenza apparentemente visibile. M aneggiando casualmente le mie ceramiche e specialmente i vasi da farmacia d ella m ia collezione, ho trovato una frattura casuale dello smalto: osservando questa al microscopio a forte ingrandimento ho intravveduto la possibilità d i notare alcune differenze tra oggetti di vecchia produzione ed oggetti m oderni. Il confronto fatto su frammenti di ceramica di epoche molto diverse m i ha fatto evidenziare qualche piccola differenza e mi ha indotto ad osservare più attentamente le modifiche ed a farne oggetto di studio. U no stud io limitato perchè è evidente che siamo soltanto degli appassionati collezionisti e non sappiamo dedicare troppo tempo a questo argom ento. Ho notato che provocando artificialmente la frattura sulla vetrina di copertura, si possono osservare alcuni comportamenti diversi che interessano q u ella che si potrebbe chiamare l anatomia dell epidermide. La rottura viene praticata con la tecnica che andrò descrivendo: ciò che si o sserva nel focolaio di rottura presenta caratteristiche che, a seconda d e ll e tà del pezzo in esame,, sono differenti l una dall altra. Non ho la pretesa di aver scoperto nulla di particolare, comunque sottopongo ben volentieri i miei risultati alla critica di chi vuole occuparsi di q u esto argomento o magari bocciarlo. Con uno strumento a punta in acciaio si produce una soluzione di continuo sullo smalto, preferibilmente dove esiste già una traccia di vena 249 -
4 tura e dove c è una colorazione scura: non bianca perchè in tal caso il risultato è confuso e non si osserva con evidenza. Per procedere adopero un punteruolo in acciaio, molto acuminato, ma a punta terminale tondeggiante. Con questo strumento procuro una piccolissima frattura superficiale, con l avvertenza di non strofinare il punto fratturato, perchè le briciole di smalto scheggiato non vengano rimosse: proprio dal modo in cui esse si dispongono al momento della percussione, dipende la possibilità di attribuire l età dell oggetto in esame. La differenza di comportamento si nota molto bene dalle diapositive che ho allestito. Sono riproduzioni fotografiche particolari, molto indaginose e costose perchè ho dovuto far allestire un apparecchio illuminante speciale per l oggetto che è a quindici millimetri di distanza dal microscopio. E pure assai difficile illuminare convenientemente il fondo del focolaio di frattura se si tien conto che si deve sempre impiegare la sorgente luminosa tangenzialmente. Premetto che dai risultati da me ottenuti, oltre un certo tempo (cioè oltre il 400) la risposta all indagine microscopica è uniforme. Tutt al più si può valutare, ma ciò è estraneo al metodo di cui vi parlo, il diverso spessore dello smalto che ricopre la maiolica. Secondo alcuni per esempio più si va indietro nel tempo e maggiore è lo spessore realizzato nello smalto. Comunque con l impiego del metodo che illustro è anche possibile valutare lo spessore dello smalto, infatti la proprietà riflettente della vetrina consente di poter vedere con l illuminazione tangenziale da me proposta, lo spessore della vetrina stessa. E questione di valutare l andamento del raggio di luce riflessa che naturalmente varia con lo spessore: è un metodo assai semplice che è basato su un occhio molto esercitato. Col sistema che ho studiato io invece posso vedere sia il grado di profondità, che le caratteristiche di frattura: a seconda dell epoca in cui è stato fabbricato il manufatto, si avrà un comportamento diverso. E veniamo ora alla descrizione del metodo: pratico, come ho detto, una piccola frattura sulla vernice nel punto stabilito ed osservo al microscopio a circa 120 ingrandimenti. Anche a ingrandimenti posso ottenere una maggior profondità di fuoco. Se la frattura è stata fatta su una maiolica antica, ad esempio del 400, all osservazione col microscopio la soluzione di continuo appare pastosa: si nota chiaramente che la parte rotta si è polverizzata in tanti minuti frammentini che si sono depositati attorno al focolaio. Se ripetiamo l esperimento su una maiolica di fabbricazione recente, ad esempio su un albarello realizzato anni or sono, vedremo che la parte vetrosa colpita dalla punta non si polve 250
5 rizza e quindi non compare al controllo microscopico. Questa diversità di com portam ento deriverebbe secondo me da un diverso stadio di cristallizzazione d e lla vetrina, dipendente dalla stagionatura. L esperim ento è stato da me condotto su ceramiche di epoche diverse, ma di accertato anno di fabbricazione, allo scopo di convalidare la persistenza del reperto. Ho proceduto sempre con lo stesso metodo, ottenendo il focolaio d i frattura del diametro di poco meno di mezzo millimetro ed ho notato ch e, entro certi lim iti, più la ceramica è vecchia e maggiore è la produzione di frammentini che si dispongono ad alone attorno al focolaio intenzionalm ente prodotto. Non ho la pretesa di aver trovato un sistema perfetto per ottenere la datazione d ella ceramica: io stesso non so darmi ragione completa di quanto ho n o tato. Ritengo comunque interessante il metodo che propongo a ll attenzione degli studiosi per gli eventuali perfezionamenti, allo 'scopo di ren d erlo più attendibile. Purtroppo ho eseguito una sola diapositiva per ogn i esperimento: è opportuno disporre di una serie di fotografie per ogni rottura provocata, allo scopo di poter evidenziare il comportamento d el traum a in diversi strati, ma soprattutto su quelli superficiali, onde p o ter valutare anche lo spessore della vernice di copertura. PESCE DISCUSSIONE Il m etodo descritto dal prof. Mela, che da appassionato raccoglitore di maioliche scruta da anni le tracce del tempo sulle superfici dello smalto, merita a mio giudizio di essere approfondito e documentato. L Oratore ha svolto le sue ricerche su due d irettrici distinte: la prima tiene conto del grado di durezza dello smalto e del colore sottostan te, la seconda sul grado di friabilità dello smalto stesso alla percussione. Durezza e friabilità si comporterebbero diversamente a seconda dell epoca di fabbricazione d ella ceramica allo studio. C è da chied ersi a mio avviso se la risposta diversa dipenda unicamente dalla età della m aiolica o se non si debbano tener presenti altri fattori che al di fuori del tempo possono alterare chimicamente le vernici e gli smalti. Nel caso di ceramiche p ro ven ien ti da scavo il contatto del terreno e l eventuale presenza di sali non possono con tribuire a modificare il modo di comportarsi? Circa la documentazione iconografica riterrei opportuno procedere all allestimento di un certo numero di fotografie seriate per ciascun esperimento in modo da riprodurre con maggiori dettagli l effetto del trauma provocato dalla punta di acciaio. S oltan to con questo accorgimento, oppure con la documentazione cinematografica, sarà, credo, possibile documentare con maggior attendibilità il reperto ottenuto
6 MANNONI Il metodo descritto merita molta considerazione: occorrerebbe però poter controllare, dal punto di vista fisico-chimico, l efficacia deh esperimento e questo si potrebbe fare dal momento che, in teoria, se la vernice cristallina è recente, ha una frattura concoide; se è di antica data, per trasformazioni subite col tempo, si spappola. Bisognerebbe quindi cercare di stabilire quale è il limite di determinazione e costruire con prove sistematiche su diversi campioni, una tabella della devetrificazione. MELA Di fronte alle argomentazioni che sono state fatte debbo aggiungere che non ho assolutamente la pretesa di considerare decisivo il metodo che ho descritto. Ricordo ancora una volta che le mie ricerche sono incomplete anche per il motivo che non mi è stato ancora possibile perfezionarle. Ho voluto soltanto dimostrare che quando si provoca una piccola frattura sullo smalto che ricopre la maiolica, si possono osservare differenze di comportamento che, secondo la mia modesta esperienza, dipenderebbero dal diverso stato di stagionatura dell esemplare in esame.
Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che esprime la forza agente tra due atomi
 Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che esprime la forza agente tra due atomi contiene le informazioni fondamentali per l elasticità
Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che esprime la forza agente tra due atomi contiene le informazioni fondamentali per l elasticità
I raggi luminosi. Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce. il modello ondulatorio (Christiaan Huygens)
 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) * la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan Huygens) *
I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) * la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan Huygens) *
Greco " Cheramos " = Argilla
 LA TERRACOTTA LA CERAMIICA E LA PORCELLANA Greco " Cheramos " = Argilla Piccola Guida a cura di Francesco Mian La porcellana appartiene al gruppo delle ceramiche e per ceramica si deve intendere ogni oggetto
LA TERRACOTTA LA CERAMIICA E LA PORCELLANA Greco " Cheramos " = Argilla Piccola Guida a cura di Francesco Mian La porcellana appartiene al gruppo delle ceramiche e per ceramica si deve intendere ogni oggetto
Un osso umano visto al microscopio di Andrea Bosi (Giugno 2012)
 Un osso umano visto al microscopio di Andrea Bosi (Giugno 2012) Prendiamo un osso di un qualsiasi mammifero, uomo compreso, sezioniamolo trasversalmente e riduciamolo ad una fettina di pochi micron, addirittura
Un osso umano visto al microscopio di Andrea Bosi (Giugno 2012) Prendiamo un osso di un qualsiasi mammifero, uomo compreso, sezioniamolo trasversalmente e riduciamolo ad una fettina di pochi micron, addirittura
RAPPORTO DI PROVA R
 RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
RAPPORTO DI PROVA DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE, DELLA RESISTENZA AL GELO E DELLA RESISTENZA A FLESSIONE AL TERMINE DEI 100 CICLI DI GELO/DISGELO DEL PRODOTTO COTTO DI FORNACE DELLA DITTA
Microscopia Elettronica
 Microscopia Elettronica Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 1 La microscopia elettronica a scansione (SEM) con microanalisi elementale La sorgente luminosa è data da un fascio
Microscopia Elettronica Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 1 La microscopia elettronica a scansione (SEM) con microanalisi elementale La sorgente luminosa è data da un fascio
Le attività pratiche e didattiche di laboratorio
 Museo della Tuscia Rupestre Francesco Spallone Naturalistico - Storico - Etnografico Le attività pratiche e didattiche di laboratorio In collaborazione con: Comune di Barbarano Romano Sistema Regionale
Museo della Tuscia Rupestre Francesco Spallone Naturalistico - Storico - Etnografico Le attività pratiche e didattiche di laboratorio In collaborazione con: Comune di Barbarano Romano Sistema Regionale
Osservare quel che non si vede La MICROSCOPIA
 Osservare quel che non si vede La MICROSCOPIA La Biologia è un campo ricco di immagini. Molti dei fenomeni biologici e strutture non sono visibili dall 'occhio umano senza un aiuto. Infatti, l'occhio umano
Osservare quel che non si vede La MICROSCOPIA La Biologia è un campo ricco di immagini. Molti dei fenomeni biologici e strutture non sono visibili dall 'occhio umano senza un aiuto. Infatti, l'occhio umano
La scelta dello stereo microscopio e dei suoi accessori
 La scelta dello stereo microscopio e dei suoi accessori Andrea Bosi, gennaio 2012 I primi problemi nascono già al momento della scelta: di tipo CMO o di tipo Greenough? Tra i moderni sono certo più diffusi
La scelta dello stereo microscopio e dei suoi accessori Andrea Bosi, gennaio 2012 I primi problemi nascono già al momento della scelta: di tipo CMO o di tipo Greenough? Tra i moderni sono certo più diffusi
INDAGINI SPETTROGRAFICHE ANTIFALSIFICAZIONI. Spettrografia all infrarosso
 INDAGINI SPETTROGRAFICHE ANTIFALSIFICAZIONI Spettrografia all infrarosso Una premessa è d obbligo, prima di iniziare la descrizione con foto esaustive di alcune falsificazioni, va rammentato che nella
INDAGINI SPETTROGRAFICHE ANTIFALSIFICAZIONI Spettrografia all infrarosso Una premessa è d obbligo, prima di iniziare la descrizione con foto esaustive di alcune falsificazioni, va rammentato che nella
Schede descrittive delle attività presentate nelle postazioni allestite presso il Museo
 3 dicembre 2016 ore 15-19 Scienziati al MAO casi di studio, tecniche, strumenti Schede descrittive delle attività presentate nelle postazioni allestite presso il Museo Patrocinio: Evento in collaborazione
3 dicembre 2016 ore 15-19 Scienziati al MAO casi di studio, tecniche, strumenti Schede descrittive delle attività presentate nelle postazioni allestite presso il Museo Patrocinio: Evento in collaborazione
Neutroni da reazioni Piezonucleari indotte da cavitazione
 Neutroni da reazioni Piezonucleari indotte da cavitazione Breve nota Lo scopo di questa relazione è sì soprattutto quello di illustrare le varie fasi della ricerca sulle reazioni piezonucleari a partire
Neutroni da reazioni Piezonucleari indotte da cavitazione Breve nota Lo scopo di questa relazione è sì soprattutto quello di illustrare le varie fasi della ricerca sulle reazioni piezonucleari a partire
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro
 Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
Portico d Ottavia a Roma: scavo archeologico e restauro L obiettivo iniziale dell intervento era di completare l indagine archeologica del piano interno del propileo (già oggetto di scavi nel 1996-97 e
PROPONENTE: MAGMA ENERGY ITALIA S.R.L
 Montecastelli Pisano, 11 gennaio 2019 OGGETTO: Presentazione delle Osservazioni alla Domanda di attivazione, del Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al Progetto di realizzazione
Montecastelli Pisano, 11 gennaio 2019 OGGETTO: Presentazione delle Osservazioni alla Domanda di attivazione, del Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al Progetto di realizzazione
Riassunto lezione 14
 Riassunto lezione 14 Onde meccaniche perturbazioni che si propagano in un mezzo Trasversali Longitudinali Interferenza (principio di sovrapposizione) Onde elettromagnetiche (si propagano anche nel vuoto)
Riassunto lezione 14 Onde meccaniche perturbazioni che si propagano in un mezzo Trasversali Longitudinali Interferenza (principio di sovrapposizione) Onde elettromagnetiche (si propagano anche nel vuoto)
Fotografia dei micro minerali, ma con quattro soldi
 Fotografia dei micro minerali, ma con quattro soldi Non sempre gli appassionati di micro mineralogia hanno abbastanza denaro per affrontare in modo efficace la fotografia di cristalli che spesso hanno
Fotografia dei micro minerali, ma con quattro soldi Non sempre gli appassionati di micro mineralogia hanno abbastanza denaro per affrontare in modo efficace la fotografia di cristalli che spesso hanno
CAPITOLO1: LO STUDIO DELLA NATURA E DELLA MATERIA
 CAPITOLO1: LO STUDIO DELLA NATURA E DELLA MATERIA Classi 1CL e 1EL Libro - Le scienze naturali: osservare la terra e la materia CAPITOLO 1- Da pagina 2 a 26 A.Gentileschi anno 2016/2017 Email docente:
CAPITOLO1: LO STUDIO DELLA NATURA E DELLA MATERIA Classi 1CL e 1EL Libro - Le scienze naturali: osservare la terra e la materia CAPITOLO 1- Da pagina 2 a 26 A.Gentileschi anno 2016/2017 Email docente:
E incredibile ho parlato con una persona e non ne ricordo il volto... Ora state buoni, bambini... VI SONO BUONI MOTIVI...
 E incredibile ho parlato con una persona e non ne ricordo il volto... Ora state buoni, bambini... VI SONO BUONI MOTIVI... 1 Queste foto prima non c erano... Lei era già stata qui? Sì, quando c era il signor
E incredibile ho parlato con una persona e non ne ricordo il volto... Ora state buoni, bambini... VI SONO BUONI MOTIVI... 1 Queste foto prima non c erano... Lei era già stata qui? Sì, quando c era il signor
09/10/15. 1 I raggi luminosi. 1 I raggi luminosi. L ottica geometrica
 1 I raggi luminosi 1 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan
1 I raggi luminosi 1 I raggi luminosi Per secoli si sono contrapposti due modelli della luce il modello corpuscolare (Newton) la luce è un flusso di particelle microscopiche il modello ondulatorio (Christiaan
Documento nr. 9. Documento nr. 9 evidenziato. pag.129. pag.130
 Documento nr. 9 Documento nr. 9 evidenziato pag.129 pag.130 Documento nr. 10 Documento nr. 10 evidenziato pag.131 pag.132 Documento nr. 11 Documento nr. 11 evidenziato pag.133 pag.134 Documento nr. 12
Documento nr. 9 Documento nr. 9 evidenziato pag.129 pag.130 Documento nr. 10 Documento nr. 10 evidenziato pag.131 pag.132 Documento nr. 11 Documento nr. 11 evidenziato pag.133 pag.134 Documento nr. 12
Test mediante le mire USAF 1951 di Andrea Bosi
 Test mediante le mire USAF 1951 di Andrea Bosi Le più usate sono certamente le mire USAF che, a seconda del modello scelto, si prestano al test di binocoli, obiettivi per fotocamera, stereo microscopi,
Test mediante le mire USAF 1951 di Andrea Bosi Le più usate sono certamente le mire USAF che, a seconda del modello scelto, si prestano al test di binocoli, obiettivi per fotocamera, stereo microscopi,
LABORATORIO DI TECNICHE CITOLOGICHE, MORFOLOGICHE E MORFOMETRICHE. Strumenti di indagine e metodi di studio delle cellule
 LABORATORIO DI TECNICHE CITOLOGICHE, MORFOLOGICHE E MORFOMETRICHE Strumenti di indagine e metodi di studio delle cellule Strumenti di indagine delle cellule 1.Metodi diretti all analisi strutturale in
LABORATORIO DI TECNICHE CITOLOGICHE, MORFOLOGICHE E MORFOMETRICHE Strumenti di indagine e metodi di studio delle cellule Strumenti di indagine delle cellule 1.Metodi diretti all analisi strutturale in
La fotografia in luce ultra violetta
 La fotografia in luce ultra violetta La luce ultravioletta possiede diverse caratteristiche che la rendono interessante in diversi campi per le modificazioni che è in grado di creare a carico di alcune
La fotografia in luce ultra violetta La luce ultravioletta possiede diverse caratteristiche che la rendono interessante in diversi campi per le modificazioni che è in grado di creare a carico di alcune
Storia di un reperto archeologico. Dott.ssa Martellucci Sabrina 1
 Storia di un reperto archeologico Dott.ssa Martellucci Sabrina 1 Come si sceglie un sito? Le Fonti : storiche; geografiche; cartografiche; fotografiche; Iconografiche. Studio Approfondimento Probabile
Storia di un reperto archeologico Dott.ssa Martellucci Sabrina 1 Come si sceglie un sito? Le Fonti : storiche; geografiche; cartografiche; fotografiche; Iconografiche. Studio Approfondimento Probabile
Corso di Psicometria Progredito
 Corso di Psicometria Progredito 4.1 I principali test statistici per la verifica di ipotesi: Il test t Gianmarco Altoè Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Università di Cagliari, Anno Accademico
Corso di Psicometria Progredito 4.1 I principali test statistici per la verifica di ipotesi: Il test t Gianmarco Altoè Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Università di Cagliari, Anno Accademico
Materiali avanzati. Informatica Grafica per le arti. Raytracing. Raytracing. Raytracing. Raytracing. Raytracing
 Informatica Grafica per le arti Materiali avanzati Marco Gribaudo marcog@di.unito.it Molti degli oggetti modellabili sono costituiti da superfici trasparenti o riflettenti. I materiali Raytrace permettono
Informatica Grafica per le arti Materiali avanzati Marco Gribaudo marcog@di.unito.it Molti degli oggetti modellabili sono costituiti da superfici trasparenti o riflettenti. I materiali Raytrace permettono
7. STATISTICA DESCRITTIVA
 7. STATISTICA DESCRITTIVA Quando si effettua un indagine statistica si ha a che fare con un numeroso insieme di oggetti, detto popolazione del quale si intende esaminare una o più caratteristiche (matricole
7. STATISTICA DESCRITTIVA Quando si effettua un indagine statistica si ha a che fare con un numeroso insieme di oggetti, detto popolazione del quale si intende esaminare una o più caratteristiche (matricole
Esercitazione n. 5 - BIO - USO DEL MICROSCOPIO COMPOSTO
 Esercitazione n. 5 - BIO - USO DEL MICROSCOPIO COMPOSTO A - IL MICROSCOPIO COMPOSTO Il microscopio è uno strumento che serve ad esaminare oggetti troppo piccoli per essere visti a occhio nudo. L occhio
Esercitazione n. 5 - BIO - USO DEL MICROSCOPIO COMPOSTO A - IL MICROSCOPIO COMPOSTO Il microscopio è uno strumento che serve ad esaminare oggetti troppo piccoli per essere visti a occhio nudo. L occhio
LA LUCE. Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione
 LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos è la luce La propagazione della luce La riflessione La rifrazione Perché vediamo gli oggetti? Perché vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché da essi
1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI
 1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI COS E UN MODELLO? La ricerca scientifica ha tra i suoi principali obiettivi quelli di comprendere descrivere come si svolgono I FENOMENI nel mondo che ci circonda MODELLI
1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI COS E UN MODELLO? La ricerca scientifica ha tra i suoi principali obiettivi quelli di comprendere descrivere come si svolgono I FENOMENI nel mondo che ci circonda MODELLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE ELABORATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE ELABORATO
Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile
 Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile di un difetto). 1 2 3 4 La resistenza teorica di un materiale
Esistono due tipologie tipo di frattura: duttile e fragile. Nel vetro si parla di frattura fragile (che avviene per propagazione veloce e instabile di un difetto). 1 2 3 4 La resistenza teorica di un materiale
Ancora sui criteri di divisibilità di Marco Bono
 Ancora sui criteri di divisibilità di Talvolta può essere utile conoscere i divisori di un numero senza effettuare le divisioni, anche se la diffusione delle calcolatrici elettroniche, sotto varie forme,
Ancora sui criteri di divisibilità di Talvolta può essere utile conoscere i divisori di un numero senza effettuare le divisioni, anche se la diffusione delle calcolatrici elettroniche, sotto varie forme,
MUSEO DELLA CERAMICA MUSA Museo d Arte di Palazzo Gavotti
 MUSEO DELLA CERAMICA MUSA Museo d Arte di Palazzo Gavotti Palazzo Gavotti, p.zza Chabrol nn.1/2, Savona Didascalie immagini per la stampa 3121, 3124, 3125, 3126 Sala 2 Ceramiche in stile istoriato barocco
MUSEO DELLA CERAMICA MUSA Museo d Arte di Palazzo Gavotti Palazzo Gavotti, p.zza Chabrol nn.1/2, Savona Didascalie immagini per la stampa 3121, 3124, 3125, 3126 Sala 2 Ceramiche in stile istoriato barocco
Come realizzare dei bozzelli di pezzo di Franco Fissore
 Come realizzare dei bozzelli di pezzo di Franco Fissore Per realizzare parecchi bozzelli e con la pretesa che vengano tutti uguali, mi sono creato diversi strumenti, che man mano andrò ad illustrare. Prima
Come realizzare dei bozzelli di pezzo di Franco Fissore Per realizzare parecchi bozzelli e con la pretesa che vengano tutti uguali, mi sono creato diversi strumenti, che man mano andrò ad illustrare. Prima
Uso dello YN 565EX e dello YN 568EX con fotocamere Nikon Entry Level (con pop up non master)
 Uso dello YN 565EX e dello YN 568EX con fotocamere Nikon Entry Level (con pop up non master) Come tutti sappiamo le fotocamere Nikon Entry Level (D40,D50, D60, D70 e le nuove serie D3xxx, D5xxx) hanno
Uso dello YN 565EX e dello YN 568EX con fotocamere Nikon Entry Level (con pop up non master) Come tutti sappiamo le fotocamere Nikon Entry Level (D40,D50, D60, D70 e le nuove serie D3xxx, D5xxx) hanno
Il Corso di Fisica per Scienze Biologiche
 Il Corso di Fisica per Scienze Biologiche Ø Prof. Attilio Santocchia Ø Ufficio presso il Dipartimento di Fisica (Quinto Piano) Tel. 075-585 2708 Ø E-mail: attilio.santocchia@pg.infn.it Ø Web: http://www.fisica.unipg.it/~attilio.santocchia
Il Corso di Fisica per Scienze Biologiche Ø Prof. Attilio Santocchia Ø Ufficio presso il Dipartimento di Fisica (Quinto Piano) Tel. 075-585 2708 Ø E-mail: attilio.santocchia@pg.infn.it Ø Web: http://www.fisica.unipg.it/~attilio.santocchia
SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA CLASSE TERZA
 Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA CLASSE TERZA
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA CLASSE TERZA
geoceramic researches s.r.l.
 geoceramic researches s.r.l. tel. : 051/676.17.38 Via Bacchello, 9 fax : 051/676.17.36 i 40050 Monte San Pietro e-mail : geoceramic@iol.it Bologna Italy home page : http://web.tiscali.it/geoceramic Spett.le
geoceramic researches s.r.l. tel. : 051/676.17.38 Via Bacchello, 9 fax : 051/676.17.36 i 40050 Monte San Pietro e-mail : geoceramic@iol.it Bologna Italy home page : http://web.tiscali.it/geoceramic Spett.le
Ingrandimento e risoluzione
 3.2. IL MICROSCOPIO OTTICO COMPOSTO IN CAMPO CHIARO Il microscopio ottico composto a luce riflessa in campo chiaro è lo strumento ottico più largamente usato per l osservazione dei microrganismi. È definito
3.2. IL MICROSCOPIO OTTICO COMPOSTO IN CAMPO CHIARO Il microscopio ottico composto a luce riflessa in campo chiaro è lo strumento ottico più largamente usato per l osservazione dei microrganismi. È definito
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE
 MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
Si tratta di un modello dalla forma classica, corredato di 4 obbiettivi e di 3 oculari intercambiabili che permettono di spaziare da 40 a 1200
 Il microscopio Per dedicarsi allo studio del mondo invisibile è necessario naturalmente avere un microscopio, per chi desiderasse acquistarne uno consigliamo di evitare certi modelli di microscopio giocattolo
Il microscopio Per dedicarsi allo studio del mondo invisibile è necessario naturalmente avere un microscopio, per chi desiderasse acquistarne uno consigliamo di evitare certi modelli di microscopio giocattolo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI DELL ELABORATO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE SINTESI DELL ELABORATO
Distribuzione statistica delle misure del periodo di un pendolo semplice
 Gruppo A2 XXX XXX XXX XXX Cesa Joshua 77685 Udine, 20/10/2006 Distribuzione statistica delle misure del periodo di un pendolo semplice Oggetto della prova Oggetto della prova è la misurazione del periodo
Gruppo A2 XXX XXX XXX XXX Cesa Joshua 77685 Udine, 20/10/2006 Distribuzione statistica delle misure del periodo di un pendolo semplice Oggetto della prova Oggetto della prova è la misurazione del periodo
Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al
 Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA 2012-2013 Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al progresso nei metodi di indagine sperimentale. Il corso
Corso di laboratorio di fisica della materia Prof. Mario Rocca AA 2012-2013 Il progresso delle conoscenze in Fisica è indissolubilmente legato al progresso nei metodi di indagine sperimentale. Il corso
Estratto da un quaderno di riflessioni scritto da Alfredo Bini.
 Estratto da un quaderno di riflessioni scritto da Alfredo Bini. Con questo modello Alfredo Bini faceva riflettere gli studenti sull inconsistenza logica delle correlazioni fra anfiteatri differenti
Estratto da un quaderno di riflessioni scritto da Alfredo Bini. Con questo modello Alfredo Bini faceva riflettere gli studenti sull inconsistenza logica delle correlazioni fra anfiteatri differenti
VERSO L UNIVERSITÀ L integrale: un solo nome, tanti oggetti
 VERSO L UNIVERSITÀ L integrale: un solo nome, tanti oggetti Nomi, simboli e formule Al termine dello studio degli integrali, può valer la pena fare un po d ordine tra i vari concetti incontrati. Abbiamo
VERSO L UNIVERSITÀ L integrale: un solo nome, tanti oggetti Nomi, simboli e formule Al termine dello studio degli integrali, può valer la pena fare un po d ordine tra i vari concetti incontrati. Abbiamo
I metodi della psicologia scientifica
 I metodi della psicologia scientifica Cos è la psicologia Lo studio scientifico del comportamento degli individui e dei loro processi mentali Fasi di un processo di ricerca: Osservazione Raccogliere informazioni
I metodi della psicologia scientifica Cos è la psicologia Lo studio scientifico del comportamento degli individui e dei loro processi mentali Fasi di un processo di ricerca: Osservazione Raccogliere informazioni
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato
 Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
Effetti del fuoco (incendio) sul calcestruzzo armato Effetti generali dell incendio a) Distribuzione della temperatura nelle strutture. Una distribuzione di temperatura non uniforme con differenze di dilatazione
Competenze da utilizzare: comprendere un testo; costruire una mappa; esporre un argomento in modo personale; utilizzare un linguaggio specifico.
 Fine scuola primaria-competenza: studio Compito: leggere un testo da riferire organizzandolo in una mappa che possa servire come traccia. Prodotto finale:una mappa del testo, esposizione orale Struttura
Fine scuola primaria-competenza: studio Compito: leggere un testo da riferire organizzandolo in una mappa che possa servire come traccia. Prodotto finale:una mappa del testo, esposizione orale Struttura
Da L indagine del mondo fisico di G.Toraldo di Francia:
 Da L indagine del mondo fisico di G.Toraldo di Francia: Che cosa sia un laboratorio s impara in laboratorio, a sperimentare s impara sperimentando, a lavorare con le mani s impara lavorando con le mani
Da L indagine del mondo fisico di G.Toraldo di Francia: Che cosa sia un laboratorio s impara in laboratorio, a sperimentare s impara sperimentando, a lavorare con le mani s impara lavorando con le mani
Capitolo 15. L interferenza e la natura ondulatoria della luce. Copyright 2009 Zanichelli editore
 Capitolo 15 L interferenza e la natura ondulatoria della luce 15.2 Il principio di sovrapposizione e l interferenza della luce Quando due onde luminose passano per uno stesso punto, i loro effetti si sommano
Capitolo 15 L interferenza e la natura ondulatoria della luce 15.2 Il principio di sovrapposizione e l interferenza della luce Quando due onde luminose passano per uno stesso punto, i loro effetti si sommano
Dipartimento Di Scienze della Terra e Geoambientali
 Dipartimento Di Scienze della Terra e Geoambientali via E. Orabona, 4 70125 BARI tel. direzione (+39) 00 5442556 fax (+39) 00 5442625 PUNTI 7_ ALLEGATO n. 1 Percorso PFP1: Lapidei e derivati; superfici
Dipartimento Di Scienze della Terra e Geoambientali via E. Orabona, 4 70125 BARI tel. direzione (+39) 00 5442556 fax (+39) 00 5442625 PUNTI 7_ ALLEGATO n. 1 Percorso PFP1: Lapidei e derivati; superfici
Acquisizione, rappresentazione e analisi di dati sperimentali
 Acquisizione, rappresentazione e analisi di dati sperimentali Aurelio Agliolo Gallitto Dipartimento di Fisica, Università di Palermo Introduzione Esperimenti illustrativi, per visualizzare un determinato
Acquisizione, rappresentazione e analisi di dati sperimentali Aurelio Agliolo Gallitto Dipartimento di Fisica, Università di Palermo Introduzione Esperimenti illustrativi, per visualizzare un determinato
Istituto:Zuccante di Mestre
 Stagiaire: a Nicola Pomiato Istituto:Zuccante di Mestre Trattamenti di superficie: Pulizia chimica ed elettrochimica del rame Trattamento di protezione del titanio I trattamenti di superficie sono stati
Stagiaire: a Nicola Pomiato Istituto:Zuccante di Mestre Trattamenti di superficie: Pulizia chimica ed elettrochimica del rame Trattamento di protezione del titanio I trattamenti di superficie sono stati
1. Teorema di reciprocità
 . Teorema di reciprocità Consideriamo un mezzo in cui sono presenti i campi (E, H ) e (E, H ). Questi campi hanno per sorgenti rispettivamente (J, M) e (J, M), ricavabili sostituendo i campi nelle equazioni
. Teorema di reciprocità Consideriamo un mezzo in cui sono presenti i campi (E, H ) e (E, H ). Questi campi hanno per sorgenti rispettivamente (J, M) e (J, M), ricavabili sostituendo i campi nelle equazioni
QUANTE STELLE RIUSCITE ANCORA A VEDERE?
 http://www.darksky.ch/ti In collaborazione con: http://www.astroticino.ch Un progetto promosso dell Associazione dell Osservatorio Kuffner di Vienna in collaborazione con Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino.
http://www.darksky.ch/ti In collaborazione con: http://www.astroticino.ch Un progetto promosso dell Associazione dell Osservatorio Kuffner di Vienna in collaborazione con Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino.
GLI STRUMENTI PER IL DISEGNO
 GLI STRUMENTI PER IL DISEGNO Gli strumenti che noi useremo sono: 1) Fogli di carta liscia di formato A3, squadrati; 2) N. 2 matite, preferibilmente micromine (una con mina H e una con mina HB); 3) Gomma
GLI STRUMENTI PER IL DISEGNO Gli strumenti che noi useremo sono: 1) Fogli di carta liscia di formato A3, squadrati; 2) N. 2 matite, preferibilmente micromine (una con mina H e una con mina HB); 3) Gomma
4 Richiesta di radiografie - osservazione
 A questo punto del percorso abbiamo rilevato che il corpo umano affascina e incuriosisce i bambini anche se la comprensione di questa problematica risulta complessa, per alunni della scuola elementare,
A questo punto del percorso abbiamo rilevato che il corpo umano affascina e incuriosisce i bambini anche se la comprensione di questa problematica risulta complessa, per alunni della scuola elementare,
Ciao, mi chiamo Mezzettino!
 Ciao, mi chiamo Mezzettino! Sono un boccale in maiolica. Oggi ti racconterò la mia storia, con quali materiali e in che modo sono stato realizzato e ti parlerò dei miei antenati. Dopo il nostro viaggio
Ciao, mi chiamo Mezzettino! Sono un boccale in maiolica. Oggi ti racconterò la mia storia, con quali materiali e in che modo sono stato realizzato e ti parlerò dei miei antenati. Dopo il nostro viaggio
3.7 ALTRI TIPI DI VETRO
 3.7 ALTRI TIPI DI VETRO Per completare il quadro dei materiali vetrosi individuati nei mosaici in tessere minute si presenta brevemente una rassegna dei vetri osservati. Come già anticipato, tali materiali
3.7 ALTRI TIPI DI VETRO Per completare il quadro dei materiali vetrosi individuati nei mosaici in tessere minute si presenta brevemente una rassegna dei vetri osservati. Come già anticipato, tali materiali
Elettromagnetismo. Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano. Lezione n
 Elettromagnetismo Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano Lezione n. 10 2.11.2016 Equazione di Poisson Metodo delle cariche immagine Anno Accademico 2016/2017 Equazione di Poisson Tramite
Elettromagnetismo Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano Lezione n. 10 2.11.2016 Equazione di Poisson Metodo delle cariche immagine Anno Accademico 2016/2017 Equazione di Poisson Tramite
Meccanica delle Terre Geotecnica Prova scritta di esame
 # 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
# 1 Con riferimento allo schema mostrato di seguito: - calcolare la tensione verticale totale, la pressione interstiziale e la tensione verticale efficace alle profondità indicate dai punti A, B, C, D,
Come si fa uno scavo archeologico
 Arologia passione Come si fa o scavo arologico Durante la vacanza a Orvieto, i miei genitori e io, abbiamo visitato la Necropoli del Crocifisso del Tufo. Lì abbiamo osservato molte tombe etrus, ogna con
Arologia passione Come si fa o scavo arologico Durante la vacanza a Orvieto, i miei genitori e io, abbiamo visitato la Necropoli del Crocifisso del Tufo. Lì abbiamo osservato molte tombe etrus, ogna con
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO FABRO - TR SCUOLA DELL INFANZIA TECNOLOGIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO FABRO - TR 1 SCUOLA DELL INFANZIA TECNOLOGIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MACRO DESCRITTORI Vedere e osservare Prevedere e immaginare PRIMO ANNO SECONDO ANNO ULTIMO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO FABRO - TR 1 SCUOLA DELL INFANZIA TECNOLOGIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MACRO DESCRITTORI Vedere e osservare Prevedere e immaginare PRIMO ANNO SECONDO ANNO ULTIMO
T E C N O L O G I A CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. INTERVENIRE E TRASFORMARE C1 - Realizzare un oggetto in cartoncino.
 CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA T E C N O L O G I A CLASSI PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE A1 - Seguire istruzioni d uso per realizzare oggetti. O B I E T T I V I D I A P P R E N D I M E N T O PREVEDERE
CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA T E C N O L O G I A CLASSI PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE A1 - Seguire istruzioni d uso per realizzare oggetti. O B I E T T I V I D I A P P R E N D I M E N T O PREVEDERE
TRATTAMENTI TERMICI 1
 TRATTAMENTI TERMICI 1 Il trattamento termico comprende una varietà di tecniche e procedure specialistiche in grado di migliorare le proprietà degli acciai e prolungarne la vita. Grazie ad installazioni
TRATTAMENTI TERMICI 1 Il trattamento termico comprende una varietà di tecniche e procedure specialistiche in grado di migliorare le proprietà degli acciai e prolungarne la vita. Grazie ad installazioni
Dialogo fra. un signore che deve fare l intervento della fistola per l emodialisi.. e un dottore che cerca di spiegare che cos è
 Dialogo fra un signore che deve fare l intervento della fistola per l emodialisi.. e un dottore che cerca di spiegare che cos è Ho capito, dottore, ci siamo: se devo fare la fistola, è perché devo poi
Dialogo fra un signore che deve fare l intervento della fistola per l emodialisi.. e un dottore che cerca di spiegare che cos è Ho capito, dottore, ci siamo: se devo fare la fistola, è perché devo poi
Le sesse del lago di Garda
 PUBBLICAZIONI D E L L ' I S T I T U T O N A Z I O N A L E DI G E O F Í S I C A N. 169 PIETRO CALOI Le sesse del lago di Garda R O M A 1949 Estratto da Annali di Geo fisica Voi. II, n. 1, 1949. pag. 19-23
PUBBLICAZIONI D E L L ' I S T I T U T O N A Z I O N A L E DI G E O F Í S I C A N. 169 PIETRO CALOI Le sesse del lago di Garda R O M A 1949 Estratto da Annali di Geo fisica Voi. II, n. 1, 1949. pag. 19-23
MISURA DELLA VELOCITA DEL SUONO
 MISURA DELLA VELOCITA DEL SUONO AVVERTENZA: durante lo svolgimento dell esperienza viene emesso un suono continuo che non è pericoloso ma potrebbe risultare fastidioso. Per questo motivo siete invitati
MISURA DELLA VELOCITA DEL SUONO AVVERTENZA: durante lo svolgimento dell esperienza viene emesso un suono continuo che non è pericoloso ma potrebbe risultare fastidioso. Per questo motivo siete invitati
INTERFERENZA 1. Allora la luce totale emessa, data dalla somma delle onde luminose emesse dai singoli atomi, NON SARA' POLARIZZATA
 INTERFERENZA 1 SORGENTI LUMINOSE NATURALI Le sorgenti di onde luminose sono, in generale, atomi e molecole (ad esempio, gli atomi che compongono il filamento di una lampadina, gli atomi che formano lo
INTERFERENZA 1 SORGENTI LUMINOSE NATURALI Le sorgenti di onde luminose sono, in generale, atomi e molecole (ad esempio, gli atomi che compongono il filamento di una lampadina, gli atomi che formano lo
Proprietà meccaniche. elasticità. resistenza. densità di legami chimici forza del legame
 Proprietà meccaniche elasticità r 0 resistenza densità di legami chimici forza del legame Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che
Proprietà meccaniche elasticità r 0 resistenza densità di legami chimici forza del legame Anche le proprietà meccaniche dipendono sostanzialmente dai legami chimici presenti nel materiale. La curva che
Il legno legno scorza cilindro centrale corteccia epidermide libro legno cambio
 Il legno Comunemente si indica come legno la parte del fusto degli alberi che si trova sotto la cosiddetta scorza (comunemente detta corteccia). Nel 1 anno di vita del fusto si distingue una zona a funzione
Il legno Comunemente si indica come legno la parte del fusto degli alberi che si trova sotto la cosiddetta scorza (comunemente detta corteccia). Nel 1 anno di vita del fusto si distingue una zona a funzione
Per realizzare una bella immagine bisogna compiere, prima dello scatto, un certo numero di operazioni, tutte necessarie e tutte importanti.
 Per realizzare una bella immagine bisogna compiere, prima dello scatto, un certo numero di operazioni, tutte necessarie e tutte importanti. La prima cosa che bisogna considerare prima di scattare una fotografia
Per realizzare una bella immagine bisogna compiere, prima dello scatto, un certo numero di operazioni, tutte necessarie e tutte importanti. La prima cosa che bisogna considerare prima di scattare una fotografia
Come realizzare i bozzelli
 Come realizzare i bozzelli Per realizzare parecchi bozzelli e con la pretesa che vengano tutti uguali, mi sono creato diversi strumenti, che man mano andrò ad illustrare. Prima di parlare della realizzazione
Come realizzare i bozzelli Per realizzare parecchi bozzelli e con la pretesa che vengano tutti uguali, mi sono creato diversi strumenti, che man mano andrò ad illustrare. Prima di parlare della realizzazione
Incurabile Una guarigione Totale Attraverso Delle preghiere Scaturite Dal profondo Del proprio Essere E anche Da coloro Che sono vicini All essere Sof
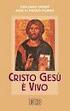 Da tempo Si sente parlare Di Miracoli Che accadono Nel Mondo Miracolo Dovrebbe essere Un avvenimento Non provocato Che ristabilisce Una situazione Sia fisica Che mentale Di enorme Gravità Incurabile Irrimediabile
Da tempo Si sente parlare Di Miracoli Che accadono Nel Mondo Miracolo Dovrebbe essere Un avvenimento Non provocato Che ristabilisce Una situazione Sia fisica Che mentale Di enorme Gravità Incurabile Irrimediabile
verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado
 verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado PROVA DI ITALIANO Comprensione della lettura Scuola..................................................................................................................................................
verso l esame di stato scuola secondaria di primo grado PROVA DI ITALIANO Comprensione della lettura Scuola..................................................................................................................................................
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO
 L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
DISCIPLINA : TECNOLOGIA CLASSE PRIMA PRIMARIA. TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO (AL TERMINE DI : CL. 3^ primaria )
 DISCIPLINA : TECNOLOGIA CLASSE PRIMA PRIMARIA TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO (AL TERMINE DI : CL. 3^ primaria ) L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale. È a conoscenza
DISCIPLINA : TECNOLOGIA CLASSE PRIMA PRIMARIA TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO (AL TERMINE DI : CL. 3^ primaria ) L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale. È a conoscenza
ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE
 LAVORAZIONI PER SEPARAZIONE ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE Vittore Carassiti - INFN FE 1 INTRODUZIONE La velocità di taglio e gli altri parametri di lavorazione Alla velocità di taglio
LAVORAZIONI PER SEPARAZIONE ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO - 4 DURATA DEL TAGLIENTE Vittore Carassiti - INFN FE 1 INTRODUZIONE La velocità di taglio e gli altri parametri di lavorazione Alla velocità di taglio
Episcopia ad alto ingrandimento. di Andrea Bosi, 04/2012
 Episcopia ad alto ingrandimento di Andrea Bosi, 04/2012 Assieme al mio compagno di avventura Nicola Ricci ci eravamo messi a discutere sulla possibilità di fare della macro spinta con dei semplici led,
Episcopia ad alto ingrandimento di Andrea Bosi, 04/2012 Assieme al mio compagno di avventura Nicola Ricci ci eravamo messi a discutere sulla possibilità di fare della macro spinta con dei semplici led,
Esercitazione n. 9 di Metodologia della Ricerca Psicologica
 Esercitazione n. 9 di Metodologia della Ricerca Psicologica Quesito 1: Un ricercatore intende studiare gli effetti a lungo termine della psicoterapia in pazienti con disturbi conseguenti a eventi traumatici.
Esercitazione n. 9 di Metodologia della Ricerca Psicologica Quesito 1: Un ricercatore intende studiare gli effetti a lungo termine della psicoterapia in pazienti con disturbi conseguenti a eventi traumatici.
Curare le vetrine: una scelta vincente
 Curare le vetrine è molto importante perché l allestimento vetrinistico è un mezzo per esporre e un opportunità per esprimere la personalità dell intera farmacia; inoltre può aiutare a vendere. Certamente
Curare le vetrine è molto importante perché l allestimento vetrinistico è un mezzo per esporre e un opportunità per esprimere la personalità dell intera farmacia; inoltre può aiutare a vendere. Certamente
LE VIBRAZIONI NEI CANTIERI: DALLA PROGETTAZIONE AL MONITORAGGIO
 LE VIBRAZIONI NEI CANTIERI: DALLA PROGETTAZIONE AL MONITORAGGIO LA GALLERIA TURISTICA DELLE GROTTE DI VILLANOVA difficile equilibrio tra vibrazioni e speleotemi Dott. Geol. Andrea Mocchiutti Milano, 14
LE VIBRAZIONI NEI CANTIERI: DALLA PROGETTAZIONE AL MONITORAGGIO LA GALLERIA TURISTICA DELLE GROTTE DI VILLANOVA difficile equilibrio tra vibrazioni e speleotemi Dott. Geol. Andrea Mocchiutti Milano, 14
il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione
 il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione Il microscopio è un occhio affascinante attraverso cui è possibile scoprire un nuovo mondo di sapere, un mondo popolato di esseri viventi e
il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione Il microscopio è un occhio affascinante attraverso cui è possibile scoprire un nuovo mondo di sapere, un mondo popolato di esseri viventi e
Nanoparticelle per la valorizzazione dei manufatti ceramici
 Nanoparticelle per la valorizzazione dei manufatti ceramici Marco Cenci Ceramiche Virginia Matteo Mannini INSTM & Università degli Studi di Firenze Workshop di inaugurazione DT Materiali Firenze, 13 Gennaio
Nanoparticelle per la valorizzazione dei manufatti ceramici Marco Cenci Ceramiche Virginia Matteo Mannini INSTM & Università degli Studi di Firenze Workshop di inaugurazione DT Materiali Firenze, 13 Gennaio
Club Alpino Italiano. Commissione Lombarda Materiali e Tecniche
 Club Alpino Italiano Commissione Lombarda Materiali e Tecniche L ASSICURAZIONE IN PARETE: L IMPORTANZA DELL ALTEZZA DELLA PRIMA PROTEZIONE E DI UNA CORRETTA ASSICURAZIONE PER RIDURRE I RISCHI DI IMPATTO
Club Alpino Italiano Commissione Lombarda Materiali e Tecniche L ASSICURAZIONE IN PARETE: L IMPORTANZA DELL ALTEZZA DELLA PRIMA PROTEZIONE E DI UNA CORRETTA ASSICURAZIONE PER RIDURRE I RISCHI DI IMPATTO
Introduzione ai Controlli Non Distruttivi. Corso di Tecnologie dei Materiali non Convenzionali - Prof. Luigi Carrino 1
 Introduzione ai Controlli Non Distruttivi Corso di Tecnologie dei Materiali non Convenzionali - Prof. Luigi Carrino 1 Introduzione I compositi hanno applicazione nei campi produttivi più disparati: AERONAUTICO
Introduzione ai Controlli Non Distruttivi Corso di Tecnologie dei Materiali non Convenzionali - Prof. Luigi Carrino 1 Introduzione I compositi hanno applicazione nei campi produttivi più disparati: AERONAUTICO
TEST DI INGRESSO. a. tra due dita poste a così piccola distanza da essere quasi a contatto
 COGNOME NOME DATA CLASSE TEST DI INGRESSO 1. Hai mai osservato una sorgente di luce guardando attraverso due dita poste vicinisme, qua a contatto? Prova! Descrivi come ti appare la sorgente quando la osservi
COGNOME NOME DATA CLASSE TEST DI INGRESSO 1. Hai mai osservato una sorgente di luce guardando attraverso due dita poste vicinisme, qua a contatto? Prova! Descrivi come ti appare la sorgente quando la osservi
 PREMESSA Sezione lucida stratigrafica (NorMal 14/83): il campione, viene dapprima inglobato in resina poliestere e orientato in modo da ottenere una sezione perpendicolare alla superficie originaria. Successivamente
PREMESSA Sezione lucida stratigrafica (NorMal 14/83): il campione, viene dapprima inglobato in resina poliestere e orientato in modo da ottenere una sezione perpendicolare alla superficie originaria. Successivamente
Errori (o bias) negli studi epidemiologici
 Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
Errori (o bias) negli studi epidemiologici Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più difficili da individuare e per questo motivo non è possibile tenerne conto in fase di analisi Variazione
Come districarsi nella ricerca del suolo
 1 Come districarsi nella ricerca del suolo Ing. Roberto Di Girolamo Via G. di Giovanni 10B 62032 Camerino (MC) mail: rdigirolamo@tin.it port.: +393356394081 Skype: roberto.di.girolamo 2 Capitolo al 3.2.2.
1 Come districarsi nella ricerca del suolo Ing. Roberto Di Girolamo Via G. di Giovanni 10B 62032 Camerino (MC) mail: rdigirolamo@tin.it port.: +393356394081 Skype: roberto.di.girolamo 2 Capitolo al 3.2.2.
cellula Robert Hooke cellule
 Uno dei principi più importanti della biologia è l affermazione che tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule. È un concetto di importanza capitale perché fornisce il punto di partenza per
Uno dei principi più importanti della biologia è l affermazione che tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule. È un concetto di importanza capitale perché fornisce il punto di partenza per
Consorzio Astrea - Lutech Numero verde: Mail:
 dodici minuti. DOMANDA Nel senso che il treno poteva fare anche eventualmente ulteriore ritardo, cioè è stato accertato? RISPOSTA Non risulta alla stazione di Erba, non risulta alla stazione madre questo.
dodici minuti. DOMANDA Nel senso che il treno poteva fare anche eventualmente ulteriore ritardo, cioè è stato accertato? RISPOSTA Non risulta alla stazione di Erba, non risulta alla stazione madre questo.
Le rocce OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ROCCE.
 Le rocce OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ROCCE. Il lavoro può essere fatto a gruppi di 4/5 alunni, ogni gruppo dovrebbe avere a disposizione un certo numero di rocce di tipo diverso, ma ogni gruppo deve
Le rocce OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ROCCE. Il lavoro può essere fatto a gruppi di 4/5 alunni, ogni gruppo dovrebbe avere a disposizione un certo numero di rocce di tipo diverso, ma ogni gruppo deve
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO. Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010
 PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
PROGETTO DI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA E SONDAGGI ESPLORATIVI SUL TERRITORIO PERSICETANO Classe 3^G Anno Scolastico 2009/2010 Nel corso dell anno scolastico 2009-2010, la classe 3^G del liceo scientifico
