Le particelle elementari
|
|
|
- Gianleone Manca
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le particelle elementari Masterclass Europea in Fisica delle Particelle Elementari Students day Torino, 20 marzo /03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 1
2 Oggi, la fisica è (alla base di tutta) la scienza della natura Con un consapevole eccesso di orgoglio, Rutherford disse una volta: La scienza e fisica, oppure e collezionare francobolli 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 2
3 Perchè? 1. Chimica, biologia, astronomia, cosmologia, geologia, trovano interpretazione e spiegazione nelle leggi della fisica 2. Non si osservano fenomeni naturali che siano in contrasto con le leggi note della fisica 3. Le leggi della fisica sono espresse in linguaggio matematico, internamente coerente e falsificabile 4. Le leggi fisiche si auto-fondano sull esperimento, non sono basate su ipotesi metafisiche o extrascientifiche 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 3
4 Riduzionismo Punto di vista generale (ma di sicuro non proprio condiviso da tutti!): Le proprieta dei sistemi complessi si possono interpretare in termini delle proprieta delle parti piu semplici che li compongono e delle forze che intervengono a comporli 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 4
5 Valore del riduzionismo Origine: meccanicismo Proprieta del sistema solare (orbite di pianeti, satelliti comete, ) ben comprese in termini delle masse dei costituenti e della legge di gravitazione universale La legge di Newton e unica, la stessa per tutte le masse (mele, Luna, pianeti, satelliti artificiali, pattinatori, ). Primo esempio di interazione fondamentale Potere post-dittivo dittivo: : ottima consistenza fra misure e calcoli Potere pre-dittivo dittivo: : previsione di fenomeni nuovi (Es. scoperta di Nettuno, avvenuta sulla base delle anomalie osservate nell orbita di Urano) 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 5
6 Cos e un interazione fondamentale? Idea estremamente unificante: All origine di tutti i fenomeni di tipo gravitazionale c e una unica forza, quella newtoniana Le differenze fra i tanti fenomeni osservati sono solo apparenti, legate a dimensioni, forme, distanze, che variano caso per caso Quindi, misurare p.es. l accelerazione di gravita consente, insieme ad altre informazioni di tipo geometrico, di misurare la massa del Sole, della Luna, di predire la posizione e la velocita delle comete, etc 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 6
7 In altre parole. la riduzione della complessita di un sistema fisico, che individua i suoi componenti semplici e studia separatamente le loro proprieta,, risulta un passo essenziale nella comprensione delle leggi naturali Almeno fino ad ora 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 7
8 La struttura della materia Origini nella chimica: Dalton, Lavoisier, Avogadro e il concetto di elemento chimico Molecole come costituenti della materia La parte piu piccola di ogni sostanza 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 8
9 Riduzionismo in azione Ci sono moltissime sostanze diverse Ipotesi: Le molecole sono fatte di atomi Da > specie molecolari a <100 specie atomiche! Straordinario passo avanti nella comprensione delle proprieta della materia 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 9
10 Il sistema periodico: Mendeleev Sistematicita nelle proprieta chimiche degli elementi Somiglianze e regolarita nelle proprieta fisiche degli atomi 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 10
11 I costituenti atomici Ricerca di evidenze fisiche che comprovino gli indizi di origine chimica sulla struttura complessa degli atomi Elettrone: Thompson Nucleo: Rutherford 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 11
12 Thompson: l elettrone Raggi catodici: radiazione emessa dai metalli quando sono riscaldati Deflessione di raggi catodici in campi elettrici e magnetici Sono elettroni, particelle di piccola massa e carica -va 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 12
13 Rutherford: il nucleo Oggi sappiamo: nuclei di elio Urti fra particelle α e atomi di oro Si osservano a volte grandi deflessioni Nocciolo pesante, di piccole dimensioni, carico positivamente, al centro dell atomo 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 13
14 La struttura atomica Altro passo nella riduzione dei sistemi complessi a quelli piu semplici: Da 100 specie atomiche a 2 costituenti atomici: nucleo ed elettrone Colla che li tiene uniti: forza elettromagnetica Una seconda interazione fondamentale: i campi elettromagnetici sono unici, hanno gli stessi effetti per tutte le cariche elettriche 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 14
15 L interazione elettromagnetica Nella visione moderna, le cariche elettriche si sentono emettendo e assorbendo continuamente fotoni: quanti di luce Fotone Tempo Fotone Molti processi: collisione, annichilazione, materializzazione,.. Tutti descritti dalla stessa legge della forza 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 15
16 Come funziona? Versione quantistica delle vecchie idee classiche Se scuotete scuotete una particella carica, essa emettera onde elettromagnetiche = quanti di luce Le onde elettromagnetiche = quanti di luce scuotono le particelle cariche che incontrano E cosi via 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 16
17 Nuclei, stabili e instabili Fino a 100 Fino a /03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 17
18 I costituenti nucleari Circa 3000 nuclei diversi conosciuti. Situazione simile a quella incontrata a proposito delle specie atomiche: similarita, regolarita, ricorrenze Riduzione: ricerca dei costituenti nucleari Identificazione di protone e neutrone: Rutherford, Chadwick Particella pesante, con carica +va Particella pesante, priva di carica 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 18
19 Radioattivita Becquerel, Rutherford,, i Curie, Scoperta dell emissione di radiazione da parte di certi elementi In seguito, messa in relazione con la instabilita nucleare: : tendenza osservata di diverse specie nucleari a disintegrarsi spontaneamente in frammenti piu leggeri, con varie modalita 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 19
20 Cosa rende stabile il nucleo? Problema: i costituenti nucleari sono a carica positiva o nulla Come fa il nucleo a restare unito, visto che cariche di ugual segno si respingono? Nuova interazione fondamentale, l interazione forte: nuova forza, molto piu intensa di quella elettromagnetica, non si manifesta fra oggetti macroscopici perche ha un raggio d azione estremamente piccolo: cm! A distanze dell ordine delle dimensioni dei costituenti nucleari essa prevale sulla repulsione elettrica fra i protoni 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 20
21 Il nucleo e le reazioni nucleari Un esempio di reazione nucleare: la fissione Bassa energia Alta energia Reazioni come questa: alla base del funzionamento dei reattori nucleari ( e della bomba A) 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 21
22 Un altra reazione Un altro esempio di reazione nucleare: la fusione Alta energia Reazioni come questa: alla base della produzione di energia Nelle stelle e dei futuri reattori a fusione (e della bomba H) 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 22
23 Cosa rende instabile il nucleo? Perche alcune specie nucleari sono instabili? Diverse modalita di disintegrazione: la piu interessante, nota come decadimento beta, ha caratteristiche bizzarre Governata da una quarta interazione fondamentale, l interazione debole, molto meno intensa dell interazione elettromagnetica Anch essa non si manifesta fra corpi macroscopici: raggio d azione piccolissimo, < cm! 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 23
24 Perche e interessante, se e debole? Catena di reazioni che fornisce energia alle stelle (incluso il Sole): ciclo dell idrogeno Processi iniziali: interazione debole! 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 24
25 Le interazioni fondamentali L indagine sulla struttura della materia conduce a studiare le proprieta dei costituenti nucleari e delle quattro interazioni fondamentali Come si fa? Come sempre in fisica: Teoria: costruzione di modelli Esperimento: uso di sonde di vario tipo 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 25
26 Principi fondamentali Ogni modello deve essere formulato in accordo con i sacri principi canonici Teoria della relativita Meccanica quantistica Perche? Non perche siano sacri Non abbiamo evidenze contrarie a questi principi, mentre ne abbiamo moltissime in favore Fino a prova contraria 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 26
27 Effetti relativistici Molti, stupefacenti, controintuitivi: nuovo modo di considerare spazio e tempo Due conseguenze importanti: Equivalenza fra massa ed energia Possibilita di trasformare l una nell altra Possibilita di processi in cui le particelle si creano e distruggono Esistenza delle antiparticelle Ogni particella (elettrone, protone,..) ha una gemella di uguale massa e carica opposta 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 27
28 Il positrone Foto in camera a nebbia Fra gli altri processi: 2 esempi di produzione di coppie Materializzazione di raggi γ di alta energia (radiazione elettromagnetica) in una coppia elettrone-positrone 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 28
29 Effetti quantistici Molti, stupefacenti, controintuitivi: nuovo modo di considerare materia e campo Due conseguenze importanti: Quantizzazione dell energia Esistenza di livelli energetici discreti Caratteristiche ondulatorie nella dinamica delle particelle Il moto delle particelle assomiglia a quello di un onda 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 29
30 La spettroscopia atomica Gli atomi eccitati (p.es. in un gas caldo) emettono luce di colori caratteristici Idrogeno (atomo semplice) Ferro (atomo complicato) Legame stretto fra livelli energetici dell atomo e colore delle righe spettrali 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 30
31 La diffrazione degli elettroni Intensita degli elettroni diffratti Figura di diffrazione, simile a quelle che si ottengono quando la luce passa attraverso piccole fenditure Le particelle hanno una lunghezza d onda λ = mv Velocita grandi = Lunghezze d onda piccole 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 31
32 Onde e dettagli geometrici Il disco di Airy non e la dimensione della stella, ma un effetto ondulatorio Se la separazione fosse inferiore, gli effetti ottici non permetterebbero di separare le due stelle: quando si ha a che fare con fenomeni ondulatori, il dettaglio minimo che si puo osservare ha dimensione λ Disco di Airy; angolo λ/d Separazione 0.8 La stella binaria ζ di Boote osservata in luce visibile - λ 530 nm Nordic Telescope d = 2.56 m 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 32
33 Metodo sperimentale Per osservare la struttura di oggetti piccoli (cellule, microorganismi, ) Sistemi ottici per convogliare e raccogliare la luce Sorgente di radiazione (lampada) Bersaglio (campione) Rivelatore di radiazione (occhio) Qual e il dettaglio minimo osservabile? Dipende dalla lunghezza d onda λ (colore) della luce usata: d min λ 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 33
34 Il microscopio elettronico Se vogliamo osservare dettagli piu piccoli (virus, ): Sorgente di radiazione (elettroni accelerati) (cannone elettronico, come in una TV) Bersaglio (campione) Rivelatore (dispositivo che misura la corrente di elettroni diffusi dal bersaglio) Anche gli elettroni hanno una λ! Accelerandoli ad energie elevate (p.es. con volt) la loro λ e volte piu piccola di quella della luce visibile! Sistemi ottici per convogliare gli elettroni 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 34
35 La formica e il microchip Un operaia (formica ) trasporta un microchip Microscopio elettronico a scansione 100X 0.3 mm Dettaglio minimo 1 µm 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 35
36 Meno frivolo Virus H5N1 (Influenza aviaria) Circa X 1micron 28 cm 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 36
37 Massa ed energia Particelle di massa elevata possono essere create trasformando energia cinetica in massa. Per formare una massa grande, servono proiettili con grande energia cinetica: 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 37
38 Acceleratori Per esplorare scale di distanza piccole Per consentire la formazione di particelle pesanti Proiettili con velocita elevata, quindi con energia elevata Super microscopio elettronico Condizioni preferite: collisioni testa a testa fra coppie di particelle in movimento (piu energia che puo trasformarsi in massa) 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 38
39 CERN, SLAC e compagnia Gli eredi del microscopio elettronico sono macchine enormi e complesse SLAC Stanford, California CERN, Ginevra, Svizzera Acc. Lineare 3 km Acc. circolari SPS (7 km), LEP/LHC (27 km) 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 39
40 Rivelatori di particelle I sostituti dell occhio umano,, per radiazioni di energia cosi alta, sono anche loro sistemi grandi e complessi ALEPH/CERN Elettronica, ottica, meccanica di precisione Migliaia di computer CDF/FNAL 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 40
41 Fisica ed alta tecnologia Da acceleratori e rivelatori: Straordinari sviluppi tecnologici Ricadute in molti campi di applicazione Lezione del prof. E. Chiavassa a seguire 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 41
42 La Big Science Studio su larga scala, soprattutto dal secondo dopoguerra Comunita mondiale impegnata nella ricerca Gigantismo di acceleratori e rivelatori (e costi) Straordinaria ricaduta tecnologica (magneti, elettronica, fisica medica, software, WWW, ) Collaborazioni di centinaia (oggi, migliaia) di ricercatori Enorme quantita di dati raccolti Interpretazione: analisi dati, computers, reti, Negli ultimi 30 anni, crescenti prove a favore del Modello Standard 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 42
43 Lo zoo delle particelle Moltissimi parenti di protone e neutrone Particelle che interagiscono fortemente: gli adroni Centinaia di specie adroniche Osservati in collisioni ad alta energia Situazione simile a quella incontrata per atomi e nuclei Indizi di una sottostruttura Q = - 1 Q = 0 Q = + 1 S = + 1 K 0 K + S = 0 π + π 0, η π + S = - 1 K + K 0 Q = - 1 Q = 0 Q = + 1 Q = + 2 S = S = - 1 Σ Σ 0 Σ + S = - 2 Ξ Ξ 0 S = - 3 Ω Q= -1 Q= 0 Q=+1 S= 0 n p S= -1 Σ Σ 0,Λ Σ + S= -2 Ξ + Ξ 0 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 43
44 Anche il protone e un atomo Domanda: il protone e elementare o composto? Metodo: versione ingrandita dell esperimento di Rutherford quark elettrone fotone protone Si osservano spesso elettroni diffusi a grandi angoli Indicazione chiara di costituenti puntiformi 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 44
45 Quark Che cosa sono questi costituenti? I quark Un enorme lavoro, sperimentale e teorico, porta a concludere che: Sono puntiformi Interagiscono fortemente Non si osservano liberi Si osservano sotto forma di stati legati Barioni: 3 quark Mesoni: quark-antiquark p π + 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 45
46 Quark: i costituenti degli adroni Scala delle energie: rapporto circa 1 miliardo! Livelli energetici del sistema elettrone + protone: atomo di idrogeno Livelli energetici del sistema quark c + antiquark c: charmonio Struttura, meccanismo simili : costituenti elementari legati 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 46
47 I leptoni, parenti dell elettrone Nel tempo, scoperta di 2 parenti dell elettrone, pesanti, carichi: Muone µ Tauone τ nonche di 3 neutrini, quasi privi di massa, scarichi Neutrino elettronico ν e Neutrino muonico ν µ Neutrino tauonico ν τ Sono puntiformi Interazioni elettromagnetica e debole Si osservano liberi Non si osservano (quasi) sotto forma di stati legati 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 47
48 Il Modello Standard: i costituenti Particelle prive di struttura 6 leptoni 6 quark Ognuno puo avere 3 diverse cariche di colore 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 48
49 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 49
50 Il Modello Standard: le interazioni Interazioni elettromagnetica e debole: unificate ad alta energia nell interazione elettrodebole, sentita da tutti i costituenti Avviene tramite lo scambio di 4 particelle mediatrici (fotone, W ±,Z 0 ) W ±,Z 0 :parenti pesanti del fotone Interazione di colore: sentita dai soli quark Avviene con lo scambio di 8 particelle mediatrici (gluoni) Quark e gluoni confinati dentro gli adroni 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 50
51 La danza perpetua, le regole del gioco Emissione e assorbimento di particelle mediatrici da parte di leptoni e quark Quali sono le regole di questi processi elementari? Come e cominciato,, e come finira tutto questo? Risposta: esperimento e teoria 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 51
52 Toccare con mano le particelle.. Nell esercitazione guidata dal dott. E.Migliore: Misure sui decadimenti della Z 0 18/03/2006 E.Menichetti - Univ. di Torino 52
Le particelle elementari
 Le particelle elementari Masterclass Europea Fisica delle Particelle Elementari Students Day Torino, 20 marzo 2007 20/03/2007 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 Oggi, la fisica è (alla base di tutta) la
Le particelle elementari Masterclass Europea Fisica delle Particelle Elementari Students Day Torino, 20 marzo 2007 20/03/2007 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 Oggi, la fisica è (alla base di tutta) la
Le particelle elementari
 Le particelle elementari Masterclass Europea Fisica delle Particelle Elementari Students Day Torino, 12 marzo 2008 12/03/2008 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 Oggi, la fisica è (alla base di tutta) la
Le particelle elementari Masterclass Europea Fisica delle Particelle Elementari Students Day Torino, 12 marzo 2008 12/03/2008 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 Oggi, la fisica è (alla base di tutta) la
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD
 05/02/2014 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD Scuola di Fisica Torino, 5 febbraio 2014 05/02/2014 E.Menichetti - Univ. di Torino 2 Il Modello Standard Che cos e? Una versione
05/02/2014 E.Menichetti - Univ. di Torino 1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD Scuola di Fisica Torino, 5 febbraio 2014 05/02/2014 E.Menichetti - Univ. di Torino 2 Il Modello Standard Che cos e? Una versione
G.V. Margagliotti. Appunti di Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare a.a. 2017/18
 G.V. Margagliotti Appunti di Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare a.a. 2017/18 2017 Indice 1 Preambolo 11 1.1 I costituenti fondamentali della materia............ 12 1.2 Elementarietà...........................
G.V. Margagliotti Appunti di Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare a.a. 2017/18 2017 Indice 1 Preambolo 11 1.1 I costituenti fondamentali della materia............ 12 1.2 Elementarietà...........................
Cosmologia e particelle
 Cosmologia e particelle Ivan De Mitri Dipartimento di Fisica Università di Lecce Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Due domande fondamentali: Quali sono i costituenti fondamentali della materia? Quali
Cosmologia e particelle Ivan De Mitri Dipartimento di Fisica Università di Lecce Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Due domande fondamentali: Quali sono i costituenti fondamentali della materia? Quali
Introduzione. (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2015/16) Fiorenzo Bastianelli
 Introduzione (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2015/16) 28.9.2015 Fiorenzo Bastianelli Lo scopo del corso è dare una introduzione alla fisica nucleare e subnucleare. Per iniziare conviene
Introduzione (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2015/16) 28.9.2015 Fiorenzo Bastianelli Lo scopo del corso è dare una introduzione alla fisica nucleare e subnucleare. Per iniziare conviene
L atomo di Bohr e i raggi X
 L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
L atomo di Bohr e i raggi X Corsi laboratorio per le scuole superiori gennaio 017 Prof. Federico Boscherini Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Bologna federico.boscherini@unibo.it www.unibo.it/docenti/federico.boscherini
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD
 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD Materia, Energia, Particelle : il DNA delle cose Torino, Marzo 2016 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino 20/03/2016 E.Menichetti -- Dip. di Fisica e INFN, Torino
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO STANDARD Materia, Energia, Particelle : il DNA delle cose Torino, Marzo 2016 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino 20/03/2016 E.Menichetti -- Dip. di Fisica e INFN, Torino
Introduzione. (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2018/19) Fiorenzo Bastianelli
 Introduzione (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2018/19) 18.9.2018 Fiorenzo Bastianelli Lo scopo del corso è dare una introduzione alla fisica nucleare e subnucleare. Per iniziare ricordiamo
Introduzione (Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2018/19) 18.9.2018 Fiorenzo Bastianelli Lo scopo del corso è dare una introduzione alla fisica nucleare e subnucleare. Per iniziare ricordiamo
IL MODELLO STANDARD. Bardonecchia, Gennaio E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino
 IL MODELLO STANDARD Bardonecchia, Gennaio 2017 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino Gennaio 2017 E.Menichetti - Univ. di Torino 2 Quadro di riferimento per la fisica delle particelle e il Modello
IL MODELLO STANDARD Bardonecchia, Gennaio 2017 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino Gennaio 2017 E.Menichetti - Univ. di Torino 2 Quadro di riferimento per la fisica delle particelle e il Modello
Introduzione alle particelle elementari
 Introduzione alle particelle elementari Christian Ferrari Liceo di Locarno Sommario 1 Introduzione Quadro generale e dimensioni del mondo microscopico Atomi, nuclei e nuove particelle Le particelle elementari
Introduzione alle particelle elementari Christian Ferrari Liceo di Locarno Sommario 1 Introduzione Quadro generale e dimensioni del mondo microscopico Atomi, nuclei e nuove particelle Le particelle elementari
Quarks sono fermioni di spin ½ e quindi esistono gli antiquarks. Struttura ripetuta di 3 particelle : u d s
 Quarks sono fermioni di spin ½ e quindi esistono gli antiquarks Struttura ripetuta di 3 particelle : u d s con 3 quarks ½, 3/2 ++ Viola il principio di Pauli numero quantico colore (il principio di Pauli
Quarks sono fermioni di spin ½ e quindi esistono gli antiquarks Struttura ripetuta di 3 particelle : u d s con 3 quarks ½, 3/2 ++ Viola il principio di Pauli numero quantico colore (il principio di Pauli
Materia e forze alla scala subatomica: il nucleo atomico, le particelle elementari
 Materia e forze alla scala subatomica: il nucleo atomico, le particelle elementari Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Modena,
Materia e forze alla scala subatomica: il nucleo atomico, le particelle elementari Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Modena,
MATERIA, ENERGIA, PARTICELLE
 08/01/2016 E.Menichetti - Dip. di Fisica e INFN, Torino 1 MATERIA, ENERGIA, PARTICELLE Modello Standard: il DNA delle cose Bardonecchia, Gennaio 2016 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino 08/01/2016
08/01/2016 E.Menichetti - Dip. di Fisica e INFN, Torino 1 MATERIA, ENERGIA, PARTICELLE Modello Standard: il DNA delle cose Bardonecchia, Gennaio 2016 E.Menichetti Dip. di Fisica e INFN, Torino 08/01/2016
Perché LHC? Breve viaggio nella fisica delle particelle. Paolo Gambino Università di Torino. Prali 24/4/2010 1
 Perché LHC? Breve viaggio nella fisica delle particelle Paolo Gambino Università di Torino Prali 24/4/2010 1 Alla ricerca della semplicità LHC è una straordinaria avventura: una sfida tecnologica senza
Perché LHC? Breve viaggio nella fisica delle particelle Paolo Gambino Università di Torino Prali 24/4/2010 1 Alla ricerca della semplicità LHC è una straordinaria avventura: una sfida tecnologica senza
Introduzione alla meccanica quantistica. Vincenzo Barone
 Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
Accademia delle Scienze di Torino 9 novembre 2017 Introduzione alla meccanica quantistica Vincenzo Barone barone@to.infn.it Parte I: Le basi della meccanica quantistica (questioni didattiche) Parte II:
La Gravità come Teoria Fondamentale
 La Gravità come Teoria Fondamentale Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
La Gravità come Teoria Fondamentale Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA
 Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA Marta Ruspa 20.01.13 M. Ruspa 1 ONDE ELETTROMAGNETICHE
Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per RADIOTERAPIA Marta Ruspa 20.01.13 M. Ruspa 1 ONDE ELETTROMAGNETICHE
L'origine della massa e il bosone di Higgs. Massimo Casarsa Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Trieste
 L'origine della massa e il bosone di Higgs Massimo Casarsa Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Trieste Trieste Next 28 29 30 settembre 2012 Scaletta ➊ Parte I: breve introduzione sul Modello
L'origine della massa e il bosone di Higgs Massimo Casarsa Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Trieste Trieste Next 28 29 30 settembre 2012 Scaletta ➊ Parte I: breve introduzione sul Modello
FISICA delle APPARECCHIATURE per MEDICINA NUCLEARE
 Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per MEDICINA NUCLEARE (lezione I, 07.05.13) Marta Ruspa 1 L
Anno Accademico 2012-2013 Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia FISICA delle APPARECCHIATURE per MEDICINA NUCLEARE (lezione I, 07.05.13) Marta Ruspa 1 L
Teoria Atomica di Dalton
 Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Teoria Atomica di Dalton Il concetto moderno della materia si origina nel 1806 con la teoria atomica di John Dalton: Ogni elementoè composto di atomi. Gli atomi di un dato elemento sono uguali. Gli atomi
Modello Standard e oltre. D. Babusci MasterClass 2007
 Modello Standard e oltre D. Babusci MasterClass 2007 Fisica delle Particelle Elementari (FdP) Si interessa del comportamento fisico dei costituenti fondamentali del mondo, i.e. di oggetti al contempo molto
Modello Standard e oltre D. Babusci MasterClass 2007 Fisica delle Particelle Elementari (FdP) Si interessa del comportamento fisico dei costituenti fondamentali del mondo, i.e. di oggetti al contempo molto
Fisica Nucleare e Fisica delle Particelle Elementari. Fabio Bossi, Laboratori Nazionali di Frascati INFN
 Fisica Nucleare e Fisica delle Particelle Elementari Fabio Bossi, Laboratori Nazionali di Frascati INFN La varieta di oggetti di differente forma e consistenza esistente in natura e forse il fatto osservativo
Fisica Nucleare e Fisica delle Particelle Elementari Fabio Bossi, Laboratori Nazionali di Frascati INFN La varieta di oggetti di differente forma e consistenza esistente in natura e forse il fatto osservativo
Radiazioni ionizzanti
 Dipartimento di Fisica a.a. 2004/2005 Fisica Medica 2 Radiazioni ionizzanti 11/3/2005 Struttura atomica Atomo Nucleo Protone 10 10 m 10 14 m 10 15 m ev MeV GeV 3 3,0 0,3 0 0 0 Atomo Dimensioni lineari
Dipartimento di Fisica a.a. 2004/2005 Fisica Medica 2 Radiazioni ionizzanti 11/3/2005 Struttura atomica Atomo Nucleo Protone 10 10 m 10 14 m 10 15 m ev MeV GeV 3 3,0 0,3 0 0 0 Atomo Dimensioni lineari
Le particelle elementari e l acceleratore LHC al CERN di Ginevra
 Le particelle elementari e l acceleratore LHC al CERN di Ginevra Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze andrea.bizzeti@fi.infn.it
Le particelle elementari e l acceleratore LHC al CERN di Ginevra Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze andrea.bizzeti@fi.infn.it
FISICA NUCLEARE. Liceo scientifico Don Bosco Fisica nucleare pag.1
 FISICA NUCLEARE Atomo e dimensioni atomiche Elementi chimici e isotopi Le quattro forze fondamentali Forza gravitazionale Forza elettrica Forze nucleari forte Forza nucleare debole Stabilità e radioattività
FISICA NUCLEARE Atomo e dimensioni atomiche Elementi chimici e isotopi Le quattro forze fondamentali Forza gravitazionale Forza elettrica Forze nucleari forte Forza nucleare debole Stabilità e radioattività
Gli acceleratori di particelle
 Gli acceleratori di particelle seconda parte Corso di valorizzazione delle eccellenze in Matematica e Fisica Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico Giolitti-Gandino Come facciamo a vedere gli
Gli acceleratori di particelle seconda parte Corso di valorizzazione delle eccellenze in Matematica e Fisica Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico Giolitti-Gandino Come facciamo a vedere gli
L Universo secondo la Fisica moderna
 Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi
Unità didattica 10. Decima unità didattica (Fisica) 1. Corso integrato di Matematica e Fisica per il Corso di Farmacia
 Unità didattica 10 Radioattività... 2 L atomo... 3 Emissione di raggi x... 4 Decadimenti nucleari. 6 Il decadimento alfa.... 7 Il decadimento beta... 8 Il decadimento gamma...... 9 Interazione dei fotoni
Unità didattica 10 Radioattività... 2 L atomo... 3 Emissione di raggi x... 4 Decadimenti nucleari. 6 Il decadimento alfa.... 7 Il decadimento beta... 8 Il decadimento gamma...... 9 Interazione dei fotoni
Introduzione alle particelle elementari
 Introduzione alle particelle elementari Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze andrea.bizzeti@fi.infn.it Physics Masterclass, Modena
Introduzione alle particelle elementari Andrea Bizzeti Università di Modena e Reggio Emilia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze andrea.bizzeti@fi.infn.it Physics Masterclass, Modena
Le Interazioni Fondamentali delle Particelle Elementari
 Le Interazioni Fondamentali delle Particelle Elementari Roberto Passante Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche, Università di Palermo ITI Mottura, Caltanissetta, 27 Marzo 2009 Struttura dell
Le Interazioni Fondamentali delle Particelle Elementari Roberto Passante Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche, Università di Palermo ITI Mottura, Caltanissetta, 27 Marzo 2009 Struttura dell
Il Modello Standard delle particelle
 Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
Il Modello Standard delle particelle Vittorio Del Duca INFN LNF Stages Estivi 12 giugno 2012 Elementi La materia è fatta di elementi con definite proprietà chimiche Atomi Ciascun elemento ha come mattone
LHC e la struttura dell Universo. Luca Lista INFN
 LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
LHC e la struttura dell Universo Luca Lista INFN Dalle particelle elementari all Universo Perché le particelle elementari sono importanti per capire la struttura dell Universo? L origine dell Universo:
SOMMARIO Premessa Classificazioni generali Zoo delle particelle Forze elementari Quadro d insieme Any question? Decadimenti radioattivi Fusione nuclea
 L ATOMO DIVISIBILE Dr. Stefano Gestri L.S. Niccolò Copernico Prato, 06-03-2014 SOMMARIO Premessa Classificazioni generali Zoo delle particelle Forze elementari Quadro d insieme Any question? Decadimenti
L ATOMO DIVISIBILE Dr. Stefano Gestri L.S. Niccolò Copernico Prato, 06-03-2014 SOMMARIO Premessa Classificazioni generali Zoo delle particelle Forze elementari Quadro d insieme Any question? Decadimenti
Introduzione alle attivita dei Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 Introduzione alle attivita dei Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare A cura di L.Benussi, P. Gianotti, G.Mazzitelli, C. Petrascu, B.Sciascia con il supporto del Servizio
Introduzione alle attivita dei Laboratori Nazionali di Frascati dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare A cura di L.Benussi, P. Gianotti, G.Mazzitelli, C. Petrascu, B.Sciascia con il supporto del Servizio
Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC
 Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC Valentina Zaccolo 26/03/19 e INFN Trieste Valentina Zaccolo Particelle e LHC Università 1 Dal mondo visibile... Dal macro al micro 26/03/19 Valentina
Le particelle elementari e la fisica di frontiera a LHC Valentina Zaccolo 26/03/19 e INFN Trieste Valentina Zaccolo Particelle e LHC Università 1 Dal mondo visibile... Dal macro al micro 26/03/19 Valentina
PROGETTO AMICI DI SCIASCIA. Fisica delle particelle
 PROGETTO AMICI DI SCIASCIA Fisica delle particelle TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 1. STORIA DELLA FISICA DELLE PARTICELLE 2. COME E FATTO L ATOMO? IPOTESI SULLA STRUTTURA DELL ATOMO 3. LA FISICA DELLE
PROGETTO AMICI DI SCIASCIA Fisica delle particelle TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 1. STORIA DELLA FISICA DELLE PARTICELLE 2. COME E FATTO L ATOMO? IPOTESI SULLA STRUTTURA DELL ATOMO 3. LA FISICA DELLE
Tutti i colori dell Universo. Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004
 Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Tutti i colori dell Universo Roberto Battiston INFN e Universita di Perugia Laboratori di Frascati 6 ottobre 2004 1 2 3 L universo si studia osservando le informazioni = particelle che esso ci invia 4
Esploriamo la chimica
 1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 7 Le particelle dell atomo 1. La natura elettrica della materia 2. Le particelle fondamentali
1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 7 Le particelle dell atomo 1. La natura elettrica della materia 2. Le particelle fondamentali
ATOMO. Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton
 Democrito IV secolo A.C. ATOMO Lavoisier Proust Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton (1808) Teoria atomica Gay-Lussac volumi di gas reagiscono secondo rapporti
Democrito IV secolo A.C. ATOMO Lavoisier Proust Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton (1808) Teoria atomica Gay-Lussac volumi di gas reagiscono secondo rapporti
Tentativi di Unificazione delle Interazioni Fondamentali. Augusto SAGNOTTI
 Tentativi di Unificazione delle Interazioni Fondamentali Augusto SAGNOTTI Scuola Normale Superiore,, Pisa San Miniato,, 3 settembre 2006 Premessa La Fisica (in linea di principio) e un impresa UMILE: Collezionare
Tentativi di Unificazione delle Interazioni Fondamentali Augusto SAGNOTTI Scuola Normale Superiore,, Pisa San Miniato,, 3 settembre 2006 Premessa La Fisica (in linea di principio) e un impresa UMILE: Collezionare
Acceleratori e Rivelatori di Particelle Elementari
 Acceleratori e Rivelatori di Particelle Elementari Massimiliano Fiorini!! Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra! Università degli Studi di Ferrara! e-mail: Massimiliano.Fiorini@cern.ch! International
Acceleratori e Rivelatori di Particelle Elementari Massimiliano Fiorini!! Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra! Università degli Studi di Ferrara! e-mail: Massimiliano.Fiorini@cern.ch! International
Sviluppi recenti della fisica sub-nucleare
 Sviluppi recenti della fisica sub-nucleare Si intende fornire una breve quadro storico, ma aggiornato agli ultimi eventi, della ricerca dei costituenti subnucleari della materia. Carlo Maria Becchi, INFN
Sviluppi recenti della fisica sub-nucleare Si intende fornire una breve quadro storico, ma aggiornato agli ultimi eventi, della ricerca dei costituenti subnucleari della materia. Carlo Maria Becchi, INFN
Fisica Moderna e contemporanea
 Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Fisica Moderna e contemporanea SSIS Puglia Prof. Luigi Schiavulli luigi.schiavulli@ba.infn.it Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin 02/02/2006 1 Sommario Quadro riassuntivo sulla Fisica
Fisica delle Interazioni Fondamentali. All'inizio del '900 due grandi rivoluzioni scientifiche. Meccanica Quantistica. Relatività Ristretta
 Fisica delle Interazioni Fondamentali All'inizio del '900 due grandi rivoluzioni scientifiche Meccanica Quantistica Relatività Ristretta (più tardi anche Relatività Generale) ONDE GRAVITAZIONALI MECCANICA
Fisica delle Interazioni Fondamentali All'inizio del '900 due grandi rivoluzioni scientifiche Meccanica Quantistica Relatività Ristretta (più tardi anche Relatività Generale) ONDE GRAVITAZIONALI MECCANICA
Fisica Nucleare e Subnucleare
 Curriculum di Fisica Nucleare e Subnucleare è rivolto allo studio sperimentale dei fenomeni che interessano nuclei e particelle elementari al fine di una più completa conoscenza delle interazioni fondamentali
Curriculum di Fisica Nucleare e Subnucleare è rivolto allo studio sperimentale dei fenomeni che interessano nuclei e particelle elementari al fine di una più completa conoscenza delle interazioni fondamentali
Lezione 19 Fisica nucleare
 Lezione 19 Fisica nucleare Nucleo Il nucleo atomico è costituito da nucleoni (N), ovvero: protoni (p) e neutroni (n). Il numero di p è caratteristico di ogni elemento; è detto numero atomico ed è indicato
Lezione 19 Fisica nucleare Nucleo Il nucleo atomico è costituito da nucleoni (N), ovvero: protoni (p) e neutroni (n). Il numero di p è caratteristico di ogni elemento; è detto numero atomico ed è indicato
Il Nucleo. Dimensioni del nucleo dell'ordine di 10. m Il raggio nucleare R = R 0 -15
 Il Nucleo Nucleo e' costituito da nucleoni (protoni e neutroni). Mentre i neutroni liberi sono abbastanza instabili tendono a decadere in un protone ed un elettrone (t 1/2 circa 900 s), i protoni sono
Il Nucleo Nucleo e' costituito da nucleoni (protoni e neutroni). Mentre i neutroni liberi sono abbastanza instabili tendono a decadere in un protone ed un elettrone (t 1/2 circa 900 s), i protoni sono
Bosone. Particella a spin intero, che obbedisce alla statistica di Bose-Einstein, che è opposta a quella di Fermi-Dirac.
 Particelle ed Interazioni fondamentali Fermione. Particella a spin semintero, che obbedisce alla statistica di Fermi-Dirac, cioè due fermioni con gli stessi numeri quantici non possono coesistere in uno
Particelle ed Interazioni fondamentali Fermione. Particella a spin semintero, che obbedisce alla statistica di Fermi-Dirac, cioè due fermioni con gli stessi numeri quantici non possono coesistere in uno
FAM A+B C. Considera la disintegrazione di una particella A in due particelle B e C: A B +C.
 Serie 19: Relatività VIII FAM C. Ferrari Esercizio 1 Collisione completamente anelastica Considera la collisione frontale di due particelle A e B di massa M A = M B = M e v A = v B = 3/5c, tale che alla
Serie 19: Relatività VIII FAM C. Ferrari Esercizio 1 Collisione completamente anelastica Considera la collisione frontale di due particelle A e B di massa M A = M B = M e v A = v B = 3/5c, tale che alla
STRUTTURA ATOMICA. Per lo studio della struttura dell atomo ci si avvale della Spettroscopia.
 STRUTTURA ATOMICA Il modello planetario dell atomo secondo Rutherford si appoggia sulla meccanica classica. Il modello non può essere corretto visto che per descrivere il comportamento delle particelle
STRUTTURA ATOMICA Il modello planetario dell atomo secondo Rutherford si appoggia sulla meccanica classica. Il modello non può essere corretto visto che per descrivere il comportamento delle particelle
1 3 STRUTTURA ATOMICA
 1 3 STRUTTURA ATOMICA COME SI SPIEGA LA STRUTTURA DELL ATOMO? Secondo il modello atomico di Rutherford e sulla base della fisica classica, gli elettroni dovrebbero collassare sul nucleo per effetto delle
1 3 STRUTTURA ATOMICA COME SI SPIEGA LA STRUTTURA DELL ATOMO? Secondo il modello atomico di Rutherford e sulla base della fisica classica, gli elettroni dovrebbero collassare sul nucleo per effetto delle
Indice. Meccanica. Le grandezze fsiche. Il moto in una dimensione. Il moto in due dimensioni. Le forze e l equilibrio III
 Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
Indice Meccanica 1 2 3 4 Le grandezze fsiche 1 Grandezze fsiche 2 2 Il Sistema Internazionale di Unità 3 3 Notazione scientifca e approssimazioni 5 4 L intervallo di tempo 9 5 La lunghezza 9 6 La massa
Particelle elementari ed interazioni fondamentali
 Particelle elementari ed interazioni fondamentali Napoli,26 febbraio 2009 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla?
Particelle elementari ed interazioni fondamentali Napoli,26 febbraio 2009 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla?
Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti.
 1. La natura elettrica della materia Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti. La carica elettrica può essere positiva o
1. La natura elettrica della materia Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti. La carica elettrica può essere positiva o
L energia assorbita dall atomo durante l urto iniziale è la stessa del fotone che sarebbe emesso nel passaggio inverso, e quindi vale: m
 QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
Programma del corso di Particelle Elementari
 Programma del corso di Particelle Elementari 1. Le interazioni fondamentali 1.1 Costituenti elementari 1.2 Quark e colore 1.3 Il colore come carica dell interazione nucleare 1.4 Unità naturali 1.5 Interazione
Programma del corso di Particelle Elementari 1. Le interazioni fondamentali 1.1 Costituenti elementari 1.2 Quark e colore 1.3 Il colore come carica dell interazione nucleare 1.4 Unità naturali 1.5 Interazione
Crisi della Fisica Classica & Fisica Quantistica
 Crisi della Fisica Classica & Fisica Quantistica Guido Montagna Dipartimento di Fisica, Università di Pavia & INFN, Sezione di Pavia February 11, 2018 G. Montagna, Università di Pavia & INFN (Dipartimento
Crisi della Fisica Classica & Fisica Quantistica Guido Montagna Dipartimento di Fisica, Università di Pavia & INFN, Sezione di Pavia February 11, 2018 G. Montagna, Università di Pavia & INFN (Dipartimento
Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari?
 13 a edizione C. Patrignani - Bologna Masterclasses 2017 2 Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari? quali sono i costituenti elementari della materia che ci circonda? quali
13 a edizione C. Patrignani - Bologna Masterclasses 2017 2 Cosa vogliamo capire studiando la fisica delle particelle elementari? quali sono i costituenti elementari della materia che ci circonda? quali
International Masterclasses 2019
 International Masterclasses 2019 Bologna, 25 e 26 febbraio 2019 http://www.bo.infn.it/masterclass/2019/index.html Masterclass Siamo alla XV edizione (a Bologna alla IX) L Iniziativa fa parte delle Masterclass
International Masterclasses 2019 Bologna, 25 e 26 febbraio 2019 http://www.bo.infn.it/masterclass/2019/index.html Masterclass Siamo alla XV edizione (a Bologna alla IX) L Iniziativa fa parte delle Masterclass
Fisica delle Particelle: esperimenti. Fabio Bossi (LNF INFN)
 Fisica delle Particelle: esperimenti Fabio Bossi (LNF INFN) fabio.bossi@lnf.infn.it Il processo scientifico di conoscenza Esperimento Osservazione quantitativa di fenomeni riguardanti alcune particelle
Fisica delle Particelle: esperimenti Fabio Bossi (LNF INFN) fabio.bossi@lnf.infn.it Il processo scientifico di conoscenza Esperimento Osservazione quantitativa di fenomeni riguardanti alcune particelle
Divagazioni sulla fisica delle particelle. La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni fondamentali
 Divagazioni sulla fisica delle particelle La fisica delle particelle come pretesto per fare alcune semplici considerazioni di fisica La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni
Divagazioni sulla fisica delle particelle La fisica delle particelle come pretesto per fare alcune semplici considerazioni di fisica La struttura della materia Le particelle fondamentali Le interazioni
Introduzione al corso. Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora...
 Introduzione al corso Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora... Legge di Boyle (1662)-> La pressione di un gas cresce quando decresce
Introduzione al corso Cenni storici ed evidenze sperimentali determinanti lo sviluppo della fisica atomica come la conosciamo ora... Legge di Boyle (1662)-> La pressione di un gas cresce quando decresce
La chimica nucleare. A cura della prof. ssa. Barone Antonina
 La chimica nucleare A cura della prof. ssa Barone Antonina La radioattività Nella seconda metà dell 800, Henry Becquerel, Pierre e Marie Curie, scoprirono che alcuni elementi( uranio, torio, radio) emettevano
La chimica nucleare A cura della prof. ssa Barone Antonina La radioattività Nella seconda metà dell 800, Henry Becquerel, Pierre e Marie Curie, scoprirono che alcuni elementi( uranio, torio, radio) emettevano
Fisica atomica. Marcello Borromeo corso di Fisica per Farmacia - Anno Accademico
 Fisica atomica Nel 1905 Einstein sostiene che la luce viaggia in pacchetti di energia, chiamati fotoni Ogni fotone ha energia proporzionale alla propria frequenza E = hν: h = 6.626 10 34 J s è chiamata
Fisica atomica Nel 1905 Einstein sostiene che la luce viaggia in pacchetti di energia, chiamati fotoni Ogni fotone ha energia proporzionale alla propria frequenza E = hν: h = 6.626 10 34 J s è chiamata
I rivelatori. Osservare il microcosmo. EEE- Cosmic Box proff.: M.Cottino, P.Porta
 I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
I rivelatori Osservare il microcosmo Cose prima mai viste L occhio umano non riesce a distinguere oggetti con dimensioni inferiori a 0,1 mm (10-4 m). I primi microscopi vennero prodotti in Olanda alla
ATOMO. Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton
 Democrito IV secolo A.C. ATOMO Lavoisier Proust Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton (808) Teoria atomica Gay-Lussac volumi di gas reagiscono secondo rapporti interi
Democrito IV secolo A.C. ATOMO Lavoisier Proust Legge della conservazione della massa Legge delle proporzioni definite Dalton (808) Teoria atomica Gay-Lussac volumi di gas reagiscono secondo rapporti interi
ELENCO ANALITICO DEGLI ARGOMENTI
 PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
PROGRAMMA PER ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE II FISICA dipartimento e contiene gli argomenti essenziali per l accesso al II anno di corso. INTRODUZIONE ALLA FISICA: GRANDEZZE E MISURE Metodo scientifico,
Particelle elementari ed interazioni fondamentali
 Particelle elementari ed interazioni fondamentali Napoli, 14 Febbraio 2012 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla?
Particelle elementari ed interazioni fondamentali Napoli, 14 Febbraio 2012 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla?
PERCHE LHC? Perche acceleratori a energie sempre maggiori? Cos è il bosone di Higgs?
 PERCHE LHC? Perche acceleratori a energie sempre maggiori? Cos è il bosone di Higgs? La fisica delle particelle elementari e governata dalle leggi della Relativita e della Meccanica Quantistica. Perché
PERCHE LHC? Perche acceleratori a energie sempre maggiori? Cos è il bosone di Higgs? La fisica delle particelle elementari e governata dalle leggi della Relativita e della Meccanica Quantistica. Perché
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu
 Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 7 Le particelle dell atomo 3 Sommario (I) 1. La natura elettrica della materia 2. La scoperta delle proprietà elettriche 3. Le
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 7 Le particelle dell atomo 3 Sommario (I) 1. La natura elettrica della materia 2. La scoperta delle proprietà elettriche 3. Le
LE FORMULE 66 ESERCIZI 67. PROBLEMA #alternatore 67. PROBLEMA #circuitocapacitivo 69. PROBLEMA #circuitorlc 70. PROBLEMA #potenza 73 PROBLEMA
 INDICE 21 L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 22 LA CORRENTE ALTERNATA 1. La corrente indotta 2 2. La legge dell induzione di Faraday-Neumann 5 3. La fem cinetica 8 4. La legge di Lenz 10 5. L autoinduzione 13
INDICE 21 L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 22 LA CORRENTE ALTERNATA 1. La corrente indotta 2 2. La legge dell induzione di Faraday-Neumann 5 3. La fem cinetica 8 4. La legge di Lenz 10 5. L autoinduzione 13
La struttura dell atomo
 La Teoria Atomica La struttura dell atomo 10-10 m 10-14 m Proprietà delle tre particelle subatomiche fondamentali Carica Massa Nome (simbolo) relativa assoluta (C) relativa (uma)* Assoluta (g) Posizione
La Teoria Atomica La struttura dell atomo 10-10 m 10-14 m Proprietà delle tre particelle subatomiche fondamentali Carica Massa Nome (simbolo) relativa assoluta (C) relativa (uma)* Assoluta (g) Posizione
L Unificazione delle Forze: E Possibile? Gianfranco PRADISI Dipartimento di Fisica
 L Unificazione delle Forze: E Possibile? Gianfranco PRADISI Dipartimento di Fisica I PILASTRI MECCANICA QUANTISTICA + Teoria Quantistica dei Campi Modello Standard Interazioni Elettrodeboli (Elettromagnetiche
L Unificazione delle Forze: E Possibile? Gianfranco PRADISI Dipartimento di Fisica I PILASTRI MECCANICA QUANTISTICA + Teoria Quantistica dei Campi Modello Standard Interazioni Elettrodeboli (Elettromagnetiche
Radioattività. 1. Massa dei nuclei. 2. Decadimenti nucleari. 3. Legge del decadimento XVI - 0. A. Contin - Fisica Generale Avanzata
 Radioattività 1. Massa dei nuclei 2. Decadimenti nucleari 3. Legge del decadimento XVI - 0 Nucleoni Protoni e neutroni sono chiamati, indifferentemente, nucleoni. Il numero di protoni (e quindi di elettroni
Radioattività 1. Massa dei nuclei 2. Decadimenti nucleari 3. Legge del decadimento XVI - 0 Nucleoni Protoni e neutroni sono chiamati, indifferentemente, nucleoni. Il numero di protoni (e quindi di elettroni
Spettro delle onde elettromagnetiche. Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione
 Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
Spettro delle onde elettromagnetiche Ottica: luce visibile leggi della riflessione e rifrazione Introduzione Abbiamo visto che la propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto è regolata dalle
2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA
 2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA 184 2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA Forza elettromagnetica 184 2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA Forza elettromagnetica? Raggio massimo
2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA 184 2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA Forza elettromagnetica 184 2 LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA NATURA Forza elettromagnetica? Raggio massimo
Capitolo 8 La struttura dell atomo
 Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
Capitolo 8 La struttura dell atomo 1. La doppia natura della luce 2. La «luce» degli atomi 3. L atomo di Bohr 4. La doppia natura dell elettrone 5. L elettrone e la meccanica quantistica 6. L equazione
Lezione 1 ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE APPLICATA ALLA MEDICINA
 Lezione 1 ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE APPLICATA ALLA MEDICINA RADIAZIONE=PROPAGAZIONE DI ENERGIA NELLO SPAZIO L energia può essere associata: a particelle materiali (radiazione corpuscolare), a vibrazioni
Lezione 1 ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE APPLICATA ALLA MEDICINA RADIAZIONE=PROPAGAZIONE DI ENERGIA NELLO SPAZIO L energia può essere associata: a particelle materiali (radiazione corpuscolare), a vibrazioni
La Fisica del Microcosmo
 Fisica 24 ore La Fisica del Microcosmo Dalla Meccanica Quantistica al Modello Standard delle Particelle Elementari Le due grandi rivoluzioni dell inizio 900: Meccanica Quantistica Relatività E = mc 2 Equazione
Fisica 24 ore La Fisica del Microcosmo Dalla Meccanica Quantistica al Modello Standard delle Particelle Elementari Le due grandi rivoluzioni dell inizio 900: Meccanica Quantistica Relatività E = mc 2 Equazione
Modelli atomici Modello atomico di Rutheford Per t s d u i diare la t s rutt ttura t a omica Ruth th f or (
 Modello atomico di Rutheford Per studiare la struttura tt atomica Rutherford (1871-1937) 1937) nel 1910 bombardòb una lamina d oro con particelle a (cioè atomi di elio) Rutherford suppose che gli atomi
Modello atomico di Rutheford Per studiare la struttura tt atomica Rutherford (1871-1937) 1937) nel 1910 bombardòb una lamina d oro con particelle a (cioè atomi di elio) Rutherford suppose che gli atomi
Sommario della lezione 2. Materia e definizioni. Struttura dell atomo
 Sommario della lezione 2 Materia e definizioni Struttura dell atomo La materia è qualsiasi cosa abbia una massa e occupi uno spazio. Esiste in tre stati: Solido Forma e volume determinati Liquido Volume
Sommario della lezione 2 Materia e definizioni Struttura dell atomo La materia è qualsiasi cosa abbia una massa e occupi uno spazio. Esiste in tre stati: Solido Forma e volume determinati Liquido Volume
Pendoli Accoppiati. Oscillazioni di Neutrini. Incontri di Orientamento PLS - Università Sapienza - 4 dicembre 2015 Lucio Ludovici/INFN
 Pendoli Accoppiati e Oscillazioni di Neutrini Incontri di Orientamento PLS - Università Sapienza - 4 dicembre 2015 Lucio Ludovici/INFN Lucio Ludovici Pendoli Accoppiati e Oscillazioni di Neutrini 2 Cosa
Pendoli Accoppiati e Oscillazioni di Neutrini Incontri di Orientamento PLS - Università Sapienza - 4 dicembre 2015 Lucio Ludovici/INFN Lucio Ludovici Pendoli Accoppiati e Oscillazioni di Neutrini 2 Cosa
introduzione alla fisica subnucleare
 introduzione alla isica subnucleare AA 2006/07 Giovanni Busetto 1 la isica subnucleare oggi gli elementi del Modello Standard AA 2006/07 Giovanni Busetto 2 la isica subnucleare oggi 3 interazioni ondamentali
introduzione alla isica subnucleare AA 2006/07 Giovanni Busetto 1 la isica subnucleare oggi gli elementi del Modello Standard AA 2006/07 Giovanni Busetto 2 la isica subnucleare oggi 3 interazioni ondamentali
DOMANDE PER CAPIRE LA FISICA
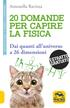 INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
INTRODUZIONE Questo libro ha lo scopo di introdurre in modo semplice alcuni interessantissimi argomenti di fisica moderna, che tengono molto impegnati gli scienziati di tutto il mondo e affascinano gli
Introduzione MODELLO STANDARD
 Introduzione MODELLO STANDARD Il Modello Standard riassume le conoscenze attuali sulle particelle fondamentali e sulle forze che interagiscono tra esse. Il Modello Standard descrive in quale modo la materia
Introduzione MODELLO STANDARD Il Modello Standard riassume le conoscenze attuali sulle particelle fondamentali e sulle forze che interagiscono tra esse. Il Modello Standard descrive in quale modo la materia
Napoli, 15 Febbraio /04/2013 F. Conventi
 Napoli, 15 Febbraio 2013 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla? (o descriverla)? Se sì, come? (quale linguaggio
Napoli, 15 Febbraio 2013 Esistono sicuramente domande che, da sempre, ci coinvolgono... Come è fatto il mondo (la realtà) che ci circonda? Possiamo comprenderla? (o descriverla)? Se sì, come? (quale linguaggio
Introduzione alla Fisica di EEE plus
 Introduzione alla Fisica di EEE plus Emanuele Biolcati Liceo Classico Massimo D Azeglio 28 settembre 2018 Emanuele Biolcati 1 Poniamoci alcune domande 1 Raggi cosmici Cosa sono? Perché si studiano? Come
Introduzione alla Fisica di EEE plus Emanuele Biolcati Liceo Classico Massimo D Azeglio 28 settembre 2018 Emanuele Biolcati 1 Poniamoci alcune domande 1 Raggi cosmici Cosa sono? Perché si studiano? Come
Il nucleo dell atomo
 Il nucleo dell atomo Ci sono quattro interazioni(forze) i i(f tra le particelle: Gravita ElettroMagnetica Nucleare Forte Nucleare Debole Le forze La forza nucleare forte è responsabile del legame tra i
Il nucleo dell atomo Ci sono quattro interazioni(forze) i i(f tra le particelle: Gravita ElettroMagnetica Nucleare Forte Nucleare Debole Le forze La forza nucleare forte è responsabile del legame tra i
Richiami di radioattività e radiazioni ionizzanti
 Richiami di radioattività e radiazioni ionizzanti Corso di formazione dei lavoratori Dott. Roberto Falcone GSP4 ION IRP Casaccia Generalità particelle - beta β - (o β + ) - è un elettrone ( o un antielettrone)
Richiami di radioattività e radiazioni ionizzanti Corso di formazione dei lavoratori Dott. Roberto Falcone GSP4 ION IRP Casaccia Generalità particelle - beta β - (o β + ) - è un elettrone ( o un antielettrone)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA. REGISTRO DELLE LEZIONI (di cui all art. 39 del Regio Decreto 6 aprile 1924, n. 674)
 Mod. 1/147 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Facoltà di Scienze M.F.N. REGISTRO DELLE LEZIONI (di cui all art. 39 del Regio Decreto 6 aprile 1924, n. 674) di Fisica delle particelle elementari
Mod. 1/147 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Facoltà di Scienze M.F.N. REGISTRO DELLE LEZIONI (di cui all art. 39 del Regio Decreto 6 aprile 1924, n. 674) di Fisica delle particelle elementari
Stelle e Neutrini: il centro del Sole
 Stelle e Neutrini: il centro del Sole Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
Stelle e Neutrini: il centro del Sole Marco G. Giammarchi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via Celoria 16 20133 Milano (Italy) marco.giammarchi@mi.infn.it http://pcgiammarchi.mi.infn.it/giammarchi/
Fisica quantistica. Liceo Malpighi, a.s. 2016/17
 Fisica quantistica Liceo Malpighi, a.s. 2016/17 DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA (lungo periodo di transizione a cavallo fra 800 e 900) MECCANICA E ASTRONOMIA NEL XIX SEC. Previsione di Nettuno
Fisica quantistica Liceo Malpighi, a.s. 2016/17 DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA (lungo periodo di transizione a cavallo fra 800 e 900) MECCANICA E ASTRONOMIA NEL XIX SEC. Previsione di Nettuno
Fisica dei mesoni. Mesoni sono particelle con spin intero e interagisce coi barioni (nucleoni) attraverso le forze forti, elettromagnetiche e deboli
 Fisica dei mesoni Mesone π e quello piu leggero nella famiglia dei mesoni E la particella che viene scambiato nell interazione forte nucleone-nucleone ed e quindi responsabile della maggiore componente
Fisica dei mesoni Mesone π e quello piu leggero nella famiglia dei mesoni E la particella che viene scambiato nell interazione forte nucleone-nucleone ed e quindi responsabile della maggiore componente
Generalità delle onde elettromagnetiche
 Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Generalità delle onde elettromagnetiche Ampiezza massima: E max (B max ) Lunghezza d onda: (m) E max (B max ) Periodo: (s) Frequenza: = 1 (s-1 ) Numero d onda: = 1 (m-1 ) = v Velocità della luce nel vuoto
Cenni di fisica moderna
 Cenni di fisica moderna 1 fisica e salute la fisica delle radiazioni è molto utilizzata in campo medico esistono applicazioni delle radiazioni non ionizzanti nella terapia e nella diagnosi (laser per applicazioni
Cenni di fisica moderna 1 fisica e salute la fisica delle radiazioni è molto utilizzata in campo medico esistono applicazioni delle radiazioni non ionizzanti nella terapia e nella diagnosi (laser per applicazioni
Analisi chimiche per i beni culturali
 Analisi chimiche per i beni culturali Nicola Ludwig ricevimento: in via Noto giovedì dopo lezione Nicola.Ludwig@unimi.it Istituto di Fisica Generale Applicata, via Celoria 16 Programma L obiettivo del
Analisi chimiche per i beni culturali Nicola Ludwig ricevimento: in via Noto giovedì dopo lezione Nicola.Ludwig@unimi.it Istituto di Fisica Generale Applicata, via Celoria 16 Programma L obiettivo del
Il nucleo dell atomo
 Il nucleo dell atomo Ci sono quattro interazioni(forze) i i(f tra le particelle: Gravita ElettroMagnetica Nucleare Forte Nucleare Debole Le forze La forza nucleare forte è responsabile del legame tra i
Il nucleo dell atomo Ci sono quattro interazioni(forze) i i(f tra le particelle: Gravita ElettroMagnetica Nucleare Forte Nucleare Debole Le forze La forza nucleare forte è responsabile del legame tra i
