Ridefinizione biostratigrafica e geocronologica delle unità formazionali neogeniche della Sardegna centrale (Italia)(*)
|
|
|
- Leonzia Mosca
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rendiconti Seminario Facoltà Scienze Università Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002) Ridefinizione biostratigrafica e geocronologica delle unità formazionali neogeniche della Sardegna centrale (Italia)(*) CARLO SPANO(**), SEBASTIANO BARCA(**), LUCIA CASU(***), ALBERTO MUNTONI(****) Abstract. Recent, detailed geological and stratigraphic surveys of a large area of the Marmilla region (central Sardinia) have made it possible to reconsider the lithobiostratigraphic characteristics of the formal and informal units in the literature on the Cenozoic (Late Oligocene Neogene) which have been in use up to now. Extension of the research to adjoining lands, including Alta Marmilla, Alto Oristanese, Sinis Planargia, Barigadu, Baronie and Sarcidano, has also made it possible to perform an overall analysis of the entire Cenozoic basin of central Sardinia and, finally, to make significant comparisons with the coeval successions outcropping in southern and northern Sardinia. In this preliminary note we then report on new data concerning the biostratigraphic aspects of the successions considered, while eco-biostratigraphic data and the depositional and synthemic arrangement, now at an advanced stage of definition, will be discussed in a later, more complete work. Some units in the literature are once again proposed, albeit with amendments, as suggested by the new regulations governing the establishment of new formal depositional units and conservation of units in the literature, and with new geochronostratigraphic delimitations (e. g. the Gesturi Formation). Other units change their hierarchical rank (e. g. the Marmilla Group), while for others it was not deemed useful to keep them (e. g. Marne di Ales), since they might cause confusion. Most of the Formations, all of the Members and Groups are proposed in this work for the first time. The formation units outcropping in central Sardinia s Cenozioc basin are represented for the most part by a sedimentary and volcano-sedimentary succession several hundreds of metres thick, the age of which is included within the Chattian-Aquitanian passage and the Plio-Quaternary. These are sediments from silicoclastics to mixed carbonatic-silicoclastics, in some cases richly fossiliferous, in which are inserted volcanic products from acid to intermediate-basic with a calcalkaline composition, the latter almost exclusively present starting from the Aquitanian up to the Late Burdigalian, with the strongest concentration in deposits of (*) Lavoro realizzato con il contributo M.U.R.S.T. 60% (Resp. S. Barca e C. Spano). (**) Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra, Via Trentino 51, Cagliari (Italia). (***) Via Lepanto 76, Cagliari (Italia). (****) Via Di Vittorio 40, Sestu (Italia). Presentato il 28/
2 122 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI Burdigalian age. As is the case in northern and southern Sardinia, central Sardinia s Miocene formations can be referred to three main sedimentary cycles recognized on the basis of heir litho-biostratigraphy and the analysis of associations of benthic macrofauna, which will be discussed in a specific article to be published shortly. The first Miocene sedimentary cycle evolved between the Chattian/Aquitanian limit and the Late Burdigalian (N6 Zone); the second cycle began in the Uppermost Burdigalian, in correspondence to the upper part of the Globigerinoides trilobus Zone (N7 Zone) and closes in the Late Serravallian (G. siakensis Zone, G. siakensis-g. obliqua obliqua Subzone); finally, after a clear regression phase, in the Tortonian (or perhaps already in the Uppermost Serravillian) the third cycle began and ended in the Early Messinian, in correspondence to the upper part of biostratigraphic N17a Zone. On the basis of a comparative analysis of autochthonous benthic associations, especially those with molluscs, and of the textural characteristics of the sediments, the prevalent depositional environment for the three cycles mentioned previously is that of a platform and secondly of a slope, but in some cases fluvio-lacustrine and deltaic. At the end of the third cycle there is a hiatus and/or erosion, or local continental sedimentation (Nuraghe Baboe Cabitza A n. Formation). A further marine sedimentary cycle locally (Sinis, Orosei) began and ends in the Lower Pliocene (Nuraghe Baboe Cabitza B n. Formation). In an overall biostratigraphic and geochronological frame, the comparison between the most important sedimentary, tectonic and volcanic occurrences in central Sardinia from the Oligocene to the Pliocene and those which occurred in the north and south of the island are pointed out. From the paleogeographic standpoint, the deposits of the first Miocene sedimentary cycle are part of the autochthonous cover of the southern European continental margin; those of the second and third cycles are instead connected with the aperture of the Balearic basin and the northern Tyrrhenian Sea; finally, the Early Pliocene marine succession is referred to the open of the southern Tyrrhenian basin, as well as the widespread volcanic activity of prevalently basaltic alkaline nature (the «Plio-Pleistocene volcanic cycle») towards the end of the Messinian and in the Pliocene. INTRODUZIONE Questo lavoro si basa sui rilevamenti geologici, litostratigrafici e biostratigrafici di dettaglio che gli scriventi già da vari anni conducono anche nell ambito degli studi biostratigrafici e paleoecologici sulle successioni terziarie della Sardegna, facenti parte del programma nazionale «Paleobenthos». Scopo principale del lavoro è l aggiornamento e/o una nuova definizione delle unità litostratigrafiche formali ed informali di età cenozoica affioranti nella Sardegna centrale (figura 1). Vengono, inoltre, fornite indicazioni sul loro significato paleoambientale e meglio precisati i loro rapporti stratigrafici con i prodotti vulcanici del Ciclo Calcoalcalino ad esse spesso associati. A quest ultimo scopo sono stati di particolare aiuto i lavori di ASSORGIA et al. [1], [2], [3], ASSORGIA et al. [4], ASSORGIA et al. [5], ASSORGIA et al. [6], ARANA et al. [7], BECCALUVA et al. [8], BROTZU et al. [9], CHERCHI & TREMOLIÈRE [10], ESU & KOTSAKIS [11], MACCIONI et al. [12], POMESANO CHERCHI [13], ROBBA & SPANO [14], CHERCHI et al. [15], SAVELLI
3 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 123 [16], SAVELLI8Öt al. [17], SMIT [18], LECCA et al. [19], PORCU [20], [21], [22], [23], LEONE et al. [24], SPANO [25] e ASSORGIA et al. [26]. I limiti delle unità litostratigrafiche già conosciute in letteratura sono stati qui verificati e spesso revisionati e sono stati definiti quelli relativi a nuove unità formali ed informali proposte in questo lavoro. I nuovi dati si basano sulla composizione delle associazioni planctoniche tratti da numerosi Autori. Le informazioni paleontologiche provenienti da lavori meno recenti sono state «rilette» e talora «reinterpretate» secondo i più aggiornati schemi biostratigrafici e geo-cronostratigrafici (STAINFORTH et al. [27], CANDE & KENT [28], OKADA & BUKRY [29], BERGGREN & MILLER [30], BERGGREN et al. [31], BANDET et al. [32], BUKRY [33] [34], IACCARINO [35], IACCARINO et al. [36], FORNACIARI & RIO [37], FORNACIARI et al. [38]) (tab. 1). Molti lavori sui Foraminiferi planctonici e sul plancton calcareo, relativi alla Sardegna, sono stati di particolare supporto: COMASCHI CARIA [39], GANDOLFI [40], PECORINI & POMESANO CHERCHI [41], CHERCHI [42] [43], [35], [36], CORRADINI [44], BARBIERI & D ONOFRIO [45], CIPOLLARI & COSENTINO [46]. I dati forniti da questi studi, opportunamente verificati ed aggiornati, sono stati integrati da ulteriori dati perloppiù inediti derivanti da nuove ricerche condotte dagli scriventi sia sulle associazioni paleontologiche, che sui rapporti statigrafici rilevati sul terreno fra le diverse unità. I dati relativi all interpretazione dei sistemi deposizionali ed alla stima delle paleobatimetrie delle varie unità litostratigrafiche, nonché rilevamenti geologici e numerose sezioni stratigrafiche misurate saranno oggetto di ulteriori note in via di stesura. UNITÀ STRATIGRAFICHE TRADIZIONALI DI NUOVA DEFINIZIONE E ORICTOCENOSI DOMINANTI (DATI PRELIMINARI) L inquadramento bio-cronostratigrafico delle unità sia formali che informali, o comunque in uso nella letteratura geologica della Sardegna, relativamente all intervallo Cattiano/Aquitaniano-Messiniano, viene riportato nella tabella 1. La loro collocazione nelle scale biostratigrafiche e cronostratigrafiche qui adottate (BLOW [47], [35] [36], [37], [38]) tiene conto delle attribuzioni e dei datum planes indicati per esse dagli Autori. Nella stessa tabella 1 vengono proposti sia aggiornamenti nomenclaturali che nuove suddivisioni delle successioni sedimentarie presenti nella Sardegna centrale in unità formali di vario rango. In particolare, alle unità istituite dagli Autori, e dagli stessi sempre indicate come «Formazioni», da noi ritenute ancora adeguate, seppure con limiti stratigrafici diversi, ma riferibili a posizioni gerarchiche diverse, è stato assegnato un rango diverso e sono state ridenominate (es. Formazione di Gesturi), seguendo le norme indicate dalla Subcommission on Neogene Stratigraphy. Altre volte i limiti bio-cronostratigrafici proposti dagli
4 124 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI scriventi ricalcano esattamente quelli attribuiti dagli Autori (es. Formazione di Capo San Marco). Così, con riferimento al Primo Ciclo di sedimentazione marina «miocenico» riconosciuto nella parte centrale dell Isola, la cui estensione temporale va dal passaggio Cattiano/Aquitaniano al Burdigaliano superiore (tabella 1), viene proposto, soprastante la Formazione di Villanovatulo, il Gruppo del Sarcidano, all interno del quale sono state contraddistinte, dal più antico al più recente, le nn. Formazioni di Duidduru Ovest, Isili, Duidduru Est, ed il Gruppo della Marmilla con le nn. Formazioni di Gonnostramatza e di Villamar. Limitatamente all area della Marmilla, viene inoltre proposta la n. Formazione di Turriga, eteropica con il Gruppo del Sarcidano. Ulteriori suddivisioni delle Formazioni in Membri sono riportate nella tabella 1. Per il Secondo Ciclo Sedimentario, riferito al Burdigaliano sommitale-serravalliano, viene indicato il Gruppo dell Alto Oristanese, con le nn. Formazioni di Dualchi e di Torre del Pozzo, alle quali corrisponde in Marmilla l eteropica Formazione di Gesturi (emendata). Il Secondo Ciclo si chiude con la messa in posto della n. Formazione di Capo Frasca Sud, che costituisce la parte stratigraficamente più bassa del Gruppo di Capo Frasca. Per il Terzo Ciclo Sedimentario, assegnato all intervallo?serravalliano superiore/ Tortoniano-Messiniano inferiore, viene distinta, ancora in seno al Gruppo di Capo Frasca, la n. Formazione di Capo Frasca Nord. CICLI SEDIMENTARI NEOGENICI E DEFINIZIONE DEI LORO LIMITI STRATIGRAFICI Nel Miocene della Sardegna centrale, così come accade per i settori meridionale e settentrionale dell Isola (tabella 2), si riconoscono tre principali cicli o successioni sedimentarie di età compresa fra il passaggio Cattiano-Aquitaniano ed il Messiniano inferiore; essi sono rappresentati da sedimenti silicoclastici e misti silicoclastici-carbonatici, spesso riccamente fossiliferi, nei quali si intercalano frequentemente prodotti piroclastici e lavici da acidi a basico-intermedi. Gli spessori massimi rilevati in sondaggio (Pozzo Campidano 1 [41]) raggiungono i 1000 m. Ad una prima lettura dei dati paleoecologici ancora in via di definizione, dedotti dall analisi comparata delle associazioni bentoniche autoctone e delle caratteristiche del sedimento, l ambiente deposizionale prevalente è di piattaforma e subordinatamente di scarpata, ma talora anche fluvio-lacustre e deltizio. Il Primo Ciclo Sedimentario affiora in Marmilla, Sarcidano, ecc.; esso ha inizio probabilmente già a partire dal Cattiano superiore e si imposta su un substrato vario, costituito da basamento ercinico (metamorfiti e granitoidi), oppure da vulcaniti del Ciclo Calco-alcalino «oligo-miocenico», attribuite dagli Autori alle serie α1 e τ1 (DERIU [48], [49]), equivalenti a SA.1 e SI.1 di COULON [50] e a LBLS e LAES di [2]. L età cattiana è desunta, oltre che dai rapporti stratigrafici, dalla datazione rilevata da
5 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 125 SERRANO et al. [51] per il deposito di Sedda Sa Gamba (Villanovaforru). Una forte accelerazione dell attività tettonica e magmatica e conseguente aumento dell energia erosiva è chiaramente documentata nel settore di Funtanazza (Sardegna meridionale) in sedimenti attribuibili al passaggio Aquitaniano-Burdigaliano ([3], BAR- BIERI et al. [52]). Un analogo trend vulcano-tettonico è stato evidenziato in depositi della Marmilla (Sardegna centrale), dove [51] riconoscono una microfauna del Burdigaliano basale costituita, fra l altro, da: Globigerina connecta, G. venezuelana, G. falconensis, G. woodi, Globigerinoides gr. trilobus, G. altiaperturus, G. bisphericus, Neogloboquadrina siakensis, G. baroemoenensis, G. dehiscens, Catapsydrax stainforthi e Globigerinella obesa. Nelle parti meno distali del bacino di sedimentazione della Sardegna centrale, come nel settore di Genoni-Nureci ed in Marmilla, è ampiamente documentata, al pari di Calada Bianca (Sardegna meridionale) nel Burdigalino inferiore (ASSORGIA et al. [53], [1], [2], [3]) una discontinuità, probabilmente di estensione regionale, da collegarsi ad una fase regressiva con conseguente impostazione di ambienti lacustri. La conclusione del Primo Ciclo Sedimentario è riferibile al Burdigaliano superiore, in corrispondenza della Zona N6 dei Foraminiferi planctonici di [47] e risulta legata con l inizio del Secondo Grande Complesso Piroclastico (tabella 1). Il Secondo Ciclo Sedimentario affiora in Marmilla, Sinis, Montiferru, Barigadu, ecc. ed ha inizio nel Burdigaliano sommitale, in corrispondenza della parte alta della Zona a Globigerinoides trilobus equivalente alla Zona N7 di [47]. Su tutta l area investigata, i primi sedimenti di questo ciclo poggiano sul Secondo Grande Complesso Piroclastico, attribuito in letteratura alla serie α2 di [48] [49], coeva delle serie SI.2 di [50] e UAES di [2]. Questi prodotti piroclastici, potenti sino ad oltre 5 m, corrispondono ai «tufi pomicei» di PECORINI [54], assegnati da questo Autore, sulla base delle associazioni a Foraminiferi planctonici, alla Zona a Globigerinoides bisphericus di CATI et al. [55], che, negli schemi cronostratigrafici più aggiornati riferiti al Mediterraneo, ricade nella parte alta della Zona a Globigerinoides trilobus di [47]. Oltre ai ben noti depositi vulcanoclastici UAES di Sa Manenzia e Paulilatino, si assegnano qui a questo Secondo Grande Complesso Piroclastico i prodotti affioranti a Ponte Su Mareu, Zoppianu, Pranu Mandara-Scala Seremida, Terra Messali-Genna Bentu, Bruncu Suergiu, Nuraghe Conca Tiddia, Monte Eguas, Bidella, Riu Florissa, Riu Gai, localizzati nel centro e nell alta Marmilla. Le associazioni a Foraminiferi planctonici dei depositi sottostanti ai prodotti di questo evento vulcanico sono costantemente caratterizzate dalla presenza di Globigerinoides trilobus (dominante), accompagnata da G. bisphericus, G. altiaperturus e Catapsydrax dissimilis. Ulteriori, nuove osservazioni sui Foraminiferi planctonici, condotte da uno degli scriventi (C. SPANO) su altri depositi fossiliferi di varie parti della Sardegna, nei quali si intercalano gli stessi «tufi pomicei», hanno confermato tali datazioni ed hanno
6 126 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI costantemente evidenziato l assenza di Catapsidrax dissimilis e Praeorbulina glomerosa e la presenza di Globigerinoides bisphericus (dominanti), G.trilobus, Globorotalia peripheroronda (forme primitive), G. continuosa. Nella parte alta di questo ciclo le associazioni bentoniche autoctone ed il rapporto Plancton/Benthos mostrano un trend regressivo su tutta l area studiata. I valori di questo rapporto relativi ai depositi immediatamente sottostanti al Secondo Grande Complesso Piroclastico e immediatamente soprastanti il medesimo prodotto vulcanico si attestano rispettivamente intorno a 50 ed a 10. La chiusura del Secondo Ciclo, determinata in più larga misura da variazioni eustatiche, è documentata nella n. Formazione di Capo Frasca, riferibile alla subzona a Orbulina universa. Per quanto attiene al Terzo Ciclo di sedimentazione marina, affiorante nella penisola della Frasca, penisola del Sinis, ecc., le microfaune planctoniche, non molto abbondanti, riportate dagli Autori, sono confinate soprattutto nel Membro della Baia di San Giovanni (n. Formazione dello Stagno Sale Porcus Spiaggia San Giovanni). Esse sono riferibili alla Zona N17 (subzona N17a). Poiché la parte alta della n. Formazione di Capo Frasca Sud è stata attribuita al Serravalliano medio-superiore e la parte più bassa della n. Formazione di Capo Frasca Nord viene riferita dagli Autori al Serravalliano superiore - Tortoniano, non si può escludere che, almeno localmente, sia presente una lacuna stratigrafica in corrispondenza di una fase erosiva durante il Serravalliano superiore. La conclusione del Terzo Ciclo Sedimentario è riportabile al Messiniano inferiore, in corrispondenza della parte alta della Zona biostratigrafica N17a. Le orictocenosi (CS) delle unità formazionali hanno fornito una buona diversità generica e specifica e sono governate dalle specie, riportate di seguito, identificate quando non è riportato diversamente, da C. SPANO. Per il Primo Ciclo di sedimentazione marina (Cattiano/Aquitaniano Burdigaliano superiore), dalla più antica (CS1) alla più recente (CS9): CS1 - n. Formazione di Duidduru Ovest Membro A: BIVALVI - Venus (Ventricoloidea) multilamella, Lucina multilamella, Cardium arcella, Aequipecten northamptoni, Gigantopecten cf. tournali, Ostrea (O.) edulis lamellosa, Anadara (A.) turoniensis, Tellina (Peronaea) planata; GASTEROPODI - Turritella (T.) turris, T. (T.) terebralis, Protoma (P.) cathedralis, Hinia (Uzita) serraticosta, Tympanotonos margaritaceous. CS2 - Membro B: GASTEROPODI - Turritella (T.) terebralis, T. (T.) turris, T. (Haustator) vermicularis, Protoma (P.) cathedralis, Astraea (Ormastralium) carinatum; BIVALVI - Cardium arcella, Lucina multilamella, Glycymeris (G.) bimaculata, Mytilus haidingeri. CS3 - n. Formazione di Isili: BIVALVI - Callista (Costacallista) erycinoides, Pholadomia (P.) alpina, Glycymeris (Panopea) menardii, Gigantopecten tournali, Pecten (P.) corsicanus, Gastrana lacunosa; GASTEROPODI - Pyrula rusticula;
7 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 127 ECHINOIDI - Clypeaster crassicostatus, Echinolampas plagiosomus, Scutella sp. CS4 - n. Formazione di Duidduru Est: BIVALVI - Cardium arcella, Tellina (Peronaea) planata, Venus (Ventricoloidea) multilamella, Pelyciora (P.) gigas, Panopea (P.) glycymeris, Megaxinus (M.) tranversus, Corbula (Varicorbula) gibba, Anadara (A.) turoniensis; GASTEROPODI - Turritella (T.) turris. CS5 - n. Formazione di Gonnostramatza Membro A: BIVALVI - Amussiopecten baranensis, Ostreinella negleta; GASTEROPODI - Vaginella depressa, V. austriaca, Clio triplicata; PESCI - squame. CS6 - Membro B: BIVALVI - Cardium arcella, Arca sp., Mimachlamys multistriata, Aequipecten northamptoni, Flabellipecten burdigalensis, GASTEROPODI - Cassidaria sp.. CS7 - Membro C: BIVALVI - Ostreinella negleta; GASTEROPODI PELAGICI - Vaginella depressa, V. austriaca, V. rotundata, Clio triplicata. CS8 - n. Formazione di Villamar Membro di Pauli Arbarei: GASTEROPODI PELAGICI - Vaginella depressa, V. austriaca, V. rotundata, Clio triplicata; BIVALVI - Venus (Ventricoloidea) multilamella, Abra (Syndosmya) longicallus, Lucinoma borealis, Ostreinella negleta; ECHINOIDI - Schizaster sp., Spatangua sp. CS9 - Membro di Pranu Idda: BIVALVI - Amussiopecten denudatum, Venus (Ventricoloidea) multilamella, Ostreinella negleta; GASTEROPODI - Vaginella depressa V. austriaca; ECHINOIDI - Schizaster sp. Le specie dominanti le orictocenosi relative alle unità del Secondo Ciclo Sedimentario (Burdigaliano sommitale Serravalliano inferiore) sono riportate di seguito, dall unità più antica (CS10) a quella più recente (CS16). CS10 - n. Formazione di Dualchi: Depositi fluvio-lacustri. CS11 - n. Formazione di Torre del Pozzo Membro A di Santa Caterina di Pittinuri: BIVALVI - Ostrea (O.) edulis lamellosa, Aequipecten submalvinae, A. scabrellus, Gigantopecten cf. ziziniae, G. nodosiformis, Amussiopecten expansus, Pecten (P.) paulensis, Cubitostrea frondosa, Venus (Ventricoloidea) multilamella; ECHINOIDI - Clypeaster intermedius, C. marginatus; CROSTACEI - Concavus (C.) concavus, Balanus perforatus; PESCI - Oxyrhina agassizi, Carcharodon megalodon; ALGHE - «Lithothamnium». CS12 - Membro B di Santa Caterina di Pittinuri: BIVALVI - Lentipecten denudatum, Mimachlamys multistriata, Aequipecten scabrellus, Propeamussium (Variamussium) duodecimlamellatum; ECHINOIDI - Schizaster desori, Psammechinus calarensis, Scutella sp. CS13 - Formazione di Gesturi (emendata) Membro di Laccu su Forraxi: BIVALVI - Venus (Ventricoloidea) multilamella, Cardium sp., Mimachlamys multistriata, M. varia, Aequipecten cf. submalvinae; GASTEROPODI - Vaginella austriaca, Clio sp., Turritella (T.) turris; ECHINOIDI - Radioli di Spatangoida; ALGHE - «Lithothamnium». CS14 - Membro di Baccu Iugesa: Sterile. CS15 - n. Formazione di Capo Frasca Sud: BIVALVI - Acanthocardia (A.)
8 128 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI paucicostata, Pelecyora (P.) islandicoides, Aequipecten scabrellus, Gigantopecten cf. ziziniae, Chlamys (C.) tauroperstriata, Ostrea (O.) edulis lamellosa; ECHINOIDI - Clypeaster sp., Scutella sp., Amphiope sp.; CROSTACEI - Concavus (C.) concavus; ALGHE - «Lithothamnium». CS16 - n. Formazione di Capo Frasca Nord: BIVALVI - Ostrea (O.) edulis lamellosa, Aequipecten scabrellus, Cubitostrea frondosa; GASTEROPODI - Diloma (Oxystele) rotellare, Turritella (T.) tricarinata, Cirsotrema (C.) pseudoscalare, Calyptraea sp., Polinices (P.) redemptus, Conus dujardini. Le specie dominanti relative alle orictocenosi delle unità del Terzo Ciclo Sedimentario (Serravalliano sommitale Messiniano inferiore), dalla più antica (CS17) alla più recente (CS22). CS17 - n. Formazione di Stagno Sale Porcus Spiaggia San Giovanni, Membro di Serra Araus: BIVALVI - Ostrea (O.) edulis lamellosa, Cubitostrea frondosa; CROSTA- CEI- Balanus sp.. CS18 - Membro di Baia San Giovanni: BIVALVI - Corbula (Varicorbula) gibba, Pecten (P.) vigolenensis, P. (P.) revolutus, Aequipecten scabrellus, Anadara (A.) turoniensis, A. (A.) diluvii, Acanthocardia (A.) paucicostata, Pelecyora (P.) islandicoides, Dosinia (Anodontia) lupinus; GASTEROPODI - Turritella (T.) tricarinata, Aporrhais (A.) uttingeriana, Natica zigrina; SCAFOPODI - Dentalium (Antalis) interruptus; ANELLIDI - Dirupa arietina. CS19 - Formazione di Capo San Marco (CHERCHI et al., [48]): BIVALVI - Acanthocardia (A.) echinata, Parvicardium minimum, Corbula (Vanicorbula) gibba, Timoclea (T.) ovata, Abra (Syndosmya) alba, Modiolus (M.) barbatus, Musculus (M.) costulatus, Gouldia (G.) minima. CS20 - Formazione del Sinis (emendata) ([15]): Calcari bianchi microcristallini, sterili. CS21 - Formazione di Torre del Sevo (emendata) ([48]): BIVALVI - Modelli interni, ECHINOIDI. CS22 - n. Formazione di Nuraghe Baboe Cabitza B (SPANO [56]): BIVALVI - Neopycnodonte navicularis, N. cochlear, Mimachlamys multistriata, M. varia, Aequipecten opercularis, Amusium cristatum, Pecten (P.) bipartitus, Hinnites ercolanianus, Clausinella fasciata, Parvicardium papillosum, Cubitostrea frondosa, Lucina orbicularis; BRACHIOPODI - Megathiris detruncata, Terebratula calabra, Megerlia truncata; CROSTACEI - Concavus (C.) concavus, Balanus spongicola. EVENTI SEDIMENTARI E GEODINAMICI CENOZOICI DELLA SARDEGNA CENTRALE I tre cicli sedimentari miocenici presenti nella Sardegna centrale si sono verosimilmente evoluti in stretto rapporto con i più importanti eventi tettonici e vulcanici manifestatisi nell Isola nell ambito dell evoluzione geodinamica cenozoica del Mediter-
9 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 129 raneo occidentale. In particolare, come già in precedenza prospettato dagli scriventi (in [2] [3]), l inizio del Primo Ciclo Sedimentario (passaggio Cattiano/Aquitaniano) può essere posto in relazione con la tettonica trascorrente prodottasi in Sardegna e nella Corsica ercinica durante la fase collisionale nord-appenninica, tra l Oligocene ed il Miocene inferiore, anteriormente al distacco e migrazione verso SE della placca sardocorsa (CARMIGNANI et al. [57 e bibliografia]) (tabella 1). Questa tettonica trascorrente in varie parti della Sardegna ha dato luogo a strutture sia transpressive (pieghe «en echelon», thrust e faglie inverse) soprattutto nei tratti NE delle principali faglie trascorrenti (faglie di Nuoro, Tavolara, Olbia, ecc.), sia a bacini transtensivi ad accentuata subsidenza lungo i loro tratti SW. Anche nella parte centrale dell Isola, particolarmente nel bacino della Marmilla, si sono accumulati forti spessori di depositi prevalentemente silicoclastici di ambienti fluviali e lacustri passanti verso SW a deltizi e marini, di età compresa fra l Oligocene superiore ed il Miocene inferiore. A tali sedimenti si associano cospicui prodotti vulcanici (tufi, ignimbriti, lave) da andesitici (LBLS) a riolitici (LAES), appartenenti al Ciclo Calco-alcalino «oligo-miocenico» sardo. L ingressione marina relativa al Primo Ciclo Sedimentario miocenico sarebbe stata pertanto favorita e guidata dall evolversi di bacini transtensivi, nei cui settori più occidentali o sud-occidentali si poterono depositare i sedimenti da continentali (nn. Formazioni di Sardara e di Villanovatulo), a transizionali e marini (livello a Pereiraia di Case Tati?, Membri A e B della n. Formazione di Duidduru Ovest, nn. Formazioni di Isili e di Duidduru Est), di età cattiano-aquitaniana. Nel Burdigaliano, ai movimenti trascorrenti si sostituì un importante fase di rifting connessa con la tettonica estensionale postcollisionale conseguente al collasso gravitativo dell Orogene nord-appenninico [57]. Oltre ad aver dato luogo alla deriva verso SE del Blocco sardo-corso, all apertura dei bacini delle Baleari e del Tirreno settentrionale (CHERCHI & MONTADERT [58], [57] e riferimenti), questa fase distensiva potè favorire anche l ulteriore estensione e l approfondimento della trasgressione marina ed il depositarsi di successioni sedimentarie da circalitorali ad epibatiali, contemporaneamente con un intensa attività vulcanica da andesitico-basaltica (LBLS) a riolitica (LAES). L accentuata instabilità che caratterizza la sedimentazione del Primo Ciclo di sedimentazione miocenico è chiaramente documentata da piegamenti, slumps, forte e costante componente vulcanogenica nei sedimenti e diffuso vulcanismo anche sottomarino (pillow-lavas e ialoclastiti) specialmente presenti in Marmilla e a Funtanazza (SPANO & BARCA [59]). Tali fenomenologie, che contraddistinguono, anche nella parte centrale dell Isola, il Primo Ciclo di sedimentazione, risultano, invece, quasi del tutto assenti nei successivi due cicli sedimentari miocenici. La nuova fase trasgressiva che nel Burdigaliano sommitale dà inizio al Secondo Ciclo di sedimentazione miocenico fu verosimilmente favorita da una energica ripresa della subsidenza nel bacino corrispondente al sistema NS del Rift Sardo, dove poterono accumularsi potenti successioni marnoso-argillose prevalentemente epibatiali, di età compresa fra il Burdigaliano superiore ed il Serravalliano medio-?superiore. A questi sedimenti marini si intercalano alcuni livelli di piroclastiti-epiclastiti acide [54], che
10 130 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI rientrano fra le ultime manifestazioni del Ciclo Calco-alcalino «oligo-miocenico» nell Isola, la cui cessazione sarebbe avvenuta subito dopo la fine della deriva del Blocco sardo-corso, come documentato anche dai dati paleomagnetici (MONTIGNY et al. [60]). La massima batimetria raggiunta nella Sardegna centrale è registrata a partire dalla parte più alta del Burdigaliano inferiore sino al Burdigaliano superiore, in corrispondenza delle Zone N6, N7 e NN4, rispettivamente delle Scale di [47] e di MARTINI [61], come suggerito dagli Pteropodi e dalle faune bentoniche autoctone epibatiali ad essi associati (in corso di definizione). A partire dal Serravalliano inferiore, nella Sardegna centrale, questo Secondo Ciclo Sedimentario manifesta una fase regressiva documentata dai sedimenti, soprattutto infralitorali, della n. Formazione di Capo Frasca Sud. La fase trasgressiva che diede avvio al Terzo Ciclo Sedimentario miocenico si manifestò, nell area cui si riferisce questa nota, forse già a partire dal Serravalliano superiore, limitatamente ai settori più subsidenti del Rift sardo, e precisamente nella Penisola del Sinis e nella Penisola della Frasca. In tali settori si depositarono sedimenti marnoso-calcarei di piattaforma, la cui età arriva sino al Messiniano inferiore ([41] e riferimenti). Successivamente, come conseguenza dell apertura del Bacino sud-tirrenico (SARTORI [62]), verso la fine del Messiniano e nel Plio-Pleistocene, in conseguenza di un accentuata ripresa della tettonica distensiva, che favorì anche una diffusa attività vulcanica a carattere alcalino prevalentemente basaltico («ciclo vulcanico plio-pleistocenico»), si manifestò l ingressione marina del Pliocene inferiore nell Oristanese (n. Formazione di Nuraghe Baboe Cabitza B), poi interrotta dai depositi continentali plio-pleistocenici della n. Formazione di Nuraghe Baboe Cabitza C. Contributi da Tesi di Laurea inedite, su tematiche attinenti all oggetto della presente nota, coordinate da C. SPANO e S. BARCA: A. PASSIU ( ), L. SANNA ( ), M.I. MEREU ( ), R. BERNARD ( ), P.D. SIRIGU ( ), E. CAPPAI ( ), L. CASU ( ), M. PINNA ( ), V. PINTUS ( ), M. SERRA ( ), A. MUNTONI ( ), M.G. ROMBI ( ), E. CABIDDU ( ), S. CARTA ( ), P. PILI ( ), D. BONEDDU ( ), R. ZEDDA ( ), L. SANNA ( ). BIBLIOGRAFIA [1] A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO, Upper Oligocene Lower Miocene sequences of the Arbus Funtanazza Coast (South Western Sardinia, Italy). In: Volume dedicato a Tommaso Cocozza (L. Carmignani & F. P. Sassi Eds.). IGCP N. 276, News-letter, 5: (1992). [2] A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO, Convegno-Escursione nella Marmilla «La Fossa Sarda» nell ambito dell evoluzione geodinamica cenozoica del Mediterraneo occidentale. Libro- Guida e Riassunti, Villanovaforru (CA), Giugno, (1997a). [3] A. ASSORGIA, L. MACCIONI & G. MACCIOTTA, Carta geopetrografica del vulcanismo pliocenico della Sardegna centro-meridionale, scala 1: SELCA Firenze (1983).
11 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 131 [4] A. ASSORGIA, S. BARCA, M. FARRIS, R. RIZZO & C. SPANO, The Cenozoic sedimentary and volcanic successions in the Monastir Furtei sector (Southern Campidano Sardinia). Mem. Soc. Geol. It., 48: (1994). [5] A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO, A synthesis on the cenozoic stratigraphic, tectonic and volcanic evolution in Sardinia (Italy). Boll. Soc. Geol. It., 116: (1997b). [6] A. ASSORGIA, S. BARCA, G. FLORE, R. LONIS, S. S. LUXORO, M. PINNA, A PORCU, F. SECCHI & C. SPANO, Carta Geologica del settore vulcanico e sedimentario cenozoico compreso tra Fordongianus e Sinis (Sardegna centrale). Firenze, S.E.L.C.A. (1995). [7] V. ARANA, F. BARBIERI & R. SANTACROCE, Some data on the comendite type area (San Pietro and Sant Antioco Islands, Sardinia). Bull. Volcan., 38: (1975). [8] L. BECCALUVA, L. CIVETTA, G. MACCIOTTA & C. A. RICCI, Geochronology in Sardinia: results and problems. Rend. Soc. It. Min. Petr., 40: (1985). [9] P. BROTZU, V. FERRINI, L. MORBIDELLI & G. TRAVERSA, Il distretto vulcanico di Capo Ferrato. Rend. Sem. Fac. Sc. Univ. Cagliari, 45: 1-46 (1975). [10] A. CHERCHI & L. TREMOLIÈRES, Nouvelles données sur l évolution structurale au Mésozoique et au Cénozoique de la Sardaigne et leurs implications géodinamiques dans le cadre méditerranéen. C. R. Acad. Sc. Paris, 298: (1984). [11] D. ESU & T. KOTSAKIS, Les vértébrés et les mollusques continentaux du Tertiaire de la Sardaigne: Paleobiogéographie et biostratigraphie. Geol. Romana, 22: (1983). [12] L. MACCIONI, M. MARCHI & A. ASSORGIA, Carta geo - petrografica dell Isola di S. Antioco (Sardegna sud-occidentale), scala 1: SELCA Firenze (1990). [13] A. POMESANO CHERCHI, Studio stratigrafico e micropaleontologico del Pozzo Oristano 1 (Sardegna). Mem. Soc. Geol. It., 10 (1): 1-16 (1971). [14] E. ROBBA & C. SPANO, Gasteropodi pelagici nel Miocene medio del Campidano meridionale (Sardegna). Riv. Ital. Paleont. Strat., 84 (3): (1978). [15] A. CHERCHI, A. MARINI, M. MURRU & E. ROBBA, Stratigrafia e paleoecologia della Penisola del Sinis (Sardegna occidentale). Riv. It. Paleont. Strat., 84 (4): (1978). [16] C. SAVELLI, Datazioni preliminari col metodo K-Ar di vulcaniti della Sardegna sudoccidentale. Soc. It. Miner. e Petr., 31: (1975). [17] C. SAVELLI, L. BECCALUVA, M. DERIU, G. MACCIOTTA & L. MACCIONI, K/Ar geochronology and evolution of tertiary «calc-alkalic» volcanism of Sardinia (Italy). Journ. Volcanol. Geotherm. Res., 5: (1979). [18] R. SMIT, Miogipsina intermedia from Sardinia. Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch, Ser. B, 77 (5): (1974). [19] L. LECCA, R. LONIS, S. LUXORO, E. MELIS, F. SECCHI & P. BROTZU, Oligo - Miocene volcanic sequences and rifting stages in Sardinia: a review. Petr. Mineral., 66: 7-61 (1997). [20] A. PORCU, Geologia della media valle del Tirso (Sardegna Centrale). Boll. Soc. Sarda di Sc. Nat., 10: 1-24 (1972). [21] A. PORCU, Depositi continentali della valle deltirso (Sardegna centrale). Rend. Sem. Fac. Sc. Univ. Cagliari, 53 (2): (1983). [22] A. PORCU, Geologia del Graben di Ottana (Sardegna centrale). Rend. Sem. Fac. Sc. Univ. Cagliari, 53 (2), (1983). [23] A. PORCU, Osservazioni stratigrafiche sul Miocene dei dintorni di Paulilatino (Sardegna centro-occidentale). Rend. Sem. Fac. Sc. Univ. Cagliari, 54 (1) (1984). [24] F. LEONE, M. L. SANNA & C. SPANO, Successioni stratigrafiche del Miocene inferiore a nord della Giara di Gesturi. Boll. Soc. Sarda di Sc. Nat., 23: (1984).
12 132 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI [25] C. SPANO, Paleocomunità a Molluschi del Miocene medio superiore di Capo Frasca (Sardegna centro occidentale). Boll. Soc. Natur. Napoli, 97: (1988). [26] A. ASSORGIA, S. BARCA, K. BALOGH, A. PORCU, R. RIZZO & C. SPANO, The Oligocene-Miocene sedimentary and volcanic successions of Central Sardinia (Italy). Rom. J. Stratigraphy, 78: 9-23 (1998). [27] R. M. STAINFORTH, J. L. LAMB, H. LUTERBACHER, J. H. BEARD & R. M. JEFFORD, Cenozoic planktonic foraminiferal zonation and characteristics of index forms. Univ. Kansas Paleontol. Contrib., 62: (1975). [28] S. CANDE & D. V. KENT, A new geomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceous and Cenozoic. Journal of Geophysical Research, 13: (1992). [29] H. OKADA & D. BUKRY, Supplementary modification and introduction of code numbers to the Low Latitude coccolith Biostratigraphic Zonation (BUKRY, 1973, 1975). Marine Micropaleontology, 5: (1980). [30] W. A. BERGGREN & K. G. MILLER, Paleogene tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology. Micropaleontology, 34: (1988). [31] W. A. BERGGREN, D. KENT, C. C. SWISHER & M. P. AUBRY, A Revised Cenozoic Geochronology and Chronostratigraphy. Geochronology Times Scales and Global Stratigraphic Correlation. SEPM Special Publication n. 54 (1995). [32] Y. BANDET, J. BURGOIS, G. GLACON, Y. GOURINARD, J. MAGNE & C. MULLER, Position du Langhien dans les échelles de chronologie biostratigraphique radiométrique et géomagnétique. C.R. Acad. Sc. Paris, 299, II (10): (1984). [33] D. BUKRY, Low Latitude Coccolith Biostratigraphic Zonation. In EDGARD N. T., Saunders J. B. et al. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 15: (1973). [34] D. BUKRY, Coccolith and Silicoflagellate Stratigraphy, North Western Pacific Ocean Deep Sea Drilling Project, Leg 32. In LARSON R. I., MOBERLY R. et alii. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 32: (1975). [35] S. IACCARINO, Mediterranean Miocene and Pliocene Planktic Foraminifera. In Boll. H. M., SAUNDERS J. B. & PERCH-NIELSEN K., Eds., Plankton Stratigraphy. Cambridge Univ. Press, (1985). [36] S. IACCARINO, S. D ONOFRIO & M. MURRU, Miocene foraminifera of several sections of the Marmilla area (Central-Western Sardinia). Boll. Soc. Paleont. Ital., 23 (2): (1985). [37] E. FORNACIARI & D. RIO, Latest Oligocene to early-middle Miocene quantitative calcareous nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropaleontology, 42 (1): 1-36 (1996). [38] E. FORNACIARI, A. DI STEFANO, D. RIO & A. NEGRI, Middle Miocene quantitative calcareous nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropaleontology 42 (1): (1996). [39] I. COMASCHI CARIA, Prima segnalazione di Pinuxylon in Sardegna con cenni sulla questione dell età dei tufi a piante nell isola. Res. Ass. Min. Sarda, 1: 1-8. [40] R. GANDOLFI, Sardegna, Appennino e Mediterraneo. Alcune considerazioni alla luce delle moderne vedute geodinamiche. Boll. Soc. Sarda Sci. Nat., XIII, (1973). [41] G. PECORINI & A. POMESANO CHERCHI, Ricerche geologiche e biostratigrafiche nel Campidano meridionale (Sardegna). Mem. Soc. Geol. It., 8: (1969). [42] A. CHERCHI, Appunti biostratigrafici sul Miocene della Sardegna(Italia). V Congr. Neogène Medit. (Lyon, 1971). Mém. B.R.G.M., 78: (1974). [43] A. CHERCHI Ed., Guide Book: 19th European Micropaleontological Colloquium, Sardinia October 1-10, (1985).
13 RIDEFINIZIONE BIOSTRATIGRAFICA E GEOCRONOLOGICA 133 [44] D. CORRADINI, Dinoflagellate cysts from the Miocene of Sardinia. Boll. Soc. Paleont. Ital., 23 (2): (1984). [45] R. BARBIERI & S. D ONOFRIO, Benthic Foraminifera of the Fangario Formation (Cagliari, Sardinia). Boll. Soc. Paleont. Ital., 23: (1985). [46] P. CIPOLLARI & D. COSENTINO, Caratteristiche stratigrafiche della Formazione della Marmilla (Miocene inferiore) nell area di Collinas - Villanovaforru (Sardegna centro-meridionale). In A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO Eds. Convegno-escursione: La «Fossa Sarda» nell ambito dell evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale, Libro-guida e Riassunti, Villanovaforru (CA), Giugno (1997). [47] W. H. BLOW, Late Middle Eocene to Recent Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy. Proc. Ist. Intern. conf. plankt. Microfossils. Genova: (1969). [48] M. DERIU, Stratigrafia, cronologia e caratteri petrochimici delle vulcaniti «oligoceniche» in Sardegna. Mem. Soc. Geol. It., 3: (1962). [49] M DERIU, Notizie sulla costituzione geologica del Bosano, della Planargia e del Montiferro settentrionale e occidentale. Monografia Reg. Bosano, Ass. Comm. Bosa e Cuglieri, 1-50 (1964). [50] C. COULON, Le volcanism calco-alcalin cénozoique de Sardaigne(Italy). Pétrographie, Géochimie et genèse des laves andésitiques et des ignimbrites-signification géodinamique. Thèse Doct. 3 Cycle Univ. Aix-Marseille III, (1977). [51] F. SERRANO, L. CASU, F. GUERRERA, M. SERRA & C. SPANO, Nuovi dati biostratigrafici sul Miocene inferiore della Sardegna. In A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO Eds. Convegnoescursione: La «Fossa Sarda» nell ambito dell evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale, Libro-guida e Riassunti, Villanovaforru (CA), Giugno, 152 (1997). [52] M. BARBIERI, F. CASTORINA, P. CIPOLLARI & D. COSENTINO, La successione del Miocene inferiore di Funtanazza (Sardegna sud-occidentale): nuovi dati cronostratigrafici. In A. ASSORGIA, S. BARCA & C. SPANO Eds. Convegno-Escursione: La «Fossa Sarda» nell ambito dell evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale, Libro-guida e Riassunti, Villanovaforru (CA), Giugno, 65 (1997). [53] A. ASSORGIA, S. BARCA, G. ONNIS, F. A. G. SECCHI & C. SPANO, Episodi sedimentari oligomiocenici nel settore occidentale dell Arcuentu e loro contesto geodinamico (Sardegna SW). Mem. Soc. Geol. It., 35: (1988). [54] G. PECORINI, Sui tufi pomicei langhiani della Sardegna meridionale. Boll. Soc. Geol. It., 93: (1974). [55] CATI et alii, Biostratigrafia del Neogene Mediterraneo basata sui Foraminiferi planctonici. Boll. Soc. Geol. It., 87: (1968). [56] C. SPANO, Macrofauna circalitorale del Pliocene inferiore di Capo S. Marco (Sardegna occidentale). Riv. It. Paleont. Strat., 95 (2): (1989). [57] L. CARMIGNANI, S. BARCA, L. DISPERATI, P. FANTOZZI, A. FUNEDDA, G. OGGIANO & S. PASCI, Tertiary compression and extension in the Sardinian. Boll. Geof. Teor. Appl., 36: (1994). [58] A. CHERCHI & L. MONTADERT, Il sistema di rifting oligo-miocenico del Mediterraneo occidentale e sue conseguenze paleogeografiche sul Terziario sardo. Mem. Soc. Geol. Ital. 24: (1984). [59] C. SPANO & S. BARCA, Ecobiostratigraphic, lithostratigraphic, depositional and synthemic setting of Cenozoic units in Southern Sardinia (Italy). Boll. Soc. Geol. It., 121: (2002). [60] R. MONTIGNY, J. B. EDEL & R. THUIZAT, Oligo-Miocene rotation of Sardinia: K-Ar ages and paleomagnetic data of Tertiary. Earth and Planetary Science Letters, 54: (1981).
14 134 C. SPANO, S. BARCA, L. CASU, A. MUNTONI [61] E. MARTINI, Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. Proc. ll Planktonic Conf. (Roma, 1970), 2: (1971). [62] R. SARTORI, Evoluzione neogenico-recente del bacino tirrenico e suoi rapporti con la geologia delle aree circostanti. Giorn. di Geol., 3: 51/2, 1-39 (1989). [63] B. U. HAQ, J. HANDERBOL & P. R. VAIL, The new chronostratigraphic basis of cenozoic and mesozoic sea leve cycles. In: Cussman foundation for Foraminiferal research. Special Pubblication, 24 (1987). [64] W. A. BERGGREN, M. P. AURBY & N. HAMILTON, Neogene magnetobiostratigraphy of Deep Sea Drilling Project Site 516 (Rio Grande Rise, South Atlantic). In: P. F. BARKER, R. L. CARLSON & D. A. JOHNSON. Init. Repts. DSDP, 72: (1983). [65] S. IACCARINO & G. SALVATORINI, A framework of planktonic foraminiferal biostratigraphy for early Miocene to late Pliocene Mediterranean area. Paleontologia ed Evoluzione, 2: (1982). [66] C. SPANO & B. FURINA, Osservazioni paleoecologiche sulle paleocomunità del Tortoniano di Capo S. Marco (Sardegna Centro-Occidentale). Atti Quarto Simposio di Ecol. e Paleoecol. delle Comunità Bentoniche-Museo Reg. Sc. Nat. Torino, (1988). [67] I. DIENI & F. MASSARI, Il Neogene ed il Quaternario nei dintorni di Orosei (Sardegna). Mem. Soc. It. Sc. Nat., 15 (2): (1966). [68] R. MAZZEI & G. OGGIANO, Messa in evidenza di due cicli sedimentari nel Miocene dell area di Florinas (Sardegna settentrionale). Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 97: (1990). [70] S. BARCA, C. SPANO & T. TICCA, Definizione lito-biostratigrafica delle unità formazionali del tardo Paleogene e Neogene del Nord Sardegna (Italia) e della Corsica (Francia). Questo volume.
Rendiconti Seminario NUOVA CLASSIFICAZIONE Facoltà Scienze Università BIOSTRATIGRAFICA Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002)
 Rendiconti Seminario NUOVA CLASSIFICAZIONE Facoltà Scienze Università BIOSTRATIGRAFICA Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002) 135 Nuova classificazione biostratigrafica e geocronologica delle unità formazionali
Rendiconti Seminario NUOVA CLASSIFICAZIONE Facoltà Scienze Università BIOSTRATIGRAFICA Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002) 135 Nuova classificazione biostratigrafica e geocronologica delle unità formazionali
Definizione lito-biostratigrafica delle unità formazionali del tardo Paleogene e Neogene del Nord Sardegna e della Corsica(*)
 Rendiconti Seminario Facoltà Scienze Università Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002) Definizione lito-biostratigrafica delle unità formazionali del tardo Paleogene e Neogene del Nord Sardegna e della Corsica(*)
Rendiconti Seminario Facoltà Scienze Università Cagliari Vol. 72 Fasc. 1 (2002) Definizione lito-biostratigrafica delle unità formazionali del tardo Paleogene e Neogene del Nord Sardegna e della Corsica(*)
INQUADRAMENTO BIO-CRONO STRATI GRAFICO DELLE TUFITI MARINE DEL MIOCENE INFERIORE AFFIORANTI NELL'AREA DI CASTELSARDO (SARDEGNA SETTENTRIONALE) (***)
 Illll :::ioc. rosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 98 (1991) pagg. 327-338, figg. 3 L. FRANCOLINI (*), R. MAZZEI (**) INQUADRAMENTO BIO-CRONO STRATI GRAFICO DELLE TUFITI MARINE DEL MIOCENE INFERIORE AFFIORANTI
Illll :::ioc. rosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 98 (1991) pagg. 327-338, figg. 3 L. FRANCOLINI (*), R. MAZZEI (**) INQUADRAMENTO BIO-CRONO STRATI GRAFICO DELLE TUFITI MARINE DEL MIOCENE INFERIORE AFFIORANTI
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale. Variazioni relative del livello marino
 Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
Concetti introduttivi alla stratigrafia sequenziale Variazioni relative del livello marino Considerando le curve che indicano la variazione nel tempo degli onlap costieri entro un determinato bacino,
SEBASTIANO BARCA (**), CARLO SPANO (**), ANNALISA CAU (**), LUISA COTTONE (**), DANIELA DEIDDA (**), GIACOMO SANNA (**)
 INQUADRAMENTO Rendiconti Seminario CRONOBIOSTRATIGRAFICO Facoltà Scienze Università Cagliari ED EVOLUZIONE Supplemento Vol. DEL 70 BACINO (2000) 375 Inquadramento cronobiostratigrafico ed evoluzione del
INQUADRAMENTO Rendiconti Seminario CRONOBIOSTRATIGRAFICO Facoltà Scienze Università Cagliari ED EVOLUZIONE Supplemento Vol. DEL 70 BACINO (2000) 375 Inquadramento cronobiostratigrafico ed evoluzione del
BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta
 Geologica Romana 39 (2006), 1-14 BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio
Geologica Romana 39 (2006), 1-14 BIO-CRONOSTRATIGRAFIA A FORAMINIFERI PLANCTONICI DEI SEDIMENTI MIOCENICI NELL AREA DI STRUDÀ (LECCE, PUGLIA) Stefano Margiotta Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9210141 LAGO LA ROTONDA Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA Pag. 2
GUIDA ALL ESCURSIONE DIDATTICA
 UNIVERSITA DI CAGLIARI Facoltà di Scienze- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche Attività interdisciplinare del Terreno Geografia Fisica e Cartografia
UNIVERSITA DI CAGLIARI Facoltà di Scienze- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche Attività interdisciplinare del Terreno Geografia Fisica e Cartografia
1. Le rocce e la loro età
 1. Le rocce e la loro età Roccia - Materiale che costituisce un opera d arte - Corpo geologico - Aggregato di fasi mineralogiche - Associazione di fasi mineralogiche - Sistema chimico - insieme di parti
1. Le rocce e la loro età Roccia - Materiale che costituisce un opera d arte - Corpo geologico - Aggregato di fasi mineralogiche - Associazione di fasi mineralogiche - Sistema chimico - insieme di parti
GRUPPO DELLA GONFOLITE LOMBARDA
 168 GRUPPO DELLA GONFOLITE LOMBARDA RANGO ETÀ REGIONE Gruppo Oligocene-Miocene (Chattiano-Serravalliano) Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 31, 32 GF Scheda a cura di Luca Delfrati Il nome
168 GRUPPO DELLA GONFOLITE LOMBARDA RANGO ETÀ REGIONE Gruppo Oligocene-Miocene (Chattiano-Serravalliano) Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 31, 32 GF Scheda a cura di Luca Delfrati Il nome
Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali
 Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. VII Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali La Stratigrafia è la sub-disciplina delle Scienze Geologiche che studia, descrive e classifica
Corso di Geologia Stratigrafica e Sedimentologia Cap. VII Stratigrafia e Unità di Classificazione Internazionali La Stratigrafia è la sub-disciplina delle Scienze Geologiche che studia, descrive e classifica
CAPUANO NICOLA PIO. CAPUANO N., TONELLI G. & VENERI F. (1987). Significato paleogeografico delle
 CAPUANO NICOLA PIO Curriculum Nato a San Giovanni Rotondo (FG) e residente in Urbino,via B.Baldi 2 - Laureato in Scienze Geologiche presso L'Università di Camerino (MC) - Titolare di un assegno ministeriale
CAPUANO NICOLA PIO Curriculum Nato a San Giovanni Rotondo (FG) e residente in Urbino,via B.Baldi 2 - Laureato in Scienze Geologiche presso L'Università di Camerino (MC) - Titolare di un assegno ministeriale
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia
 Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
Modulo 2: Nozioni di base di Geologia Il principio dell attualismo in Geologia la stratigrafia e le sue leggi fondamentali cenni sulla Paleogeografia dell appennino centrale dal Mesozoico ad oggi 1) Principio
ARENARIA GLAUCONITICA DI BELLUNO
 Accordo di Programma SGN-CNR COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA della Società Geologica Italiana Catalogo delle Formazioni Geologiche Italiane Status della scheda Status della formazione Età Regione
Accordo di Programma SGN-CNR COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA della Società Geologica Italiana Catalogo delle Formazioni Geologiche Italiane Status della scheda Status della formazione Età Regione
CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1: CATALOGO DELLE FORMAZIONI SICILIA
 CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 331 3. - SICILIA CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 333 ARENAZZOLO RANGO ETÀ REGIONE Membro Miocene Superiore (Messiniano
CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 331 3. - SICILIA CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 333 ARENAZZOLO RANGO ETÀ REGIONE Membro Miocene Superiore (Messiniano
GEOLOGIA STRATIGRAFICA
 ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
ITG A. POZZO LICEO TECNOLOGICO GEOLOGIA STRATIGRAFICA INDIRIZZO: Costruzioni, Ambiente, Territorio - opzione B GEOLOGIA E TERRITORIO Classe 4^ - 3 ore settimanali Schede a cura del prof. Romano Oss GEOLOGIA
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA
 PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
PRINCIPI DI STRATIGRAFIA STRATIGRAFIA: parte della Geologia che studia la successione delle rocce sedimentarie secondo l ordine di deposizione e cerca di ricostruire gli originari ambienti di sedimentazione.
INFORMAZIONI PERSONALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MADRELINGUA ALTRA LINGUA C U R R I C U L U M V I T A E
 C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome BAMBINI ANNA MARIA Indirizzo VIA VILLA FONTANA, 88-55018, S. COLOMBANO (LU) Telefono 0583/92.70.03 E-mail annamaria.bambini@unisi.it Nazionalità
C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome BAMBINI ANNA MARIA Indirizzo VIA VILLA FONTANA, 88-55018, S. COLOMBANO (LU) Telefono 0583/92.70.03 E-mail annamaria.bambini@unisi.it Nazionalità
Terre emerse nell ultima glaciazione (15000 anni fa)
 Terre emerse nell ultima glaciazione (15000 anni fa) Sezione geologica della Piana Costiera Ionica Trasgressioni e regressioni e quantità di apporti Stazionamento alto (highstand): periodi durante
Terre emerse nell ultima glaciazione (15000 anni fa) Sezione geologica della Piana Costiera Ionica Trasgressioni e regressioni e quantità di apporti Stazionamento alto (highstand): periodi durante
ATENEO: Meccanismi di messa in posto di dicchi in aree vulcaniche attraverso analisi di terreno, modellazione analogica e numerica.
 Specifiche economiche deliberate per il dottorato Ateneo Dip. Esterne Giovani Riserva Tassa Sovran. 6 1 0 1 1 2 3 ATENEO: Meccanismi di messa in posto di dicchi in aree vulcaniche attraverso analisi di
Specifiche economiche deliberate per il dottorato Ateneo Dip. Esterne Giovani Riserva Tassa Sovran. 6 1 0 1 1 2 3 ATENEO: Meccanismi di messa in posto di dicchi in aree vulcaniche attraverso analisi di
PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO DELLA PIANURA EMILIANO-ROMAGNOLA ALLA SCALA 1:50.000
 Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
Conferenza del Dott. Paolo Severi di Giovedì 18 Marzo 2010 ore 15.00 tenuta presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell Università di Parma PARTE 1 DI 2 NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA DI SOTTOSUOLO
Fossili della collezione didattica Genere e specie Età Località N Inv. Collocazione Q uantità Note Abra nitida Pliocene 402 P14 11 * Acanthocardia
 Abra nitida Pliocene 402 P14 11 * Acanthocardia erinacea Pliocene Montefeltro 382 P10 2 * Acanthocardia multicostata (?) Miocene 383 P10 3 * Anadara darwini Miocene Tornano (FO)? 350 P7 1 * Anadara diluvii
Abra nitida Pliocene 402 P14 11 * Acanthocardia erinacea Pliocene Montefeltro 382 P10 2 * Acanthocardia multicostata (?) Miocene 383 P10 3 * Anadara darwini Miocene Tornano (FO)? 350 P7 1 * Anadara diluvii
ANALISI SISMOMETRICHE FINALIZZATE ALLO STUDIO DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE NELL AREA URBANA DI RIETI
 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata all Ingegneria e alla Pianificazione Territoriale Tesi di laurea sperimentale in Geologia Applicata
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata all Ingegneria e alla Pianificazione Territoriale Tesi di laurea sperimentale in Geologia Applicata
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4
 RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
RETE NATURA 2000 REGIONE BASILICATA DIRETTIVA 92/437CEE DPR 357/97 MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE -relazione geologica- AREA 4 IT9220144 LAGO SAN GIULIANO E TIMMARI Dott.ssa SARLI Serafina INDICE PREMESSA
Università degli Studi di Napoli Federico II
 Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Relatore: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe n 35. Corso di Laurea Magistrale
GEOLOGIA DI SOTTOSUOLO
 GEOLOGIA DI SOTTOSUOLO Silvia Rosselli Il territorio di Milano nella nuova cartografia geologica Milano, 12 maggio 2017 1) Quadro geologico di riferimento: la collaborazione con ENI Ricostruzione dell
GEOLOGIA DI SOTTOSUOLO Silvia Rosselli Il territorio di Milano nella nuova cartografia geologica Milano, 12 maggio 2017 1) Quadro geologico di riferimento: la collaborazione con ENI Ricostruzione dell
5B. Cenni di Geodinamica dell Appennino e dell area mediterranea
 5B. Cenni di Geodinamica dell Appennino e dell area mediterranea L Appennino Settentrionale è una catena orogenica strutturalmente complessa, formatasi a partire dal Cretaceo superiore in seguito alla
5B. Cenni di Geodinamica dell Appennino e dell area mediterranea L Appennino Settentrionale è una catena orogenica strutturalmente complessa, formatasi a partire dal Cretaceo superiore in seguito alla
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA
 DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
DESCRIZIONE GEOSITO 08: LA NOVA A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito ricade all interno della Riserva Naturale Selva del Lamone in zona La Roccaccia, nel comune
NOTE DI GEOLOGIA E PALEOECOLOGIA RELATIVE AD ALCUNI SITI AD AMPHIOPE AGASSIZ, 1840 (ECHINOIDEA: CLYPEASTEROIDA) IN SARDEGNA
 PARVA NATURALIA 2010-2011 - Volume 9: 127-176 NOTE DI GEOLOGIA E PALEOECOLOGIA RELATIVE AD ALCUNI SITI AD AMPHIOPE AGASSIZ, 1840 (ECHINOIDEA: CLYPEASTEROIDA) IN SARDEGNA PAOLO STARA 1, ROBERTO RIZZO 2,
PARVA NATURALIA 2010-2011 - Volume 9: 127-176 NOTE DI GEOLOGIA E PALEOECOLOGIA RELATIVE AD ALCUNI SITI AD AMPHIOPE AGASSIZ, 1840 (ECHINOIDEA: CLYPEASTEROIDA) IN SARDEGNA PAOLO STARA 1, ROBERTO RIZZO 2,
di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico
 di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico L Isola di Sant Antioco si è formata oltre centocinquanta milioni di anni fa. A tale epoca risalgono le rocce più antiche
di Mauro Carta, geologo e docente di Scienze Naturali Il basamento calcareo mesozoico L Isola di Sant Antioco si è formata oltre centocinquanta milioni di anni fa. A tale epoca risalgono le rocce più antiche
PROSPEZIONE MINERARIA DI LITOTIPI ZEOLITIZZATI NEL LOGUDORO ORIENTALE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Istituto di Scienze Geologico-Mineralogiche Unione Europea Fondo Sociale Europeo DOTTORATO DI RICERCA IN Scienza e Tecnologia dei Minerali e delle Rocce di Interesse Industriale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Istituto di Scienze Geologico-Mineralogiche Unione Europea Fondo Sociale Europeo DOTTORATO DI RICERCA IN Scienza e Tecnologia dei Minerali e delle Rocce di Interesse Industriale
CALCARI A CLYMENIE 298 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA
 4. - SARDEGNA 298 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA CALCARI A CLYMENIE RANGO ETÀ REGIONE Formazione Frasniano - Tournaisiano Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 226 548, 549
4. - SARDEGNA 298 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA CALCARI A CLYMENIE RANGO ETÀ REGIONE Formazione Frasniano - Tournaisiano Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 226 548, 549
Cenni di Geologia dell Italia GFGeol-STAN Italia 1
 Cenni di Geologia dell Italia 2017-2018 14 GFGeol-STAN Italia 1 Italia: storia geologica recente, recentissima + divulgativo, illustrato. + specialistico, disegni B&W 2017-2018 14 GFGeol-STAN Italia 2
Cenni di Geologia dell Italia 2017-2018 14 GFGeol-STAN Italia 1 Italia: storia geologica recente, recentissima + divulgativo, illustrato. + specialistico, disegni B&W 2017-2018 14 GFGeol-STAN Italia 2
COMUNE DI GUASILA. Provincia di CAGLIARI
 Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
Timbri: COMUNE DI GUASILA Provincia di CAGLIARI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.AP.R.I. s.c. a r.l. Sig. Carlo Schirru Tecnico: Dott. Ing. Pierpaolo Medda Dott. Geol. Fabio Sanna
PROGETTO. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
 NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 528 ORISTANO Parte a terra cura di: S. Barca (1), E.D. Patta (2), M. Murtas (3), G. Pisanu (2) e M. Serra (4) Parte a mare cura
NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 528 ORISTANO Parte a terra cura di: S. Barca (1), E.D. Patta (2), M. Murtas (3), G. Pisanu (2) e M. Serra (4) Parte a mare cura
MILIOLITICO 302 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA
 302 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA MILIOLITICO RANGO ETÀ REGIONE Formazione Ypresiano Inferiore Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 232-232bis, 233, 239-240 564 MLI Scheda
302 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA MILIOLITICO RANGO ETÀ REGIONE Formazione Ypresiano Inferiore Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 232-232bis, 233, 239-240 564 MLI Scheda
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione:
 CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
CAPITOLO 6 Tettonica 6.1. Introduzione: Al fine di chiarire il ruolo della tettonica nell evoluzione sedimentaria dell area di studio, sono stati analizzati i principali caratteri strutturali della successione
EVOLUZIONE MORFOTETTONICA DELLA CONCA D ORO
 Laureanda: Melania TERZO Relatore: Cipriano DI MAGGIO EVOLUZIONE MORFOTETTONICA DELLA CONCA D ORO Sono presentati i risultati di uno studio morfotettonico condotto, nell ambito di una tesi di laurea, lungo
Laureanda: Melania TERZO Relatore: Cipriano DI MAGGIO EVOLUZIONE MORFOTETTONICA DELLA CONCA D ORO Sono presentati i risultati di uno studio morfotettonico condotto, nell ambito di una tesi di laurea, lungo
Modulo 1: Nozioni di base di Geologia
 Modulo 1: Nozioni di base di Geologia La Terra (Parametri fisici -Origine-Struttura Dinamica) Metodi di datazione assoluta e relativa Il Tempo Geologico e le sue principali suddivisioni La Terra: le principali
Modulo 1: Nozioni di base di Geologia La Terra (Parametri fisici -Origine-Struttura Dinamica) Metodi di datazione assoluta e relativa Il Tempo Geologico e le sue principali suddivisioni La Terra: le principali
La Panchina Tirreniana
 La Panchina Tirreniana La Panchina tirreniana è un insieme di sedimenti marini depositati in modo orizzontale (da cui il nome) che si sono solidificati nel corso del tempo. 4 m Suolo di calpestio punico
La Panchina Tirreniana La Panchina tirreniana è un insieme di sedimenti marini depositati in modo orizzontale (da cui il nome) che si sono solidificati nel corso del tempo. 4 m Suolo di calpestio punico
I VIAGGI DELLE PIANTE 1.2
 I VIAGGI DELLE PIANTE 1.2 Primo incontro, Parte Seconda, a cura di Milena Bertacchini LE PIANTE VIAGGIANO a grande scala trasporto a piccola scala FATTORI NATURALI FATTORE UOMO Movimenti crostali Mutamenti
I VIAGGI DELLE PIANTE 1.2 Primo incontro, Parte Seconda, a cura di Milena Bertacchini LE PIANTE VIAGGIANO a grande scala trasporto a piccola scala FATTORI NATURALI FATTORE UOMO Movimenti crostali Mutamenti
3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale
 3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale Tettonica delle placche crostali Concetto fondamentale delle Scienze della Terra Risultato dell integrazione di molte discipline Basata su considerazioni
3 - Tettonica delle placche crostali: una teoria globale Tettonica delle placche crostali Concetto fondamentale delle Scienze della Terra Risultato dell integrazione di molte discipline Basata su considerazioni
Caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo della Città di Roma
 Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria Caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo della Città di Roma Moscatelli M. (1), Milli S. (2), Patera A.
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria Caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo della Città di Roma Moscatelli M. (1), Milli S. (2), Patera A.
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con
 La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
La storia geologica del territorio di Cerignola coincide con la storia geologica del pianeta: quando, 4.600 milioni di anni fa, la superficie terrestre fino allora concentrata in una sola unità strutturale
A - Paleontologia e stratigrafia
 A - Paleontologia e stratigrafia Codice A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A20 A21 TITOLO I Lagenina del Golfo di Napoli di Buchner (1940) e la "sesta estinzione" Una successione a macroforaminiferi
A - Paleontologia e stratigrafia Codice A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A20 A21 TITOLO I Lagenina del Golfo di Napoli di Buchner (1940) e la "sesta estinzione" Una successione a macroforaminiferi
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI
 DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
DESCRIZIONE GEOSITO 15: MONTE CASOLI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito è situato nel territorio comunale di Bomarzo, a nord-ovest del centro abitato, in località
Strike-slip Faults. - Faglie Trasformi: associate ai margini di placca, tagliano l intero spessore litosferico
 Strike-slip Faults - Faglie Trasformi: associate ai margini di placca, tagliano l intero spessore litosferico - Faglie Trascorrenti: confinate allo spessore crostale, sono generalmente intra-continentali
Strike-slip Faults - Faglie Trasformi: associate ai margini di placca, tagliano l intero spessore litosferico - Faglie Trascorrenti: confinate allo spessore crostale, sono generalmente intra-continentali
PARTE II Nannoplancton calcareo e nannofossili calcarei: tassonomia e biostratigrafia. biostratigrafia e schemi biostratigrafici
 PARTE II Nannoplancton calcareo e nannofossili calcarei: tassonomia e biostratigrafia OUTLINE caratteristiche morfologiche e terminologia biostratigrafia e schemi biostratigrafici utilità della biostratigrafia
PARTE II Nannoplancton calcareo e nannofossili calcarei: tassonomia e biostratigrafia OUTLINE caratteristiche morfologiche e terminologia biostratigrafia e schemi biostratigrafici utilità della biostratigrafia
La seconda fase del Rift Sardo: vulcanismo ed evoluzione dei sub-bacini di Ardara-Chilivani e Bonorva (Sardegna settentrionale)
 Boll. Soc. Geol. It., 124 (2005), 3-20, 6 ff., 2 tabb. La seconda fase del Rift Sardo: vulcanismo ed evoluzione dei sub-bacini di Ardara-Chilivani e Bonorva (Sardegna settentrionale) ANTONIO SAU (*), LUCIANO
Boll. Soc. Geol. It., 124 (2005), 3-20, 6 ff., 2 tabb. La seconda fase del Rift Sardo: vulcanismo ed evoluzione dei sub-bacini di Ardara-Chilivani e Bonorva (Sardegna settentrionale) ANTONIO SAU (*), LUCIANO
Cenni di Geologia di Treville (AL) Dott. Alfredo Frixa, Geologo
 Cenni di Geologia di Treville (AL) Le unità geologiche affioranti sul territorio comunale di Treville sono in prevalenza marne e marne calcaree (con contenuto in argilla anche del 50%), con locali livelli
Cenni di Geologia di Treville (AL) Le unità geologiche affioranti sul territorio comunale di Treville sono in prevalenza marne e marne calcaree (con contenuto in argilla anche del 50%), con locali livelli
LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
 Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Pagina 1 di 5. Tipo scheda:/livello BNP-C. Codice univoco: Ente schedatore: UNICA. Ente Competente: S09. Ente Proponente:
 Pagina 1 di 5 Tipo scheda:/livello BNP-C Codice univoco: 2000190137 Ente schedatore: UNICA Ente Competente: S09 Ente Proponente: ALTRI CODICI Codice museo: MDLCA - Codice collezione: GP - Codice campione:
Pagina 1 di 5 Tipo scheda:/livello BNP-C Codice univoco: 2000190137 Ente schedatore: UNICA Ente Competente: S09 Ente Proponente: ALTRI CODICI Codice museo: MDLCA - Codice collezione: GP - Codice campione:
UNIVERSITÀ DI PISA. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
 UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
UNIVERSITÀ DI PISA Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche Anno Accademico 2011/2012 Candidato: Sara Mariotti Titolo della tesi Architettura deposizionale dei depositi tardo-quaternari
PETROGRAFIA REGIONALE
 Università di Pisa Dipartimento di Scienze della Terra Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche PETROGRAFIA REGIONALE a.a. 2014-2015 Sergio Rocchi rocchi@dst.unipi.it URL corso: http://www.dst.unipi.it/dst/rocchi/sr/pr.html
Università di Pisa Dipartimento di Scienze della Terra Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche PETROGRAFIA REGIONALE a.a. 2014-2015 Sergio Rocchi rocchi@dst.unipi.it URL corso: http://www.dst.unipi.it/dst/rocchi/sr/pr.html
CAI COMITATO SCIENTIFICO LIGURE PIEMONTESE VALDOSTANO GEOLOGIA DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE (BTP)
 CAI COMITATO SCIENTIFICO LIGURE PIEMONTESE VALDOSTANO GEOLOGIA DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE (BTP) GIUSEPPE BEN geoben2009@gmail.com 1 CARTA STRUTTURALE D ITALIA 2 CARTA STRUTTURALE D ITALIA 3 CRONOLOGIA
CAI COMITATO SCIENTIFICO LIGURE PIEMONTESE VALDOSTANO GEOLOGIA DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE (BTP) GIUSEPPE BEN geoben2009@gmail.com 1 CARTA STRUTTURALE D ITALIA 2 CARTA STRUTTURALE D ITALIA 3 CRONOLOGIA
DESCRIZIONE GEOSITO 13: CIVITA DI BAGNOREGIO E VALLE DEI CALANCHI
 DESCRIZIONE GEOSITO 13: CIVITA DI BAGNOREGIO E VALLE DEI CALANCHI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito comprende la rupe di Civita di Bagnoregio e la Valle dei
DESCRIZIONE GEOSITO 13: CIVITA DI BAGNOREGIO E VALLE DEI CALANCHI A) DESCRIZIONE GEOLOGICA, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DEL GEOSITO Il geosito comprende la rupe di Civita di Bagnoregio e la Valle dei
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA DIPARTIMENTO DI SCIENZE
 Programma di insegnamento per l A.A. 2015-2016 Insegnamento: GEOLOGIA 1, Modulo A Docente: Albina Colella Corso di studio: Scienze Geologiche Anno di corso: I Periodo didattico: II Semestre Tipologia:
Programma di insegnamento per l A.A. 2015-2016 Insegnamento: GEOLOGIA 1, Modulo A Docente: Albina Colella Corso di studio: Scienze Geologiche Anno di corso: I Periodo didattico: II Semestre Tipologia:
Paleontologia Stratigrafica
 Paleontologia Stratigrafica Stratigrafia Scienza che studia la disposizione, la successione nel tempo e la struttura chimico fisica dei corpi rocciosi Moti delle placche Vulcanesimo Cosmo, Sole Rotazione
Paleontologia Stratigrafica Stratigrafia Scienza che studia la disposizione, la successione nel tempo e la struttura chimico fisica dei corpi rocciosi Moti delle placche Vulcanesimo Cosmo, Sole Rotazione
CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DEL GOLFO DI TRIESTE
 CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DEL GOLFO DI TRIESTE di Martina Busetti 1, Fabrizio Zgur 1, Roberto Romeo 1, Lorenzo Sormani 1, Franco Pettenati 1 1 Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DEL GOLFO DI TRIESTE di Martina Busetti 1, Fabrizio Zgur 1, Roberto Romeo 1, Lorenzo Sormani 1, Franco Pettenati 1 1 Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
DEFINIZIONE E OBBIETTIVI DELLA STRATIGRAFIA
 DEFINIZIONE E OBBIETTIVI DELLA STRATIGRAFIA Lo scopo della stratigrafia é quello di ordinare nel tempo e nello spazio i diversi corpi litologici che costituiscono la porzione accessibile della crosta terrestre;
DEFINIZIONE E OBBIETTIVI DELLA STRATIGRAFIA Lo scopo della stratigrafia é quello di ordinare nel tempo e nello spazio i diversi corpi litologici che costituiscono la porzione accessibile della crosta terrestre;
1- GMPF Introduzione corso Geoarcheologia, morfologia e processi formativi
 Corso 1- GMPF Introduzione corso Geoarcheologia, morfologia e processi formativi Prof. Stefano Lugli Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Via Campi
Corso 1- GMPF Introduzione corso Geoarcheologia, morfologia e processi formativi Prof. Stefano Lugli Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Via Campi
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
 Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche XII Congresso GeoSed Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario Sezione della Società Geologica italiana Cagliari
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche XII Congresso GeoSed Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario Sezione della Società Geologica italiana Cagliari
Negli ultimi anni nuovi criteri e metodi per definire i depositi quaternari continentali: Unità Allostratigrafiche e UBSU
 La stratigrafia del Quaternario - 2 Abbiamo visto come per vari motivi le unità della stratigrafia classica, ma anche le unità morfologiche, pedologiche NON siano del tutto adatte al rilevamento del Quaternario,
La stratigrafia del Quaternario - 2 Abbiamo visto come per vari motivi le unità della stratigrafia classica, ma anche le unità morfologiche, pedologiche NON siano del tutto adatte al rilevamento del Quaternario,
ESCURSIONE IN LOCALITA PIETRAPERTOSA - CASTELMEZZANO A cura di Sergio Longhitano, Domenico Chiarella e Marcello Tropeano
 Università degli Studi della Basilicata Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche CORSO DI GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA Anno Accademico 2007/2008 CAMPO DI GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA
Università degli Studi della Basilicata Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche CORSO DI GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA Anno Accademico 2007/2008 CAMPO DI GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA
LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI
 Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
Read Online and Download Ebook LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO VERSIONE RIVEDUTA BY GIOVANNI LUZZI DOWNLOAD EBOOK : LA SACRA BIBBIA: OSSIA L'ANTICO E IL NUOVO Click link bellow and
STRATI E STRATIFICAZIONE
 Concetto di strato. STRATI E STRATIFICAZIONE Definizione Fisica: uno STRATO rappresenta uno corpo costituito da un accumulo di sedimenti, fisicamente delimitato alla base (letto) ed al tetto da superfici
Concetto di strato. STRATI E STRATIFICAZIONE Definizione Fisica: uno STRATO rappresenta uno corpo costituito da un accumulo di sedimenti, fisicamente delimitato alla base (letto) ed al tetto da superfici
PRIMA DIDASCALIA: Appennino - Maghrebide dei Monti di Trabia o di Calamigna)
 PRIMA DIDASCALIA: ERA MESOZOICA > TRIASSICO > LADINICO/CARNICO (241-228 Ma) Rocce appartenenti a Facies del dominio Imerese (Catena Appennino - Maghrebide dei Monti di Trabia o di Calamigna), originatesi
PRIMA DIDASCALIA: ERA MESOZOICA > TRIASSICO > LADINICO/CARNICO (241-228 Ma) Rocce appartenenti a Facies del dominio Imerese (Catena Appennino - Maghrebide dei Monti di Trabia o di Calamigna), originatesi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Geologiche
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Geologiche STUDIO STRATIGRAFICO DI SUCCESSIONI MESOZOICHE DEL DOMINIO SUDALPINO AFFIORANTI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Scienze Geologiche STUDIO STRATIGRAFICO DI SUCCESSIONI MESOZOICHE DEL DOMINIO SUDALPINO AFFIORANTI
Lago Nero Report 2006
 Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
Lago Nero Report 2006 1.0 Premessa La presente relazione illustra i primi risultati di una campagna di indagini geognostiche eseguite in Località Lago Nero nel Comune di Tornareccio (CH), nell ambito del
1936); Faglia orientale del Liri (Segr( 1969; 1971; 1975), Linea Val Roveto- Atina (Funicello
 Faglia della Marsica (Beneo 1936); Faglia orientale del Liri (Segr( Segrè,1950; Zuccari 1963), Dondi et al. 1966 (Pozzo Trevi); Pieri 1966 Faglia della Marsica occidentale (Parotto( 1969; 1971; 1975),
Faglia della Marsica (Beneo 1936); Faglia orientale del Liri (Segr( Segrè,1950; Zuccari 1963), Dondi et al. 1966 (Pozzo Trevi); Pieri 1966 Faglia della Marsica occidentale (Parotto( 1969; 1971; 1975),
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Posizione accademica Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia Università degli Studi di PAVIA Dipartimento Dipartimento
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Posizione accademica Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia Università degli Studi di PAVIA Dipartimento Dipartimento
Geomorfologia dei processi gravitativi in scarpata continentale (Margine meridionale sardo)
 Geomorfologia dei processi gravitativi in scarpata continentale (Margine meridionale sardo) Deiana Giacomo (a), Lecca Luciano (a), Meleddu Antonietta (a), Paliaga Enrico M. (a), Orrù Paolo.E (a) (a) Dipartimento
Geomorfologia dei processi gravitativi in scarpata continentale (Margine meridionale sardo) Deiana Giacomo (a), Lecca Luciano (a), Meleddu Antonietta (a), Paliaga Enrico M. (a), Orrù Paolo.E (a) (a) Dipartimento
IL NUBRIFAGIO NEL BASSO SARCA NELLA NOTTE DEL 29 GIUGNO 2009
 Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT N. 04/2009 IL NUBRIFAGIO NEL BASSO SARCA NELLA NOTTE DEL 29 GIUGNO 2009 a cura di Roberto Barbiero, Marta Pendesini e Serenella Saibanti Giugno 2009 Dipartimento
Provincia Autonoma di Trento METEOTRENTINO REPORT N. 04/2009 IL NUBRIFAGIO NEL BASSO SARCA NELLA NOTTE DEL 29 GIUGNO 2009 a cura di Roberto Barbiero, Marta Pendesini e Serenella Saibanti Giugno 2009 Dipartimento
MARGINI DI PIATTAFORMA CARBONATICA E REEFs CARBONATICI
 MARGINI DI PIATTAFORMA CARBONATICA E REEFs CARBONATICI I reefs carbonatici sono ottimi indicatori delle condizioni ambientali (clima, profondità d acqua, ossigenazione). Il loro riconoscimento lungo i
MARGINI DI PIATTAFORMA CARBONATICA E REEFs CARBONATICI I reefs carbonatici sono ottimi indicatori delle condizioni ambientali (clima, profondità d acqua, ossigenazione). Il loro riconoscimento lungo i
Ricostruzione tephro-cronologica dei depositi recenti del cono della Fossa di Vulcano e della penisola di Vulcanello (isole Eolie).
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Tesi di laurea in Vulcanologia Ricostruzione tephro-cronologica dei depositi recenti
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Tesi di laurea in Vulcanologia Ricostruzione tephro-cronologica dei depositi recenti
Vulcanismo sottomarino dell area sud-orientale tirrenica: gli edifici sommersi Marsili e Palinuro
 Vulcanismo sottomarino dell area sud-orientale tirrenica: gli edifici sommersi Marsili e Palinuro Salvatore Passaro Istituto per l Ambiente Marino Costiero (IAMC), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Calata
Vulcanismo sottomarino dell area sud-orientale tirrenica: gli edifici sommersi Marsili e Palinuro Salvatore Passaro Istituto per l Ambiente Marino Costiero (IAMC), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Calata
Introduzione al Magmatismo Cenozoico Italiano
 Introduzione al Magmatismo Cenozoico Italiano Distribuzione *** Criteri classificativi *** Considerazioni petrologiche *** Implicazioni geodinamiche Magmatismo cenozoico dell Italia In Italia peninsulare
Introduzione al Magmatismo Cenozoico Italiano Distribuzione *** Criteri classificativi *** Considerazioni petrologiche *** Implicazioni geodinamiche Magmatismo cenozoico dell Italia In Italia peninsulare
LIGNITIFERO RANGO ETÀ REGIONE. Formazione Ypresiano Superiore - Luteziano Inferiore Sardegna
 308 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA LIGNITIFERO RANGO ETÀ REGIONE Formazione Ypresiano Superiore - Luteziano Inferiore Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 232-232bis, 233
308 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA LIGNITIFERO RANGO ETÀ REGIONE Formazione Ypresiano Superiore - Luteziano Inferiore Sardegna FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 232-232bis, 233
Sergio Ginesu 1, Francesco Secchi 1. Istituto Scienze Geologico Mineralogiche, Università di Sassari
 401 EVOLUZIONE RECENTE DEL LITORALE TRA PORTOSCUSO E SAN GIOVAN- NI SUERGIU (SULCIS, SARDEGNA SUD OCCIDENTALE) Sergio Ginesu 1, Francesco Secchi 1 1 Istituto Scienze Geologico Mineralogiche, Università
401 EVOLUZIONE RECENTE DEL LITORALE TRA PORTOSCUSO E SAN GIOVAN- NI SUERGIU (SULCIS, SARDEGNA SUD OCCIDENTALE) Sergio Ginesu 1, Francesco Secchi 1 1 Istituto Scienze Geologico Mineralogiche, Università
Angela Girone BORSE DI STUDIO - STAGES ALL ESTERO-.
 Angela Girone 1997: laurea in Scienze Geologiche presso l Università degli studi di Bari. 1997-2000: Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra presso l Università di Bari (XIII ciclo). 2002-2003: Assegnista
Angela Girone 1997: laurea in Scienze Geologiche presso l Università degli studi di Bari. 1997-2000: Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra presso l Università di Bari (XIII ciclo). 2002-2003: Assegnista
I DEPOSITI MIOCENICI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE: IL BACINO DEL LOGUDORO PREMESSA
 I DEPOSITI MIOCENICI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE: IL BACINO DEL LOGUDORO A. FUNEDDA*, G. OGGIANO** & V. PASCUCCI** * Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Cagliari, Via Trentino 51, 09100
I DEPOSITI MIOCENICI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE: IL BACINO DEL LOGUDORO A. FUNEDDA*, G. OGGIANO** & V. PASCUCCI** * Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Cagliari, Via Trentino 51, 09100
Relazione geomorfologica sulla riserva naturale di Canale Monterano (Roma) 1. Inquadramento geografico dell area di Canale Monterano
 Arata Alessandro, Bruni Lorenzo, Cianfanelli Valentina, Fortunato Carolina: Relazione geomorfologica sulla riserva naturale di Canale Monterano (Roma) 1. Inquadramento geografico dell area di Canale Monterano
Arata Alessandro, Bruni Lorenzo, Cianfanelli Valentina, Fortunato Carolina: Relazione geomorfologica sulla riserva naturale di Canale Monterano (Roma) 1. Inquadramento geografico dell area di Canale Monterano
I BRACHIOPODI DELLE CALCARENITI DI CASTRO MARINA (LECCE)
 EMMA TADDEI RUGGIERO 1, ROBERTO TADDEI 2 1 Dipartimento di Scienze della Terra Università di Napoli Federico II 2 Dipartimento delle Scienze Biologiche, Sezione Biologia Vegetale Università di Napoli Federico
EMMA TADDEI RUGGIERO 1, ROBERTO TADDEI 2 1 Dipartimento di Scienze della Terra Università di Napoli Federico II 2 Dipartimento delle Scienze Biologiche, Sezione Biologia Vegetale Università di Napoli Federico
OSTEOSARCOMA. VIIIa OSTEOSARCOMA 0-14 ANNI. Schede specifiche per tumore. I tumori in Italia Rapporto AIRTUM 2012 TUMORI INFANTILI
 I tumori in Italia Rapporto AIRTUM TUMORI INFANTILI OSTEOSARCOMA - ANNI - ANNI INCIDENZA Tasso. Nella classe di età - anni, il tasso di incidenza standardizzato per età è di, casi per milione/anno (IC9%,-,)
I tumori in Italia Rapporto AIRTUM TUMORI INFANTILI OSTEOSARCOMA - ANNI - ANNI INCIDENZA Tasso. Nella classe di età - anni, il tasso di incidenza standardizzato per età è di, casi per milione/anno (IC9%,-,)
IL TERRITORIO DI SONDRIO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA
 IL TERRITORIO DI SONDRIO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA venerdì 5 settembre 2014, 9:30 16:30 Sala Consiliare del Comune di Tirano Piazza Cavour 18 Tirano (SO) Le successioni sedimentarie del Sudalpino
IL TERRITORIO DI SONDRIO NELLA NUOVA CARTOGRAFIA GEOLOGICA venerdì 5 settembre 2014, 9:30 16:30 Sala Consiliare del Comune di Tirano Piazza Cavour 18 Tirano (SO) Le successioni sedimentarie del Sudalpino
Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna
 Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna lmartelli@regione.emilia-romagna.it fmolinari@regione.emilia-romagna.it fsciuto@regione.emilia-romagna.it Esempio di riserve geotermiche
Analisi preliminare delle risorse geotermiche in Emilia-Romagna lmartelli@regione.emilia-romagna.it fmolinari@regione.emilia-romagna.it fsciuto@regione.emilia-romagna.it Esempio di riserve geotermiche
SASS DE LA LUNA 106 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA
 106 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA SASS DE LA LUNA RANGO ETÀ REGIONE Formazione Albiano Superiore Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 33, 34, 46, 47 080 SDL Scheda a cura
106 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA SASS DE LA LUNA RANGO ETÀ REGIONE Formazione Albiano Superiore Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA 33, 34, 46, 47 080 SDL Scheda a cura
STRATIGRAFIA SEQUENZIALE STRATIGRAFIA SEQUENZIALE
 STRATIGRAFIA SEQUENZIALE La stratigrafia sequenziale è considerata una delle più importanti discipline di sintesi della geologia del sedimentario, poiché cerca di spiegare l architettura deposizionale
STRATIGRAFIA SEQUENZIALE La stratigrafia sequenziale è considerata una delle più importanti discipline di sintesi della geologia del sedimentario, poiché cerca di spiegare l architettura deposizionale
Le variazioni del livello del mare nel Quaternario
 Le variazioni del livello del mare nel Quaternario Trieste, 1875 (Venezia, 1872; Genova, 1884; Marsiglia, 1885: Marina di Ravenna, 1896) AA 2015-2106 GQt Livello mare 1 Alla fine degli anni 60. Le calotte
Le variazioni del livello del mare nel Quaternario Trieste, 1875 (Venezia, 1872; Genova, 1884; Marsiglia, 1885: Marina di Ravenna, 1896) AA 2015-2106 GQt Livello mare 1 Alla fine degli anni 60. Le calotte
PIETRA SIMONA RANGO ETÀ REGIONE. Permiano Inferiore FOGLIO AL FOGLIO AL SIGLA CDG 1
 36 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA PIETRA SIMONA RANGO ETÀ REGIONE Membro Permiano Inferiore Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA CDG 1 Scheda a cura di Fabrizio Berra,
36 APAT - CNR - COMMISSIONE ITALIANA DI STRATIGRAFIA PIETRA SIMONA RANGO ETÀ REGIONE Membro Permiano Inferiore Lombardia FOGLIO AL 100.000 FOGLIO AL 50.000 SIGLA CDG 1 Scheda a cura di Fabrizio Berra,
Acquiferi alluvionali della pianura padana
 Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
Acquiferi alluvionali della pianura padana Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia - Romagna La struttura geologica degli acquiferi padani La Pianura Padana è una pianura alluvionale
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION
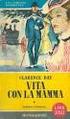 AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : AVERE 30 ANNI E VIVERE CON LA MAMMA BIBLIOTECA BIETTI ITALIAN EDITION PDF Click button to download
The Great Pangea Controversy
 The Great Pangea Controversy Premises we saw earlier that the time-averaged geomagnetic field is a geocentric axial dipole (GAD) field. A GAD implies that: 1) Tan(Inc) = 2*Tan(lat), or Inc = invtan(2*tan(lat))
The Great Pangea Controversy Premises we saw earlier that the time-averaged geomagnetic field is a geocentric axial dipole (GAD) field. A GAD implies that: 1) Tan(Inc) = 2*Tan(lat), or Inc = invtan(2*tan(lat))
Consiglio Nazionale delle Ricerche. RAPPORTO DI EVENTO Fenomeni franosi avvenuti in Val Germanasca (TO) il 16 marzo 2011
 Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA CENTRO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RAPPORTO DI EVENTO
LE ROCCE. (seconda parte) Lezioni d'autore. di Simona Mazziotti Tagliani
 LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
LE ROCCE (seconda parte) Lezioni d'autore di Simona Mazziotti Tagliani VIDEO VIDEO Le rocce sedimentarie (I) Le rocce sedimentarie, seppur in quantità minore nella crosta terrestre rispetto alle metamorfiche
ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE
 ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE FAGLIA ATTIVA E' considerata attiva una faglia originatasi e/o riattivatasi durante il campo di stress agente correntemente nell'area.. Faglia quaternaria, pleistocenica,
ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA STRUTTURALE FAGLIA ATTIVA E' considerata attiva una faglia originatasi e/o riattivatasi durante il campo di stress agente correntemente nell'area.. Faglia quaternaria, pleistocenica,
Geologia I A.A. 2016/2017 MODULO I
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Geologia I A.A. 2016/2017 MODULO I Docente: Prof MARCO BRANDANO (Canali A-K e L-Z), Dipartimento Scienze della Terra, piano, III stanza 325 tel 34240e-mail: marco.brandano@uniroma1.it.
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE Geologia I A.A. 2016/2017 MODULO I Docente: Prof MARCO BRANDANO (Canali A-K e L-Z), Dipartimento Scienze della Terra, piano, III stanza 325 tel 34240e-mail: marco.brandano@uniroma1.it.
Quarantacinque disegni di Alberto Giacometti Edited by Lamberto Vitali, foreword by Jean Leymarie Einaudi, Turin, 1963
 Quarantacinque disegni di Alberto Giacometti Edited by Lamberto Vitali, foreword by Jean Leymarie Einaudi, Turin, 1963 The album of facsimiles Quarantacinque disegni di Alberto Giacometti has been published
Quarantacinque disegni di Alberto Giacometti Edited by Lamberto Vitali, foreword by Jean Leymarie Einaudi, Turin, 1963 The album of facsimiles Quarantacinque disegni di Alberto Giacometti has been published
MIRIAM COBIANCHI CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI ESPERIENZE PROFESSIONALI RICERCA PROFESSORE ASSOCIATO DI PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA (SSD GEO/01)
 MIRIAM COBIANCHI PROFESSORE ASSOCIATO DI PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA (SSD GEO/01) ASSOCIATE PROFESSOR OF PALEONTOLOGY AND PALEOECOLOGY CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI Nata a Pavia il 9 luglio 1961,
MIRIAM COBIANCHI PROFESSORE ASSOCIATO DI PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA (SSD GEO/01) ASSOCIATE PROFESSOR OF PALEONTOLOGY AND PALEOECOLOGY CURRICULUM VITAE DATI ANAGRAFICI Nata a Pavia il 9 luglio 1961,
CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 331 3. - SICILIA
 CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 331 3. - SICILIA CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 345 CALCARE DI BASE RANGO ETÀ REGIONE Membro Miocene Superiore
CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 331 3. - SICILIA CARTA GEOLOGICA D ITALIA 1:50.000 - CATALOGO DELLE FORMAZIONI 345 CALCARE DI BASE RANGO ETÀ REGIONE Membro Miocene Superiore
