IL CONCETTO DI VIRTU IN DUNS SCOTO
|
|
|
- Agnello Cara
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL CONCETTO DI VIRTU IN DUNS SCOTO Situazione di crisi A nessuno sfugge che oggi il mondo sta vivendo un periodo di crisi generale, che investe tutti gli aspetti della vita e della società, dall individuo al sociale, dall economico al politico, dal morale al religioso. La crisi riguarda non solo le istituzioni, ma soprattutto gli individui, e sembra avere un denominatore comune che gli esperti chiamano crisi dei valori. Alle trasformazioni vertiginose, ai cambiamenti continui, alla complessità crescente dei problemi, non sempre corrisponde un adeguata preparazione educativa e formativa né da parte dell individuo né da parte delle agenzie preposte a tale scopo, cioè famiglia scuola e società. Si assiste alla constatazione abbastanza amara che la rincorsa al successo economico senza troppe remore etiche e la vita vissuta all'insegna del divertimento e del piacere sfrenati conducono l uomo a sperimentare penosi sentimenti di solitudine, di noia, di insicurezza, di vuoto esistenziale, di profondo disorientamento morale e anche religioso. Questo fatto sembra paradossalmente acuito, anziché lenito, dalla libertà di cui gode l'uomo, dalla molteplicità di opzioni fra cui è chiamato a scegliere, in assoluta solitudine, senza riferimenti certi e senza guide, che non siano il profitto economico e l'interesse personale. Sembra vivere in un turbine vorticoso, da cui non si vede la via d uscita. La situazione esige risposte geniali e capaci per non continuare a schiacciare ancor di più l'individuo nella sua impotenza e insicurezza. La principale forma di insicurezza è la perdita della propria identità. L uomo non sa più chi è, né perché esiste, né da dove viene, né dove va. Alla base della crisi dei valori sembra poter aggiungere questa perdita dei valori esistenziali. E fino a quando l uomo, in un modo o nell altro, non dà una risposta personale a queste domande, non potrà iniziare un percorso di rinnovamento regolare e continuo. E un processo profondamente culturale. Pur senza entrare nello specifico delle profonde cause culturali dell odierna crisi, sembra utile gettare uno sguardo al passato per vedere di poter cogliere qualche indicazione per interpretare non solo l attuale momento critico, ma anche per gettare le basi di un progetto culturale di rinnovamento personale, perché, una volta recuperata la propria identità, si potrà con più sicurezza contribuire anche a rinnovare le strutture sociali della famiglia e dello stato. Un concetto base di un possibile rinnovamento culturale è certamente il recupero del concetto di virtù, cui è legato strettamente, dalla sua etimologia latina, quello di vir, uomo.
2 E così, si rientra nella dimensione esistenziale e religiosa della crisi, che giustifica il tentativo di riscoprire un Pensatore che, pur essendo poco conosciuto, può dare un valido contributo culturale e spirituale alla formazione della nuova identità dell uomo, così da poter iniziare il suo rinnovamento e vivere l esistenza con più sicurezza e fiducia in se stesso. Il nome di questo Pensatore è Giovanni Duns Scoto ( ), il rappresentante più qualificato del mondo francescano, perché ha dato scientificità all ideale di Francesco d Assisi. Tra le sue caratteristiche principali bisogna annoverare certamente un pensiero forte, che permette di superare con più facilità gli attacchi contro la verticale, sferrati dagli arieti del moderno pensiero debole, attraverso il suo esasperato soggettivismo relativismo e libertinismo. Il suo riferimento speculativo sarà fatto dopo l accenno all etimologia del termine virtù e al suo significato classico-cristiano. Etimologia del termine virtù Poiché il concetto di virtù che Duns Scoto utilizza è di derivazione classico-cristiana, torna utile accennare ad entranbe le condizioni. Il termine virtù deriva dal greco ἀρετή, areté - (da ararisko, mettere insieme, unire; che ha attinenza con aresko, piacere, arestos, piacevole; e con ariston, nel modo migliore) - ha diversi significati e possono riguardare le qualità specifiche di un oggetto o di una persona. Il più antico significato sembra quello di eccellenza, ossia una caratteristica che si applica sia a un aperazione determinata sia a una dote comunicata da una potenza superiore, e spesso esse si trovano insieme, perché l opera esistenziale a cui tutti aspirano è la felicità o la gloria. Viene messo spesso in relazione alle qualità fisiche o spirituali di un uomo e alle doti di una donna sia come valore sia come grazia e bellezza. Altro significato importante, già documentabile al periodo omerico, è quello che indica un modo di agire dell uomo: coraggio, valore militare; oppure il frutto di tale azione: merito. In breve, dall etimologia del termine greco areté, virtù, si possono trarre utili indicazioni che esprimono diversi stati d'animo o qualità dell individuo, a seconda della situazione storico-sociale considerata. Così per esempio, può indicare: la capacità di compiere il bene, di eccellere in qualcosa, di comportarsi in maniera ottimale, di tendere alla propria perfezione d essere; ma anche di esprimere doti di valore fisico o morale, di carattere forte, di bellezza estetica, di merito spirituale.
3 Significato classico di virtù La concezione della virtù nel pensiero greco antico costituisce il fulcro centrale dell'etica e delle sue trasformazioni storiche. Al tempo dei sofisti, il concetto di virtù viene utilizzato in maniera empirico e utilitaristico, nel senso che si dava importanza più all aspetto formale del linguaggio che non al suo contenuto. Con Socrate, si riveste di una certa intellettualità, ed entra nella dimensione etica, cioè nella valutazione del comportamento dell uomo in ordine al suo contenuto, specialmente in riferimento al bene e alla giustizia, espressioni di un ordine cosmico universale. Questo nuovo significato etico del termine virtù s impone in tutta la filosofia morale greca del periodo socratico. Esso non riguarda più tutte le qualità dell uomo, ma abbraccia soltanto quelle di natura etica, cioè di ricerca del bene e del giusto per attuarli. La virtù diviene così un mezzo di ricerca della sapienza con cui l uomo perfeziona il suo essere e il suo comportamento secondo bontà e giustizia. Valori che, pure non essendo di per sé insegnabili, ma solo indicativi, invitano l uomo a saper trarre da sé stesso la forza di comprendere veramente il bene e il giusto per attuarli nella vita. E il famoso metodo maieutico di Socrate, ossia a saper trarre da sé la norma universale del bene e del giusto per realizzarla nella pratica, come la partoriente che mette al mondo un nuovo essere con l aiuto della levatrice. La coloratura intellettuale dell areté non indica, perciò, solo l aspetto conoscitivo della bontà o della giustizia, ma comporta anche l impegno a realizzare tale bontà o giustizia. Il termine, infatti, connota sì il significato di conoscenza e di scienza, ma sfocia altresì nella saggezza e nella sapienza, che sono le caratteristiche dell agire dell uomo. Anzi, lo stesso originario senso di επιστηµε, episteme - (dal greco epistamai: conosco per fare, so per esperienza, valgo per quello che faccio) - indica la ricerca continua e dialettica del bene... per realizzarlo, dietro la guida del δαιµονιον, daimonion, ossia la voce interiore e divina che suggerisce ciò che non si deve fare per vivere bene. E una voce solo negativa e proibitiva, ma non positiva e propositiva. In Platone, che è il teorico e l interprete di Socrate, il concetto di virtù si perfeziona al massimo, fino a universalizzarli nell idea di Bene e di Giustizia assoluti, che come tali sono al
4 di sopra di ogni scienza e sapienza, e così non possono essere insegnabili, ma solo ideali cui ispirarsi. Così il Bene consiste nell Idea di Bene, da cui ha origine ogni bene nella vita terrena; e la Giustizia nell Idea di Giustizia, a cui ogni azione umana deve ispirarsi per agire con giustizia. Questo è il motivo della non insegnabilità del Bene o della Giustizia, ma possono essere dei punti ideali di riferimento nella pratica, attraverso l applicazione del metodo negativo, cioè di ciò che non è bene, applicando i quattro gradi della conoscenza: sensazione, credenza, ragione e intelletto, fino ad arrivare all idea assoluta. Nell ultimo Platone, ritorna la visione intellettualistica della virtù come condizione dell anima che si rispecchia nella compagine dello Stato, concepita come la massima espressione terrestre del Bene e della Giustizia, la cui perfezione dipende dallo sviluppo armonico delle virtù principali - sapienza, per i governanti; coraggio, per i difensori; e temperanza per i produttori - che determina e assicura l equa distribuzione dei beni secondo giustizia. Nasce così la classificazione delle quattro famose virtù morali - sapienza, fortezza, temperanza e giustizia 1 - dette poi cardinali, perché costituiscono il cardine per tutte le altre virtù morali,. Aristotele come immanentizza il concetto platonico di idea nel singolo, così interiorizza anche quello di virtù, e lo considera come contegno umano basato su qualità e decisione 2, introducendo così la distinzione tra virtù etiche o pratiche e virtù dianoetiche o atteggiamenti teoretici 3. Viene affermata anche la dimensione ontologica della virtù con la dottrina della medietas 4. Le virtù naturali, pertanto, si distinguono in morali e dianoetiche, a seconda del modo come si acquisiscono: se attraverso i costumi e le consuetudini o lo studio e la ricerca; e si dicono naturali, perché hanno come origine fine ed esercizio lo sforzo e l impegno umano. Tra le virtù morali si ricordano le principali: prudenza, temperanza, fortezza e giustizia; tra quelle dianoetiche: intelletto, scienza, saggezza, sapienza. La conseguenza di questo processo di interiorizzazione comporta anche la trasfomazione del fine della virtù, dal Bene platonico alla Felicità (ευδαιµονια, eudaimonia), un qualcosa verso cui ogni essere per sua natura tende per raggiungere la sua perfezione, e come tale 1 Repubblica, 353; Etica nicomachea, II, 4s. 3 Etica nicomachea, 1130b-1131a. 4 Etica nicomachea, 1107a.
5 dev essere desiderabile per se stessa e non per altri fini. Così la virtù perfetta coincide con la felicità completa che si realizza nell esercizio delle capacità intellettive e nell agire pratico secondo una ragione disinteressata, fino alla contemplazione finale del νουσ νοετιχοσ, dell Intelletto Puro o Pensiero di Pensiero. Così l attenzione del concetto di virtù si sposta dall essere di Bene di Platone al divenire continuo di Aristotele, riconcquistando con più forza la dimensione intellettiva iniziale, come un sapere pratico autonomo. Fondamentale di questo sapere che orienta all'azione, per Aristotele, è la virtù della ρονεσισ, phronesis, prudenza, perché essa, facendosi habitus (o disposizione morale), consente non solo di discernere i fini da perseguire, ma anche di individuare i mezzi con cui realizzarli. A differenza di Platone che sosteneva l'immortalità personale dell'anima come vero soggetto della felicità morale, Aristotele invece, rinunciando alla concezione dell'anima immortale individualmente, intende la felicità racchiusa in questa vita e in questo mondo, senza alcun riferimento ad altro dopo la morte. Il suo percorso esistenziale inizia e finisce nella sfera della concreta esistenza, pur orientata idealmente verso l ευδαιμονια. Aristotele critica Platone anche per la sua idea di Bene universale, che sia cioè qualcosa di comune a tutti. Per Aristotele, invece, ogni forma di sapere e ogni scelta sono orientati a un loro specifico fine, la cui molteplicità fattuale produce una molteplicità altrettanto irriducibile di fini, e quindi, di beni. Non è possibile parlare di bene in senso universale o unitario se non per analogia. Tre sono i tipi di bene per Aristotele: il bene in sé, vale a dire l'eudaimonia; il bene per altro, ossia un effetto desiderato in funzione di un altro fine, per cui questo bene risulta essere un mezzo più che un vero e proprio fine; e il bene politico dei molti, dei cittadini della polis che vale più del singolo bene per cui la politica viene a coincidere con la ricerca del bene comune. Il concetto di virtù, infine, nella corrente dello Stoicismo riceve un grande influsso, perché viene messo in relazione con il principio dell uomo scintilla del Fuoco eterno o Logos. E come partecipazione di questo Logos, è considerato microcosmo, ossia una totalità in cui tutto l universo è riprodotto. Pertanto, la virtù consiste nel vivere in modo conforme e in armonia con la natura del mondo, secondo il princìpio di conservazione: gli animali tendono a preservare se stessi obbedendo agli impulsi della natura, gli uomini invece devono scegliere sempre quel che conviene alla natura di esseri razionali, secondo la ferrea legge del destino, senza farsi coinvolgere emotivamente. Se l uomo segue questa guida della natura, raggiunge
6 il massimo grado di perfezione, l απάθεια, l apatia, ossia il controllo da parte dell anima di tutte le passioni, anche del dolore e della morte, come eventi da accogliere serenamente senza alcun coinvolgimento emotivo. Nella visione morale dello Stoicismo, grande importanza assume la virtù della saggezza che permette di raggiungere la felicità. Punto centrale è il concetto di αταρασσια, atarassia o impertubarbilità d animo, cui si arriva con la perfetta padronanza di sé stessi, che si ottiene attraverso l obbedienza alla forza del destino che non agisce esteriormente su di lui, bensì dall'interno. L uomo vuole quel che deve, e deve quel che la sua stessa ragione gli impone. Lo Stoicismo, pertanto, non si presenta come un esercizio forzato di vita, perché tutto, nell esistenza del saggio, scorre pacificamente. E poiché il Bene consiste nel vivere secondo il Lògos, il male è solo ciò che in apparenza vi si oppone. Ne risultano così tre tipologie di azioni: quelle dettate dalla ragione, come il rispetto per i genitori, gli amici e la patria; quelle contrarie alla natura o al dovere, e quindi da evitare, in quanto irrazionali ed emotive; quelle indifferenti sia al bene che al male, come ad esempio sollevare una pagliuzza, o grattarsi la barba. Come nell etica stoica le azioni indifferenti - salute, ricchezza, potere, piacere, schiavitù, ignominia - non hanno alcuna importanza, così anche i beni intermedi non esistono. Gli stoici, infatti, ammettono soltanto la felicità o l'infelicità, che dipendono unicamente dall uomo. Onde la netta contrapposizione duale: o si è sapienti o si è stolti. Di conseguenza, nessuno è schiavo per natura, l'essere umano è assolutamente libero di approdare alla saggezza, mentre schiavo è soltanto colui che si fa dominare dalle passioni. Caratteristica del saggio è quella di abbandonare il punto di vista individuale per assumere quello universale, approdando così all unione mistica e ascetica con il cosmo. Di questo processo che conduce alla contemplazione finale del Logos, la virtù costituisce l ultimo gradino. In questo modo, è recuperata la concezione intellettuale precedente di Socrate e di Platone, secondo cui il Bene è uno solo, e scaturisce dall'unico vero sapere. Significato cristiano di virtù Il mondo giudaico, non avendo un termine corrispondente al greco areté, risente dell influsso ellenistico, con la differenza che significatodi virtù si colora di religioso, ossia
7 come sinonimo di giustizia di Dio o di gloria di Dio 5. Così per es., in Abacuc, il termine hod viene tradotto due volte con areté e sempre riferito a Dio 6 ; mentre in Zaccaria, lo stesso termine hod viene riferito a Giosia, designato come il messia sacerdote 7. Il ricordo poi dei Maccabei contribuisce al significato di virtù come fedeltà a Dio, ossia come campione di fede in vita e in morte 8. Anche attraverso la fase latino-cristiana, il termine virtù - (dal latino vir, uomo, forza, virilità, coraggio, valore) - conserva inalterato il significato greco, anche se si perfeziona con l introduzione del concetto della virtù soprannaturale o infusa, completamente estraneo al mondo antico. Pur utilizzando schemi e termini greci, il NT si distingue dal mondo classico per l anima che li pervade. Anima che si concretizza attorno ai concetti di amore 9 e di fede 10. E da notare anche che il NT non conosce la distinzione aristotelica tra virtù etiche e dianoetiche, in quanto pone l accento sul carattere globale, operativo e obbedienziale dell azione umana nei confronti della legge divina. Ma ciò che distingue profondamente i due mondi è il problema dell origine delle virtù: per il mondo classico è lo stesso uomo, per quello cristiano è lo Spirito. Di conseguenza, le virtù neotestamentarie non promanano né dall armonia dell anima (Platone), né dall essenza della natura umana (Aristotele), né dalla docilità alla forza del destino (Stoicismo), ma sono considerate come doni (charisma) dello Spirito divino. Perché questa profonda distinzione? Semplicemente perché la virtù greca è antropocentrica, nel senso che evidenzia l opera e il merito dell uomo: inizia dall uomo e termina nell uomo; mentre nel Vangelo, la virtù è cristica, cioè Cristo è origine modello e fine. E nel modello cristico, non c è spazio al vanto umano, perché tutto il bene che è nell uomo è dono di Dio e frutto del suo Spirito con la responsabile collaborazione dell uomo. L origine della virtù classica è umana, quella cristiana è divina. Differenza profondamente qualitativa, che contraddistingue la virtù semplicemente 5 Is 42, 8, 12; 43, 21; 63, 7. 6 Ab 3, 3. 7 Zc 6, Mac IV, 7, 22; 9, 8. 18; 10, 10; 11, 2; 17, Gal 5, 22; Ef 4, 32-35; Col 3, Ef 4, 2ss; 2 Pt 1, 5.
8 umana, fine a se stessa, e la virtù cristiana aperta anche alla trascendenza del divino, da cui promana nella sua cifra essenziale. Nasce così la categoria del credente in senso pieno, ossia di colui che crede in un Dio Creatore dell uomo e Remuneratore finale delle sue azioni. La virtù in Duns Scoto Quando Duns Scoto parla della virtù, utilizza sempre il linguaggio classico, specialmente quello di tipo aristotelico, distinguendolo dal significato cristiano o infuso, in base al contesto in cui viene utilizzato e alla specifica trattazione. Genericamente intende la virtù come una «disposizione del perfetto all ottimo» 11, ossia come l operazione di una potenza umana che si perfeziona al massimo 12 ; o una «disposizione elettiva della volontà» 13 ; o un «principio di 11 Ordinatio, I, d. 17, pars 1, q. 2, n. 14, (n. 63): «virtus est dispositio perfecti ad optimum, ex VII Physicorum [cap. 3]; non est autem dispositio passiva, quia - ut prius - non est ratio recipiendi; ergo est in ratione principii activi»; Reportata Parisiensia, III, d. 18, q. 3, n. 2, (n. 75): «virtus est dispositio perfecti ad optimum, id est, potentiae ad actum perfectum; omnis autem potentia quae est nata perfici aliqua perfectione, ex qua omnis operatio redditur melior, indiget illa perfectione». 12 Reportata Parisiensia, IV, d. 14, q. 2, n. 16, (n. 69): «potest dici, quod cum virtutes non sint nisi quoddam supplementum miseriae nostrae, quam modo patimur in statu isto, non fuissent in statu innocentiae virtutes, cum ibi nulla fuisset miseria, et ideo posset concedi quod in statu innocentiae non fuissent virtutes sicut nec modo in Angelis ponuntur»; Ordinatio, IV, d. 14, q. 2, n. 11, (n. 109): «quaecumque enim virtus inclinat ad complacendum in bono honesto, inclinat etiam ad detestandum, et ad displicendum de malo inhonesto opposito, utpote castitas de aliquo inordinato contra castitatem inclinat ad displicentiam, et humilitas de actu inordinato superbiae, et sic de caeteris»; Ordinatio, I, d. 17, pars 1, q. 2, n. 14, (n. 62): «virtus est quae habentem perficit et opus eius bonum reddit ; non reddit autem illud bonum in ratione principii passivi, quia non est ratio recipiendi; ergo in ratione principii activi». 13 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 5, (n. 24): «Virtus est habitus electivus in medietate existens quoad nos, determinata ratione, et ut utique sapiens determinabit»; Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 8): «Virtus est habitus electivus ; electio autem est appetitus consiliativus, aut consilium; appetitivus saltem est appetitivus cum ratione; igitur praesupponit rationem; igitur est voluntati»; Ordinatio, I, prol., pars 5, q. 2, n. 21, (n. 425): «ut patet per defìnitionem eius II Ethicorum [cap. 5],virtus est habitus electivus»; Collationes, col. 30, n. 5, (n. 23): «virtus est habitus electivus; ergo sicut possumus habere habitum intellectivum respectu eorum, quae sunt ad finem, ita et respectu finis, sicut patet de charitate, quae est virtus, et respectu finis»; Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 17, (n. 57): «virtus non est habitus electivus, nisi voluntatis, in cuius potestate est secundum imperium eius ipsas moderari»; Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 7): «Virtutis est habitus electivus ex definitione sua II Ethicorum electio autem est actus voluntatis vel rationis VI Ethicorum est enim appetitus consiliativus; hoc autem pertinet ad voluntatem, quae operatur, praesupposita cognitione rationis; habitus autem est illius potentiae, cuius est per se talis operatio; igitur habitus moralis est per se voluntatis»; Collationes, col. 1, n. 10, (n. 27): «facilitas non est de ratione formali virtutis. Tum quia est communis virtuti morali et scientiae: utraque enim facilitat potentiam amovendo
9 un atto lodevole» 14, fondato sulla «volontà» 15, ritenuta libera e responsabile di ogni «bene onesto» 16, o, in modo molto sintetico, di godere il godibile 17, perfezionato sempre dalla carità, che perfeziona ogni virtù 18. Come si vede, pur restando legato alla terminologia aristotelica, introduce di nuovo l elemento della volontà, considerata come la sede delle stesse virtù 19, ad eccezione della difficultatem respectu actus: tum, quia hoc non apparet in definitione virtutis quae est quod «fit habitum electivus determinatus recta ratione». 14 Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 9): «virtus est per se principium actus laudabilis, II Ethicorum nulli autem debetur laus, nisi voluntarie agenti; igitur eius est virtus, eius est per se libere agere; illud est voluntas»; Ordinatio, I, d. 17, pars 1, q. 2, n. 14, (n. 65): «virtus est tale principium actus, in quan tum bonus, quod sine ea non posset actus esse bonus»; Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 23, (n. 78): «virtus fundatur in voluntate, ut libera est, quia sic dicta deliberativa non condividitur contra se, ut libera, sicut nec speciale contra commune». 15 Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 23, (n. 78): «virtus fundatur in voluntate, ut libera est, quia sic dicta deliberativa non condividitur contra se, ut libera, sicut nec speciale contra commune»; Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 8): «virtus habet pro per se obiecto bonum honestum; illud autem est per se obiectum voluntatis»; Reportata Parisiensia, IV, d. 46, q. 4, n. 12, (n. 44): «Respondeo, si virtus est recta, quia est conformis practicae, multo magis quando est conformis principio practico, et secundum illud principium practicum potest voluntas inclinare solum ad opus; principia enim practica sunt non sequi necessario ex conclusionibus. Si autem secundum conclusiones practicas inclinatur voluntas, hoc est in quantum principium practicum et voluntas concurrunt, et de necessitate tales conclusiones sequuntur ex principiis, et non pono practica, nisi omnia deducta ex principiis speculabilibus». 16 Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 8): «virtus habet pro per se obiecto bonum honestum; illud autem est per se obiectum voluntatis»; Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 9): «virtutes sunt maxima bona, secundum Aristotelem I Rhetoricae, cap. 9. Similiter est bonum honestum et decretum contra bonum utile et delectabile, et ideo maxima bona secundum Aristotelem sunt secundum id in quo excedit homo brutum, quia tendit in honestum, ut distinguitur a brutis, sicut arguit Philosophus I Ethicorum, cap. 1, homo cum sit felix, felicitas est in eo quo distinguitur ab aliis». 17 Ordinatio, IV, d. 49, q. 5, n. 4, (n. 254): «[Augustinus] 83 Quaestionum quaestione 30 [dicit] quod virtus consistit in fruendo fruendis». 18 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 25, (n. 86): «Augustinus contra Iulianum IV cap. 2, videtur dicere quod non sunt verae et perfectae virtutes sine charitate»; Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 18, (n. 54): «virtus autem moralis non est suprema perfectio voluntatis, nec prudentia intellectus, sed charitas voluntatis, et fides intellectus, et charitas videtur excedere fidem; tamen ista responsio non videtur sufficeret quia respectu eiusdem obiecti nobilior potentia videtur habere nobiliorem actum, quando utraque agit secundum totam virtutem sui, quia ibi non est excessus ex parte obiecti, quia idem est; igitur ex parte potentiarum tantum, et eatenus nobilior excedit»; Ordinatio, III, d. 36, q. un., n., (n. 84): «Augustinus contra Iulianum IV cap. 2, videtur dicere quod virtutes non sunt verae sine charitate, quia non perducunt ad beatitudinem»; Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 25, (n. 88): «virtutes videntur esse quaedam dispositiones ad charitatem, sicut felicitas naturalis ad supernaturalem»; Ibidem, n. 25, (n. 89): «definitio virtutis moralis potest perfecte salvari in aliquo sine virtute theologica».
10 fede e della prudenza, e anche l elemento della carità, che nobilita ogni azione virtuosa. Ciò che lo contradistingue dal mondo greco è anche la distinzione tra virtù morali o naturali e virtù morali-cardinali o infuse, con l appropriazione e l approfondimento delle virtù teologiche o infuse, caratteristiche proprie del cristianesimo. Qui, è sufficiente dire che, per il Dottor Sottile, le virtù sono di una necessità contingente e relativa allo stato attuale dell uomo 20, che lo perfezionano in tutte le sue facoltà 21 sia nei rapporti con la divinità sia nei rapporti con gli uomini e le cose. La differenza di fondo tra le virtù naturali acquisite e le virtù infuse si possono raggruppare intorno a tre caratteristiche: origine, esercizio e fine. Per l origine, le virtù infuse provengono immediatamente da Dio e hanno Dio come oggetto principale; per l esercizio, le virtù infuse danno il potere o la possibilità di compiere atti meritori, con una certa tendenza a farli; per il fine, le virtù infuse tendono a Dio come massimo bene soprannaturale 22. Le virtù naturali hanno come origine l uomo stesso; come esercizio, la ripetizione degli atti che procura la facilità a compierli; per il fine, hanno il perfezionamento dell uomo stesso che desidera massimamente la felicità, comunque intesa, e pur sempre d ordine naturale. 19 Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 7): «Virtutis est habitus electivus ex definitione sua II Ethicorum electio autem est actus voluntatis vel rationis VI Ethicorum est enim appetitus consiliativus; hoc autem pertinet ad voluntatem, quae operatur, praesupposita cognitione rationis; habitus autem est illius potentiae, cuius est per se talis operatio; igitur habitus moralis est per se voluntatis». 20 Reportata Parisiensia, IV, d. 14, q. 2, n. 16, (n. 69): «potest dici, quod cum virtutes non sint nisi quoddam supplementum miseriae nostrae, quam modo patimur in statu isto, non fuissent in statu innocentiae virtutes, cum ibi nulla fuisset miseria, et ideo posset concedi quod in statu innocentiae non fuissent virtutes sicut nec modo in Angelis ponuntur». 21 Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 6, (n. 21): «Ad istam quaestionem potest dici sine assertione, quod non sunt necessarii in via, nisi illi habitus, qui sunt virtutes morales, intellectuales et theologicae. Quod ostenditur sic: nam ratione naturali concluditur necessitas habitus intellectualis intellectum circa speculabilia, et habitus perficientis intellectum circa operabilia; et ita habetur habitus intellectualis specutativus et practicus. Consimiliter ratione naturali concluditur necessitas habitus perficientis appetitum circa ea quae sunt appetibilia in ordine ad se, et ulterius circa appetibilia in ordine ad alterum; et ita habetur prima distinctio virtutis appetitivit ordinantis talem potentiam in actibus ad se, et ad alterum». 22 Ordinatio, IV, d. 45, q. 2, n. 6, (n. 49): «virtus infusa habebit aliam regulam propriam quam acquisita, et ex alietate regulae poterit poni alia virtus specie, quia virtus in ratione essentiali virtutis, dependet a regula cui conformatur; haec autem non poterit fingi differentia specifica speciei infusae, et prius acquisitae, quia non est haec differentia nisi tantummodo principii effectivi, vel modi efficiendi; talis autem non distinguit effectus specie».
11 Tra i due ordine di virtù, quello naturale e quello soprannaturale, c è una differenza sostanziale sia per quanto riguarda il principio sia il motivo formale; mentre è più facile notare tale differenza, meno evidente sembra quella tra l esercizio o la facilità con cui si praticano le virtù. Difatti, in tutti e due gli ordini di virtù, l esercizio o la ripetizione degli atti è fondamentale per acquisire la padronanza della virtù, pur conservando la differenza d origine: umana per la virtù naturale che dipende totalmente dalle facoltà umane di ripetere gli atti; soprannaturale per quella infusa che offre alla volontà la possibilità di compiere atti meritori per la vita eterna. Duns Scoto accetta la distinzione generale tra virtù morali e virtù teologiche, affermandone per le prime l origine umana, e per le seconde quella divina. Tra le virtù morali, distingue però le quattro virtù cardinali - prudenza temperanza giustizia e fortezza - che insieme alle tre virtù teologali - fede speranza e carità - costituiscono il così detto septenaria virtutum, che è infuso e perfeziona completamente la vita dell uomo e nella dimensione antropologica e in quella spirituale, operando così una profonda semplificazione nel cammino della vita spirituale o di perfezione 23. Il settenario delle virtù viene infuso con il sacramento del Battesimo. 23 Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 14, (n. 40): «Secundum hoc igitur in connumeratione omnium virtutum sunt tres theologicae, et quattuor cardinales. De theologicis habetur ab Apostolo, 1 Corinthiorum 13, de moralibus Sapientiae 8. Iste numerus septenarius simpliciter perficit viatorem, ita quod secundum gradus istarum in specie sua est ipse perfectus; secundum enim quod istae sunt intensiores et remissiores, secundum hoc est magis vel minus perfectus; et si sint intensissimae, quantum possunt esse in via, est homo simpliciter perfectus, quantum potest esse in via, non curando modo de ista perfectione, quae habetur per virtutes speculativas acquisitas, quae prius exclusae sunt»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 14, (n. 47): «Per istas quippe septem virtutes, intelligendo de eis, et de speciebus earum necessariis, de quibus postea dicetur, si sint in se perfectissimae, est homo simpliciter perfectissimus, et circa Deum in se, et circa omnia alia a Deo, ut intelligibilia ratione practica, et ut appetibilia vel sibi, vel alteri, et hoc in ordine ad se, in quem possunt virtutes acquisitae esse, vel in ordine ad finem ultimum in quem possunt virtutes acquisitae cum charitate»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 21, (n. 68): «Sic igitur patet quod in sustinendo septem virtutes sufficienter perficere hominem in via, in se, vel in suis speciebus, non erunt necessarii alii habitus, qui nec sint illi, nec species earum, nec enumerantur alii in donis, nec in beatitudinibus, nec in fructibus. Et licet numerus sit alius explicitus beatitudinum et donorum, hoc est, quia aliquae species illarum septem virtutum aliter exprimuntur hic quam ibi, et non quia sint alii habitus, qui non sunt illarum virtutum species. Si etiam tantum ponderaretur Scriptura, quae ponit alicubi octonarium, alicubi septenarium, oporteret eos distinguere, ut diversos habitus; quare igitur non ponuntur distincti habitus illi, de quibus facit mentionem Apostolus 1 Corinthiorum 12, ubi ponitur novenarius ab illis, quos enumerat Petrus [1, 1, 5]: «Ministrate in fide vestra virtutum», etc. Frequenter igitur Scriptura eadem realiter exprimens, exprimit sub aliis verbis, nunc omittens quaedam, nunc alibi explicans sic omissa»; Ordinatio, III, 34, un., n. 7, (n. 23): «illi habitus tantum ponendi sunt in viatore, quibus perficitur, circa omne obiectum, quantum perfici
12 Per Duns Scoto, perciò, le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali sono infuse. La sua preoccupazione è d ordine teologico: assicurare a tutti i battezzati gli stessi mezzi per compiere opere meritorie per la salvezza eterna. I consigli evangelici, le beatitudini e i doni dello Spirito sono materia di libera scelta e vi corrispondono opere di maggior perfezionamento, cioè non strettamente necessario per la salvezza. Il settenario delle virtù, invece, è comune a tutti i cristiani, che lo ricevono per infusione nel Battesimo come mezzo necessario e universale di salvezza. La struttura settenaria delle virtù è ordinato alla carità 24, secondo una visione sistematica e gerarchica: subordina le beatitudini e i doni alle virtù morali, le virtù morali alle virtù cardinali e le virtù cardinali alle virtù teologali, che hanno nella carità la loro ultima perfezione. potest in via; huiusmodi sunt septem virtutes in genere, non curando de scientiis specutativis acquisitis; igitur praeter scientias specutativas acquisitas nullus erit habitus in viatore ponendus, alius simpliciter a septem virtutibus. Probatio maioris, obiectum circa quod perfici potest viator, non potest esse nisi Deus vel creatura; sed circa Deum sufficienter perficitur tribus virtutibus theologicis, et hoc, perfectissime quantum perfici potest, si ilii tres habitus sint perfectissimi in suo genere; circa creaturam vero (non loquendo de speculativis), intellectus perfectissime perficitur per prudentiam, si prudentia sit perfectissima; ipsa enim est de omni agibili, et quantum ad omnem conditionem agibilis perfectissima notitia»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 7, (n. 27): «Habitus etiam appetitivi sunt virtutes appetitivae, quae virtutes sufficienter perficiunt viatorem ad appetendum, vel ad diligendum, sive in ordine ad se, sive ad aliud; igitur homo perfectus tribus virtutibus theologicis, et virtutibus intellectualibus speculativis et practicis, et virtutibus moralibus ordinantibus ad se et ad alterum, perficitur quantum potest competere viatori; igitur non videtur aliqua necessitas ponendi aliquos alios habitus ab istis, qui sunt virtutes theologicae, intellectuales et morales»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 21, (n. 64): «De fructibus dico quod quidam illorum sunt virtutes secundum illam regulam, secundum quam enumeratae sunt in illo septenario; quaedam autem sunt species: virtutum ibidem enumeratarum; quaedam, nec sic nec sic, sed delectationes consequentes actus, verbi gratia, charitas exprimitur ibi proprio nomine, et similiter fides, spes autem in hoc quod dicitur longanimitas. Unde legitur de Patriarchis, longanimes in spe, quasi in longum animose expectantes»; Reportata Parisiensia, III, d. 34, q. un., n. 12, (n. 36): «De fructibus dico, quod quaedam illorum sunt virtutes enumeratae in illo septenario in se vel in suis speciebus; quidam autem sunt delectationes consequentes actus». 24 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 26, (n. 90): «Potest dici quod nulla virtus inclinat ad finem ultimum, nisi mediante illa, cuius est per se respicere finem ultimum; et ita si sola charitas respicit finem ultimum immediate, aliae non erunt ad finem ultimum nisi mediante charitas»; Ibidem, n. 26, (n. 91: «Pro tanto igitur [virtutes] dicuntur esse informes sine charitas, et formatae per charitatem, pro quanto charitas ordinat ipsas, et earum fines in finem ultimum; in qua ordinatione est ultima earum perfectio... virtutes non sunt verae sine charitate, quia non perducunt ad beatitudinem».
13 Tra le caratteristiche delle virtù sembra utile accennare anche al problema della loro connessione 25. Genericamente, Duns Scoto ritiene che l anima di ogni singola virtù è la carità 26 ; per cui quanto più grande è la carità tanta più crescono le singole virtù e si rafforzano alla radice. Il possesso di una virtù autentica è segno sicuro del possesso di altre virtù: chi possiede la carità possiede tutte le altre virtù, secondo l inno alla carità di Paolo 27. Bisogna precisare, però, che comunemente si ritiene che tutte le virtù sono connesse tra di loro sia le morali sia le teologali, nel senso che chi posside una ne possiede tutte. Duns Scoto, invece, afferma che non necessariamente le virtù morali né quelle teologali sono connesse tra loro né secondo il genere né secondo il numero. Le virtù morali non sono connesse necessariamente tra loro, perché il possesso dell una non perfeziona essenzialmente l altra, benché l una sia di aiuto o di giovamento all altra 28 ; neppure le virtù teologali sono necessariamente connesse tar loro, perché nell altra vita resta solo la carità, mentre fede e speranza cessano di essere, così è possibile nella vita terrena possedere fede e speranza senza della carità. Quali virtù sono infuse? Nel comune sentire, sono infuse sia le virtù teologali che quelle morali; per Duns Scoto invece sono infuse solo le virtù teologali, e quattro virtù cardinali. Per quanto riguarda il numero delle virtù morali, si ritiene che siano molteplici, cioè tutte le virtù morali in genere; mentre per Duns Scoto, il numero delle virtù morali importanti sono solo quattro, quelle cardinali, tutte le altre si riducono a una di esse. Onde il cosiddetto settenario delle virtù indispensabile per la perfezione umana: tre virtù teologali e quattro virtù cardinali. Con il settenario delle virtù Duns Scoto esemplifica al massimo la via spirituale della perfezione dell uomo in se stesso e in rapporto a Dio e al mondo: le virtù cardinali lo perfezionano in se 25 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 2, (n. 9): «Hic sunt quattuor articuli: primus de connexione virtutum moralium in se secundum genera et species illorum generum; secundus de connexione cuiuslibet virtutis moralis cum prudentia; tertius de connexione virtutum moralium cum theologicis; quartus de connexione theologicarum inter se». 26 Ordinatio, III, 36, q. un., n. 25, (n. 86): «Augustinus contra Iulianum IV cap. 2, videre dicere quod non sunt verae virtutes sine charitate, quia non perducunt ad beatitudinem» Cor 13, Ordinatio, III, d. 36, q. un., n 7, (n. 32): «concedo quod virtutes morales, nec secundum genera sua, quae communiter assignantur, Iustitia, Fortitudo et Temperantia, nec secundum illa generaliora, quae prius assignavi, quae sunt virtutes disponentes affectum ad seipsum vel ad alium, sunt necessario connexae».
14 stesso e in rapporto alle cose; le virtù teologali, invece, lo perfezionano in rapporto a Dio, fine ultimo della sua vita. Per la perfezione dell uomo, dunque, è sufficiente il settenario delle virtù, tutte le altre virtù, compreso le beatitudini e i doni, sono tutte riducibili a una delle virtù cardinali 29. Perché Duns Scoto applica a se stesso il principio non sunt multiplicanda entia sine necessitate, riducendo tutta l impalcatura dell edificio spirituale al semplice settenario? A questa legittima domanda si può rispondere con le stesse sue parole: il settenario delle virtù vissuto nella sua autenticità perfeziona l uomo sia nei rapporti con la Trascendenza e sia nei rapporti con la contingenza 30. Prima di accennare ai due gruppi di virtù che costituiscono il settenario, sembra utile ribadire il pensiero di Duns Scoto circa il problema molto discusso della connessione delle virtù, secondo l adagio simul stant vel simul cadunt. Secondo la dottrina comune esiste tra le virtù morali una necessaria connessione, nel senso che dove c è una virtù, là ci sono pure le altre, o in forma negativa non ci può essere una virtù morale senza le altre. E di conseguenza tra le virtù morali vige una perfetta solidarietà. Pensiero espresso anche da Francesco d Assisi nella Salutatio virtutum. Duns Scoto, invece, pur accettando una certa solidarietà tra le virtù morali e quelle cardinali, avanza delle osservazioni critiche, per meglio salvaguardare la libertà della volontà nell atto morale. Difatti, ritiene che le virtù morali e cardinali sono necessariamente richieste all uomo per raggiungere il perfetto fine della virtù stessa, ma non sono necessariamente connesse tra di loro se considerate in se stesse, perché ciascuna virtù ha la propria perfezione e può condurre al proprio fine. Di conseguenza, l uomo può possedere una virtù morale senza possederne le altre Reportata Parisiensia, III, d. 34, q. un., n. 13, (n. 40): «Ideo ad quaestionem patet quod virtutes, beatitudines et dona omnino non sunt habitus distincti raliter»; Ibidem, n. 11, (n. 34): «In donis numerantur quattuor virtutes cardinales: prudentia... fortitudo... temperatia... iustitia... Duae infusae exprimitur: caritas... fides...». 30 Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 21, (n. 68): «Sic igitur patet quod in sustinendo septem virtutes sufficienter perficere hominem in via, in se vel suis speciebus, non erunt necessarii alii habitus, qui non sint illi, nec species earum, nec enumerantur alii in donis nec in beatitudinibus nec in fructibus» 31 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 7, (n. 32): «Virtutes morales [non] sunt necessario connexae»; Ibidem, n. 7, (n. 33): «Una virtus est aliqua perfectio hominis, sed non totalis; sufficeret enim tunc una virtus moralis; igitur partialis. Quando autem sunt plures perfectiones partiales, idem perfectibile potest esse simpliciter perfectum secundum unam perfectionem in summo, et simpliciter imperfectum secundum aliam... Potest aliquis habere perfectionem respectu
15 Anche in rapporto alla sede delle virtù, Duns Scoto ha una posizione sua propria. Altri affermano che le virtù morali, ad eccezione della giustizia, hanno come sede specifica l appetito sensitivo; egli invece ritiene come sede delle virtù morali la stessa volontà, ad eccezione della prudenza che risiede nell intelletto, e questo per salvaguardare sempre la libertà della volontà nell atto morale. Difatti, perché l atto umano sia lodevole dev essere responsabile e libero. E questo lo garantisce solo la volontà 32. Onde evitare possibili equivoci circa lo stesso atto della volontà, il Dottor Sottile afferma: «ogni atto della volontà è naturalmente preceduto da un atto dell intelletto» 33. Lo stesso concetto di praxis, che è atto principalmente della volontà, si realizza sempre in conformità alla retta intellezione 34. In forza dell origine delle virtù, Duns Scoto, in perfetta coerenza con la sua dottrina cristocentrica, afferma che come Cristo sana perfettamente il corpo 35, quando lo sana, così sana perfettamente l anima nelle sue qualità specifiche: nell intelletto mediante la fede; e nella volontà mediante la speranza e la carità 36. Le virtù morali-cardinali, invece, perfezionano l uomo nelle sue dimensioni antropologiche, avendo come modello sempre e unicamente lo stesso Cristo, di cui ne è l immagine. Così al centro e al vertice del settenario delle virtù che perfezionano l uomo, Duns Scoto pone il Cristo: Cristo come Dio trasmette le materiae temperantiae, nihil habendo de perfectione, quae requireretur respectu materiae alterius virtutis, et per consequens potest esse simpliciter temperatus, etiam quantum ad quemcumque habitum temperantiae, etsi non sit fortis; non tamen erit simpliciter moralis sine omnibus virtutibus moralibus»; Ibidem, n. 10: «Concedo enim quod sicut sorores, etsi iuvent se mutuo ad convivendum, una tamen non est altera, nec essentialiter perficit alteram; ita istae virtutes bene iuvant se ad salvandum se mutuo, et in hoc potest intelligi dictum quorundam, quod una non est tota sine alia, quia non ita bene salvantur sine alia»; Ibidem, n. 9: «Conceditur igitur quod una [virtus] non producit sufficienter simpliciter, sed quantum sufficit ad perfectionem talis virtutis». 32 Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 9): «Praeterea, virtus est per laudabilis, II Ethicorum nulli autem debetur laus, nisi voluntarie agenti; igitur eius est virtus, eius est per se libere agere; illud est voluntas». 33 Reportata Parisiensia I, d. 17, q. 3, n. 3, (n. 55): «omnem actum voluntatis naturaliter praecedit actus intellectus». 34 Cf Ordinatio, I, prol., pars 5, q. 2,, n. 3, n «Dico igitur primo [cf supra n. 341] quod praxis ad quam cognitio practica extenditur est actus alterius potentiae quam intellectus, naturaliter posterior intellectione, natus elici conformiter intellectioni rectae ad hoc ut sit rectus.» 35 Mt 9, 1-6; l esempio della guarigione del paralitico, è citato dallo stesso Duns Scoto nella nota successiva. 36 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 14, (n. 50): «Unde sicut quando [Christus, Mt 9, 1-6] sanat aliquem secundum corpus, perfecte sanat pro statu in quo est; ita etiam secundum animam, et quia in anima est aimado Dei secundum tres potentias, quae deformatae sunt per peccatum, ideo Christus reformando, sicut perficit voluntatem per charitatem [et spem], sic intellectum per fidem».
16 virtù teologali; come Uomo, le virtù cardinali. E questo per realizzare il principio da lui espresso: «l immagine esige l imitazione di ciò di cui è immagine, e di esprimerlo» 37, e di conseguenza, l immagine imperfetta dell uomo tende verso l immagine perfetta del Cristo. E segnato così il percorso di perfezione dell uomo. Conclusione Da questo veloce bagno etimologico nel termine virtù, si ricava che nella categoria di uomo possono insistere due dimensioni esistenziali principali, quella del non-credente e quella del credente. Avulso da ogni determinazione sociale o religiosa, l uomo vive allo stato brado o secondo madre natura; come cittadino, invece, contempera le naturali inclinazioni con le leggi socio-politiche dello stato in cui vive; come cristiano, infine, sublima le due precedenti situazioni con l influsso della grazia, che riceve in dono da Dio, in cui crede essere Creatore della vita e Remuneratore delle azioni umane in una vita nell al di là, come il Cristo ha rivelato. Escludendo la possibilità dell uomo naturale o primitivo, in società coesistono almeno due categorie di uomini: il non-credente o cittadino e il credente o cittadino- cristiano. Il primo è tenuto ad osservare le leggi del proprio paese; il secondo, invece, oltre alle leggi dello stato è tenuto a rispettare anche quelle di Dio. E qui nascono le difficoltà: come conciliare il duplice impegno? A ciò viene incontro lo Spirito, donando delle virtù particolari, o delle forze, con cui vivere coerentemente anche la dimensione sociale e politica dell esistenza umana. Ora, è stato importante aver accennato al concetto di virtù, come strumento speciale della vita morale, e come espressione di una fede donata direttamente da Dio per mezzo di Cristo Gesù, specialmente nei Sacramenti. Per es., nel Battesimo, viene donato al battezzato oltre alla grazia, anche il settenario delle virtù, cioè le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali, che Duns Scoto afferma essere infuse, perché il cristiano possa da un lato regolare con maggior sicurezza i raporti con Dio, e dall altro gestire correttamente i rapporti con i propri simili e con le cose. Così da realizzare nella vita il paolino vivere in Cristo, ossia permettere a Cristo di vivere in noi. illud». 37 Ordinatio, I, d. 3, pars 3, q. 4, n. 2, (n. 772): «imago nata est imitari ipsum cuius est imago, et exprimere
17 Il mistero della fede! La sfida del cristiano!
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C.
 ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
Ringraziamenti... pag. 3. Abbreviazioni...» 5. Introduzione...» 7. Capitolo primo
 Xxxx Indice Ringraziamenti... pag. 3 Abbreviazioni...» 5 Introduzione...» 7 Capitolo primo Etica delle virtù e giustizia...» 11 A) Premessa al concetto di giustizia come virtù...» 11 1.1. La giustizia
Xxxx Indice Ringraziamenti... pag. 3 Abbreviazioni...» 5 Introduzione...» 7 Capitolo primo Etica delle virtù e giustizia...» 11 A) Premessa al concetto di giustizia come virtù...» 11 1.1. La giustizia
Che cos è la libertà?
 Che cos è la libertà? Forme di libertà Essere causa delle proprie scelte, indipendenti da condizionamenti esterni ( autodeterminazione) Capacità di affermare la propria autonomia, senza invadere o interferire
Che cos è la libertà? Forme di libertà Essere causa delle proprie scelte, indipendenti da condizionamenti esterni ( autodeterminazione) Capacità di affermare la propria autonomia, senza invadere o interferire
Giannino Piana introduzione all ETiCa CRiSTiana 367 QUERiniana
 Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
IL SETTENARIO DELLE VIRTU DI DUNS SCOTO (II puntata)
 IL SETTENARIO DELLE VIRTU DI DUNS SCOTO (II puntata) LE VIRTÙ TEOLOGICHE La spiritualità e la devozione di Duns Scoto sono contrassegnate dalla prospettiva della dottrina cristocentrica, in cui le due
IL SETTENARIO DELLE VIRTU DI DUNS SCOTO (II puntata) LE VIRTÙ TEOLOGICHE La spiritualità e la devozione di Duns Scoto sono contrassegnate dalla prospettiva della dottrina cristocentrica, in cui le due
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica
 RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
ETICA GENERALE ETICA
 ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
ETICA GENERALE Master di Bioetica 2016/17 ETICA La prassi umana: l uomo che agisce è il primo soggetto etico. La libertà come premessa al discorso morale: non si offre agire etico senza la libertà. Atti
CONSIGLIO. consigliare ed ascoltare col cuore
 CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
CONSIGLIO consigliare ed ascoltare col cuore IL DONO DEL CONSIGLIO Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita, che ci fa fare le scelte giuste per
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si
 I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
I sette doni dello Spirito Santo La nostra vita può essere paragonata ad una barca priva di motore e spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele gonfiate dal vento, tutto diventa
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia
 Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell
Critica del Giudizio
 Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
Critica del Giudizio Dalle due Critiche ( Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica) emerge l opposizione tra il mondo naturale, dominato dalla necessità ed estraneo alla morale e allo spirito,
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico
 Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 TERZO INCONTRO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME SAPERE TEORICO PRATICO L epistemologia della DSC Dimensione
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 TERZO INCONTRO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME SAPERE TEORICO PRATICO L epistemologia della DSC Dimensione
POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D. Disciplina: FILOSOFIA
 POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D Disciplina: FILOSOFIA Che cos è la filosofia L amore per il sapere Il cammino della filosofia: l influsso dell
POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D Disciplina: FILOSOFIA Che cos è la filosofia L amore per il sapere Il cammino della filosofia: l influsso dell
RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile
 RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
Epicureismo e stoicismo
 Epicureismo e stoicismo per una ricapitolazione a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Tutto il pensiero greco si sviluppa intorno al problema del divenire Divenire = l uscire e il rientrare nel nulla
Epicureismo e stoicismo per una ricapitolazione a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Tutto il pensiero greco si sviluppa intorno al problema del divenire Divenire = l uscire e il rientrare nel nulla
Socrate. Atene a.c.
 Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
Socrate Atene 470-399 a.c. La sofistica Movimento filosofico, e più ampiamente etico e culturale, affermatosi nella Grecia antica, e soprattutto in Atene, tra il 5 e il 4 sec. a.c. L insegnamento sofistico
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Libertà individuale e valori sociali 1. Platone. Istruzione e formazione secondo la paideia classica. Lezioni d'autore
 Libertà individuale e valori sociali 1. Platone. Istruzione e formazione secondo la paideia classica Lezioni d'autore Dibattito sul tema dell educazione (Atene, V-IV sec. a.c. Quale valore ha la formazione
Libertà individuale e valori sociali 1. Platone. Istruzione e formazione secondo la paideia classica Lezioni d'autore Dibattito sul tema dell educazione (Atene, V-IV sec. a.c. Quale valore ha la formazione
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO Classe 3D. LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele
 LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe 3D LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele PROGRAMA FILOSOFIA LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSIA
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN ANNO SCOLASTICO 2016-2017 Classe 3D LIBRO DI TESTO: Abbagnano- Fornero CON-FILOSOFARE Dalle origine ad Aristotele PROGRAMA FILOSOFIA LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSIA
G.W.F. Hegel. Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia
 G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
G.W.F. Hegel Filosofia dello Spirito. Spirito Assoluto: Arte. Religione. Filosofia Spirito Assoluto Spirito Assoluto Negli stati e nella storia lo Spirito trova un incarnazione che resta sempre determinata
LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN PALERMO PROGRAMMA DI FILOSOFIA. cl. III H. anno scolastico 2011/2012
 LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN PALERMO PROGRAMMA DI FILOSOFIA cl. III H anno scolastico 2011/2012 Testo di riferimento: N. Abbagnano, G. Fornero La Filosofia - Paravia UNITA 1: IL PENSIERO PRESOCRATICO
LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN PALERMO PROGRAMMA DI FILOSOFIA cl. III H anno scolastico 2011/2012 Testo di riferimento: N. Abbagnano, G. Fornero La Filosofia - Paravia UNITA 1: IL PENSIERO PRESOCRATICO
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A
 HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,
Plotino. Ne risulta una sintesi che influenzerà il pensiero cristiano e moderno.
 Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato. Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a
 Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a filosofi e teologi: sviluppare una nuova visione di
Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a filosofi e teologi: sviluppare una nuova visione di
Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana.
 SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.
 Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia
 LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
Sintesi sul neoplatonismo
 Sintesi sul neoplatonismo Tra il II e III secolo d. C in ambiente ellenistico si sviluppa una tendenza a tornare al pensiero pre-cristiano (in particolare platonismo e aristotelismo), prescindendo dalle
Sintesi sul neoplatonismo Tra il II e III secolo d. C in ambiente ellenistico si sviluppa una tendenza a tornare al pensiero pre-cristiano (in particolare platonismo e aristotelismo), prescindendo dalle
BENEDETTO SPINOZA a cura di Pietro Gavagnin con il contributo degli alunni di 4AOL as
 BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
BENEDETTO SPINOZA 1632-1677 a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net con il contributo degli alunni di 4AOL as 2014-2015 OPERE: TRATTATO TEOLOGICO - POLITICO (1670) Scopo fondamentale del trattato è la
SAN PAOLO. lettera ai Romani
 SAN PAOLO La lettera ai Romani Il peccato dell umanità 1,18-3,20 La giustizia di Dio 3,21-4,25 Dalla giustificazione alla salvezza 5,1-8,39 Qual è la situazione dell uomo giustificato? Quale la sua condotta?
SAN PAOLO La lettera ai Romani Il peccato dell umanità 1,18-3,20 La giustizia di Dio 3,21-4,25 Dalla giustificazione alla salvezza 5,1-8,39 Qual è la situazione dell uomo giustificato? Quale la sua condotta?
importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.
 CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per
Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio Testo: Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei)
 Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA Motivazioni dell IRC nella scuola Differenza fra IRC e catechesi
Programmazione IRC 1B MAT 2017/18 Docente: Cherchi Antonio : Tutte le voci del mondo (Luigi Solinas-Sei) 1. INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA Motivazioni dell IRC nella scuola Differenza fra IRC e catechesi
7 Introduzione 23 1 a Lezione 23 L esordio della riflessione filosofica: da Esiodo ai Milesi Nota introduttiva Le riflessioni sul cosmo e
 Indice 7 Introduzione 23 1 a Lezione 23 L esordio della riflessione filosofica: da Esiodo ai Milesi 23 1. Nota introduttiva 24 2. Le riflessioni sul cosmo e sugli dèi di un pastore della Beozia 32 3. La
Indice 7 Introduzione 23 1 a Lezione 23 L esordio della riflessione filosofica: da Esiodo ai Milesi 23 1. Nota introduttiva 24 2. Le riflessioni sul cosmo e sugli dèi di un pastore della Beozia 32 3. La
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE a.s.2014/2015 RELIGIONE CATTOLICA NEL PROFESSIONALE GRAFICO AMMINISTRATIVO PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI A CURA DEL RESPONSABILE
Attualità del pensiero politico di Dante?
 Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO
 L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
L'ETÀ ELLENISTICA ED IL NEOPLATONISMO Argomenti L'età ellenistica Lo Stoicismo Epicuro e l'epicureismo Lo scetticismo Plotino ed il neoplatonismo L'ETÀ ELLENISTICA Influssi della cultura orientale sul
Plotino di Licopoli. Fasi della filosofia antica
 Plotino di Licopoli Fasi della filosofia antica Periodo naturalistico (VI sec. a.c.) Periodo umanistico (V sec. a.c.) Periodo metafisico (IV sec. a.c.) Periodo ellenistico (IV-I sec. a.c.) Periodo religioso
Plotino di Licopoli Fasi della filosofia antica Periodo naturalistico (VI sec. a.c.) Periodo umanistico (V sec. a.c.) Periodo metafisico (IV sec. a.c.) Periodo ellenistico (IV-I sec. a.c.) Periodo religioso
La Stoa antica (III sec. a.c.)
 La Stoa antica (III sec. a.c.) Cleante di Asso (304/03-223/22 a.c.) Crisippo di Soli (281/78-208/05 a.c.) Zenone di Cizio (336/35-264/63 a.c.) Lo stoicismo Conducimi, o Zeus, e tu o fato là dove da voi
La Stoa antica (III sec. a.c.) Cleante di Asso (304/03-223/22 a.c.) Crisippo di Soli (281/78-208/05 a.c.) Zenone di Cizio (336/35-264/63 a.c.) Lo stoicismo Conducimi, o Zeus, e tu o fato là dove da voi
LA DOTTRINA DELL EROS IN PLATONE OVVERO, IL SIMPOSIO MA NON SOLO
 LA DOTTRINA DELL EROS IN PLATONE OVVERO, IL SIMPOSIO MA NON SOLO LA FILOSOFIA, OVVERO PLATONE Secondo Alfredo North Whitehead, l intera storia della filosofia occidentale non sarebbe che un lungo commento
LA DOTTRINA DELL EROS IN PLATONE OVVERO, IL SIMPOSIO MA NON SOLO LA FILOSOFIA, OVVERO PLATONE Secondo Alfredo North Whitehead, l intera storia della filosofia occidentale non sarebbe che un lungo commento
68 h 40 min km. Da Kant a Hegel
 Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Linee di fondo dell antropologia di Lutero. alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521
 Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Pastorale delle famiglie
 Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Pastorale delle famiglie Animatori Filippo e Graziella Anfuso Parrocchia Santa Maria della Guardia Ordine Frati Minori - Catania www.parrocchiadellaguardia.it La ragionevolezza della fede in Dio Benedetto
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
Il cammino del discernimento nella Comunità Capi
 Il cammino del discernimento nella Comunità Capi l Assistente Ecclesiastico che accompagna P. ROBERTO DEL RICCIO SJ 6 FEBBRAIO 2018 Accompagnare Il compito del presbitero «[ ] spetta ai sacerdoti, [ ]
Il cammino del discernimento nella Comunità Capi l Assistente Ecclesiastico che accompagna P. ROBERTO DEL RICCIO SJ 6 FEBBRAIO 2018 Accompagnare Il compito del presbitero «[ ] spetta ai sacerdoti, [ ]
After Virtue. Seconda parte Capp
 After Virtue Seconda parte Capp. 10-18 Necessità di una storia delle virtù (158) Cap. 9 Etica classica : centralità delle storie La comprensione della società eroica è necessaria per la comprensione della
After Virtue Seconda parte Capp. 10-18 Necessità di una storia delle virtù (158) Cap. 9 Etica classica : centralità delle storie La comprensione della società eroica è necessaria per la comprensione della
CROCE DI CRISTO E CROCE DELL'UOMO. 10 aprile 2016
 CROCE DI CRISTO E CROCE DELL'UOMO 10 aprile 2016 lo Spirito Consolatore nella vita dell uomo Portare la riflessione della Chiesa sui temi fondamentali e fondanti la fede cristiana comporta innanzitutto
CROCE DI CRISTO E CROCE DELL'UOMO 10 aprile 2016 lo Spirito Consolatore nella vita dell uomo Portare la riflessione della Chiesa sui temi fondamentali e fondanti la fede cristiana comporta innanzitutto
THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo
 THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo (Westport, 1588 Londra, 1679) La filosofia di Hobbes è volta a costituire una comunità ordinata e pacifica, sulla base di uno Stato assoluto. Il SAPERE consiste
THOMAS HOBBES: il fondatore dell assolutismo (Westport, 1588 Londra, 1679) La filosofia di Hobbes è volta a costituire una comunità ordinata e pacifica, sulla base di uno Stato assoluto. Il SAPERE consiste
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA PRIMARIA. FILONE n 12: COMPETENZA RELIGIOSA
 Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA PRIMARIA INDICATORE: DIO E L UOMO Sviluppa il concetto d identità personale e sa interagire con i compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo.
Programmazione didattico-educativa d Istituto SCUOLA PRIMARIA INDICATORE: DIO E L UOMO Sviluppa il concetto d identità personale e sa interagire con i compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo.
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico
 Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NELLA VITA DELLA CHIESA Per la Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale
Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all impegno sociale e politico 1 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NELLA VITA DELLA CHIESA Per la Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^
 R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI DI GROSSETO CLASSE III D PROGRAMMA A.S MATERIA: FILOSOFIA
 LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI DI GROSSETO CLASSE III D PROGRAMMA A.S. 2018-2019 MATERIA: FILOSOFIA N.B: dove non altrimenti specificato, le pagine dei testi fanno riferimento al libro in adozione MODULO
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI DI GROSSETO CLASSE III D PROGRAMMA A.S. 2018-2019 MATERIA: FILOSOFIA N.B: dove non altrimenti specificato, le pagine dei testi fanno riferimento al libro in adozione MODULO
I PRONOMI (PERSONALI,
 I PRONOMI (PERSONALI, RIFLESSIVI, DETERMINATIVI, DIMOSTRATIVI) I PRONOMI PERSONALI PRIMA PERSONA SECONDA PERSONA Singolare Plurale Singolare Plurale Nom. EGO NOS TU VOS Gen. MEI NOSTRI, NOSTRUM TUI VESTRI,
I PRONOMI (PERSONALI, RIFLESSIVI, DETERMINATIVI, DIMOSTRATIVI) I PRONOMI PERSONALI PRIMA PERSONA SECONDA PERSONA Singolare Plurale Singolare Plurale Nom. EGO NOS TU VOS Gen. MEI NOSTRI, NOSTRUM TUI VESTRI,
Programmazione di Circolo RELIGIONE CATTOLICA. Anno Scolastico
 Programmazione di Circolo Anno Scolastico 2014 2015 PREMESSA La Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della società italiana, pertanto offre una prima conoscenza
Programmazione di Circolo Anno Scolastico 2014 2015 PREMESSA La Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della società italiana, pertanto offre una prima conoscenza
Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo
 ARISTOTELE Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo Organon (analitica) - Categorie Termini Soggetto predicati Le Categorie sostanza quantità qualità relazione luogo tempo giacere
ARISTOTELE Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo Organon (analitica) - Categorie Termini Soggetto predicati Le Categorie sostanza quantità qualità relazione luogo tempo giacere
L indagine sulla natura: il pensiero presocratico
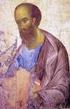 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE TERZA SEZ. D DOCENTE: ADELE FRARACCI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 L indagine sulla natura: il pensiero presocratico La Grecia e la nascita della filosofia Le condizioni storico-politiche
Percorso su LIM da Kant all idealismo
 Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
IMMANUEL KANT Critica del giudizio (1790)
 IL SENTIMENTO Nella Critica del Giudizio, Kant studia quello che chiama sentimento, così come nelle altre due critiche aveva analizzato la conoscenza e la morale. Anche il sentimento di cui egli parla
IL SENTIMENTO Nella Critica del Giudizio, Kant studia quello che chiama sentimento, così come nelle altre due critiche aveva analizzato la conoscenza e la morale. Anche il sentimento di cui egli parla
INDICE GENERALE. Introduzione parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ
 INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
INDICE GENERALE Introduzione...005 parte prima L ANTROPOLOGIA TRA LA MODERNITÀ E LA POSTMODERNITÀ I. La fede cristiana nella stagione della postmodernità...015 1.1. Il mondo culturale contemporaneo...015
LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I
 ANTONIO ROSMINI LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I Sulla vita perfetta in generale STRESA 2008 Trasposizione in lingua aggiornata di SUOR MARIA MICHELA RIVA Centro Internazionale di Studi Rosminiani STRESA (VB)
ANTONIO ROSMINI LEZIONI SPIRITUALI LEZIONE I Sulla vita perfetta in generale STRESA 2008 Trasposizione in lingua aggiornata di SUOR MARIA MICHELA RIVA Centro Internazionale di Studi Rosminiani STRESA (VB)
PAOLO, IL MIO FILOSOFO. Giovanni Lauriola
 PAOLO, IL MIO FILOSOFO Giovanni Lauriola L espressione Paolo è il mio Filosofo - ( Philosophus noster, Paulus est ) 1 - appartiene a Giovanni Duns Scoto, pensatore francescano del medio evo (1265-1308),
PAOLO, IL MIO FILOSOFO Giovanni Lauriola L espressione Paolo è il mio Filosofo - ( Philosophus noster, Paulus est ) 1 - appartiene a Giovanni Duns Scoto, pensatore francescano del medio evo (1265-1308),
LO STUDIO DELLA SESSUALITÀ IN ARISTOTELE
 LO STUDIO DELLA SESSUALITÀ IN ARISTOTELE UN CONTESTO MUTATO Fine della indipendenza delle poleis greche (338 a.c., battaglia di Cheronea) Trasformazione dei rapporti individuo polis Trasformazione delle
LO STUDIO DELLA SESSUALITÀ IN ARISTOTELE UN CONTESTO MUTATO Fine della indipendenza delle poleis greche (338 a.c., battaglia di Cheronea) Trasformazione dei rapporti individuo polis Trasformazione delle
INDICE GENERALE. Indice generale PARTE PRIMA I FONDAMENTI ANTROPOLOGICI E TEOLOGICI
 Indice generale INDICE GENERALE PREFAZIONE pag. PARTE PRIMA I FONDAMENTI ANTROPOLOGICI E TEOLOGICI PREMESSA» 11 La novità antropologica» 11 II disegno salvifico di Dio» 13 II tema della molteplicità e
Indice generale INDICE GENERALE PREFAZIONE pag. PARTE PRIMA I FONDAMENTI ANTROPOLOGICI E TEOLOGICI PREMESSA» 11 La novità antropologica» 11 II disegno salvifico di Dio» 13 II tema della molteplicità e
- Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano)
 GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
GESU' E' SACERDOTE - Messia (in ebraico) Cristo (in greco) Unto con olio = Consacrato = Sacerdote (in italiano) - Chi è il Sacerdote? (Lettera agli Ebrei 5, 1 ss) "Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele
 Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
Arianna Fermani VITA FELICE UMANA In dialogo con Platone e Aristotele eum x filosofia eum x 2006 eum edizioni università di macerata vicolo Tornabuoni, 58-62100 Macerata info.ceum@unimc.it http://ceum.unimc.it
CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSI TRIENNIO. Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità. Fare non è creare.
 CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSI TRIENNIO Traguardi di competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità Riflette su Dio Creatore e Padre Riconoscere che per la religione cristiana Dio è creatore e
CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSI TRIENNIO Traguardi di competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità Riflette su Dio Creatore e Padre Riconoscere che per la religione cristiana Dio è creatore e
DISCIPLINA: Religione Cattolica
 CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
IMMANUEL KANT. (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE
 IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IMMANUEL KANT (1724 Germania-1804) INTRODUZIONE ILLUMINISMO ROMANTICISMO SAPERE AUDE (Ultimo periodo della sua vita) USCIRE DALLO STATO DI MINORITA Nella CRITICA DEL GIUDIZIO CONDIZIONE DELL UOMO CHE NON
IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO
 IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO COSCIENZA E SUA FORMAZIONE COSCIENZA SEDE DEL DISCERNIMENTO Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vita
IL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO COSCIENZA E SUA FORMAZIONE COSCIENZA SEDE DEL DISCERNIMENTO Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vita
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO : Classe: III B Linguistico
 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE G. MARCONI PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018: Classe: III B Linguistico Docente: Scordo Annunziata Maria COMPETENZE - Riflettere sulle
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G.VERONESE G. MARCONI PROGRAMMAZIONE FINALE DI FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018: Classe: III B Linguistico Docente: Scordo Annunziata Maria COMPETENZE - Riflettere sulle
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2017-2018 Classe 1 A 1. Questioni di morale sociale: matrimonio e famiglia. 2. La realtà antropologica dell uomo e della donna: differenza e diversità. 3. Il progetto di Dio
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno Classe 1 A
 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
PROGRAMMA SVOLTO DI IRC anno 2018-2019 Classe 1 A 1. Il senso religioso: le domande esistenziali dell uomo - partire da se stessi - L uomo composto di corpo e anima. Inscindibilità della natura umana.
CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana. La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17
 CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17 La luce della coscienza.indd 2 07/05/19 14:17 MIGUEL CUARTERO SAMPERI TOMMASO MORO La luce della coscienza Prefazione
CULTURA Studium 167. Biblioteca Moreana La luce della coscienza.indd 1 07/05/19 14:17 La luce della coscienza.indd 2 07/05/19 14:17 MIGUEL CUARTERO SAMPERI TOMMASO MORO La luce della coscienza Prefazione
PROGRAMMA CONSUNTIVO - FILOSOFIA Pag. 1/6
 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V Ambito Territoriale Foggia LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI SEDE ASSOCIATA DI
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V Ambito Territoriale Foggia LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI SEDE ASSOCIATA DI
RELIGIONE: TERZO BIENNIO. classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE
 RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
RELIGIONE: TERZO BIENNIO classe V scuola primaria e classe I scuola secondaria COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE Riconoscere che il rapporto con Dio è esperienza fondamentale nella vita di molte persone, individuare
ANTROPOLOGIA TEOLOGICA
 Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
Giovanni Ancona ANTROPOLOGIA TEOLOGICA Temi fondamentali QUERINIANA Indice generale Introduzione........................................... 5 1. La riflessione teologica intorno al l uomo (antropologia
scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell uomo sono state più incerte e l uomo è divenuto
 l uomo, la cui natura non è ascrivibile né ad una condizione di necessità assoluta né di libertà - - scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell
l uomo, la cui natura non è ascrivibile né ad una condizione di necessità assoluta né di libertà - - scienza dell essenza e della costruzione essenziale dell uomo nel suo tempo l essenza e l origine dell
SCUOLA DELL INFANZIA RELIGIONE
 1 PTOF 2015/2018 CURRICOLO VERTICALE AREA STORICO - GEOGRAFICA Religione - Si accosta alla conoscenza di Dio. SCUOLA DELL INFANZIA RELIGIONE DIO E L UOMO CONOSCENZE - Riconosce il valore e il rispetto
1 PTOF 2015/2018 CURRICOLO VERTICALE AREA STORICO - GEOGRAFICA Religione - Si accosta alla conoscenza di Dio. SCUOLA DELL INFANZIA RELIGIONE DIO E L UOMO CONOSCENZE - Riconosce il valore e il rispetto
catechista a servizio della Parola L identità del catechista
 catechista a servizio della Parola L identità del catechista la catechesi in primo luogo è un atto relazionale, educativo e comunicativo. La catechesi, promuove e fa maturare la conversione iniziale,
catechista a servizio della Parola L identità del catechista la catechesi in primo luogo è un atto relazionale, educativo e comunicativo. La catechesi, promuove e fa maturare la conversione iniziale,
La filosofia come istanza critica. Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè
 Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
Immanuel Kant La filosofia Prof. Marco Lombardi Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè Da dove derivano i giudizi sintetici a priori? 2 La rivoluzione copernicana Kant, per rispondere a questo interrogativo,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONGINEVRO ARCORE
 CURRICOLO RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA Scoprire nell'ambiente i segni che richiamano ai Cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio creatore e Padre Scopre le tracce di Dio nella bellezza
CURRICOLO RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA Scoprire nell'ambiente i segni che richiamano ai Cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio creatore e Padre Scopre le tracce di Dio nella bellezza
COLLEGIO PLENARIO DOCENTI
 COLLEGIO PLENARIO DOCENTI 7 FEBBRAIO 2019 INTRODUZIONE Sfondo magisteriale e contesto attuale (frammentazione e complessità). 1. IL TERZO CRITERIO PER IL RINNOVAMENTO DEGLI STUDI ECCLESIASTICI Il punto
COLLEGIO PLENARIO DOCENTI 7 FEBBRAIO 2019 INTRODUZIONE Sfondo magisteriale e contesto attuale (frammentazione e complessità). 1. IL TERZO CRITERIO PER IL RINNOVAMENTO DEGLI STUDI ECCLESIASTICI Il punto
L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi
 Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
Filosofia U. D. IV L enciclopedia delle scienze filosofiche V LSPP Marconi Nell Enciclopedia (1817) è descritto il sistema filosofico di Hegel in possesso del sapere assoluto ovvero di essere già consapevole
LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA
 LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA Chi, superando le difficoltà della forma, è abituato a vedere i perenni problemi della teologia in molte questioni agitate dagli Scolastici,
LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA Chi, superando le difficoltà della forma, è abituato a vedere i perenni problemi della teologia in molte questioni agitate dagli Scolastici,
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale
 Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
Il rapporto tra fede ed etica. Per una comprensione delle sfide morali in un mondo plurale Prof. Antonio Autiero Napoli, 20 settembre 2010 1 Alcune premesse I Il significato della fede per l etica II Fede
PROGRAMMA DI STORIA. Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO
 PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
PROGRAMMA DI STORIA Liceo Classico Statale Vitruvio, Formia CLASSE 1 C ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PROF. A.OLIVO I/I SECOLI CENTRALI DEL MEDIOEVO: SECC. XI/XIII 1-I fondamenti del potere 2.1-La signoria
Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali Allegato 2.E al Piano Triennale dell Offerta Formativa 2016/19 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA
 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA DELL INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI Obiettivi riferiti all intero percorso della scuola dell infanzia OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE Osservare con attenzione
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Inno cristologico Colossesi. pausa
 Inno cristologico Colossesi Parrocchia S. M. della Guardia Catania Frati Minori Inno Lettera ai Colossesi 1,15-20 Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo
Inno cristologico Colossesi Parrocchia S. M. della Guardia Catania Frati Minori Inno Lettera ai Colossesi 1,15-20 Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo
La disciplina nel corso dell anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. : CLASSE: 5 A LSA MATERIA: RELIGIONE DOCENTE: BRUSCHI ALBERTO L insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. : CLASSE: 5 A LSA MATERIA: RELIGIONE DOCENTE: BRUSCHI ALBERTO L insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici
