IL SETTENARIO DELLE VIRTU DI DUNS SCOTO (II puntata)
|
|
|
- Gildo Filippi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL SETTENARIO DELLE VIRTU DI DUNS SCOTO (II puntata) LE VIRTÙ TEOLOGICHE La spiritualità e la devozione di Duns Scoto sono contrassegnate dalla prospettiva della dottrina cristocentrica, in cui le due correnti dell ascetica cristiana - teocentrismo e antropocentrismo - trovano la loro perfetta sintesi di simbiosi. Per il suo spirito concreto proveniente dall ideale francescano, il Maestro scozzese rifiuta la concezione aristotelica del primato dell intelletto sulla volontà, della speculazione sulla pratica, della scienza sull amore; e, viceversa, afferma la concezione della preminenza della volontà sull intelletto, della pratica sulla speculazione e dell amore sulla dottrina. Per Duns Scoto, quindi, è la volontà che domina sull intelletto, mediante la carità, sia nella vita presente che in quella futura 1. Un punto fermo della spiritualità scotista è dato dalla ferma convinzione che la perfezione cristiana consiste nella corretta pratica del numero settenario 2 delle virtù, tre virtù teologali e quattro virtù cardinali, che differiscono per natura, in quanto appartengono all ordine soprannaturale perché infuse da Dio con la grazia battesimale. Con il possesso e l esercizio delle virtù teologali, l uomo si perfeziona in ordine a Dio 3 ; mentre con quelle 1 Reportata Parisiensia, IV, d. 49, q. 2, n. 11, (n. 66): «... maioris capacitatis est voluntas quam intellectus, hic et in patria». 2 Ordinatio, III, 34, un., n. 21, (n. 64): «De fructibus dico quod quidam illorum sunt virtutes secundum illam regulam, secundum quam enumeratae sunt in illo septenario; quaedam autem sunt species: virtutum ibidem enumeratarum; quaedam, nec sic nec sic, sed delectationes consequentes actus, verbi gratia, charitas exprimitur ibi proprio nomine, et similiter fides, spes autem in hoc quod dicitur longanimitas. Unde legitur de Patriarchis, longanimes in spe, quasi in longum animose expectantes»; RP III, 34, un., n. 11, (n. 36): «De fructibus dico, quod quaedam illorum sunt virtutes enumeratae in illo septenario in se vel in suis speciebus; quidam autem sunt delectationes consequentes actus»; Ordinatio, III, 34, un., n. 7, (n. 23): «illi habitus tantum ponendi sunt in viatore, quibus perficitur, circa omne obiectum, quantum perfici potest in via; huiusmodi sunt septem virtutes in genere, non curando de scientiis specutativis acquisitis; igitur praeter scientias specutativas acquisitas nullus erit habitus in viatore ponendus, alius simpliciter a septem virtutibus. Probatio maioris, obiectum circa quod perfici potest viator, non potest esse nisi Deus vel creatura; sed circa Deum sufficienter perficitur tribus virtutibus theologicis, et hoc, perfectissime quantum perfici potest, si ilii tres habitus sint perfectissimi in suo genere; circa creaturam vero (non loquendo de speculativis), intellectus perfectissime perficitur per prudentiam, si prudentia sit perfectissima; ipsa enim est de omni agibili, et quantum ad omnem conditionem agibilis perfectissima notitia». 3 Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 7, (, n. 23): «Illi habitus tantum ponendi sunt in viatore, quibus perficitur circa omne obiectum, quantum perfici potest in via; huiusmodi sunt septem virtutes in genere»; Ord III, d. 34, q. un., n. 6, (n. 22): «et fide tenemus tres virtutes theologicas esse necessarias perficientes immediate animam respectu obiecti increati»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 7, (n. 25): «Per tres autem virtutes Theologicas sufficienter perficitur viator circa Deum immediate, quia circa ipsum, ut immediate cognoscendum in via,
2 cardinali, in ordine a sé stesso e nelle relazioni con gli altri 4. Per raggiungere la perfezione 5, quindi, non c è bisogno di rifarsi a tante virtù, ma è sufficiente possedere e praticare semplicemente il settenario delle virtù 6. Riduce al massimo il castello spirituale. I doni dello Spirito Santo, le beatitudini e i consigli evangelici e tutte le altre virtù morali, di conseguenza, non sono distinti dalle virtù del settenario, anzi si confondono con i loro abiti, ne formano il corteo e l ornamento, e imprimono a esse un dinamismo più efficace in ordine al soprannaturale 7. In questo modo, Duns Scoto concepisce il complesso mondo spirituale dell uomo in forma sistematica e gerarchica, ordinando tutte le virtù alla carità 8 : subordina ciò che è inferiore a ciò che è superiore, e ciò che è superiore a ciò che è sommo; o che è lo stesso: subordina gli abiti delle beatitudini, dei doni, dei consigli evangelici e le virtù morali alle virtù cardinali, e le virtù cardinali alle virtù teologali, e, alla fine, integrando i sufficienter perficit, quia de Deo in via non potest haberi nisi cognitio fidei». 4 Ibidem, n. 14, (n. 46): «In connumeratione virtutum habetur ab Apostolo (1 Cor 13, 13), de moralibus a Sapientiae (8, 7). Iste numerus simpliciter perficit viatorum, ita quod secundum gradus istorum in specie sua est perfectus... Per istas quippe septem virtutes... est homo simpliciter perfectissimu et circa Deum in se et circa omnia alia a Deo». Cf anche Reportata Parisiensia, III, d. 33, q. un., n. 18, (n ). 5 Ordinatio, III, d. 34,q. un., n. 7, (n. 27): «Igitur non videtur aliqua necessitas ponendi aliquos alios habitus ab istis, qui sunt virtutes theologicae et morales». 6 Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 14, (n. 46): «Secundum hoc igitur in connumeratione omnium virtutum sunt tres theologicae, et quattuor cardinales. De theologicis habetur ab Apostolo, (1 Cor 13, 13), de moralibus Sapientiae (8, 7). Iste numerus septenarius simpliciter perficit viatorem, ita quod secundum gradus istarum in specie sua est ipse perfectus; secundum enim quod istae sunt intensiores et remissiores, secundum hoc est magis vel minus perfectus; et si sint intensissimae, quantum possunt esse in via, est homo simpliciter perfectus, quantum potest esse in via, non curando modo de ista perfectione, quae habetur per virtutes speculativas acquisitas, quae prius exclusae sunt»; Ordinatio, III, d. 34, q. un., n. 14, (n. 47): «Per istas quippe septem virtutes, intelligendo de eis, et de speciebus earum necessariis, de quibus postea dicetur, si sint in se perfectissimae, est homo simpliciter perfectissimus, et circa Deum in se, et circa omnia alia a Deo, ut intelligibilia ratione practica, et ut appetibilia vel sibi, vel alteri, et hoc in ordine ad se, in quem possunt virtutes acquisitae esse, vel in ordine ad finem ultimum in quem possunt virtutes acquisitae cum charitate»; Ordinatio, d. 34, q. un., n. 19, (n. 59): «Sic igitur patet quod in sustinendo septem virtutes sufficienter perficere hominem in via, in se, vel in suis speciebus, non erunt necessarii alii habitus, qui nec sint illi, nec species earum, nec enumerantur alii in donis, nec in beatitudinibus, nec in fructibus. Et licet numerus sit alius explicitus beatitudinum et donorum, hoc est, quia aliquae species illarum septem virtutum aliter exprimuntur hic quam ibi, et non quia sint alii habitus, qui non sunt illarum virtutum species. Si etiam tantum ponderaretur Scriptura, quae ponit alicubi octonarium, alicubi septenarium, oporteret eos distinguere, ut diversos habitus; quare igitur non ponuntur distincti habitus illi, de quibus facit mentionem Apostolus 1 Corinthiorum 12, ubi ponitur novenarius ab illis, quos enumerat Petrus [1, 1, 5]: «Ministrate in fide vestra virtutum», etc. Frequenter igitur Scriptura eadem realiter exprimens, exprimit sub aliis verbis, nunc omittens quaedam, nunc alibi explicans sic omissa». 7 Reportata parisiensia, III, d. 34, q. un., n. 13, (n. 39): «Ideo ad quaestionem, patet quod virtutes, beatitudines et dona non sunt habitus distincti realiter». I teologi del XIII secolo, come ad esempio Bonaventura e Tommaso, considerano i doni e le beatitudini in se stessi, a se stanti, ossia necessariamente distinte dalle virtù. 8 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 26, (n. 91): «Pro tanto igitur dicuntur [virtutes] esse informes sine charitate et formatae per charitatem, pro quanto charitas ordinat ipsas [virtutes], et earum fines in finem ultimum: in qua ordinatione est ultima earum (virtutum) perfectio... Nam virtutes non sunt verae sine charitate, quia non perducunt ad beatitudnem».
3 reciproci rapporti delle virtù, riduce e ordina tutto alla carità, ultima perfezione delle virtù. Senza carità, dice Duns Scoto, non ci sono autentiche virtù. La carità è l anima e il cuore di tutte le virtù e di tutti i doni. È la tradizione etica e scotiana dell inno alla carità di Paolo 9. In sintonia con la dottrina del primato della volontà, Duns Scoto precisa che la sede propria delle virtù, a eccezione della fede e della prudenza, è la stessa volontà, la quale, però, non opera mai ciecamente, ma sempre illuminata dall intelletto. L atto umano per essere lodevole dev essere responsabile e libero 10. E con profonda convinzione afferma che «ogni atto della volontà è naturalmente preceduto dall intelletto» 11, così da evitare ogni velleità di false interpretazioni sul rapporto tra le due facoltà; anzi la stessa concezione della praxis, come atto della volontà, si realizza sempre in conformità alla retta intellezione 12. In coerenza con la sua dottrina cristocentrica, Duns Scoto identifica l origine delle virtù direttamente ed esclusivamente con Cristo. Come Cristo sana perfettamente il corpo 13, così sana perfettamente l anima nelle sue facoltà specifiche: nell intelletto mediante la fede; nella volontà mediante la speranza e la carità 14. La presenza per infusione delle tre virtù teologiche è garanzia dello stato di perfezione oggettivo dell uomo, che così viene restaurato spiritualmente nella sua immagine con Cristo. A differenza di coloro che sostengono l origine per infusione non solo delle virtù teologali, ma anche delle virtù morali, Duns Scoto distingue: le virtù teologiche e le virtù cardinali hanno origine per infusione, mentre le virtù morali si acquisiscono mediante la ripetizione degli atti 15. Le virtù morali, benché perfette in se stesse, sono inabili a condurre l uomo fino al suo fine ultimo, cioè in ordine al 9 Cf 1 Cor 13, Ordinatio, III, d. 33, q. un., n. 2, (n. 9): «Virtus est per se principium actus laudabilis, II Ethicorum [cap. 5]: nulli autem debetur laus, nisi voluntarie agenti; igitureius est virtus cuius est per se libere agere; illud est est voluntas». 11 Reportata Parisiensia, I, d. 17, q. 3, n. 3, (n. 55): «Omnem actum voluntatis naturaliter praecedit actus intellectus». 12 Lectura, I, prologus, pars 1, q. 2, n. 2, (n. 137): «nihil ets praxis formaliter nisi actus voluntatis imperatus vel elicitus, quia nullus actus sequitur actum intellectus cui conformiter elicitur nisi actus voluntatis, quia omnes actus aliarum potentiarum possunt praecedere actum intellectus, sed non actus voluntatis». 13 Mt 9, 1-6 ; è l esempio della guarigione del paralitico, portato dallo stesso Duns Scoto nella nota Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 14, (n. 50): «Unde sicut quando [Christus, Mt 9, 1-6] sanat aliquem secundum corpus, perfecte sanat pro statu in quo est; ita etiam secundum animam, et quia in anima est aimado Dei secundum tres potentias, quae deformatae sunt per peccatum, ideo Christus reformando, sicut perficit voluntatem per charitatem [et spem], sic intellectum per fidem»; d. 36, q. un., n Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 28, (n. 94): «Licet de istis virtutibus moralibus infusis multa dicuntur... ideo non videtur necessitas ponendi virtutes morales infusas, sed acquisitas».
4 soprannaturale; per agire in ordine al soprannaturale devono essre informate dalla carità, a cui servono come disposizione ad agire verso la perfezione. Senza carità, infatti, le virtù morali sono informe, mentre sono formate per e con la carità. Benché l esercizio di ogni singola virtù morale perfezioni l uomo intorno al fine specifico della singola virtù, tuttavia per raggiungere perfettamente il fine dell esistenza è necessario la solidarietà tra le virtù, ossia la presenza di tutte le altre virtù 16, che «come sorelle collaborino al raggiungimento della perfezione» 17. Mentre tra le virtù morali può sussistere questa solidarietà, essa può non sussistere nelle virtu teologali. Difatti, precisa il Maestro francescano tre specifiche situazioni: in cielo si avrà la carità senza fede e senza speranza; durante la vita si possono avere fede e speranza senza carità; nell origine invece vengono infuse tutte e tre insieme per liberalità di Dio, in Cristo 18. E poiché le virtù tendono al perfezionamento dell uomo, sia nei riguardi di Dio che nei riguardi degli uomini e delle cose, esse hanno come unico e necessario modello Cristo, di cui l uomo ne è l imago. E così, al centro dell intero settenario delle virtù, che «semplicemente perfeziona l uomo» 19, Duns Scoto pone il Cristo: in quanto Dio, è unica fonte della grazia, che si trasmette con le virtù teologali; in quanto Uomo, è l unica misura della moralità dell uomo, mediante le virtù cardinali. Come a dire: l immagine imperfetta dell uomo tende verso l immagine perfetta del Cristo; l «immagine esige l imitazione di ciò di cui è immagine, e di esprimerlo» 20. Si è scoperta così l origine ontologica della sequela e dell imitazione Christi. Alla domanda qual è la caratteristica della virtù teologica, Duns Scoto con molta precisione risponde precisando le tre condizioni necessarie. Scrive: «Tre sono le condizioni per aversi una virtù teologica: primo, avere Dio come oggetto primario; secondo, avere per 16 Ibidem, n. 8, (n. 37): «Una virtus non perducit perfecte ad finem virtutum... omnes autem requiruntur ad perfecte perducendum». 17 Ibidem, n. 9, (n. 40): «sicut sorores, etsi iuvent se mutuo ad convivendum iuvant ergo se mutuo sicut sorores». 18 Ibidem, n. 30, (n. 101): «Quaecumque separari possunt [vitutes] in esse, potest Deus separari in fieri; et ideo quantum est ex se non necessario connectuntur in infusione, sed ex liberalitate divina connectuntur, quia Deus totum hominem perficit, ita sicut corporaliter nullum sanavit nisi perfecte, ita etiam spiritualiter non sant hominem, nisi perfecte sanet; perfecta autem sanitas est, si quantum ad intellectum habet fidem et quantum ad voluntatel spem et caritatem». 19 Ibidem, d. 34, q. un., n. 14, (n. 46): «Iste numerus septenarius simpliciter perficit viatorem». 20 Ordinatio, I, d. 3, pars 3, q. 4, n. 2, (n. 772): «imago nata est imitari ipsum cuius est imago, et exprimere
5 regola la prima regola degli atti umani, non acquisita ma infusa; terzo, sia immediatamente infusa da Dio, come causa efficiente» 21. Queste condizioni distinguono le virtù teologiche infuse dalle virtù acquisite. Mentre le prime due condizioni possono essere soddisfatte in entrambi i gruppi di virtù, non così per la terza condizione, che resta prerogativa esclusiva di Dio 22. Neppure sono tra di loro connesse le virtù teologiche, nel senso che possedendo una virtù si posseggono anche le altre, perché non c è alcuna necessità di questo tipo di connessione. Difatti, sia in cielo che in terra si può possedere la fede e la speranza senza della carità. Così scrive: «Le virtù teologiche non sono connesse tra di loro, come è in cielo, dove rimane solo la carità senza fede e senza speranza; così come è in terra nel peccatore, che conserva la fede e la speranza, ma non la carità; dunque tra le tre virtù non c è connessione necessaria» 23. E per quanto riguarda la corruzione o l annientamento delle virtù teologali infuse, il Maestro francescano è dell avviso che soltanto una causa demeritoria può incidere su di esse. Scrive: «Nessuna virtù infusa può essere corrotta per un atto umano contrario, ma soltanto per una causa demeritoria, cioè con il peccato grave; con il peccato, non si conserva la grazia e, quindi, la virtù vien meno» 24. La certezza della presenza della virtù infusa o soprannaturale, illud». 21 Ordinatio, III, d. 26, q. un., n. 15, (n. 50): «Respondeo, tres conditiones ponuntur pertinere ad virtutem theologicam: prima est respicere Deum pro primo obiecto; secunda habere pro regula primam regulam humanorum actuum, non autem regulam acquisitam; tertia immediate infundi a Deo, sicut a causa efficiente». 22 Cf Ibidem, n. 15, (n. 51): «Si omnes tres [conditiones] requirantur ad virtutem theologicam, patet quo fides et charitas acquisitae non sunt virtutes theologicae, nec spes acquisita, quia deficiunt in tertia conditione. Si prima sufficiat, vel etiam prima cum secunda, sic spes acquisita potest poni virtus theologica, quia est circa Deum immediato, ut circa obiectum desiderando ipsum, ut bonum speranti, et si non speret illud in se fore, tamen sperat, id est, desiderat illud sibi, et non aliud. Similiter secunda conditio concurrit ibi, quia habens spem acquisitam innititur immediate primae veritati ut primaa regulae nostrorum actuum; non enim desiderat quod prudentia acquisita dictat desiderandum, sed quod veritas prima supernaturaliter ostendit esse desiderandum». 23 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 30, (n. 99): «dico quod virtutes theologicae non sunt connexae inter se, sicut patet in patria, ubi manebit habitus e actus charitatis sine habitu et actu fidei et spei; sicut etiam patet in via, ubi in peccatore manet fides et spes sine charitate; igitur ex ratione habituum in existendo, non est necessaria connexio earum». 24 Ordinatio, IV, d. 1, q. 1, n. 32, (n. 142): «nulla virtus infusa potest corrumpi in nobis per aliquem actum nostrum, quasi per naturam repugnantiae, sed solum per causam demeritoriam; anima enim peccans demeretur, quod gratia non conservetur in ea, et sic in secundo instanti naturae, propter tale demeritum quasi praecedens, Deus non conservat gratiam, et sic annihilatur».
6 secondo Duns Scoto, non la si può avere con nessuna dimostrazione razionale, ma solo attraverso la fede 25. E la fede riguarda esclusivamente ciò che appartiene a Dio La virtù della fede Le virtù teologali - fede speranza e carità - costituiscono, secondo Duns Scoto, la base di tutta la vita spirituale del credente, che lo collegano immediatamente a Cristo, dal quale provengono per infusione e lo perfezionano in ordine a Dio. Senza delle virtù teologiche non si può piacere a Dio, né si può entrare in comunione con Lui. Alla domanda se la fede e la speranza senza della carità possono dirsi delle vere e proprie virtù27, Duns Scoto distingue un duplice aspetto, uno generico e uno specifico. Per la dimensione generica si possono e si devono riconoscere come vere e proprie virtù, perché hanno un loro specifico oggetto; per la dimensione specifica o di perfezione hanno bisogno della virtù della carità che è «la perfezione di ogni virtù»28. Intorno alla definizione della fede, Duns Scoto presenta una rosa di soluzioni diverse, a seconda se a fondamento c è un testo scritturistico o un concetto speculativo. Le diverse indicazioni della Scrittura si possono raggruppare intorno all espressione della Lettera agli Ebrei (11, 1) che definisce la fede «come sostanza delle verità sperate e conoscenza delle verità non evidenti»29, da cui ricava anche la descrizione come assenso a una verità di per sé non evidente, basato sull autorità del testante e non dell oggetto30; e a quella dei Romani 25 Ordinatio, IV, d. 4, q. 2, n. 4, (n. 25): «nulla virtus supernaturalis potest probari, neque ex actu aliquo, neque ex aliqua conditione alicuius actus; sed nec forte in universali potest probari per rationem naturalem, aliquam virtutem supernaturalem inesse». 26 Lectura I, prol. pars 2, q. 3, n. 76: «fides tantum est respectu Dei». 27 Ordinatio, III, d. 36, q. un., n. 31, (n. 102): «Si quaeritur utrum fides et spes sine charitate essent virtutes?». 28 Cf Ibidem, (n. 103): «Dici potest, sicut prius dictum est de virtutibus moralibus, quod in specie sua possunt esse perfectae, in quantum scilicet sunt principia propriorum actuum respectu propriorum obiectorum; sed perfectionem illam ultimam, quam habent in attingendo finem, ad quem ordinantur ex charitate, non possunt habere sine ipsa. Et haec quidem perfectio tam in moralibus quam in istis, licet dicatur communiter esse in attingendo finem per aliquam operationem elicitam, sive per aliquem ordinem istarum, vel eorum actuum ad finem, potest tamen dici esse praecipue in hoc quod est acceptari a Deo, ordinando ad beatitudinem; sic quippe nulla virtus, nec eius actus acceptatur sine charitate, quae sola dividit inter filios regni et perditionis». 29 Ordinatio, III, d. 31, q. un., n. 2, (n. 6): «Fides est substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium». 30 Reportata Parisiensia, III, d. 31, q. un., n. 2, (n. 7): «Dico quod omnis illa virtus evacuabitur, cuius inclinatio ad actum est incompossibilis beatitudini pro statu illo in patria, sic est de fide et spe. Probo: fides enim est habitus inclinans ad assentiendum vero complexo, cuius evidentia non apparet, ideo, ut habetur secundum
7 (10, 14) che la descrive nel suo processo dinamico dell ascolto di qualcuno mandato a parlare o a insegnare31. Dalla prima definizione, Duns Scoto ricava anche il concetto della fede come assenso a un complesso di verità, prodotto non dall evidenza dell oggetto-verità, ma dal soggetto che attesta tali verità, cioè da Dio stesso, che fa le veci dell oggetto nel produrre l assenso nell intelletto32. L assenso, pur prodotto nell intelletto, non garantisce definitivamente l aspetto speculativo della fede, perché la sua caratteristica resta sempre quella di aspetto pratico, «habitus practicus»33. Il Maestro francescano descrive la fede anche come «una certa forma che rappresenta in modo oscuro Dio»34; o anche come «una visione stabile»35 di Apostolum ad Hebreos 11, [1]: «est argumentum non apparentium», etc. Et est proprie de vero complexo, ut de obiecto, quod respicit intellectus secundum portionem superiorem, scilicet de Deo. Inclinat autem ad assentiendum vero complexo de Deo non propter evidentiam, sed propter efficaciam causantis. Sed ibi non inclinabit ad assentiendum alicui de Deo non evidenti, quia de ratione beatitudinis est omnia ibi esse sub evidentia, ideo, etc. Potest tamen esse fides in patria de aliquibus quae creduntur, sed acquisita». 31 Ordinatio, IV, d. 4, q. 2, n. 1, (n. 14): «Romanorum l0 [14]: «Fides est ex auditu»; parvuli non possunt sic accipere fidem»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 5, (n.14): «secundum Apostolum, fides est ex auditu, auditus autem est ex praedicante; praedicare autem nullus potest, nisi mittatur; igitur de primo ad ultimum non potest homo credere, nisi audiat aliquem praedicantem sibi credibilia». 32 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 12, (n. 28): «assensus, quem causat in nobis fides infusa, non est ita perfectus, sicut erit quando videbimus Deum, sicut est»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 12, (n. 45): «fides non est potentia, quia potentia se tenet a parte animae, fides a parte obiecti, ut partialis causa respectu actus; ideo non est potentia animae, sed causat assensum totum, ut tenet vicem obiecti»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 15, (n. 38): «fides non habet a parte obiecti causare assensum, quia similiter tunc gratia esset infusa ad creandam assensum, licet non ad praesentandum obiecta, quia si obiecta sunt apprehensa, necessario gratia assensum causat de illis. Sic si fides causaret assensum in vice obiecti, tunc de novo baptizatus, si habeat fidem infusam et praesentiam credibilium, ut de resurrectione mortuorum, necessario habebit assensum huius, scilicet quod mortui resurgent, ante omnem actum voluntatis, quia habitis, quae concurrunt ad actum credendi in actu primo, necessario sequitur actus; consequens est falsum, quia non plus crederet post baptismum quam ante, nisi esset edoctus; ergo videtur quod fides acquisita sufficit, nec experitur quis aliam cum tali assensu, et hoc sit circa principale dictum quod non sola fides causat assensum»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 9, (n. 35): «nihil movet intellectum nostrum naturaliter ad causandum assensum intellectus istis credibilibus, ideo Deus supplet vicem obiecti, ut sicut ex frequentia actuum cognitionis imperfecta terminorum in articuli generaretur in nobis assensus imperfectus de credibilibus, si tamen termini moverent imperfecte ad huiusmodi assensum causandum, sic Deus infundit nobis habitum fidei inclinantem intellectum nostrum in assensum articulorum, ita quod fides respiciat ipsum Deum, de quo formantur articuli, quibus sicut obiectis secundariis assentimus per habitum». 33 Lectura I, prol., pars 4, q. 2, n. 180: «fides est habitus practicus». Ordinatio, I, prol., pars 5, q. 2, n. 530: «dico quod fides non est habitus speculativus, nec credere est actus speculativus, nec visio sequens credere est speculativa, sed practica; nata est enim illa visio conformis esse fruitioni et prius naturaliter haberi in intellectu creato ut fruitio recta illi conformiter eliciatur». 34 Collatio, 10, 5, 17: «fides est quaedam forma, quae obscure repraesentat Deum, et ita est forma imperfectior; ergo non repugnat, quod causetur creatura rationalis, quae includit perfectionem illius; ergo talis creatura ex puris naturalibus potest omne credibile cognoscere, et firmiter assentire».
8 Dio, che non cambia mai, escludendo che sia un «dono supernaturale»36. Per quanto riguarda la certezza che la fede produce nel credente, afferma: «la certezza della fede non deriva dall oggetto, ma dall autorità del teste, cioè dall autorità di Dio...»37. La fede, pertanto, non è né una disposizione speculativa né una visione speculativa susseguente alla stessa visione del credere, ma è una disposizione pratica conforme alla visione dell oggetto goduto per la veridicità del teste. La prima grande distinzione è quella tra fede acquisita e fede infusa, a seconda dell autorità cui fa riferimento, se la Chiesa o Dio stesso. Così ad es., si parla di fede acquisita quando si dice di credere a qualche credibile rivelato in forza dell autorità della Chiesa. Classico è l es., di Agostino, ripreso anche da Duns Scoto, quando afferma che non crederebbe al Vangelo se non lo credesse la Chiesa38, oppure qualsiasi verità definita dalla stessa Chiesa come rivelata Collatio, 16, 5, 18: «fides modo erit tunc visio tamen obiectum non mutatur, sed alio modo se habet ad voluntatem». 36 Reportata Parisiensia, II, 1, 1, 24: «fides non est donum supernaturale, quia stat cum peccato mortali». 37, III, 23, un., 12: «fides non habet certitudinem ex obiecto, sed ex veracitate testis, scilicet Dei; et hoc modo facile est videre, quomodo fides est cum aenigmate et obscuritate, quia habens fidem non credit articulum esse verum ex evidentia obiecti, sed propter hoc, quod assentit veracitati infundentis habitum, et in hoc revelantis credibilia». 38 Cf Epistola contra fundamentum Manichaei, 5, in Quaestiones quodlibetales, q. 14, n. 5, (n. 27): «non crederet Evangelium, nisi credert Ecclesiae catholicae»; Collatio, 10, n. 4, (n.11): «non credo Evangelio, nisi quia credo Ecclesia catholica a qua acquiritur fides de credendis; ergo non maior certitudo est in actu fidei infusa, quam acquisitae; argo frustra ponitur lumen fidei infusae ad intelligendum aliquod verum, cum sufficiat fides acquisita»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 4, (n. 9): «certum est, quod in nobis est fides revelatorum credibilium acquisita. Quod patet per Augustinum in Epistola Contra fundamentum manichaei, qui dicit quod non crederet Evangelio, nisi crederet Ecclesiae Catholicae. Patet igitur per eum, quod libris Canonis sacri non est credendum, nisi quia primo credendum est Ecclesiae approbanti et auctorizanti libros istos, et contenta in eis; quamvis aliqui libri auctoritatem habeant ex auctoribus suis, non tamen adhaeremus eis firmiter, nisi quia creditur Ecclesiae approbanti et testificanti veraces esse eorum auctores». Ibidem, n. 4, (n. 10): «dicit Augustinus ibidem, quod Evangelium Nazaraeorum non admittam, quia non admittitur ab Ecclesia. Sicut igitur si nulla fides infusa esset in me, crederem firmiter historiis librorum Canonis propter auctoritatem Ecelesiae, sicut fide acquisita credo aliis historiis a quibusdam famosis viris scriptis et narratis. Credo igitur fide acquisita Evangelio, quia Ecclesia tenet scriptores veraces, quod ego audiens acquiro mihi habitum credendi dictis illorum»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 3, (n.11): «libris Canonicis non est credendum, nisi quia primo credimus Ecclesiae approbanti, et asserenti, et tradenti illos. Licet enim aliqui libri auctoritatem habent ex auctoribus suis, non tamen creditur eis, nisi quia Ecclesiae approbanti et testificanti illos esse veraces. Unde ibidem dicit Augustinus: «Evangelium Nazarenorum non admittam, quia nec Ecclesia admisit»; fidem ergo acquisitam habemus ex testimonio Ecclesiae. Ergo si nulla esset in me fides infusa, possem credere quod Ecclesia bene credit, et bene determinavit, sicut si crederem alias historias bene admissas propter veritatem eas credentium; et sic audiendo eas acquiro habitum credendi istorum dictis. Patet ergo quod habemus fidem acquisitam adhaerendo testimonio Ecclesiae, et sic Evangelio potest credi ex sola fide acquisita». 39 Ordinatio, IV, d. 11, q. 3, n. 15, (n. 140): «Et breviter, quidquid ibi dicitur esse credendum, tenendum est esse de substantia fidei, et hoc post istam declarationem solemnem factam ab Ecclesia». Ordinatio, IV, d. 11, q. 3, n. 5, (n. 102): «nihil est tenendum tanquam de substantia fidei, nisi quod potest expresse haberi de Scriptura vel expresse declaratum est per Ecclesiam vel evidenter sequitur ex aliquo plane contento in Scriptura vel plane determinato ab Ecclesia».
9 Ma che cosa è veramente la fede acquisita, come nasce e si genera nell uomo? Basandosi sul testo paolino ai Romani (10, 14), Duns Scoto descrive la fede acquisita come un processo dinamico e interagente tra l ascolto della parola di Cristo e l atteggiamento umano che recepisce l ascoltato e dà l assenso fermo e deciso della volontà come vero. Scrive: «la fede acquisita è generata dall ascolto e dall attività umana che aderisce fermamente a ciò che ha ascoltato»40. La fede acquisita o per ascolto si fonda sull autorità di Dio stesso che da un lato non può né ingannarsi né ingannare41 e dall altro assiste colui che parla a nome suo, operando anche dei miracoli, dal momento che Dio non può assistere chi dice il falso a nome suo42. Oltre all autorità di Dio, Duns Scoto chiama in causa l autorità della Chiesa, che è l unica garante dell autenticità dei testi sacri della Scrittura, secondo l interpretazione cristocentrica della parola di Dio e della volontà di Cristo. In questo passaggio, segue molto da vicino il pensiero di Agostino, che in più punti ha dichiarato che non crederebbe al Vangelo, se non lo credesse la Chiesa. Dalla posizione del Maestro francescano appare a tutto tondo che l importanza della Chiesa sembra addirittura superiore a quella della Scrittura, nel senso che è la Chiesa ad approvare e ad autorizzare i libri sacri come sacri; di conseguenza si deve prima credere alla Chiesa, per poter credere alla Scrittura, e non viceversa. In fondo, quindi, la fede acquisita poggia sulla testimonianza della Chiesa 43. La fede, invece, è infusa quando si crede a qualche credibile in forza dell autorità di Dio stesso, rivelata nella Scrittura, come ad es., il mistero della Trinità, il mistero 40 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 5, (n. 18): «Hoc igitur tenendum est tanquam certum, quod revelatorum in Scriptura est in nobis fides acquisita, generata ex auditu et ex actibus nostris, qua eis firmiter adhaeremus». 41 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 5, (n.14): «talis habet fidem acquisitam, quia firmiter credit praedicanti verbum Dei, propter hoc forte, quia videt miracula ipsum facere, quae non potest facere nisi virtute Dei, quem scit non posse decipi, nec velle fallere per huiusmodi miracula; habet talis fidem acquisitam quae praecedit charitatem, et tunc forte hic habet voluntatem peccandi». 42 Ordinatio, III, 23, un., n. 5, (n. 15): «Hoc argumentum [ex auditu] non valet, nisi loqueretur de fide acquisita, quia haec fides generatur in homine, ex hoc quod audit verba praedicantis, adhibendo fidem dictis suis, quia non oportet quemlibet talem esse bonum moraliter per charitatem infusam, sed potest esse in peccato mortali, et audiendo praedicantem, et videndo miracula fieri, credit ei, et hoc, quia dictat sibi naturaliter ratio, quod Deus non assistit falsitati alicuius, operando miracula ad falsa alicuius praedicata vel dicta; igitur fides illa praecedit charitatem, et per consequens est acquisita, quia infusa non infunditur nisi cum charitate»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 5, (n. 14): «Quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedicante? et concluditur, ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. Sed talis fides, quae habetur ex auditu a praedicante verbum Dei, non est fides infusa, sed tantum acquisita, quia non oportet talem credentem per praedicationem de verbo Dei, statim habere bonos mores, quia ponitur quod sit tunc in peccato mortali, quando audit praedicantem, et ei assentit».
10 dell Incarnazione44. La fede teologica - afferma Duns Scoto - è una virtù infusa, la cui esistenza è nota solo per rivelazione; per definirla utilizza la definizione agli Ebrei (11, 1): «la fede è sostanza (fondamento) delle cose che si sperano e prova (argomento) di quelle che non si vedono»45. E personalmente stabilisce una profonda analogia tra l esistenza della Trinità e l infusione della fede: «come credo che Dio sia uno e trino, così credo che in me la fede sia infusa»46. La credenza della fede infusa esclude due estremi: da un lato, la leggerezza a credere facilmente; e dall altro, la pertinacia o l ostinazione a non credere se non alla propria ragione. Tra le due posizioni radicali, la fede tiene la via di mezzo: è partecipazione del lume divino nell uomo47. La sede propria della fede, perciò, è l intelletto48. La fede infusa è necessaria, perché perfeziona e sana l uomo dopo la colpa del peccato originale Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 4, (n. 9-10); Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 3, (n.11). 44 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 14, (n. 49): «Ad quaestionem tamen dico quod oportet ponere fidem infusam propter auctoritatem Scripturae et Sanctorum; sed non potest demonstrari fidem infusam inesse alicui, nisi praesupposita fide, quod velit credere Scripturae et Sanctis, sed infideli nunquam ostenderetur; sed sicut credo Deum esse trinum et unum, ita credo nec habere fidem infusam, qua hoc credo, et hoc a Deo, ut perficiat animam in actu primo, quia Dei est perfecte perficere quando perficit»; Lectura I prol., pars 2, q. 3, n. 76: «fides tantum est respectu Dei». 45 Ordinatio, III, d. 31, q. un., n. 6; «Fides est substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium»; Reportata Parisiensia, III, d. 31, q. un., n. 2, (n. 7): «Dico quod omnis illa virtus evacuabitur, cuius inclinatio ad actum est incompossibilis beatitudini pro statu illo in patria, sic est de fide et spe. Probo: fides enim est habitus inclinans ad assentiendum vero complexo, cuius evidentia non apparet, ideo, ut habetur secundum Apostolum ad Hebreos 11 [1]: «est argumentum non apparentium», etc. Et est proprie de vero complexo, ut de obiecto, quod respicit intellectus secundum portionem superiorem, scilicet de Deo. Inclinat autem ad assentiendum vero complexo de Deo non propter evidentiam, sed propter efficaciam causantis. Sed ibi non inclinabit ad assentiendum alicui de Deo non evidenti, quia de ratione beatitudinis est omnia ibi esse sub evidentia, ideo, etc. Potest tamen esse fides in patria de aliquibus quae creduntur, sed acquisita». 46 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 14, (n. 49): «Dico quod oportet ponere fidem infusam propter auctoritatem Scripturae et Sanctorum; sed non potets demonstrari fidem infusam inesse alicui, nisi praesupposita fide, quod velit credere Scripturae et Sanctis... sicut credo Deum esse trinum, ita credo me habere fidem infusam». Riecheggia la definizione agli Ebrei: la fede è il fondamento delle cose sperate e l argomento di ciò che non appare (11, 1). 47 Quaestiones quodlibetales, q. 17, n. 11, (n. 36): «Unde fides infusa est partecipatio quaedam luminis divini». 48 Ordinatio, III, d. 26, q. un., n. 24, (n. 80): «Fides est media inter levitatem, quia nimis firmiter assentitur ei quod non est credendum iuxta illud: Qui cito credit levis est corde [Eccl 19, 4], et inter pertinaciam, qua quis nimis resistit credendis, nolens alicui assentire, nisi per rationem naturalem ostendetur»; se. in intellectu tantum una fides ponitur, quia licet sit respectu omnium credibilium temporalium, tamen propter unam rationem, quae est de illis respectu primi credibilis, ad quod alia attributionem habent»; Reportata Parisiensia, III, d. 25, q. un., n. 24: «intellectus est subiectum eius [scil. fidei], quia perfectio prima ipsius intellectus est fides»; Ordinatio, III, 23, un., n. 10, (n. 35): «nihil movet intellectum nostrum naturaliter ad causandum assensum intellectus istis credibilibus, ideo Deus supplet vicem obiecti, ut sicut ex frequentia actuum cognitionis imperfecta terminorum in articuli generaretur in nobis assensus imperfectus de credibilibus, si tamen termini moverent imperfecte ad huiusmodi assensum causandum, sic Deus infundit nobis habitum fidei inclinantem intellectum nostrum in assensum articulorum, ita quod fides respiciat ipsum Deum, de quo formantur articuli, quibus sicut obiectis secundariis assentimus per habitum»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 15, (n. 39): «si habitus fidei sic
11 Come si può definire la fede infusa? Non è facile definirla. Duns Scoto premette anzitutto che «la fede infusa vine infusa con la carità o grazia»50 ed «è necessaria per la salvezza dell uomo, perché lo rende accetto e caro a Dio, dal momento che la carità orna e perfeziona la volontà, che è accettata da Dio»51; e poi la definisce anche come «l assenso determinato e certo a credere il vero»52. Il termine che necessita di precisazione è quello di assenso certo e determinato, e difatti viene discusso in diversi punti. Prima di tutto, dichiara che l assenso di per sé è «imperfetto»53 ma «infallibile»54, proprio per distinguerlo dall assenso della fede acquisita che è «certo e senza dubbio»55. L assenso della fede infusa è «più certo» inclinet potentiam in actum, nullo modo actu voluntatis posito, posset credere, si haberet habitum fidei ante omnem actum voluntatis, cum termini articulorum possent apprehendi ante omnem actum voluntatis, et ita voluntas nullam causalitatem haberet respectu illius, quod est contra Augustinum tractatus 26 In Ioanne quia «caetera potest homo nolens, credere non nisi volens». Unde si habitus fidei tantum inclinet intellectum ad credendum, tunc praeter habitum inclinantem ad assensum, oportet ponere habitum repraesentantem obiecta, cum non sint in illo habitu credibilia praesentia et oportet quod credibilia aliquo modo sint ostensa et repraesentata intellectui, ad hoc quod credantur». 49 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 17, (n. 41): «ad quid ponitur in nobis fides infusa? Dico quod ponitur ut perficiat animam in actu primo, et actus secundus sit intensior. Sicut enim Deus sanans corpus, perfecte sanat, ita etiam sanans animam secundum legem suam, perfecte sanat. Imago vero animae consistit in intelligentia, memoria et voluntate, quae deformatae erant per peccatum, et sanans animam perficit eam, et quantum ad intellectum et voluntatem, reformans utrumque supernaturaliter; et ideo sicut dat voluntati habitum charitatis, ut diligat perfecte Deum, licet ex naturalibus possit cum diligere ex parte obiecti, non tamen eodem modo sine charitate et cum charitate. Dat itaque, ut non solum perficiatur in actu primo, sed etiam propter actum secundum, ut intensior et perfectior sit actus dividendi ex potentia et charitate, quem ex potentia solum, ut dictum est libro primo dist. 17. Sic perficit intellectum habitu supernaturali fidei, omnino eodem modo proportionabili, non solum ut actum primum perficiat, sed ut intendat actum secundum. Differunt tamen in hoc quod charitas cum hoc quod facit actum suum acceptum, facit et actum cuiuslibet alterius potentiae acceptum, quod non facit fides»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 9, (n. 31): «Aliter potest poni fides infusa in nobis sic: credibilia possunt accipi et cognosci a nobis naturaliter in quolibet genere credibilium in conceptibus generalibus entis et veri, et sic de aliis. Possumus enim hanc: Deus est trinus et unus, cognoscere in terminis suis generaliter, cognoscendo Deum sub conceptu generali, et similiter trinum, et sic de aliis terminis. Sed hanc: Deus est trinus in personis, et unus in essentia, numquam cognoscimus evidenter, nec est nobis evidens ex terminis, nisi termini eius apprehendantur a nobis in particulari sub propriis rationibus. Licet igitur isti termini apprehendantur in universali a nobis, ut tamen sic apprehensi, non sunt termini propositionis immediate simpliciter primae, sed mediate». 50 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 5, (n.15): «[fides] infusa non infunditur nisi cum charitate»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n.5, (n.14): «fides enim infusa non infunditur a Deo, nisi quando charitas infunditur». 51 Ordinatio, III, d. 25, q. 1, n. 2, (n. 6): «dico quid fides infusa fuit necessaria homini salvando pro omni statu, quia sicut anima non est accepta Deo, nisi ornetur et perficiatur per charitatem quoad voluntatem, sic non acceptatur a Deo». 52 Ivi: «ista autem supernaturalis perfectio, qua anima determinate assentit vero et credit verum, est fides infusa». 53 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n, 12, (n. 28): «assensus, quem causat in nobis fides infusa a Deo, non est ita perfectus, sicut erit quando videbimus cum sicut est, scilicet Deum, sed est imperfectus». 54 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 16, (n. 55): «aut intelligis, quod per fidem infusam assentit quis firmiter, ita quod non possit non assentire vel dubitare de eo cui assentit; aut quod assentit infallibiliter, id est, indeceptibiliter, ita quod non decipitur in suo assensu». 55 Ivi: «aut intelligis, quod per fidem infusam assentit quis firmiter, ita quod non possit non assentire vel dubitare de eo cui assentit; aut quod assentit infallibiliter, id est, indeceptibiliter, ita quod non decipitur in suo
12 dell assenso della fede acquisita, come «la conclusione è meno certa del principio, dal momento che la certezza della conclusione si basa sulla certezza del principio»56. E basandosi su alcuni testi scritturistici e liturgici, Duns Scoto dichiara ancora che «l assenso della fede infusa non dipende totalmente dalla volontà»57, ma soprattutto dall autorità di Dio rivelante58. Circa il come la fede infusa sia presente nell uomo, Duns Scoto non può dare una risposta certa59. Per quanto riguarda, invece, il motivo per cui sia presente è molto esplicito: «per perfezionare l anima nell atto primo e per rendere più inteso l atto secondo»60; anche se non ha certezza definitiva: «non è certamente manifesto il motivo per cui bisogna ricorrere alla fede infusa, come per la fede acquisita»61. Il paragone di natura teologica è abbastanza convincente: il peccato originale. Scrive: «Come Dio, quando interviene sanando il corpo, lo sana perfettamente, così sana anche perfettamente l anima nelle sue facoltà»62. E poiché «l immagine dell anima consiste nell intelligenza, nella memoria e nella volontà, che sono state deformate dal peccato [originale], quando Dio sana l anima, la perfeziona assensu. Si primo modo, sic aliam est de fide acquisita, quia stante fide acquisita, et dum homo assentit per eam alicui obiecto, non potest dubitare vel non assentire; aliter de eodem obiecto et sub eadem ratione esset fides, sive adhaesio et dubitatio, et ita opposita, quod est falsum; igitur propter firmam adhaesionem non oportet ponere fidem infusam». 56 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 8, (n. 30): «fides infusa si ponitur, est certior quam acquisita, sed quod sit minus certa, probo, quia conclusio est minus certa quam principium, ex quo tota certitudo eius est a certitudine principii». 57 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 15, (n. 53): «Nec pono habitum fidei infusae solum propter gradum in actu, sed etiam propter assensum, quia assensus non est totaliter a voluntate. Aliqui enim sunt, qui vellent magis assentire et tamen minus assentiunt ideo petebant apostoli: «Domine, adauge nobis fidem», Lucae 17 [5], et in quadam collecta [scil. XXX] petitur augumentum eius: «Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei et charitatis augmentum». Istud non oporteret petere, si totus assensus esset a voluntate; nec fides excludit omnem dubitationem, sed dubitationem vincentem et trahentem in oppositum credibilis». 58 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 7, (n. 16): creditur veritati testificantis non propter evidentiam obiecti, sic hic cum assentitur alicui revelato a Deo, quia assentitur veritati Dei asserentis, et quia Deus supernaturaliter revelat»; Ordinatio, III, 23, un., n. 6, (n. 19): «assentit vel credit dicto alicuius, quia credit veracitati asserentis illud esse verum, sic fides infusa assentit alicui revelato, quia credit Deo, vel veracitati Dei asserentis illud. Et quia quod Deus asserit, supernaturaliter revelat, ideo fides assentiens tali revelato, quia assentit veracitati revelantis, est habitus supernaturalis, revelat autem credibilia, quando infundit habitum». 59 Ivi: «de fide infusa, quomodo sit ponenda in nobis, et hoc non est ita certum, an sit, vel quomodo sit ponenda in nobis, tamen potest dici quod fides infusa similis est in aliquo fidei acquisitae, imo in multis»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 7, (n. 16): «De fide autem infusa non est certum quomodo sit in nobis ponenda, tamen potest dici quod in aliquo est similis fidei acquisitae, quia sicut ibi assentitur». 60 Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 17, (n. 41): «ad quid ponitur in nobis fides infusa? Dico quod ponitur ut perficiat animam in actu primo, et actus secundus sit intensior». 61 Ibidem, n. 16, (n. 39): «non est certum et manifestum, ad quid ponenda sit fides infusa in nobis, sicut fides acquisita». 62 Ibidem, n. 17, (n. 41): «Sicut enim Deus sanans corpus, perfecte sanat, ita etiam sanans animam secundum legem suam, perfecte sanat».
13 contemporaneamente nell intelletto e nella volontà in modo soprannaturale; e così dona alla volontà il dono della carità con cui può amare perfettamente Dio...» 63. Con un linguaggio di natura logica afferma la stessa cosa utilizzando le espressione «atto primo» per intendere l intelletto e per «atto secondo» la volontà 64. Dalla descrizione dei due atti di fede, Duns Scoto afferma che essi sono intrinsecamente diversi, perché poggiano su principi differenti. Scrive: «L atto di fede acquisita e l atto di fede infusa sono di diversa ragione, perché hanno principi diversi: l atto di fede acquisita dipende dall intelletto e dalla veridicità di colui che asserisce che qualcosa è credibile, mentre l atto di fede infusa dipende dall intelletto e dalla fede infusa; dunque, da principi differenti scaturiscono atti di diversa ragione»65. Nell analisi dei due atti di fede, chiarisce sempre meglio la loro differenza. Prima di tutto stabilisce la gradualità di certezza tra l atto di fede acquisita con le altre fonti di sapere, dichiarando che esso, benché superiore all opinione, è inferiore alla scienza66, perché include sempre la possibilità del contrario o dell errore o del dubbio, nel senso che, potendo sbagliare, non ha la massima certezza67. E poi paragonandolo all atto di fede infusa, dichiara che è «più 63 Ivi: «Imago vero animae consistit in intelligentia, memoria et voluntate, quae deformatae erant per peccatum, et sanans animam perficit eam, et quantum ad intellectum et voluntatem, reformans utrumque supernaturaliter; et ideo sicut dat voluntati habitum charitatis, ut diligat perfecte Deum, licet ex naturalibus possit cum diligere ex parte obiecti, non tamen eodem modo sine charitate et cum charitate». 64 Cf Ivi: «Dat itaque, ut non solum perficiatur in actu primo, sed etiam propter actum secundum, ut intensior et perfectior sit actus dividendi ex potentia et charitate, quem ex potentia solum. Sic perficit intellectum habitu supernaturali fidei, omnino eodem modo proportionabili, non solum ut actum primum perficiat, sed ut intendat actum secundum. Differunt tamen in hoc quod charitas cum hoc quod facit actum suum acceptum, facit et actum cuiuslibet alterius potentiae acceptum, quod non facit fides»; Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 16, (n. 57): «Dico tunc, quod fides infusa est propter actum primum, et propter perfectionem gradus actus secundi, quem gradum non posset habere intellectus eum fide acquisita, solum, et si propter aliquam certitudinem maiorem velitis dicere, solvatis argumentum factum, quod non»; Reportata Parisiensia, III, d. 23, q. un., n. 20, (n. 48): «Dico itaque [...] quod fides est propter actum primum, et propter gradum perfectionem actus secundi, quem gradum non posset intellectus habere actu suo cum sola fide acquisita»; Reportata Parisiensia, III, d. 25, q. un., n. 2, (n. 6): «fides infusa non est necessaria ad determinate dicendum verum, vel assentiendum credibilibus [...], licet ad ornandum animam in actu primo, et ad causandum aliquem gradum in actu secundo». 65 Ordinatio, III, d. 23, q. un., n. 12, (n. 44): «tunc sequitur quod actus fidei acquisitae et infusae sint alterius rationis, quia habent principia alterius rationis; nam actus fidei acquisitae dependet ab intellectu et veracitate asserentis aliquid credibile; sed actus fidei infusae ab intellectu, et fide infusa; igitur ex quo principia, saltem partialia sunt alterius rationis, sequitur quod actus sint alterius rationis»; Ibidem, n. 11, (n. 41) «tunc dissimilis est fides ista [scil. infusa] ab acquisita, quia ratio tendendi in aliquod creditum fide acquisita, est veritas testis asserentis illud esse verum. 66 Ibidem, n. 5, (n. 16): «fides acquisita est super opinione, quae adheret uni parti contradictionis cum formidine alterius, licet sit infra scientiam, quae est ex evidentia obiecti scibilis». 67 Ivi:: «fides acquisita est super opinione, quae adheret uni parti contradictionis cum formidine alterius, licet sit infra scientiam, quae est ex evidentia obiecti scibilis»; Reportata Parisiensia, I, prol., q. 2, n. 13, (n. 178): «fides acquisita... includit quamdam formidinem, quia fides non habet firmitatem, nisi ex auctoritate illius
IL CONCETTO DI VIRTU IN DUNS SCOTO
 IL CONCETTO DI VIRTU IN DUNS SCOTO Situazione di crisi A nessuno sfugge che oggi il mondo sta vivendo un periodo di crisi generale, che investe tutti gli aspetti della vita e della società, dall individuo
IL CONCETTO DI VIRTU IN DUNS SCOTO Situazione di crisi A nessuno sfugge che oggi il mondo sta vivendo un periodo di crisi generale, che investe tutti gli aspetti della vita e della società, dall individuo
Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana.
 SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
SAGGIO di Angelo Marchesi Riflessioni in margine ad una opportuna distinzione tra le verità di fede e l autonomia della ragione umana. Ho letto con interesse, (come vecchio docente di Filosofia della religione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Sacra Famiglia anno B
 1 Prima lettura (Gen 15,1-6; 21,1-3) Sacra Famiglia anno B In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto
1 Prima lettura (Gen 15,1-6; 21,1-3) Sacra Famiglia anno B In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto
Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale?
 FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO
 NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
I PRONOMI E AGGETTIVI
 I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza
 L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio
 Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo. Il fine ultimo dell'uomo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
Il simbolo nicenocostantinopolitano. La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione
 Il simbolo nicenocostantinopolitano La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione Credo in unum Deum Credo in un solo Dio Punti di attenzione: affermazione del monoteismo contro
Il simbolo nicenocostantinopolitano La sintesi delle verità di fede cristiane: testo e punti di attenzione Credo in unum Deum Credo in un solo Dio Punti di attenzione: affermazione del monoteismo contro
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra
 Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine. Il conseguimento della beatitudine
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
Il credere come atto volontario secondo San Tommaso
 CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
Linee di fondo dell antropologia di Lutero. alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521
 Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Introduzione alla Teologia
 Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
Introduzione alla Teologia Settima lezione: La nascita della teologia scolastica Istituto Superiore di Scienze Religiose Giuseppe Toniolo - Pescara Prof. Bruno Marien Anno Accademico 2008-2009 11 dicembre
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE
 GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
GIOVANNI DI MIRECOURT, COMMENTO ALLE SENTENZE nato 1310/1315 legge e commenta le Sentenze a Parigi nel 1345 condannato nel 1346 morto probabilmente durante la grande peste del 1348/50 monaco cistercense
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza. Il soggetto della speranza
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza Il soggetto della speranza Prooemium Proemio [39502] IIª-IIae q. 18 pr. Deinde considerandum est de subiecto spei. Et circa hoc
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza Il soggetto della speranza Prooemium Proemio [39502] IIª-IIae q. 18 pr. Deinde considerandum est de subiecto spei. Et circa hoc
Sacra Famiglia anno C
 1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo
 Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio. L'amore di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento
 _ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
_ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA
 LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta
Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo
 Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo Da https://www.edizionistudiodomenicano.it/on-line.php = Tommaso dʼaquino, La Somma Teologica, Tr. italiana
Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo Da https://www.edizionistudiodomenicano.it/on-line.php = Tommaso dʼaquino, La Somma Teologica, Tr. italiana
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae
 Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
Prologo dell'ordinatio
 BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO Prologo dell'ordinatio Traduzione italiana con testo originale a fronte A cura del Seminario Teologico "Immacolata Mediatrice" dei Frati Francescani dell'immacolata Premessa di
BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO Prologo dell'ordinatio Traduzione italiana con testo originale a fronte A cura del Seminario Teologico "Immacolata Mediatrice" dei Frati Francescani dell'immacolata Premessa di
CRISTO RIVELA LA CHIESA SECONDO DUNS SCOTO. Lauriola Giovanni. Premessa
 CRISTO RIVELA LA CHIESA SECONDO DUNS SCOTO 1 Lauriola Giovanni Premessa Non è facile esprimere il mistero della Chiesa, secondo il pensiero di Giovanni Duns Scoto. Una delle principali difficoltà proviene
CRISTO RIVELA LA CHIESA SECONDO DUNS SCOTO 1 Lauriola Giovanni Premessa Non è facile esprimere il mistero della Chiesa, secondo il pensiero di Giovanni Duns Scoto. Una delle principali difficoltà proviene
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO
 LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
Attualità del pensiero politico di Dante?
 Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
Attualità del pensiero politico di Dante? Paolo Chiesa Università di Milano 20 dicembre 2018 Coordinate Dantesche INATTUALITA DEL PENSIERO POLITICO DI DANTE Nella Monarchia Dante si propone di esporre
!)Ku,Ky(! Luca Visone : PORTFOLIO :.
 .: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
.: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
Giannino Piana introduzione all ETiCa CRiSTiana 367 QUERiniana
 Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
Giannino Piana INTRODUZIONE ALL ETICA CRISTIANA 367 QUERINIANA Indice Prefazione.... 5 parte prima I FONDAMENTI 1. Crisi e attualità della domanda etica... 9 1. Alla radice della crisi: la ricerca delle
IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1. Giovanni Lauriola ofm. Premessa
 IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1 Giovanni Lauriola ofm Premessa Nella storia della teologia, i termini Cristocentrismo e Giovanni Duns Scoto sono talmente correlativi e complementari che l
IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1 Giovanni Lauriola ofm Premessa Nella storia della teologia, i termini Cristocentrismo e Giovanni Duns Scoto sono talmente correlativi e complementari che l
LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO
 LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO MARCO FORLIVESI La dottrina del Liber de veritate catholicæ fidei QUESTIONE GENERALE Il Liber de
LA QUESTIONE DEL RAPPORTO FRA OPERAZIONE DIVINA E OPERAZIONE CREATURALE NEL PENSIERO DI TOMMASO D AQUINO MARCO FORLIVESI La dottrina del Liber de veritate catholicæ fidei QUESTIONE GENERALE Il Liber de
LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA
 LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA Chi, superando le difficoltà della forma, è abituato a vedere i perenni problemi della teologia in molte questioni agitate dagli Scolastici,
LA NOZIONE DELLA TEOLOGIA PRESSO SCOTO E LA SCUOLA AGOSTINIANA Chi, superando le difficoltà della forma, è abituato a vedere i perenni problemi della teologia in molte questioni agitate dagli Scolastici,
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA
 IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo.
 1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
PAOLO, IL MIO FILOSOFO. Giovanni Lauriola
 PAOLO, IL MIO FILOSOFO Giovanni Lauriola L espressione Paolo è il mio Filosofo - ( Philosophus noster, Paulus est ) 1 - appartiene a Giovanni Duns Scoto, pensatore francescano del medio evo (1265-1308),
PAOLO, IL MIO FILOSOFO Giovanni Lauriola L espressione Paolo è il mio Filosofo - ( Philosophus noster, Paulus est ) 1 - appartiene a Giovanni Duns Scoto, pensatore francescano del medio evo (1265-1308),
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO
 LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO
 FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO Per cogliere il senso del fondamento della legge morale e della moralità dell atto umano, secondo Duns Scoto, bisogna sottendere da un lato la sua visione teologica
FONDAMENTO DELLA MORALITA SECONDO DUNS SCOTO Per cogliere il senso del fondamento della legge morale e della moralità dell atto umano, secondo Duns Scoto, bisogna sottendere da un lato la sua visione teologica
Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio
 Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE.
 PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
Davide Riserbato AGERE OBIECTUM. LA FINALITÀ PRATICA DELLA TEOLOGIA COME DILECTIO DEI IN PIETRO AUREOLO
 Davide Riserbato AGERE OBIECTUM. LA FINALITÀ PRATICA DELLA TEOLOGIA COME DILECTIO DEI IN PIETRO AUREOLO 1. Introduzione Tanto l uomo sa quanto opera. E tanto è sapiente quanto ama Dio e il prossimo 1.
Davide Riserbato AGERE OBIECTUM. LA FINALITÀ PRATICA DELLA TEOLOGIA COME DILECTIO DEI IN PIETRO AUREOLO 1. Introduzione Tanto l uomo sa quanto opera. E tanto è sapiente quanto ama Dio e il prossimo 1.
LA PREDESTINAZIONE DI CRISTO IN PAOLO E DUNS SCOTO
 LA PREDESTINAZIONE DI CRISTO IN PAOLO E DUNS SCOTO Il nucleo attorno al quale si organizza l intera visione teologica di Paolo è certamente l annuncio del disegno di Dio. Lo si evince da Atti (20, 27),
LA PREDESTINAZIONE DI CRISTO IN PAOLO E DUNS SCOTO Il nucleo attorno al quale si organizza l intera visione teologica di Paolo è certamente l annuncio del disegno di Dio. Lo si evince da Atti (20, 27),
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la
 Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
Gli argomenti che rientrano nel campo della Cristologia comprendono la Trinità, che tratta del rapporto fra Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e la rinascita che riguarda il rapporto fra Gesù, lo Spirito Santo
Dal latino intus-legere Leggere dentro, in profondità.
 INTELLETTO Dal latino intus-legere Leggere dentro, in profondità. DEFINIZIONE E il dono della comprensione profonda degli avvenimenti, delle cose e delle persone alla luce di Dio. Si tratta, anche, di
INTELLETTO Dal latino intus-legere Leggere dentro, in profondità. DEFINIZIONE E il dono della comprensione profonda degli avvenimenti, delle cose e delle persone alla luce di Dio. Si tratta, anche, di
Parte IV. Sistematica
 Parte IV. Sistematica I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa IV. Presentazione sistematica V. Conclusione: Maria e la
Parte IV. Sistematica I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il Mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa IV. Presentazione sistematica V. Conclusione: Maria e la
ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio
 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo Tertia pars Quaestio
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo Tertia pars Quaestio
Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato. Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a
 Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a filosofi e teologi: sviluppare una nuova visione di
Una prospettiva francescana per un umanesimo cristiano rinnovato Nella sua Enciclica del 2009, Caritas in Veritate, Benedetto XVI lancia una sfida a filosofi e teologi: sviluppare una nuova visione di
DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA
 DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA 3. LA CHIESA E L ECCLESIOLOGIA LUNGO LA STORIA - CANONISTICA - TRATTATI E APOLOGETICA - VATICANO I È necessario che questa dottrina certa ed immutabile,
DIOCESI DI JESI SCUOLA DI TEOLOGIA CORSO DI ECCLESIOLOGIA 3. LA CHIESA E L ECCLESIOLOGIA LUNGO LA STORIA - CANONISTICA - TRATTATI E APOLOGETICA - VATICANO I È necessario che questa dottrina certa ed immutabile,
Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività
 PRIN 2010-2011 Unità di Ricerca PRIN-ILIESI Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività 2013-2014 Consiglio Nazionale delle Ricerche
PRIN 2010-2011 Unità di Ricerca PRIN-ILIESI Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività 2013-2014 Consiglio Nazionale delle Ricerche
OMELIA PER LA CHIUSURA DEL VII CENTENARIO DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO (Castellana Grotte, 8.11.
 OMELIA PER LA CHIUSURA DEL VII CENTENARIO DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO (Castellana Grotte, 8.11.1992) Eccellenze Reverendissime, Autorità, Signore e Signori, Oggi, 8 novembre
OMELIA PER LA CHIUSURA DEL VII CENTENARIO DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO (Castellana Grotte, 8.11.1992) Eccellenze Reverendissime, Autorità, Signore e Signori, Oggi, 8 novembre
MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA?
 Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
NON VOGLIO CHE SIATE NELL IGNORANZA
 NON VOGLIO CHE SIATE NELL IGNORANZA In 3 argomenti fondamentali, il popolo di Dio non può permettersi di essere nell ignoranza. I doni dello Spirito Santo 1 CORINZI 12 La resurrezione dei morti 1 TESSALONNICESI
NON VOGLIO CHE SIATE NELL IGNORANZA In 3 argomenti fondamentali, il popolo di Dio non può permettersi di essere nell ignoranza. I doni dello Spirito Santo 1 CORINZI 12 La resurrezione dei morti 1 TESSALONNICESI
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE
 I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
La fede - caro amico associato - è
 Cammino di perfezione/22 Làsciati illuminare dalla luce della fede: essa ti unisce a Dio La fede - caro amico associato - è una luce potentissima che penetra le ombre e squarcia le tenebre. Non si dà fede
Cammino di perfezione/22 Làsciati illuminare dalla luce della fede: essa ti unisce a Dio La fede - caro amico associato - è una luce potentissima che penetra le ombre e squarcia le tenebre. Non si dà fede
68 h 40 min km. Da Kant a Hegel
 Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
TOMMASO D'AQUINO. Legge naturale e legge umana
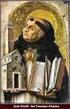 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Il fondamento teologico della prassi del battesimo dei bambini in S. Tommaso d Aquino
 1 Gilles Emery, O.P. Lectio magistralis tenuta in occasione della cerimonia di conferimento del Premio internazionale Tommaso d Aquino Aquino, 4 marzo 2017 Il fondamento teologico della prassi del battesimo
1 Gilles Emery, O.P. Lectio magistralis tenuta in occasione della cerimonia di conferimento del Premio internazionale Tommaso d Aquino Aquino, 4 marzo 2017 Il fondamento teologico della prassi del battesimo
COMPENDIO DI TEOLOGIA FONDAMENTALE
 Salvador Pié-Ninot COMPENDIO DI TEOLOGIA FONDAMENTALE Editrice Queriniana Indice generale Prefazione... 5 1. La teologia fondamentale: identità e storia... 9 Bibliografia 9 I. Introduzione 10 II. Nota
Salvador Pié-Ninot COMPENDIO DI TEOLOGIA FONDAMENTALE Editrice Queriniana Indice generale Prefazione... 5 1. La teologia fondamentale: identità e storia... 9 Bibliografia 9 I. Introduzione 10 II. Nota
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI
 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana
 La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana Il tema che qui desidero sviluppare è il significato antropologico della grazia come partecipazione
La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana Il tema che qui desidero sviluppare è il significato antropologico della grazia come partecipazione
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
~ 7 ~ riportato una traduzione libera nel mio San Zanobi. Vita, reliquie, iconografia, Phasar ed., 2005, Firenze, p. 118.
 I sei sermoni di Remigio dei Girolami 1 (1247-1319), dei quali presentiamo il testo, sono tra le pochissime composizioni omiletiche conosciute dedicate a san Zanobi e, forse, le più antiche che ci sono
I sei sermoni di Remigio dei Girolami 1 (1247-1319), dei quali presentiamo il testo, sono tra le pochissime composizioni omiletiche conosciute dedicate a san Zanobi e, forse, le più antiche che ci sono
Cataldo Zuccaro. Teologia morale fondamentale
 Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
Cataldo Zuccaro Teologia morale fondamentale QUERINIANA Indice Introduzione.... 5 I. Questioni epistemologiche iniziali. Scoprire le carte... 9 1. Epistemologie, scienze, teologia 10 1.1 Frantumazione
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LA SOMMA TEOLOGICA. eso S. TOMMASO D AQUINO. L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA
 S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile
 S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
COLLEGIO PLENARIO DOCENTI
 COLLEGIO PLENARIO DOCENTI 7 FEBBRAIO 2019 INTRODUZIONE Sfondo magisteriale e contesto attuale (frammentazione e complessità). 1. IL TERZO CRITERIO PER IL RINNOVAMENTO DEGLI STUDI ECCLESIASTICI Il punto
COLLEGIO PLENARIO DOCENTI 7 FEBBRAIO 2019 INTRODUZIONE Sfondo magisteriale e contesto attuale (frammentazione e complessità). 1. IL TERZO CRITERIO PER IL RINNOVAMENTO DEGLI STUDI ECCLESIASTICI Il punto
possibili [LEIBNIZ, Discours de Metaphysique, 6: GP IV 431; cfr. GP III 558; VI 244, 241,
 Gennaro AULETTA Il problema della scelta di Dio. Un breve esame di una tesi di Leibniz alla luce della discussione medievale Summary: Leibniz thesis that God chooses the best possible world is analyzed.
Gennaro AULETTA Il problema della scelta di Dio. Un breve esame di una tesi di Leibniz alla luce della discussione medievale Summary: Leibniz thesis that God chooses the best possible world is analyzed.
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica
 PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
PEDAGOGIA Tommaso d Aquino e la Scolastica Tassi, I saperi dell educazione, cap. 1, pp. 5-19 Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 1, pp. 479-83 + testo pp. 502-503 SCOLASTICA = filosofia cristiana del
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
Relazione incontro su CCC (1992): struttura e contenuti Prof. Don Mauro Angelini
 Relazione incontro su CCC (1992): struttura e contenuti Prof. Don Mauro Angelini Presentazione del testo Nel 1985 Giovanni Paolo II convoca l Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in occasione
Relazione incontro su CCC (1992): struttura e contenuti Prof. Don Mauro Angelini Presentazione del testo Nel 1985 Giovanni Paolo II convoca l Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in occasione
Pag. 1 AI SACERDOTI DI ROMA: 14 DICEMBRE ( 71?)
 Pag. 1 AI SACERDOTI DI ROMA: 14 DICEMBRE ( 71?) 1. Un ora di adorazione insieme in preparazione del Natale (cf. Mysterium fidei): conferma in noi la pietà eucaristica; dà l esempio di ciò che dobbiamo
Pag. 1 AI SACERDOTI DI ROMA: 14 DICEMBRE ( 71?) 1. Un ora di adorazione insieme in preparazione del Natale (cf. Mysterium fidei): conferma in noi la pietà eucaristica; dà l esempio di ciò che dobbiamo
FRANCESCO D APPIGNANO
 1 2 CENTRO STUDI FRANCESCO D APPIGNANO COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO Atti del III Convegno Internazionale su FRANCESCO D APPIGNANO a cura di DOMENICO PRIORI Appignano del Tronto 24 settembre 2005 Sommario
1 2 CENTRO STUDI FRANCESCO D APPIGNANO COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO Atti del III Convegno Internazionale su FRANCESCO D APPIGNANO a cura di DOMENICO PRIORI Appignano del Tronto 24 settembre 2005 Sommario
DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA
 DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA SIGNIFICATI DELL ESPRESSIONE DIRITTO COMUNE Diritto generale e universale, civile e canonico (Utrumque ius) Diritto generale rispetto ai diritti particolari
DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA SIGNIFICATI DELL ESPRESSIONE DIRITTO COMUNE Diritto generale e universale, civile e canonico (Utrumque ius) Diritto generale rispetto ai diritti particolari
Introduzione CoglIere la grazia della verifica
 Cogliere la grazia della verifica La vita monastica secondo l insegnamento della Regola di san Benedetto trova la sua ragione d essere in quanto itinerario di trasformazione (conversatio) dei monaci e
Cogliere la grazia della verifica La vita monastica secondo l insegnamento della Regola di san Benedetto trova la sua ragione d essere in quanto itinerario di trasformazione (conversatio) dei monaci e
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è la sua opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è la sua opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito]
![NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito] NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito]](/thumbs/54/34540019.jpg) NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO [Dialogus de deo abscondito] Testo italiano e testo latino 2 NICOLA CUSANO (1401-1464) [1] Dialogo sul Dio nascosto tra due, dei quali l'uno gentile, l'altro Cristiano Dice
NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO [Dialogus de deo abscondito] Testo italiano e testo latino 2 NICOLA CUSANO (1401-1464) [1] Dialogo sul Dio nascosto tra due, dei quali l'uno gentile, l'altro Cristiano Dice
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio. Giustizia e misericordia di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio Giustizia e misericordia di Dio Prima pars Quaestio 21 Prooemium Prima parte Questione 21 Proemio [29324] Iª q. 21 pr. Post considerationem
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio Giustizia e misericordia di Dio Prima pars Quaestio 21 Prooemium Prima parte Questione 21 Proemio [29324] Iª q. 21 pr. Post considerationem
Centro Informazioni turisti
 11/01/2016 09:39:16 Generale Nome sondaggio Centro Informazioni turisti Autore Richard Žižka Lingua Italiano URL Sondaggio http://www.survio.com/survey/d/v5o1a2q6h2p6a4c6a Prima risposta 28/02/2014 Ultima
11/01/2016 09:39:16 Generale Nome sondaggio Centro Informazioni turisti Autore Richard Žižka Lingua Italiano URL Sondaggio http://www.survio.com/survey/d/v5o1a2q6h2p6a4c6a Prima risposta 28/02/2014 Ultima
RELIGIONE IRC Monoennio. Competenza 1. - DIO E L UOMO Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre.
 RELIGIONE IRC Monoennio Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre. -IL LINGUAGGIO i segni cristiani nell ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. - Comprendere che il creato,
RELIGIONE IRC Monoennio Scoprire che per la religione Dio è Creatore e Padre. -IL LINGUAGGIO i segni cristiani nell ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. - Comprendere che il creato,
Robert Codjo Sastre. Vita evangelica e fede cristiana in Africa
 Robert Codjo Sastre Vita evangelica e fede cristiana in Africa Célestin Coomlan Avocan ROBERT CODJO SASTRE Vita evangelica e fede cristiana in Africa biografia www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
Robert Codjo Sastre Vita evangelica e fede cristiana in Africa Célestin Coomlan Avocan ROBERT CODJO SASTRE Vita evangelica e fede cristiana in Africa biografia www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CATTOLICA
 DIO E L UOMO Classe prima Classe seconda Classe terza Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza Suscitare nei bambini l attitudine all attenzione, alla curiosità e un atteggiamento di scoperta
DIO E L UOMO Classe prima Classe seconda Classe terza Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza Suscitare nei bambini l attitudine all attenzione, alla curiosità e un atteggiamento di scoperta
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat
 Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
Dio e l uomo OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI IRELIGIONE CATTOLICA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI CLASSE PRIME CLASSI SECONDE CLASSE TERZA
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI IRELIGIONE CATTOLICA PRIMARIA Dio e l uomo CLASSE PRIME CLASSI SECONDE CLASSE TERZA Dio e l uomo Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI IRELIGIONE CATTOLICA PRIMARIA Dio e l uomo CLASSE PRIME CLASSI SECONDE CLASSE TERZA Dio e l uomo Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
