Prologo dell'ordinatio
|
|
|
- Renato Damiano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO Prologo dell'ordinatio Traduzione italiana con testo originale a fronte A cura del Seminario Teologico "Immacolata Mediatrice" dei Frati Francescani dell'immacolata Premessa di P. Peter Damian M. Fehlner, FI Introduzione di P. Alessandro M. Apollonio, FI CASA MARIANA EDITRICE
2 Testo latino tratto da IOANNIS DUNS SCOTI, Opem Omnia, Ordinatio, Prologus, Città del Vaticano, 1950, voi. I, pp Nihil Obstat ex parte ordinis quominus opus cui titulus: "Prologo dell'ordinatio" Imprimatur: Pater Stephanus M. Manelli Min. Gen. FI Data: 8 settembre 2006 Collana: "QUADERNI DI STUDI SCOTlsn" Direttore responsabile: P. PETER DAMIAN M. FEHLNER, FI Sede: Frati Francescani dell'immacolata Santuario "Madonna delle Indulgenze" Casalucense Sant'Elia Fiumerapido (FR) Copyright 2006 Casa Mariana Editrice via dell'immacolata, Frigento (AV) tel.lfax ISBN
3 Prologo deii'ordinatio
4 PARSPRIMA DE NECESSITATE DOCTRINAE REVELATAE LA NECESSITÀ DELLA DOTTRINA RIVELATA QUAESTIO UNICA UTRUM HOMINI PRO STATU ISTO SIT NECESSARIUM ALIQUAM DOCTRINAM SUPERNATURALITER INSPIRARI [1] Quaeritur utrum homini pro statu isto sit necessarium aliquam doctrinam specialem supernaturaliter inspirari, ad quam videlicet non posset attingere lumine naturali intellectusl. Et quod non, arguo sic: omnis potentia habens aliquod commune pro primo obiecto, potest naturaliter in quodlibet contentum sub ipso sicut in per se obiectum naturale. Hoc probatur per exemplum de primo obiecto visus et aliis contentis sub illo, et ita inductive in aliis obiectis primis et potentiis. Probatur etiam per rationem, quia primum obiectum dicitur quod est adaequatum cum potentia; sed si in aliquo esset ratio eius, scilicet primi obiecti, circa quod non posset potentia habere actum, non esset potentia adaequata, sed obiectum excederet potentiam. Patet igitur maior. Sed primum obiectum intellectus nostri naturale est ens in quantum ens; ergo intellectus noster potest naturaliter habere actum circa quodcumque ens, et sic circa quodcumque intelligibile non-ens, quia negatio cognoscitur per affirmationem 2. Ergo etc. Probatio minoris, Avicenna I Metaphysicae cap. 5: «Ens et l'es prima impressione in animam QUESTIONE UNICA SE È NECESSARIO CHE ALL 'UOMO SIA RIVELATA SOPRANNATURALMENTE UNA QUALCHE DOTTRINA Si ricerca se è necessario che all'uomo, nel presente stato, [1] sia soprannaturalmente comunicata, per divina ispirazione [inspirari], una qualche dottrina speciale alla quale, cioè, egli non possa giungere con il lume naturale dell'intelletto. Sembra di no, per le seguenti ragioni. (a) Ogni facoltà, avente qualche ente comune come oggetto primo, ha naturalmente potere di percezione su qualsiasi cosa che è contenuta al di sotto dello stesso, come sull'oggetto naturale per sé. Questo si prova con l'esempio dell'oggetto primo della vista e delle altre cose contenute sotto di esso e così, in modo induttivo, con ciò che è contenuto in altri oggetti primi e nelle facoltà [corrispondenti]. Lo si prova anche con la ragione perché è detto "oggetto primo" ciò che è adeguato alla facoltà; ma se in qualcosa ci fosse la ragione dell'oggetto primo, e la facoltà non potesse avere il suo atto circa tale oggetto, la facoltà non sarebbe adeguata, poiché l'oggetto sarebbe eccedente la stessa facoltà. La maggiore a è dunque evidente l. l Cf. DUNS SCOTUS, Leetllra, pro!., pars l, q. un. 2 Cf. ARISTOT., Ano/. Post., I, c. 24 [ t. 40] (A c. 25, 86b 34-35). 2 l Il Beato Scoto procede normalmente seguendo il metodo sillogistico, secondo cui ogni ragionamento corretto dev'esser composto da due premesse -legate tra loro da un termine medio -, e una conclusione che componga o disgiunga tra loro gli estremi delle due premesse. Ora, la prima premessa, 3
5 imprimuntur, nec possunt manifestari ex aliis»3; si autem esset aliquidaliud ab istis primum obiectum, ista possentmanifestari per rationem eius; sed hoc est impossibile. [2J Praeterea, sensus non indiget aliqua cognitione supernaturali pro statu isto; ergo nec intellectus. Antecedens patet. Probatio consequentiae: «Natura non deficit in necessariis», III De anima 4 ; et si in imperfectis non deficit, multo magis nec in perfectis; ergo si non deficit in potentiis inferioribus quantum adnecessaria earum propter actus suos habendos et finem earum consequendum, multo magis nec deficit in necessariis potentiae superiori ad actum suum et finem consequendum. Ergo etc 5 (b) Ma l'oggetto primo naturale della nostra intelligenza è l'ente in quanto ente; dunque il nostro intelletto può naturalmente conoscere [habere actumj qualsiasi ente e quindi anche qualsiasi non-ente intelligibile, perchè la negazione si conosce attraverso l'affennazione. Dunque, ecc. La prova della minoreb si ha da Avicenna, libro I, cap. 5, de La metqfisica: «L'ente e la cosa sono impressi nell'anima con la prima impressione, e non possono essere manifestati da altro»; se invece qualcosa di diverso da questi 2 fosse l'oggetto primo, l'ente e la cosa potrebbero essere manifestati mediante la ragione di questo oggetto primo; ma ciò è impossibile. Inoltre, il senso non ha bisogno di alcuna conoscenza so- [2J prannaturale nel presente stato, dunque nemmeno l'intelletto. L'antecedente è evidente. Prova della conseguenza: «La natura non viene meno nelle cose necessarie», libro III de L'anima; e se non è manchevole nelle cose imperfette, tanto più [non mancheràj in quelle perfette; dunque, se la natura non è deficiente nelle facoltà inferiorì3 quanto alle cose loro necessarie per avere i propri atti e per conseguire il loro fine, molto più non sarà mancante delle cose necessarie alla facoltà superiore 4 per realizzare il suo atto ed il conseguimento del fine. Dunque... 3 AVICENNA, Metaph., l, c. 6 (72 rb). 4 ARISTOT., De an., lll, t. 45 (f c. 9, 432b 21-32). 5 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 1, q. 4, argo 2. 4 (l f. IlA). 4 ordinariamente, è detta maggiore, la seconda minore. Per facilitare la loro identificazione, laddove ve ne fosse l'utilità, si sono contraddistinte le due premesse con lettere tra parentesi: (a) la maggiore; (b) la minore. Quando, nel corso dell'argomentazione, vi è il riferimento ad una premessa, la lettera coitispondente è messa in esponente, per es. a. 2 Ossia l'ente e la cosa. Per «ente e la cosa» si può intendere l'ente in quanto ente e l'essenza della cosa materiale, ovvero l'oggetto proprio e l'oggetto primo della conoscenza. 3 Ossia, il senso interno ed esterno, ecc. 4 Ossia, l'intelletto. 5
6 [3] Praeterea, si aliqua talis doctrina sit necessaria, hoc est quia potentia in puris naturalibus est improportionata obiecto ut sic cognoscibili; ergo oportet quod per aliquid aliud a se fiat ei proportionata. Illud aliud aut est naturale, aut supernaturale; si naturale, ergo totum est improportionatum primo obiecto; si supernaturale, ergo potentia est improportionata illi, et ita per aliud debet proportionari, et sic in infinitum. Ergo cum non sit procedere in infinitum, II Metaphysicae6, oportet stare in primo, dicendo quod potentia intellectiva sit proportionata omni cognoscibili et secundum omnem modum cognoscibilis. Ergo etc 7. [4] Ad oppositum: Omnis doctrina divinitus inspirata utilis est ad arguendum (2 Tm 3,16) etc. Praeterea, de sapientia dicitur: Non est qui possit scire vias eius, sed qui scit universa novit eam (Bar 3,31-32); ergo nullus alius potest habere eam nisi a sciente universa. Hoc quantum ad necessitatem eius. De facto autem subdit: Tradidit eam Iacob puero suo et Israel dilecto suo (Bar 3, 37), quantum ad Vetus Testamentum; et sequitur: Post haec in terris visus est et cum hominibus conversatus est (Bar 3,38), quantum ad Novum Testamentum. Inoltre, se una tale dottrina 5 fosse necessaria, ciò sarebbe [3] perché la facoltà nella sua realtà puramente naturale non è proporzionata alla conoscenza dell'oggetto come tale; dunque è necessario che diventi proporzionata ad esso per mezzo di qualcosa di diverso da sé. Quest'altra causa [illud aliudj o è nahlrale o soprannaturale; se naturale, è dunque totalmente sproporzionata all'oggetto primo; se è soprannaturale, la facoltà è sproporzionata a quel mezz0 6, per cui dev'esser proporzionata per mezzo di qualcos'altro, e così via all'infinito. Dunque, non essendo giusto procedere all'infinito, come dice Aristotele nel libro II, de La metafisica, bisogna stare alla prima affermazione, e dire che la facoltà intellettiva è proporzionata ad ogni conoscibile secondo ogni suo modo. Dunque... [non è necessaria una dottrina rivelata in modo soprannaturale]. In contrario: [4] «Ogni dottrina divinamente ispirata è utile per insegnare» ecc. (II Tim 3, 16)7. Inoltre, in Bamc, 3, è detto della Sapienza: «Non c'è nessuno che possa conoscere le sue vie, ma chi conosce tutte le cose la conosce»8; dunque nessun altro può possederla se non colui che conosce ogni cosa. Questo quanto alla necessità di una dottrina divinamente ispirata [eius]. Quanto all'esistenza di fatto di tale dottrina, relativamente all'antico Testamento, Bamc afferma:«la diede a Giacobbe suo figlio, a Israele suo 6 Cf. ARrSTOT., Metaph., II, t (a c. 2, 994a l-994b 31). 7 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 3, q. 5, argo 2 (I f. 29S). 6 5 Ossia, la dottrina soprannaturalmente ispirata. 6 Ossia, all'altra causa «intermedia». 7 «Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona» (II Tim 3, 16). 8 «Nessuno conosce la sua via, nessuno pensa al suo sentiero. Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza» (Bar 3, 31-32). 7
7 diletto»9, e aggiunge: «Dopo queste cose è apparsa sulla terra ed ha abitato con gli uomini»lo, in relazione al Nuovo Testamento. I. - CONTROVERSIA INTER PHILOSOPHOS ET THEOLOGOS [5] In ista quaestione videtur controversia inter philosophos et theologos. Et tenent philosophi perfectionem naturae, et negant perfectionem supernaturalem; theologi vero cognoscunt defectum naturae et necessitatem gratiae et perfectionem supernaturalem. A. - OPINIO PHILOSOPHORUM Diceret igitur philosophus quod nulla est cognitio supernaturalis homini necessaria pro statu isto, sed quod omnem cognitionem sibi necessariam posset acquirere ex actione causarum naturalium 8 Ad hoc adducitur simul auctoritas et ratio philosophi ex diversis locis. [6] Primo illud III De anima, ubi dicit quod «intellectus agens est quo est omnia facere, et possibilis est quo est omnia fieri». Ex hoc arguo sic: activo naturali et passivo simul approximatis et non impeditis sequitur actio necessario 9, quia non dependet essentialiter nisi ex eis tamquam ex causis prioribus; activum autem respectu omnis intelligibilis est intellectus agens, et passivum est intellectus possibilis, et haec sunt naturaliter in anima, nec sunt impedita. Patet. Ergo virtute naturali istorum 8 Cf. AVERRoEs, Metaph., II, com. 1; De an., 111, com. 36; cf. etiam HEN RICUS GAND., Summa, a. 4, q. 5, in corpo (I f. 33E. 32B). 9 Cf. ARISTOT., Metaph., IX, t. lo (8 c.5, 1048a 5-7). 8 I. - CONTROVERSIA TRA I FILOSOFI E I TEOLOGI In questa questione sembra che ci sia disaccordo tra filosofi [5] e teologi. I filosofi sostengono la perfezione della natura, e negano la perfezione soprannaturale; i teologi, invece, conoscono i difetti della natura, la necessità della grazia e la perfezione soprannaturale. A. - OPINIONE DEI FILOSOFI Il filosofo direbbe, dunque, che nessuna conoscenza soprannaturale è necessaria all'uomo nel presente stato, ma che egli possa acquisire ogni conoscenza necessaria a sé tramite l'azione delle cause naturali. Per provare ciò viene addotta l'autorità e l'argomentazione del Filosofo, che ha parlato di ciò in diver SI passi. Innanzi tutto nel libro III de L'anima, dove dice che «l'in- [6] telletto agente è ciò per cui sono fatte tutte le cose [sul piano intenzionale], e l'intelletto possibile è quello per cui divengono tutte le cose»l1. Di qui la seguente argomentazione: ad 9 «Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo servo, a Israele suo diletto» (Bar 3, 37). IO «Per questo è apparsa sulla tena e ha vissuto fra gli uomini» (Bar 3, 38). Il «xnì fa1'w 6 Ilèv 1'owiÌ't'oç voùç 't'c{> nàv't'11 Y VWlJ~tE 6 aè 1'<{> nàv1'~ notetv» (ARISTOTELE, De ano, III, t. 18 (1 C. 5, 430a 14-15). S. Tommaso, riguardo all'intelletto agente e possibile, si esprime nei se- 9
8 potest sequi actus intelligendi respectu cuiuscumque intelligibilis 1o [7] Confirmatur ratione: omni potentiae naturali passivae correspondet aliquod activum naturale, alioquin videretur potentia passiva esse frustra in natura si per nihil in natura posset reduci ad actum; sed intellectus possibilis est potentia passiva respectu quorumcumque intelligibilium; ergo correspondet sibi aliqua potentia activa naturalisii. Sequitur igitur propositum. Minor patet, quia intellectus possibilis naturaliter appetit cognitionem cuiuscumque cognoscibilis; naturaliter etiam perficitur per quamcumque cognitionem; igitur est naturaliter receptivus cuiuscumque intellectionis. [8] Praeterea, VI Metaphysicae distinguitur habitus speculativus in mathematicam, physicam et metaphysicam; et ex probatione eiusdem, ibidem, non videtur possibile esse plures habitus esse speculativos, quia in istis consideratur de toto ente, et in se et quoad omnes partes l2 Sicut autem non posset esse aliqua IO Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. l, q. 5 ad 2 (f. 15t); a. 3, q. 2, argo l, et in corp.(f. 28E-F). Il Cf. ARISTaT., De an., III, t. 17 (f' C. 5, 430a 10-14); Metaph. V, t. 17 (~ C. 12, l 019a b 15); De caelo, I, t. 32 (A C. 4, 271a 32-33); AVER ROES, Metaph., II, com ARISTOT., Metaph., VI, t. 2 (E C. 1,1026 a 18-19); et t. 1-2 (col b a 19). lo un [principio] attivo naturale e ad un [principio] passivo congiunti insieme e non impediti, segue necessariamente un'azione, perché questa non dipende essenzialmente se non da loro, intese come cause prime; il [principio] attivo, dunque, rispetto ad ogni intelligibile, è l'intelletto agente, mentre il passivo è l'intelletto possibile; questi [principi] si trovano naturalmente nell'anima, e [perciò] non sono impediti. È evidente. Dunque, per la capacità naturale di questi [principi], può seguire un atto di intelligenza rispetto a qualsiasi intelligibile. La tesi è confermata dalla seguente ragione: (a) ad ogni fa- [7] coltà naturale passiva corrisponde una [facoltà] naturale attiva, altrimenti la facoltà passiva in natura sembrerebbe vanificata, se nulla in natura la potesse ridurre all'atto; (b) ma l'intelletto possibile è una facoltà passiva rispetto a qualunque intelligibile; dunque corrisponde ad esso una qualche facoltà naturale attiva. È confermata, dunque, la tesi. La minoreh si evidenzia dal fatto che l'intelletto possibile è naturalmente proteso alla conoscenza di qualunque intelligibile, ed è naturalmente perfezionato per mezzo di qualsiasi conoscenza; dunque recepisce naturalmente qualsiasi [tipo di] conoscenza intellettiva. Inoltre, nel libro VI de La metqfisica, l'abito speculativo si [8] distingue in matematica, fisica e metafisica; e dalla dimostrazione di ciò, nello stesso luogo, non sembra possibile che ci siano [oltre a questi] altri abiti speculativi, perché in questi si guenti termini, citando Aristotele, libro III de L'anima: «Aristotele insegna che l'intelletto possibile è la potenza a diventare tutte le cose, e l'intelletto agente la potenza a far diventare tutte le cose» (cf. SAN TOMMASO D'AQUINo, La Somma Teologica, I, q. 88, a. l, risposta al sesto, ed. Salani, trad. it. a cura dei Domenicani italiani, Firenze 1956, voi. VI, p. 126); ancora: «Dice il Filosofo che come nella natura, così anche nell'anima, vi è un principio per cui essa è in potenza a diventare tutte le cose, e un principio, per cui tutto rende attuale. Si deve dunque ammettere un intelletto agente» (cf. Id., I, q. 79, a. 3, risposta al quinto, ed. cit., p. 314). 11
9 speculativa alia ab istis, sic nec posset esse aliqua alia practica a practicis acquisitis activis et factivis. Ergo scientiae practicae acquisitae sufficiunt ad perficiendum intellectum practicum et speculativae acquisitae sufficiunt ad perficiendum intellec~lm speculativum13. [9] Pra~terea, potens naturaliter intelligere principium, potest naturallter cognoscere conclusiones inclusas in principio. Ranc concl.u~ion~mprobo, quia scientia conclusionum non dependet msi ex mtellectu principii et deductione conclusionum ex principio, sicut patet ex definitione 'scire' I Posteriorum 14; sed dedu~t.io est ex se manifesta, sicut patet ex syllogismi perfecti defimtlon.e I Priorum l5, quia «nullius est indigens ut sit vel appareat evidenter necessarius»; igitur si principia intelligantur, habentur omnia quae sunt necessaria ad scientiam conclusionis. Et sic patet maior. [lo] ~ed ~aturaliter intelligimus prima principia, in quibus virtuallter I~cluduntur omnes conclusiones; ergo naturaliter possumus SClre omnes conclusiones scibiles..probatio primae partis minoris: quia termini principiorum pnmorum sunt communissimi, igitur illos naturaliter possu-. 13 Cf. HENRICUS GAND., SUlJ1ma, a. 2, q. 3, in corpo (f. 24M); a. 3, q. 3, m corpo et argo 2 (f. 29L. K). - THOMAS, De vel'itate, q. 14, a. lo argo 3 (ed. Pannen. IX 242b). 14 ARlSTaT., Ana!. Post., I, C. 2 [t. 5J (A C. 2 7 l b 9-12). 15 ARISTOT., Anal. PriOl:, I, C. l (A C. l 24b 22-24). 12 considera l'ente nella sua totalità, ossia in se stesso e in tutte le sue parti. Come non ci potrebbe essere alcuna [scienza] speculativa oltre a questi [abiti speculativi], così non ci potrebbe essere alcun'altra [scienza] pratica diversa da quegli [abiti] pratici acquisiti, attivi e fattivi [activis et jactivis]. Dunque, le scienze pratiche acquisite sono sufficienti alla perfezione dell'intelletto pratico, e [le scienze] speculative acquisite sono sufficienti alla perfezione dell'intelletto speculativo. Inoltre, (a) colui che può naturalmente conoscere intellet- [9] tivamente il principio, può naturalmente conoscere le conclusioni contenute nel principio. Provo questa deduzione: la conoscenza delle conclusioni non dipende se non dalla conoscenza del principio e dalla deduzione delle conclusioni dal principio, come risulta evidente dalla definizione di «conoscere» che si trova in Aristotele, libro I degli Analitici posteriori; ma la deduzione è manifesta per se stessa, come risulta evidente dalla definizione del sillogismo perfetto data da Aristotele, nel libro I degli Analitici primi, poiché esso «non manca di nulla affinché sia o appaia evidentemente necessario»; dunque, se si conoscono i principi, si ha tutto il necessario per conoscere le conclusioni. E così è provata la maggiore a (b 1) Ma con le nostre capacità naturali noi conosciamo [lo] intellettivamente i primi principi, (b2) nei quali virtualmente sono incluse tutte le conclusioni. Dunque, possiamo naturalmente conoscere tutte le conclusioni conoscibili. Provo la prima pmie della minore b1 : poiché i termini dei primi principi sono comunissimi, dunque li possiamo conoscere naturalmente, come risulta da Aristotele, nel libro I de Lafisica, secondo cui le cose comunissime sono conosciute imme- 13
10 PARTE PRlMA [l1j mus intelligere, quia ex I Physicorum l6 communissima primo intelliguntur; «principia autem cognoscimus et intelligimus in quantum tenninos cognoscimus», I Posteri07'um 1?; ergo prima principia possumus naturaliter conoscerel 8 Probatio secundae partis minoris: quia termini primorum principiorum sunt communissimi, igitur quando distribuuntur, distribuuntur pro omnibus conceptibus inferioribus; accipiuntur autem tales termini universaliter in primis principiis, et ita extendunt se ad omnes conceptus particulares, et per consequens ad extrema omnium conclusionum specialium. diatamente [primo ]12; orbene, ancora secondo Aristotele, nel libro I degli Analitici posteriori, «noi conosciamo e comprendiamo i primi principi in quanto conosciamo i [loroj termini»; dunque possiamo conoscere naturalmente i primi principi. Provo la seconda parte della minore b2 : i termini dei primi [11 J principi sono comunissimi, dunque quando sono 'distribuiti' 13, lo sono su tutti i concetti inferiori; tali termini sono usati universalmente nei primi principi, e così si estendono a tutti i concetti particolari, e di conseguenza anche agli estremi di tutte le conclusioni speciali. B. - IMPROBATIO OPINIONIS PmLosoPHORUM B. - CONFUTAZIONE DELL'OPINIONE DEI FILOSOFI [12J Contra istam positionem tripliciter potest argui. Nota, nullum supernaturale potest ratione naturali ostendi inesse viatori, nec necessario requiri ad perfectionem eius; nec etiam habens potest cognoscere illud sibi inesse. Igitur impossibile est hic contra Aristotelem uti ratione naturali: si arguatur ex creditis, non est ratio contra philosophum, quia praemissam creditam non concedet. Unde istae rationes hic factae contra ipsum alteram praemissam habent creditam vel probatam ex credito; ideo non sunt nisi persuasiones theologicae, ex creditis ad creditum. 16 ARISTOT., Physic., l, t. 3 (A c a 21-22). 17 ARlSTOT., Anal. post., l, c. 3, [t. 6] (A c. 3 72b 23-25). 18 Cf. HENRlCUS GAND., Summa, a. 6, q. 1, argo l, (l f. 42A). 14 Contro questa posizione si può argomentare in tre modi. [12J Nota bene: non si può dimostrare, per mezzo della ragione naturale, che ci sia alcunché di soprannaturale nel viatore, né che il soprannaturale si richieda necessariamente alla sua perfezione; e nemmeno colui che possiede [il soprannaturalej può co- 12 Primo è, per Duns Scoto, l'avverbio che dice riferimento ad una serie ordinata di cause di cui la prima influisce su tutte le altre, senza esserne influenzata a sua volta. Più genericamente, "primo" sta per "immediatalnente". 13 A questa argomentazione risponde Duns Scoto avanti, ai nn In logica, si ha la distribuzione di un termine universale quando esso è riferito separatamente ai soggetti che costituiscono la sua estensione: «La distribuzione [in logica] è la moltiplicazione di un termine comune fatta per mezzo di un segno universale. Ad es. quando si dice "ogni uomo" viene distribuito o scambiato per ogni suo termine inferiore tramite il segno "ogni"; e così vi si trova la moltiplicazione comune. Dico poi "termine comune" perché il termine singolare non può esser distribuito. Infatti, le seguenti espressioni sono incoerenti: "ogni Socrate", "ogni Platone", e altre simili» (cf. PETRUS HISPANUS, Tractatus, ti'. 12, ed. L. M. De Rijk, Assen 1972, p. 209 ss.). 15
11 [13] Prima ratio principalis - Primo sic: omni agenti per cognitionem necessaria est distincta cognitio sui finis 19 Ranc probo, quia omne agens propter finem agit ex appetitu finis 20 ; omne per se agens agit propter finem 21 ; igitur omne per se agens suo modo appetit finem. Igitur sicut agenti naturali est necessarius appetitus finis propter quem debet agere, ita agenti per cognitionem - quod etiam est per se agens, ex II Physicorum 22 - necessarius est appetitus sui finis propter quem debet agere 23 Patet ergo maior. Sed homo non potest scire ex naturalibus finem suum distincte; igitur necessaria est sibi de hoc aliqua cognitio supernaturalis 24 noscere che quello si trova dentro di lui. Dunque, è impossibile argomentare su questo punto contro Aristotele per mezzo della ragione naturale: se poi si argomentasse a partire dalle verità di fede, ciò non sarebbe una ragione valida contro il filosofo, perché egli non concederebbe le premesse di fede. Ne consegue che queste ragioni qui esposte contro lo stesso [filosofo], avendo una premessa creduta [per fede] o fondata su ciò che si crede [per fede]; sono solo persuasioni teologiche, che partono da verità di fede, e giungono ad altre verità di fede. Prima ragione principale (a) A chiunque agisce con co- [13] gnizione, è necessaria la conoscenza distinta del proprio fine. Provo questo: chiunque agisce per un fine, agisce [mosso] dal desiderio del fine; chiunque agisce per sé, agisce per un fine; dunque, chiunque agisce per sé, tende a suo modo verso il fine. Dunque, come all'agente naturale è necessaria l'inclinazione verso il fine [appetitus finis] per il quale deve agire, così all'agente consapevole - che è anche agente per sé, come è detto da Aristotele, nel libro II de Lafisica - è necessaria l'inclinazione al suo fine per il quale deve agire. Dunque la maggiore è evidente. (b) Ma l'uomo non può conoscere con le facoltà naturali, in modo distinto, il suo fine proprio; dunque, per conoscerlo [de hoc] gli è necessaria una certa cognizione soprannaturale. 19 Cf. THOMAS, S. theo/., I, q. 1, a. 1, in corpo (IV 6b). 20 Cf. ARISTOT., Metaph., II, t. 8 (o. C. 2, 994b 13-14). 21 Cf. ARISTOT., Physic., II, t. 49 (B C b 17-22). 22 Cf. ARISTOT., Physic., II, t. 49 (B C b 17-22). 23 Cf. HENRICUS GAND., SUlIlllla, a. 4, q. 3, in corpo (I f. 3lN-320). 24 Cf. THOMAS, S. theol., I, q. 1, a. 1, in corpo (IV 6b); HENRICUS GAND., SUlIlllla, a. 4, q. 5, in corpo (I f. 32B-33E)
12 [14] Minor patet: primo, quia Philosophus sequens naturalem rationem aut ponit felicitatem esse perfectam in cognitione acquisita substantiarum separatarum, sicut videtur velle I et X Ethicorum 25, aut si non determinate asserat illam esse supremam perfectionem nobis possibilem, aliam ratione naturali non concludit, ita quod soli naturali rationi innitendo vel errabit circa finem in particu1ari vel dubius remanebit26; unde I Ethicoru111 dubitando ait: «Si quod est deorum donum, rationabile est felicitatem esse»27. [15] Secundo probatur eadem minor per rationem, quia nullius substantiae finis proprius cognoscitur a nobis nisi ex actibus eius nobis manifestis ex quibus ostenditur quod talis finis sit conveniens tali naturae; nullos actus experimur nec cognoscimus inesse nostrae naturae pro statu isto ex quibus cognoscamus visionem substantiarum separatarum esse convenientem nobis; igitur non possumus naturaliter cognoscere distincte quod ille finis sit conveniens naturae nostrae28. [16] Hoc saltem certum est quod quaedam condiciones finis propter quas est appetibilior et ferventius inquirendus non possunt determinate cognosci ratione naturali. Etsi enim daretur quod ratio sufficeret ad probandum quod visio Dei nuda et fruitio est finis hominis, tamen non concludetur quod ista perpetuo convenient homini perfecto, in anima et corpore, sicut 25 ARISTOT., Eth. adnic., I, c. 9 (A c. 6, I 097b-1 098a 20); X, c. 8 (K c. 7, 1177a l2-l177b I); c.1o (c. 8, 1178b 7-32; c. 9, ll79a 22-32). 26 Adnotatio DUlls Scoti: Hoc est creditum. 27 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. l, q. 12, in corpo (f. 21 I); a. 4, q. 5, in corpo et ad 5 (f. 33B. I); a. 3, q. 3 in corpo (f. 29L). 28 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 4, q. 5, in corpo (I f. 32B-33D). 18 La minore b è evidente: primo, perché il Filosofo seguendo [14] la ragione naturale o ammette che la felicità sia perfetta nella conoscenza acquisita delle sostanze separate, come sembra volere nel I e nel X libro dell 'Etica, oppure, se non afferma in modo preciso che tale conoscenza sia la suprema perfezione possibile per noi, non arriva con la sola ragione naturale ad ammettere un'altra [felicità perfetta], così che, appoggiandosi alla sola ragione naturale, o sbaglierà circa il fine in particolare o rimarrà nel dubbio; così che nel libroi dell'etica, dubitando dice: «Se vi è qualche dono da parte degli dei, è ragionevole che esso sia la felicità». In secondo luogo si prova la stessa minore con la ragione: [15] noi non possiamo conoscere il fine proprio di nessuna sostanza se non dai suoi atti14 a noi noti, dai quali traspare che tale fine sia conveniente a tale natura. Orbene noi non sperimentiamo né conosciamo alcun atto come proprio [inesse] della nostra natura, nel presente stato, dal quale si possa conoscere che la visione delle sostanze separate sia conveniente per noi; dunque, non possiamo conoscere distintamente, con le facoltà naturali, se quel fine sia conveniente alla nostra natura. Almeno questo è certo: che certe condizioni del fine a mo- [16] tivo delle quali esso è più attraente e da ricercarsi più intensamente, non possono essere conosciute in modo determinato dalla ragione naturale. Infatti, anche se si ammettesse che la ragione sia sufficiente per provare che la pura [nuda] visione e la fruizione di Dio costituiscono il fine dell'uomo, tuttavia non si potrà concludere che queste convengano in perpetuo all'uomo perfetto, in anima e corpo, come sarà detto nel libro IV alla distinzione 43. Tuttavia, la perpetuità di un bene siffatto, è la condizione che conferisce al fine maggiore "appetibilità" di 14 Ossia, gli atti della sostanza. 19
13 dicetur in IV distinctione Et tamen perpetuitas huiusmodi boni est condicio reddens finem appetibiliorem quam si esset transitorium. Consequi enim hoc bonum in natura perfecta est appetibilius quam in anima separata, sicut patet per Augustinum XII Super Genesim 30 Istas igitur et similes condiciones finis necessarium est nosse ad efficaciter inquirendum finem, et tamen ad eas non sufficit ratio naturalis; igitur requiritur doctrina supernaturaliter tradita. [17] Secunda ratio principalis - Secundo sic 3I : omni cognoscenti agenti propter finem necessaria est cognitio quomodo et qualiter acquiratur talis finis; et etiam necessaria est cognitio omnium quae sunt ad illum finem necessaria; et tertio necessaria est cognitio quod omnia illa sufficiunt ad talem finem. Primum patet, quia si nesciat quomodo et qualiter finis acquiratur, nesciet qualiter ad consecutionem ipsius se disponet. Secundum probatur, quia si nesciat onmia necessaria ad ipsum, propter ignorantiam alicuius actus necessarii ad ipsum poterit a fine deficere. Si etiam, quantum ad tertium, nesciantur illa necessaria sufficere, ex dubitatione quod ignoret aliquid necessarium, non efficaciter prosequetur illud quod est necessarium. [18] Sed haec tria non potest viator naturali ratione cognoscere. Probatio de primo, quia beatitudo confeltur tamquam praemium pro meritis quae Deus acceptat tamquam digna tali prae- 29 Cf. DUNS SCOTUS, Ordinatio, IV, d. 43, q.2, n. [32]. 30 AUGUST., De Cen. ad Zitt., XII, c. 35, n. 68 (PL 34, ; CSEL XXVIII pars II 432, , 11). 31 Adnotatio DUl1s Scoti: haec procedit de contingentibus; ergo non de scibilibus. 20 quanta non ne avrebbe se fosse transitorio. Conseguire, infatti, questo bene in una natura perfetta è più desiderabile che non nell'anima separata, come risulta da sant'agostino nel libro XII sulla Genesi. Dunque, è necessario conoscere queste ed altre condizioni del fine per perseguirlo efficacemente, e tuttavia [per giungere] ad esse non basta la ragione naturale; dunque è necessaria una dottrina trasmessa in modo soprannaturale. Seconda ragione principale (a) Ad ogni essere dotato [17] di conoscenza, che agisce per conseguire il fine, è necessaria la conoscenza delle modalità [quomodo et qua/iter] per conseguire il fine; (b) è anche necessaria la conoscenza di tutte quelle cose che sono necessarie in ordine a quel fine; (c) in terzo luogo è necessario sapere che tutte quelle cose sono sufficienti in ordine a tale fine. Il primo punto a è evidente, perché se non si conoscono le modalità per conseguire il fine, non si saprà nemmeno come disporsi per conseguirlo. Il secondo punto b si prova perché se non si conoscesse tutto ciò che è necessario al fine [ipsum], per l'ignoranza di qualche atto necessario al suo conseguimento, si potrà venir meno e non conseguire il fine stesso. Quanto al terzo punto C, se non si sapesse che quelle cose necessarie sono anche sufficienti, per il dubbio di ignorare qualcosa di necessario, senza efficacia si seguirà ciò che è necessario. Ma l'uomo viatore non può conoscere queste tre cose con [18] la ragione naturale. Quanto alla prima a, lo si prova così: la beatitudine è conferita come premio per i meriti che Dio accetta come degni di tale premio, e di conseguenza [essa] non segue i nostri atti, di qualsiasi tipo essi fossero, per naturale necessità, ma è data in modo contingente da Dio, il quale accetta alcuni atti come meritori in ordine al premio [ad ipsum]. Ciò non è conoscibile naturalmente, come sembra [probabile], perché 21
14 mio, et per consequens non naturali necessitate sequitur ad actus nostros qualescumque sed contingenter datur a Deo, actus aliquos in ordine ad ipsum tamquam meritorios acceptante 32 Ishld non est naturaliter scibile, ut videtur, quia hic etiam errabant philosophi, ponentes ornnia quae sunt a Deo immediate esse ab eo necessari0 33 Saltem alia duo membra sunt manifesta: non enim potest sciri nahlrali ratione acceptatio voluntatis divinae utpote tamquam contingenter acceptantis talia vel talia digna vita aeterna, et quod etiam illa sufficiant; dependet mere ex voluntate divina circa ea ad quae contingenter se habet; igitur etc. [19] Istantiae contra duas rationes principales - Contra istas duas rationes instatur. Contra primam sic: omnis natura creata essentialiter dependet a qualibet per se causa eius, et propter talem dependentiam ex causato cognito potest sciri demonstratione quia 34 et cognosci quaelibet eius per se causa; igitur cum natura hominis sit homini naturaliter cognoscibilis, quia non est potentiae eius cognitivae impropoliionalis, sequitur quod ex ista nahlra cognita possit naturaliter cognosci finis illius naturae Adnotatio DlIns Scoti: hoc est creditum; cf. DUNS SCOTUS, Ordinatio, l,d. 17, pars 1, q. 3, n. [24-25]; QlIodl., q. 17, n. [3-6]. 33 Cf. HENRICUS GAND., Slimma, a. 29, q. 5, in corpo (I f. 1741); 34 Cf. ARiSTaT., Anal. Post., I, c. 13, [t. 30] (A, c. 13, 78a, 22-78b, 34). 35 Adnotatio DlIns Scoti: concedo, finis qui est causa finalis, et hoc sub ista ratione sub qua est causa finalis et similiter sicut cognoscitur efficiens sub ratione quae necessario requiritur ut sit efficiens primum; cf. etiam HENRICUS GAND., Slimma, a. 4, q. 8, in corpo (f. 34V-35X). 22 anche qui erravano i filosofi, i quali affermavano che tutto ciò che viene da Dio in modo immediato, deriva da lui in modo necessano. Almeno le altre due proposizioni bc sono evidenti: infatti, con la ragione naturale non si può conoscere l'accettazione da parte della volontà divina, in quanto la divina volontà accetta in modo contingente questi o quegli altri [atti] come degni della vita eterna, né [si può conoscere] che tali atti siano sufficienti in ordine a quella. Quelle cose verso le quali la volontà divina si comporta [se habet] in modo contingente, dipendono solo dalla stessa volontà divina. Dunque... Istanze contro le due ragioni principali - Si muovono [19] delle difficoltà a queste due ragioni 15. Contro la prima16: ogni natura creata dipende essenzialmente da qualche sua causa per sé 1? A motivo di tale dipendenza, a partire dall'effetto conosciuto [ex causato cognito], può essere dedotta [sciri] per mezzo di una dimostrazione quia 18, e conosciuta, qualsiasi sua causa per sé. Dunque, dal momento che la natura dell'uomo è naturalmente conoscibile per l'uomo, perché non è spropor- 15 Cf. sopra, nn Cf. n. 13: «Ciò che agisce con conoscenza in vista di un fine, deve conoscere il fine in modo distinto; ma l'uomo non conosce distintamente il suo fine, con le sue sole facoltà nahlrali; dunque l'uomo, con le sole forze narurali, non può agire efficacemente in vista del conseguimento del proprio fine». 17 Causa per sé è contrapposta a causa per accidens. La causa per sé causa in virtù della propria narura e non di qualche suo accidente. Lo scavo del pozzo è causa per sé del ritrovamento dell'acqua e causa per accidens del ritrovamento di un tesoro. Oppure, la medicina è causa per sé della guarigione e causa per accidens dell'arricchimento del medico. 18 La dimostrazione qllia è una dimostrazione induttiva: parte dagli effetti e risale alla causa, in base al principio di causalità secondo cui ogni effetto ha una causa proporzionata a sé. 23
15 [20] Confirmatur ratio: si enim ex natura inferiori cognita cognoscatur eius finis, non hoc minus est possibile in proposito, quia nec minor dependentia in proposito finiti ad suum finem est quam in aliis 36. [21] Ex hac etiam ratione videtur quod falsa sit illa propositio 'finis substantiae non cognoscitur nisi ex eius actibus'37, quae assumebatur in probatione minoris, quia ex cognitione naturae in se potest eius finis cognosci demonstratione quia. [22] Quod si dicatur quod ratio concludit hominem posse naturaliter cognoscere suum finem naturalem, non autem de fine supernaturali, contra, Augustinus libro De praedestinatione sanctorum: «Posse habere fidem, sicut posse habere caritatem, naturae est hominum, quamvis habere fidem, sicut habere caritatem, gratiae sit fidelium»38. Si ergo natura hominis est naturaliter cognoscibilis homini, naturaliter est etiam cognoscibilis illa potentia ut est talis naturae, et per consequens ordinabilitas talis naturae ad finem ad quem fides et caritas disponit. zionata rispetto alla sua facoltà conoscitiva, segue che dalla conoscenza di tale natura si possa conoscere naturalmente il fine di quella natura stessa 19 Si conferma l'argomentazione: infatti, se dalla conoscen- [20] za della natura inferiore 20 è conosciuto il suo fine, questo non è meno possibile nel caso propost0 21, perché nemmeno in tal caso la dipendenza del finito dal fine è minore rispetto agli altri casi. Da questa ragione anche si vede la falsità di quella proposi- [21] zione: «Il fine della sostanza non lo si conosce se non dai suoi atti»22, la quale si assumeva nella prova della minore 23, perché dalla conoscenza della natura in sé può esser conosciuto il suo fine con una dimostrazione quia 24 Se si dicesse che l'argomento conclude che l'uomo può na- [22] turalmente conoscere il suo fine naturale, non però il suo fine soprannaturale, si porterebbe contro La predestinazione dei santi di Agostino, il quale afferma che «Poter aver fede, come poter avere carità è [proprio] della natura degli uomini, benché avere fede, come avere carità è [proprio] della grazia dei fedeli». Se dunque la natura dell'uomo è naturalmente conoscibile all'uomo, naturalmente è anche conoscibile quella facoltà in quanto appartiene a tale natura, e di conseguenza [è conoscibile] l'ordinabilità di tale natura al fine a cui dispone la fede e la carità. 36 Cf. HENRlCUS GAND., Summa, a. 4, q. 8, in corpo (I f. 34V-35V). 37 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 4, q. 8, ad 1 et 2 (f. 35Y. Z). 38 AUGUST., De predest. Sanet., c. 5, n. lo (PL 44, 968) Ossia, il fine della natura umana. 20 Ossia, la natura non intelligente. 21 Ossia, il fine dell'uomo conosciuto a partire dalla conoscenza della natura umana. 22 Cf. sopra, n Cf. sopra, n Cf. sopra n. 19, in nota. 25
16 [23]!tem, homo naturaliter appetit finem illum quem dicis supematuralem; igitur ad illum finem naturaliter ordinatur 39 ; igitur ex tali ordinatione potest concludi finis ille ut ex cognitione naturae ordinatae ad ipsum. [24]!tem, naturaliter est cognoscibile primum obiectum intellectus esse ens, secundumavicennam 4o, et naturaliter cognoscibile est in Deo perfectissime salvari rationem entis; finis autem cuiuscumque potentiae est optimum eomm quae continentur sub eius obiecto primo, quia in illo solo est perfecta quietatio et delectatio, ex X Ethicorum 41 ; ergo naturaliter cognoscibile est hominem ordinari secundum intellectum ad Deum tamquam ad finem. [25] Confinnatur ratio, quia cui naturaliter cognoscibilis est potentia aliqua, ei naturaliter cognoscibile est quid sit eius primum obiectum, et ulterius, potest cognoscere in quo salvatur ratio illius primi obiecti et quod perfectissimum tale est finis potentiae; mens autem nota est sibi, secundumaugustinum De Trinitate 42 ; igitur sibi est notum quid sit eius primum obiectum 43 Et novit Deum non excedi a ratione illius primi obiecti, quia tunc nullo modo esset ab ipsa mente intelligibilis 44 ; ergo novit Deum esse optimum in qua salvatur ratio sui obiecti, et ita ipsum novit esse finem potentiae. 39 Cf. HENRICUS GAND., Slimma, a. 8, q. 2, ad 1 (I f. 65N); a. 4, q. 5, in corpo et ad 1 (f. 33C-F). 40 Cf. AVICENNA, Metaph., I, c. 6 (72rb). 41 Cf. ARISTOT., Eth. adnic., X, c. 4 (K c. 4, 1174b, 14-23). 42 Cf. AUGUST., De Trin., IX, c , n. 16.,18 (PL 42,970). 43 Cf. HENRICUS GAND., Slimma, a. 40, q. 7, argo 2, et in corpo (I f. 259 G.H). 44 Cf. ibidem, a. 4, q. 5, in corpo (f. 33C). 26 Inoltre, l'uomo naturalmente desidera quel fine che dici [23] essere soprannaturale; dunque a quel fine egli è naturalmente ordinato; dunque, da tale ordinazione può essere dedotto quel fine come dalla conoscenza della natura ordinata ad esso. Inoltre, secondo Avicenna 25 è naturalmente conoscibile che [24] il primo oggetto dell'intelletto è l'ente, ed è naturalmente conoscibile che in Dio si trova in modo perfettissimo la ragione di ente; il fine di qualsiasi facoltà è il grado massimo di perfezione di quelle cose che sono contenute sotto l'oggetto primo della potenza [eius], perché solo nell'ottimo [illo] vi è la perfetta quiete e dilettazione, come dice Aristotele nel libro X, cap. 4, dell'etica nicomachea; dunque è naturalmente conoscibile che l'uomo sia intellettualmente ordinato [secundum intellectum] a Dio come al [proprio] fine. L'argomento [ratio] è confermato perché, colui che può [25] naturalmente conoscere una qualche facoltà, può anche conoscere il suo oggetto primo, e inoltre, può conoscere ciò in cui si trova [sa/vatur] la ragione di quell'oggetto primo e che tale [oggetto] perfettissimo è il fine della facoltà. La mente, inoltre, conosce se stessa, secondo Agostino, nel libro IX, capitoli 11-12, de La Trinità, dunque conosce quale sia il suo oggetto primo; sa inoltre che Dio non è eccedente rispetto alla ragione di quel primo oggetto, perché altrimenti non sarebbe in alcun modo conoscibile per la mente stessa; dunque conosce che Dio è l'ottimo in cui si trova la ragione del suo oggett0 26, e così sa che Dio [ipsum] è il fine della facoltà. 25 Cf. sopra, n Ossia, oggetto dell'intelligenza. 27
17 [26] Contra secundam rationem arguitur sic: si per unum extremum cognoscitur aliud extremum, ergo et media; sed necessaria ad consecutionem finis sunt media inter naturam et finem suum consequendum 45 ; igitur cum ex cognitione naturae possit finis cognosci, secundum prius probata, videtur quod similiter media ad finem necessaria possunt cognosci. [27] Confirmatur ratio: ita enim in proposito videtur esse necessaria conexio entium ad ipsum finem sicut est in aliis; sed propter talem conexionem in aliis ex fine cognoscuntur alia, sicut per rationem sanitatis concluditur talia et talia requiri ad sanitatem; igitur etc 46 [28] Responsio ad instantias - Ad primum istorum dico quod licet procedat de fine qui est causa finalis et non de fine attingendo per operationem quorum finium distinctio dicetur infra 47 - potest tamen dici ad illud, et ad sequens de Augustino, et ad tertium de potentia et primo obiecto, unica responsione, quod omnia accipiunt naturam nostram vel potentiam intellectivam esse nobis naturaliter cognoscibilem; quod falsum est, sub illa ratione propria et speciali sub qua ad talem finem 01' dinatur, et sub qua capax est gratiae consummatae, et sub qua habet Deum pro perfectissimo obiecto. Non enim cognoscitur anima nostra a nobis nec natura nostra pro statu isto nisi sub aliqua ratione generali, abstrahibili a sensibilibus, sicut patebit infra distinctione 3 48 Et secundum talem generalem rationem 45 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 4, q. 9, in corpo (f. 35B). 46 Cf. ibidem, a. 3, q. 3, argo 1 (f. 28K). 47 Cf. DUNS SCOTUS, Ol'dinatio, I, d. 1, pars 1, q. 1, n. [5]. 48 Cf. DUNS SCOTUS, Ol'dinatio, I, d. 3, pars 1, q. 3, n. [24]. 28 Contro il secondo argoment0 27 si procede nel modo seguen- [26] te: se per mezzo di un estremo si conosce l'altro estremo, dunque si conoscono anche le cose intermedie; ma le cose necessarie per conseguire il fine sono intermedie tra la natura ed il suo fine al quale tende; dunque, poiché dalla conoscenza della natura può esser conosciuto il fine, secondo quanto è stato provato sopra 28, sembra che similmente possono esser conosciuti i mezzi che sono necessari per conseguire il fine. Si conferma l'argomento: nell'enunciato si vede, infatti, che [27] la connessione degli enti allo stesso fine è necessaria, come lo è negli altri [mezzi al fine]; ma per tale connessione necessaria negli altri [mezzi al fine], a partire dal fine si conoscono gli altri [mezzi], come per la ragione della salute si conclude che tale e tal altra cosa sia richiesta per la salute stessa. Dunque... Risposta alle obiezioni - Alla prima 29 dico che, benché [28] pmia dal fine che è causa finale e non dal raggiungimento del fine per mezzo dell'operazione - circa la distinzione tra questi fini si dirà più avanti - si può dare una risposta unica alle varie obiezioni sopra sollevate (alla prima 30, alla seguente che cita sant'agostin0 3I e alla terza dove si parla della facoltà e dell'oggetto prim0 32 ): tutte considerano la nostra natura o la facoltà intellettiva come naturalmente conoscibile per noi; ciò è falso, se si considera la conoscenza sotto quella ragione propria e speciale sotto la quale è ordinata a tale fine, ed è capace della grazia consumata, ed ha Dio come oggetto perfettissimo. Infatti, la nostra anima non è conosciuta da noi stessi, né è co- 27 Cf. sopra, nl Cf. sopra, Cf. sopra, Cf. sopra, Cf. sopra, Cf. sopra,
18 non convenit sibi ordinari ad illum finem, nec posse capere gratiam, nec habere Deum pro obiecto perfectissimo. [29] Tunc ad formam. Cum dicitur quod ex ente ad finem potest demonstrari finis demonstratione quia, dico quod non est verum nisi cognito ente ad finem sub illa ratione propria sub qua habet finem illum. Sic minor est falsa. - Et cum probatur per proportionem, dico quod licet mens sit eadem sibi, non tamen pro statu isto est sibi proportionalis tamquam obiectum nisi secundum rationes generales quae possunt abstrahi ab imaginabilibus. [30] Ad confirmationem dico quod nec aliarum substantiarum fines proprii cognoscuntur, qui scilicet sunt earum secundum rationes proprias, nisi sint aliqui actus manifesti ex quibus concludatur ordo earum ad talem finem. [31] Et ex hoc patet ad illud quod additur contra probationem minoris, quod illa propositio non est falsa, 'non cognoscitur a nobis finis proprius substantiae nisi per actum eius manifestum'; non enim accipit propositio quod non posset aliter finis cognosci. Bene enim verum est quod si substantia cognosceretur sub propria ratione, ex ipsa sic cognita posset eius per se causa cognosci. Sed non sic cognoscitur a nobis nunc aliqua substantia, et ideo nunc nullum finem possumus concludere proprium substantiae nisi per actum evidentem de illa substantia ut nota in universali et confuse. In proposito deficit utraque via; sed probatio minoris tangit unam, de ignorantia actus, supponendo aliam, de ignorantia scilicet naturae in se. 30 nosciuta la nostra natura, nello stato presente, se non sotto una qualche ragione generale, astraibile dalle cose sensibili, come sarà evidente avanti nella dist. 3. E [alla natura conosciuta] secondo tale ragione generale, non conviene essere ordinata a quel fine, né poter ricevere la grazia, né avere Dio come oggetto perfettissimo. Veniamo ora al nucleo della questione [tune adformam]. [29] Quando si dice che [dall'ordinazione] dell'ente al fine può essere dimostrato il fine con una dimostrazione quia 33, dico che ciò non è vero se l'ente [ordinato] al fine non è conosciuto sotto quella ragione propria sotto la quale ha quel fine. Così la minore è falsa 34. E quando si prova la tesi tramite la proporzione 35, dico che benché la mente sia identica a se stessa, non è proporzionata a se stessa nel presente stato, come oggetto, se non secondo ragioni generali che possono esser astratte dalle immagini sensibili. Come conferma 36 dico che non sono conosciuti i fini propri [30] delle altre sostanze, i quali competono ad esse secondo le ragioni proprie, se non vi siano alcuni atti manifesti dai quali si concluda il loro ordine a tale fine. Da ciò appare manifesto, riguardo a ciò che è stato aggiun- [31] t0 37 contro la prova della minore, che la seguente proposizione non è falsa: «il fine proprio della sostanza non è da noi conosciuto se non per mezzo di un suo atto manifesto»38. Infatti, la proposizione non intende [dire] che il fine non possa essere co- 33 Cf. sopra, n È falso che «la natura dell'uomo è naturalmente conoscibile perché non è sproporzionata alla sua potenza conoscitiva» (n. 19). 35 Cf. sopra, n Cf. sopra, n Cf. sopra, n Cf. sopra, n
19 [32] Ad secundum de Augustino dico quod illa potentia habendi caritatem ut ipsa est dispositio respectu Dei in se sub propria ratione amandi, convenit naturae hominis secundum rationem specialem, non communem sibi et sensibilibus; ideo non est illa potentialitas naturaliter cognoscibilis pro statu isto de homine, sicut nec homo cognoscitur sub illa ratione sub qua eius est haec potentia.!ta respondeo ad istud in quantum adduci potest ad conclusionem principalem, scilicet oppositam minori rationis primae. Sed in quantum adducitur contra illam responsionem de fine supernaturali et naturali, respondeo: concedo Deum esse finem naturalem hominis, sed non naturaliter adipiscendum sed supernaturaliter4 9 Et hoc probat ratio sequens de desiderio naturali, quam concedo. 49 Cf. HENRICUS GAND., Summa, a. 13, q. 2, in corpo CI f. 9lT-X); a. 8, q. 2, in corpo (f. 64H). 32 nosciuto in alcun modo diverso. E' ben vero che se la sostanza fosse conosciuta sotto la sua ragione propria, dalla stessa [sostanza] così conosciuta potrebbe esser conosciuta la sua causa per sé. Ma non così è ora conosciuta da noi alcuna sostanza, e perciò ora non possiamo dedurre alcun fine proprio della sostanza se non per mezzo di un atto evidente proveniente da quella sostanza, in quanto nota in modo universale e confuso. NelI'assunt0 39 [in proposifo] mancano entrambe le vie [qui sopra descritte]: ma la prova della minore 40 tratta di una, l'ignoranza dell'atto, supponendo l'altra, che riguarda t'ignoranza della natura in sé. Al secondo argomento tratto da sant'agostin0 41, dico che [32] quella potenza di avere la carità, in quanto la stessa è disposizione rispetto a Dio in se stesso, sotto la ragione propria dell'amore, conviene alla natura dell'uomo secondo una ragione speciale, non comune a sé e alle cose sensibili; perciò quella potenzialità non è naturalmente conoscibile dall'uomo nello stato presente, come nemmeno l'uomo è conosciuto sotto quella ragione sotto la quale si trova questa sua potenza. Così rispondo a questo [argomento], in quanto può esser addotto alla conclusione principale 42, opposta alla minore della prima ragione 43 Ma per quant0 44 si adduce contro quella risposta ri- 39 Ossia, nella premessa minore: «L'uomo non può conoscere con le sole facoltà naturali, in modo distinto, il suo fine» (n. 13). 40 Cf. n Cf. ibidem. 42 Cf. sopra, n. 19: «Poiché la natura dell'uomo è conoscibile naturalmente, perché non è sproporzionata alla sua potenza conoscitiva, segue che dalla conoscenza di questa natura si può conoscere naturalmente il fine di quella natura». 43 Cf. sopra, n. 13: «L'uomo non può conoscere distintamente il suo fine con le capacità naturali». 44 Lo stesso argomento di sant'agostino. 33
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza
 L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale?
 FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
FEDE RAGIONE Tre domande: (1) Perché ci occupiamo del rapporto tra le fede e la ragione? (2) Quali sono i limiti della nostra ragione naturale? (3) C'è contraddizione tra fede e ragione? Percorso: Chiariamo
Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag
 Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.
Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva
 TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.
 La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
04 - Logica delle dimostrazioni
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia CdS Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale Appunti del corso di Matematica 04 - Logica delle dimostrazioni Anno Accademico 013/014 D. Provenzano,
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia CdS Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale Appunti del corso di Matematica 04 - Logica delle dimostrazioni Anno Accademico 013/014 D. Provenzano,
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile
 RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
Nicola Cusano. Il Dio nascosto
 Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa. Divisione della vita in attiva e contemplativa
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara)
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
Descartes Meditazioni Metafisiche. Schema
 Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
LA SOMMA TEOLOGICA. eso S. TOMMASO D AQUINO. L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA
 S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni. IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo
 Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo ISBN 978-88-250-4458-4 Copyright 2017 by P.P.F.M.C. MESSAGGERO DI SANT ANTONIO EDITRICE Basilica
Giorgio Ronzoni testo Luca Salvagno illustrazioni IL DONO PERFETTO Alla scoperta dei doni dello Spirito Santo ISBN 978-88-250-4458-4 Copyright 2017 by P.P.F.M.C. MESSAGGERO DI SANT ANTONIO EDITRICE Basilica
LO SPIRITO E LA PAROLA
 LEZIONE 1 DELLA SCUOLA DEL SABATO LO SPIRITO E LA PAROLA 1 TRIMESTRE 2017 SABATO 7 GENNAIO 2017 Lo Spirito Santo è stato il motore e la genesi del processo di creazione della Parola scritta da Dio la Bibbia.
LEZIONE 1 DELLA SCUOLA DEL SABATO LO SPIRITO E LA PAROLA 1 TRIMESTRE 2017 SABATO 7 GENNAIO 2017 Lo Spirito Santo è stato il motore e la genesi del processo di creazione della Parola scritta da Dio la Bibbia.
OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986
 Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986-1- I. APPROCCIO FILOSOFICO L atto di pensare, che è proprio dell intelletto,
Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986-1- I. APPROCCIO FILOSOFICO L atto di pensare, che è proprio dell intelletto,
TOMMASO D'AQUINO. Legge naturale e legge umana
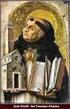 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO
 Revista Espanola de Filosofia Medieval, II (2004), pp. 83-96 LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA ' DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO Federica Bergamino Pontificia Universita della
Revista Espanola de Filosofia Medieval, II (2004), pp. 83-96 LA NATURA ANALOGICA DEL BENE: RADICE METAFISICA ' DELLA LIBERTA DELLA SCELTA IN TOMMASO D'AQUINO Federica Bergamino Pontificia Universita della
ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio
 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
La fisica. Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto)
 La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile
 S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
S.Th., I a, q. 13, a. 1 Se Dio sia da noi nominabile [Ob. 2] Omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina
Boezio e la teoria delle proporzioni. Calcidio e il commento al Timeo di Platone
 Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI
 ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI Di Claudio Antonio Testi PREMESSA Con questo breve contributo vorrei sviluppare una breve analisi logica del termine naturale in un ottica tomista.
ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI Di Claudio Antonio Testi PREMESSA Con questo breve contributo vorrei sviluppare una breve analisi logica del termine naturale in un ottica tomista.
FILOSOFIA E GIUSTIZIA
 FILOSOFIA E GIUSTIZIA Aristotele (Etica Nicomachea) amplia le precedenti definizioni, contrapponendo giustizia e ingiustizia. Il mezzo della giustizia equivale all'eguale e non è una quantità fissa, ma
FILOSOFIA E GIUSTIZIA Aristotele (Etica Nicomachea) amplia le precedenti definizioni, contrapponendo giustizia e ingiustizia. Il mezzo della giustizia equivale all'eguale e non è una quantità fissa, ma
LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:
 LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE.
 PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA
 STUDI E RICERCHE Andrea Colli Chiara Selogna FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA UNO STUDIO SUL DE IMAGINE DI GIOVANNI DUNS SCOTO Il De imagine di GIOVANNI Duns Scoto Una nota introduttiva Il De imagine
STUDI E RICERCHE Andrea Colli Chiara Selogna FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA UNO STUDIO SUL DE IMAGINE DI GIOVANNI DUNS SCOTO Il De imagine di GIOVANNI Duns Scoto Una nota introduttiva Il De imagine
NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI.
 NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI. Una proposizione è un affermazione che è vera o falsa, ma non può essere contemporaneamente vera e falsa. ESEMPI Sono proposizioni : 7 è maggiore di 2 Londra è la capitale
NOZIONI DI LOGICA PROPOSIZIONI. Una proposizione è un affermazione che è vera o falsa, ma non può essere contemporaneamente vera e falsa. ESEMPI Sono proposizioni : 7 è maggiore di 2 Londra è la capitale
Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio
 Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XIII (2007), pp. 5-31 ISSN 1824-3770 (online) 2008 Firenze University Press Ockham e la dimostrazione dell esistenza di Dio Fabrizio Amerini In this
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio. L'amore di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
Richiami teorici ed esercizi di Logica
 Facoltà di ingegneria Università della Calabria Corsi di Potenziamento Matematica e Logica A. A. 2008-2009 Richiami teorici ed esercizi di Logica Proposizioni logiche: Ogni espressione matematica alla
Facoltà di ingegneria Università della Calabria Corsi di Potenziamento Matematica e Logica A. A. 2008-2009 Richiami teorici ed esercizi di Logica Proposizioni logiche: Ogni espressione matematica alla
Il sommo bene dell uomo
 Lettura 8 Boezio di Dacia Il sommo bene dell uomo Il sommo bene, in Boezio di Dacia - Giacomo da Pistoia, Ricerca della felicità e piaceri dell intelletto, a cura di F. Bottin, Firenze, Nardini Editore,
Lettura 8 Boezio di Dacia Il sommo bene dell uomo Il sommo bene, in Boezio di Dacia - Giacomo da Pistoia, Ricerca della felicità e piaceri dell intelletto, a cura di F. Bottin, Firenze, Nardini Editore,
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae
 Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
Et ipse : La imago Dei nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae. Nel prologo alla seconda parte della Summa Theologiae San Tommaso ricorda che l uomo è stato creato ad immagine di Dio in quanto
CONOSCENZA ED ESPERIENZA
 CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza
Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.
 Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come
Cosa sono gli oggetti intenzionali?
 Dominik Perler Cosa sono gli oggetti intenzionali? Una controversia fra i discepoli diretti di Scoto Presentazione di Roberto Pasi e Luca Morri Object-theory Content-theory Early Brentano Late Brentano
Dominik Perler Cosa sono gli oggetti intenzionali? Una controversia fra i discepoli diretti di Scoto Presentazione di Roberto Pasi e Luca Morri Object-theory Content-theory Early Brentano Late Brentano
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
Filosofia e acquisizione di competenze
 Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia
Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno
 Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
Introduzione nei Comandamenti Sacri dello Spirito Beinsa Duno 1. Chi è il Maestro Dunov? 2. Chi è il Maestro della Fratellanza Bianca? 3. Chi è il Maestro della Grande Fratellanza Bianca? 4. Chi è il Maestro
LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII
 STEPHEN L. BROCK LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII È indubbio, mi pare, che sulla questione della causalità del primo motore nel libro XII della Metafisica,
STEPHEN L. BROCK LA CAUSALITÀ DEL MOTORE IMMOBILE NEL COMMENTO DI TOMMASO D AQUINO A METAFISICA XII È indubbio, mi pare, che sulla questione della causalità del primo motore nel libro XII della Metafisica,
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Linee di fondo dell antropologia di Lutero. alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521
 Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Linee di fondo dell antropologia di Lutero alla luce di suoi scritti fra il 1516 e il 1521 Teologia per Lutero biblica, non sistematica pratica, affettiva, esistenziale teologia spiritualità pastorale
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE
 Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
Aristotele ARISTOTELE LA VITA E LE OPERE Vita ARISTOTELE NACQUE A STAGIRA NEL NORD DELLA GRECIA NEL 384 A.C. NEL 367, ALL'ETÀ DI 17 ANNI, ANDÒ AD ATENE AL FINE DI ENTRARE A FAR PARTE DELL'ACCADEMIA DI
Un po di logica. Christian Ferrari. Laboratorio di matematica
 Un po di logica Christian Ferrari Laboratorio di matematica 1 Introduzione La logica è la disciplina che studia le condizioni di correttezza del ragionamento. Il suo scopo è quindi quello di elaborare
Un po di logica Christian Ferrari Laboratorio di matematica 1 Introduzione La logica è la disciplina che studia le condizioni di correttezza del ragionamento. Il suo scopo è quindi quello di elaborare
IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1. Giovanni Lauriola ofm. Premessa
 IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1 Giovanni Lauriola ofm Premessa Nella storia della teologia, i termini Cristocentrismo e Giovanni Duns Scoto sono talmente correlativi e complementari che l
IL CRISTOCENTRISMO DI GIOVANNI DUNS SCOTO 1 1 Giovanni Lauriola ofm Premessa Nella storia della teologia, i termini Cristocentrismo e Giovanni Duns Scoto sono talmente correlativi e complementari che l
Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva
 Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,
INDlCE. Introduzione 13. PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21
 INDlCE Introduzione 13 PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21 1. L'etica di Kant e la tradizione della "Schulphilosophie" 23 2. Due interpretazioni dell'etica di Kant 27 3. Illuogo natio dell'etica
INDlCE Introduzione 13 PARTE PRIMA La formazione dell'etica di Kant 21 1. L'etica di Kant e la tradizione della "Schulphilosophie" 23 2. Due interpretazioni dell'etica di Kant 27 3. Illuogo natio dell'etica
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli
 FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli
Filosofia l origine. A cura di Pietro Gavagnin Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.
 Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Filosofia l origine A cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Pubblicato con Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Uso Comune del termine Non fare il filosofo! Finché facciamo
Duns Scoto e l analogia entis
 19 Duns Scoto e l analogia entis LEONARDO CAPPELLETTI This article shows that, within the Duns Scotus s metaphisical doctrine (like in quaestiones subtilissimae super libros metaphysicorum Aristotelis),
19 Duns Scoto e l analogia entis LEONARDO CAPPELLETTI This article shows that, within the Duns Scotus s metaphisical doctrine (like in quaestiones subtilissimae super libros metaphysicorum Aristotelis),
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica
 RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
Logica Matematica. Informatica Filosofia. Simone Martini
 Logica Matematica Informatica Filosofia Simone Martini Dipartimento di Scienze dell Informazione martini@cs.unibo.it Newsgroups: unibo.cs.informatica.logica Ricevimento studenti: Mercoledì 14-15 1 / 29
Logica Matematica Informatica Filosofia Simone Martini Dipartimento di Scienze dell Informazione martini@cs.unibo.it Newsgroups: unibo.cs.informatica.logica Ricevimento studenti: Mercoledì 14-15 1 / 29
Appunti di geometria euclidea
 Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
Appunti di geometria euclidea Il metodo assiomatico Appunti di geometria Euclidea Lezione 1 Prima di esaminare nel dettaglio la Geometria dal punto di vista dei Greci è opportuno fare unrichiamo di Logica.
Prof. Francesco Paparella, Università di Bergamo, corso di Storia della Filosofia Medievale, a.a
 De Trinitate IV, 1.3 2.4 Temi centrali sono 1) l indagine intorno alla relazione tra Logos e Parola nell'ambito della relazione delle persone della Trinità e 2) l attingimento del Vero da parte dell uomo
De Trinitate IV, 1.3 2.4 Temi centrali sono 1) l indagine intorno alla relazione tra Logos e Parola nell'ambito della relazione delle persone della Trinità e 2) l attingimento del Vero da parte dell uomo
DIALETTICA TRASCENDENTALE
 Critica della ragione che cerca di essere pura La ragione crea i sillogismi ed è l organo della totalità L idea è la totalità delle condizioni dell esperienza DIALETTICA TRASCENDENTALE La Dialettica trascendentale
Critica della ragione che cerca di essere pura La ragione crea i sillogismi ed è l organo della totalità L idea è la totalità delle condizioni dell esperienza DIALETTICA TRASCENDENTALE La Dialettica trascendentale
Convegno di Fognano settembre Persona e individuo
 Convegno di Fognano 23-25 settembre 2011 Persona e individuo Il tema del rapporto tra la persona e l individuo offre sempre abbondante materia di riflessione, di indagine e di discussione, considerando
Convegno di Fognano 23-25 settembre 2011 Persona e individuo Il tema del rapporto tra la persona e l individuo offre sempre abbondante materia di riflessione, di indagine e di discussione, considerando
!)Ku,Ky(! Luca Visone : PORTFOLIO :.
 .: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
.: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
Barbara Pozzo. La vita che sei. varia
 Barbara Pozzo La vita che sei varia Proprietà letteraria riservata 2014 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-07690-6 Prima edizione BUR settembre 2014 Realizzazione editoriale: Langue&Parole, Milano
Barbara Pozzo La vita che sei varia Proprietà letteraria riservata 2014 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-07690-6 Prima edizione BUR settembre 2014 Realizzazione editoriale: Langue&Parole, Milano
Immanuel Kant. Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino
 Immanuel Kant Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino Come e cosa conosciamo? https://www.youtube.com/watch?v=oux2mylkiby Le opere precritiche Dal razionalismo tedesco
Immanuel Kant Corso di Riallineamento di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof.ssa Laura Stochino Come e cosa conosciamo? https://www.youtube.com/watch?v=oux2mylkiby Le opere precritiche Dal razionalismo tedesco
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 175 Il rapimento. Il rapimento
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 175 Il rapimento Il rapimento Secunda pars secundae partis Quaestio 175 Prooemium Seconda parte della seconda parte Questione 175 Proemio [45972] IIª-IIae,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 175 Il rapimento Il rapimento Secunda pars secundae partis Quaestio 175 Prooemium Seconda parte della seconda parte Questione 175 Proemio [45972] IIª-IIae,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio. Giustizia e misericordia di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio Giustizia e misericordia di Dio Prima pars Quaestio 21 Prooemium Prima parte Questione 21 Proemio [29324] Iª q. 21 pr. Post considerationem
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 21 Giustizia e Misericordia di Dio Giustizia e misericordia di Dio Prima pars Quaestio 21 Prooemium Prima parte Questione 21 Proemio [29324] Iª q. 21 pr. Post considerationem
L Enciclopedia delle scienze filosofiche
 L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel
Ciò che è caro agli dei
 Ciò che è caro agli dei Un esercitazione Una conversazione sulla santità VII. SOCRATE -... Prima, caro amico, non mi hai spiegato abbastanza: io ti domandavo che cos è il santo e tu mi hai detto che il
Ciò che è caro agli dei Un esercitazione Una conversazione sulla santità VII. SOCRATE -... Prima, caro amico, non mi hai spiegato abbastanza: io ti domandavo che cos è il santo e tu mi hai detto che il
Il credere come atto volontario secondo San Tommaso
 CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE L UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO: PROSPETTIVA DI TOMMASO D AQUINO ROMA, 21-25 settembre 2003 Pontificia Accademia di San Tommaso Società Internazionale Tommaso d
NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito]
![NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito] NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO. [Dialogus de deo abscondito]](/thumbs/54/34540019.jpg) NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO [Dialogus de deo abscondito] Testo italiano e testo latino 2 NICOLA CUSANO (1401-1464) [1] Dialogo sul Dio nascosto tra due, dei quali l'uno gentile, l'altro Cristiano Dice
NICOLA CUSANO IL DIO NASCOSTO [Dialogus de deo abscondito] Testo italiano e testo latino 2 NICOLA CUSANO (1401-1464) [1] Dialogo sul Dio nascosto tra due, dei quali l'uno gentile, l'altro Cristiano Dice
Plotino. Ne risulta una sintesi che influenzerà il pensiero cristiano e moderno.
 Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e
IL MAESTRO SECONDO TOMMASO D AQUINO DE VERITATE, QUAESTIO UNDECIMA INTRODUZIONE E TRADUZIONE
 e -HUM ANISTICA 4 Riproposizione de il Maestro : un prezioso testo tomano sulle modalità pedagogiche Antonio Tubiello IL MAESTRO SECONDO TOMMASO D AQUINO DE VERITATE, QUAESTIO UNDECIMA INTRODUZIONE E TRADUZIONE
e -HUM ANISTICA 4 Riproposizione de il Maestro : un prezioso testo tomano sulle modalità pedagogiche Antonio Tubiello IL MAESTRO SECONDO TOMMASO D AQUINO DE VERITATE, QUAESTIO UNDECIMA INTRODUZIONE E TRADUZIONE
La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana
 La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana Il tema che qui desidero sviluppare è il significato antropologico della grazia come partecipazione
La grazia come partecipazione della natura divina: implicazioni antropologiche dei misteri della fede cristiana Il tema che qui desidero sviluppare è il significato antropologico della grazia come partecipazione
Leonardo Messinese. L apparire di Dio. Per una metafisica teologica. Edizioni ETS
 Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Leonardo Messinese L apparire di Dio Per una metafisica teologica Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2015 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa info@edizioniets.com www.edizioniets.com
Francesco Albertini interprete di Enrico di Gand. L esse essentiae e l autonomia ontologica dei possibili.
 Giornale Critico di Storia delle Idee 8/2012 Francesco Albertini interprete di Enrico di Gand. L esse essentiae e l autonomia ontologica dei possibili. di Alfredo Gatto L idea che la teoria cartesiana
Giornale Critico di Storia delle Idee 8/2012 Francesco Albertini interprete di Enrico di Gand. L esse essentiae e l autonomia ontologica dei possibili. di Alfredo Gatto L idea che la teoria cartesiana
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat
 Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa Alain Contat Non c è discepolo dell Aquinate che non sappia che l ultima resolutio metafisica dell ente sbocca su haec sublimis
I paradossi di Zenone
 I paradossi di Zenone F. Fabrizi - P. Pennestrì The Mascheroni CAD Team Liceo Scientifico Isaac Newton, Roma Le fonti bibliografiche impiegate per conoscere il pensiero di Zenone sono Platone (nel dialogo
I paradossi di Zenone F. Fabrizi - P. Pennestrì The Mascheroni CAD Team Liceo Scientifico Isaac Newton, Roma Le fonti bibliografiche impiegate per conoscere il pensiero di Zenone sono Platone (nel dialogo
Duns Scoto Magister e Teologo
 Riccardo Fedriga, Claudia Macerola, Federico Minzoni Duns Scoto Magister e Teologo Indagine sul pluralismo metodologico e conoscitivo nel pensiero di Giovanni Duns Scoto * ed è appunto supponendo tutto
Riccardo Fedriga, Claudia Macerola, Federico Minzoni Duns Scoto Magister e Teologo Indagine sul pluralismo metodologico e conoscitivo nel pensiero di Giovanni Duns Scoto * ed è appunto supponendo tutto
MARCO FORLIVESI C È UNA FILOSOFIA NELL OPERA DI FRANCISCO SUÁREZ? IL CASO DELLA DOTTRINA SUL VERBUM MENTIS TRA AUCTORITATES E ARGOMENTI DI RAGIONE *
 MARCO FORLIVESI C È UNA FILOSOFIA NELL OPERA DI FRANCISCO SUÁREZ? IL CASO DELLA DOTTRINA SUL VERBUM MENTIS TRA AUCTORITATES E ARGOMENTI DI RAGIONE * quid sit sentiendum de verbo mentis, est res valde controversa
MARCO FORLIVESI C È UNA FILOSOFIA NELL OPERA DI FRANCISCO SUÁREZ? IL CASO DELLA DOTTRINA SUL VERBUM MENTIS TRA AUCTORITATES E ARGOMENTI DI RAGIONE * quid sit sentiendum de verbo mentis, est res valde controversa
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
L'algebra Booleana. Generalità. Definizioni
 L'algebra Booleana Generalità L algebra booleana è stata sviluppata da George Boole nel 1854, ed è diventata famosa intorno al 1938 poiché permette l analisi delle reti di commutazione, i cui soli stati
L'algebra Booleana Generalità L algebra booleana è stata sviluppata da George Boole nel 1854, ed è diventata famosa intorno al 1938 poiché permette l analisi delle reti di commutazione, i cui soli stati
LE REGOLE DI DEDUZIONE
 LE REGOLE DI DEDUZIONE II concetto di regola di deduzione Ci proponiamo di formulare alcune regole, dette regole di deduzione o ragionamento, in virtù delle quali, a partire da certe P1, P2,..., Pn, sia
LE REGOLE DI DEDUZIONE II concetto di regola di deduzione Ci proponiamo di formulare alcune regole, dette regole di deduzione o ragionamento, in virtù delle quali, a partire da certe P1, P2,..., Pn, sia
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ
 GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ Breve dimostrazione di un errore notevole di Cartesio ed altri a proposito di una legge di natura, secondo la quale essi vogliono che da Dio sia sempre conservata la stessa quantità
TOMMASO D AQUINO. Commissione Leonina Roma-Parigi INTRODUZIONE, TRADUZIONE, NOTE Daniele Didero EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA
 I Talenti 17 TOMMASO D AQUINO COMMENTO AGLI ANALITICI POSTERIORI DI ARISTOTELE Libro I, lezioni 1-34 TESTO CRITICO Commissione Leonina Roma-Parigi 1989 INTRODUZIONE, TRADUZIONE, NOTE Daniele Didero EDIZIONI
I Talenti 17 TOMMASO D AQUINO COMMENTO AGLI ANALITICI POSTERIORI DI ARISTOTELE Libro I, lezioni 1-34 TESTO CRITICO Commissione Leonina Roma-Parigi 1989 INTRODUZIONE, TRADUZIONE, NOTE Daniele Didero EDIZIONI
IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA. PSICOLOGIA DELL'ATTO CONOSCITIVO IN S. TOMMASO
 IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA. PSICOLOGIA DELL'ATTO CONOSCITIVO IN S. TOMMASO Vengono qui riportati i primi quattro articoli della Questione 85 (in tutto è composta da otto articoli). La versione italiana
IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA. PSICOLOGIA DELL'ATTO CONOSCITIVO IN S. TOMMASO Vengono qui riportati i primi quattro articoli della Questione 85 (in tutto è composta da otto articoli). La versione italiana
Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE
 I SOFISTI E SOCRATE Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE I FILOSOFI DELL'UOMO E DELLA CITTÀ Protagora, Gorgia Protagora Trasimaco, Prodico, Ippia, Callicle, Crizia
I SOFISTI E SOCRATE Argomenti LA SOFISTICA PROTAGORA E GORGIA IL PROBLEMA DELLE LEGGI SOCRATE I FILOSOFI DELL'UOMO E DELLA CITTÀ Protagora, Gorgia Protagora Trasimaco, Prodico, Ippia, Callicle, Crizia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA CORSO DI STUDI IN INFORMATICA ESERCITAZIONI AL CORSO DI LOGICA MATEMATICA LOGICA PROPOSIZIONALE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA CORSO DI STUDI IN INFORMATICA ESERCITAZIONI AL CORSO DI LOGICA MATEMATICA LOGICA PROPOSIZIONALE TAVOLE DI VERITÀ, COLETEZZA VERO-FUNZIONALE Esercizio 1. Calcola le tavole
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA CORSO DI STUDI IN INFORMATICA ESERCITAZIONI AL CORSO DI LOGICA MATEMATICA LOGICA PROPOSIZIONALE TAVOLE DI VERITÀ, COLETEZZA VERO-FUNZIONALE Esercizio 1. Calcola le tavole
THOMAS HOBBES. Di: Francesco Coccorese. Claudia D'Ambrosio. Francesco Aldieri
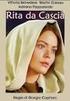 THOMAS HOBBES Di: Francesco Coccorese Claudia D'Ambrosio Francesco Aldieri Nacque a Westport, Inghilterra, il 5 Aprile 1588; Ebbe rapporti con l'ambiente culturale europeo grazie ai suo viaggi; La sua
THOMAS HOBBES Di: Francesco Coccorese Claudia D'Ambrosio Francesco Aldieri Nacque a Westport, Inghilterra, il 5 Aprile 1588; Ebbe rapporti con l'ambiente culturale europeo grazie ai suo viaggi; La sua
II DOMENICA DOPO NATALE
 II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
II DOMENICA DOPO NATALE PRIMA LETTURA Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16) La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell assemblea
STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso
 STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso 1. L analogia, l univocità, il concetto di ente: un excursus storico Le teorie medievali dell analogia
STUDI ALCUNE TRATTAZIONI TARDO-MEDIEVALI SULL UNIVOCITÀ E L ANALOGIA DELL ENTE* di Saverio Di Liso 1. L analogia, l univocità, il concetto di ente: un excursus storico Le teorie medievali dell analogia
Materiale didattico aggiuntivo - Analisi Matematica I CENNI DI LOGICA MATEMATICA. 1. Proposizioni. Valori logici. Connettivi logici. Tavole di verita.
 Materiale didattico aggiuntivo - Analisi Matematica I CENNI DI LOGICA MATEMATICA 1. Proposizioni. Valori logici. Connettivi logici. Tavole di verita. Intenderemo per PROPOSIZIONE (o ENUNCIATO) una qualunque
Materiale didattico aggiuntivo - Analisi Matematica I CENNI DI LOGICA MATEMATICA 1. Proposizioni. Valori logici. Connettivi logici. Tavole di verita. Intenderemo per PROPOSIZIONE (o ENUNCIATO) una qualunque
Appunti di Storia della della Filosofia Greca. Aristotele
 Appunti di Storia della della Filosofia Greca Aristotele Contesto storico e cenni biografici Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.c. vive in un periodo di decadenza della civiltà greca, con il cittadino
Appunti di Storia della della Filosofia Greca Aristotele Contesto storico e cenni biografici Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.c. vive in un periodo di decadenza della civiltà greca, con il cittadino
La metafisica del De ente et essentia di S. Tommaso d Aquino
 La metafisica del De ente et essentia di S. Tommaso d Aquino INTRODUZIONE Il De ente et essentia è un'opera giovanile, scritta da Tommaso, come già si è detto, tra il 1252 e il 1256, quando egli si trovava
La metafisica del De ente et essentia di S. Tommaso d Aquino INTRODUZIONE Il De ente et essentia è un'opera giovanile, scritta da Tommaso, come già si è detto, tra il 1252 e il 1256, quando egli si trovava
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: DIMOSTRAZIONE VELOCE.
 IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: DIMOSTRAZIONE VELOCE. PH. ELLIA Indice Introduzione 1 1. Divisori di un numero. 1 2. Il Teorema Fondamentale dell Aritmetica. 2 3. L insieme dei numeri primi è
IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: DIMOSTRAZIONE VELOCE. PH. ELLIA Indice Introduzione 1 1. Divisori di un numero. 1 2. Il Teorema Fondamentale dell Aritmetica. 2 3. L insieme dei numeri primi è
