Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività
|
|
|
- Tiziano Casadei
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PRIN Unità di Ricerca PRIN-ILIESI Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee Seminario PRIN ILIESI: Roma, 18 marzo 2014 Questi materiali sono disponibili sul sito PRIN ILIESI grazie a: FRANCESCO PAOLO RAIMONDI Per un lessico di Pietro Pomponazzi: il rapporto anima-corpo e i suoi riflessi sull etica
2 Seminario PRIN ILIESI: Roma, 18 marzo 2014 FRANCESCO PAOLO RAIMONDI Per un lessico di Pietro Pomponazzi: il rapporto anima-corpo e i suoi riflessi sull etica Materiali Nel primo paragrafo (Premessa), Raimondi sostiene che Pomponazzi non è solo un puro esegeta e commentatore dei testi aristotelici, ma anche per le lacune e le oscurità degli stessi assume un preciso impegno teoretico volto sia a chiarire passi ardui e oscuri, rendendoli più coerenti con la dottrina di fondo dello Stagirita, sia a elaborare una propria concezione della psicologia. * * * Passi tratti dal De immortalitate animae cui Raimondi fa riferimento nel seminario di studio. Le citazioni si riferiscono all edizione: P. POMPONAZZI, Tutti i trattati peripatetici, a cura di F. P. Raimondi e J. M. García Valverde, Milano, Paragrafo 2 Ho ritenuto di dare avvio alla nostra disamina a partire da questa osservazione: l uomo ha una natura non semplice, ma molteplice, non certa, ma bifronte (ancipitis) ed ha una collocazione media tra il mortale e l immortale (Initium autem considerationis nostrae hinc sumendum duxi: hominem scilicet non simplicis, sed multiplicis, non certae, sed ancipitis naturae esse, mediumque inter mortalia et immortalia collocari, I, 1). Poiché però la natura procede con gradualità... l intelletto umano... si pone come intermedio tra l astratto e il non astratto, cioè tra le Intelligenze e il grado sensitivo, al di sotto delle Intelligenze e sopra gli enti sensitivi... il pensare, non essendo organico, non è immaginazione, ma non può essere senza immaginazione... Quindi l anima umana non ha bisogno di un corpo come soggetto, ma ne ha bisogno come oggetto (Cum natura autem ordinate procedat... intellectus humanus... ponitur medius inter abstracta et non abstracta, scilicet Intelligentias et gradum sensitivum, infra quidem Intelligentias et supra sensitiva... intelligere non esse phantasiam, cum non sit organicum, et quod non potest esse sine phantasia... ergo anima humana non indiget organo ut subiecto, sed ut obiecto, IX, 7). L anima umana è da definire assolutamente mortale. Ed essendo media tra ciò che è astratto in assoluto e ciò che immerso nella materia, partecipa in qualche modo della immortalità, come mostra la sua stessa operazione essenziale. Infatti, non dipende dal corpo come soggetto (in ciò si accorda con le Intelligenze e si differenzia dalle bestie) ed ha bisogno di un corpo come oggetto (in ciò si accorda con le bestie). Perciò è altresì mortale (Quare anima humana... absolute pronuntianda est mortalis. Verum cum sit media inter abstracta simpliciter et immersa materiae, quoquo modo de immortalitate participat, quod et sua essentialis operatio ostendit. Nam non dependet a corpore tamquam subiecto, in quo convenit 1
3 cum Intelligentiis et differt a bestiis; et indiget corpore ut obiecto, in quo convenit cum bestiis. Quare et mortalis est, IX, 15). * * * Paragrafo 3 L anima è l atto di un corpo fisico, organico etc. Quindi l anima intellettiva è l atto di un corpo fisico organico. E poiché secondo l essere l intelletto è atto di un corpo fisico organico, anche nelle sue operazioni dipenderà da un organo o come soggetto o come oggetto. Dunque non sarà mai totalmente libero da un organo (anima est actus corporis physici organici etc. Ergo anima intellectiva est actus corporis physici organici. Cum itaque secundum esse intellectus sit actus corporis physici organici, ergo et in omni suo opere dependebit ab organo, aut tamquam subiecto, aut tamquam obiecto. Numquam ergo totaliter absolvetur ab organo, IV, 6). Per concludere a favore della inseparabilità è sufficiente per Aristotele che [l intelletto] sia o una facoltà organica o, se non organica, una facoltà che sia almeno tale da non poter passare all azione senza un oggetto corporeo. Dice, infatti, Aristotele nel testo 12 del I De anima che non è possibile che l intelletto sia separato se è immaginazione o se non è senza immaginazione... Se dunque per l inseparabilità è sufficiente essere alternativamente o in un organo, come in un soggetto, o dipendere da esso, come oggetto, per la separabilità si richiede congiuntamente tanto l indipendenza da un organo, come soggetto, quanto l indipendenza da un organo, come oggetto, almeno in qualche sua operazione... questo è il punto nodale su cui verte la questione (Modo ad inseparabilitatem concludendam sufficit, secundum Aristotelem, quod sit vel virtus organica vel, si non organica, saltem quod sine obiecto corporali non possit exire in opus. Dicit enim textu duodecimo primi De anima quod sive intellectus sit phantasia sive non sit sine phantasia, non contingit ipsum separari... si igitur ad inseparabilitatem sufficit alternative vel esse in organo tamquam in subiecto vel ab ipso dependere tamquam ab obiecto, igitur ad separabilitatem coniunctim requiritur neque dependere ab organo tamquam a subiecto, neque tamquam ab obiecto, saltem in aliqua sui operatione. Cum autem istud sit de quo est quaestio, IV, 11). Se dunque l essenza con cui sento fosse altra da quella per la quale penso, come potrebbe accadere che l io che sente sia lo stesso che pensa? Se così fosse, potremmo dire che due uomini congiunti simultaneamente si scambino reciprocamente le conoscenze; ma questa è un affermazione ridicola. Non è difficile capire quanto siffatta opinione sia lontana da Aristotele. Infatti, nel II De anima egli afferma che il vegetativo è nel sensitivo come il triangolo è nel quadrato... E poiché per Aristotele il sensitivo e l intellettivo stanno nei mortali allo stesso modo, il sensitivo non sarà una sostanza distinta dall intellettivo (Si igitur altera esset essentia qua sentio et qua intelligo, quo igitur modo fieri posset ut idem qui sentio sim ille qui intelligo? Sic etenim dicere possemus quod duo homines simul coniuncti sic mutuas habent cognitiones; quod ridiculum est. Quam autem huiusmodi opinio sit ab Aristotele remota, non difficile est videre. Etenim De anima II ponit vegetativum in sensitivo veluti trigonum in tetragono... Quare cum per Aristotelem eodem modo in mortalibus se habeat sensitivum ad intellectivum, sensitivum non erit distincta res ab intellectivo, VI, 2). Qualsivoglia soggetto conoscente è atto del corpo fisico organico, ma ciascuno in modo diverso. Infatti, le Intelligenze non sono atti del corpo, in quanto sono Intelligenze, poiché nel loro pensare e desiderare non hanno affatto bisogno del corpo... L anima sensitiva, però, è 2
4 assolutamente atto del corpo fisico organico, perché ha bisogno del corpo sia come soggetto, non potendo esercitare il proprio compito se non in un organo, sia come oggetto. L anima intermedia, che è l intelletto umano, non è libera dal corpo in nessuna delle sue operazioni, né è totalmente immersa in esso; perciò non avrà bisogno del corpo come soggetto, ma ne avrà bisogno come oggetto. E così nel modo intermedio di essere tra l astratto e il non astratto sarà atto del corpo organico... l intelletto umano in ogni sua operazione è atto del corpo organico, poiché sempre dipende dal corpo come oggetto (quodlibet cognoscens est actus corporis physici organici, verum aliter et aliter. Nam Intelligentiae non sunt actus corporis, qua Intelligentiae sunt, quoniam in suo intelligere et desiderare nullo pacto indigent corpore... Anima autem sensitiva simpliciter est actus corporis physici organici, quia et indiget corpore tamquam subiecto, cum non fungatur suo officio nisi in organo, et indiget corpore tamquam obiecto. Media vero, quae est intellectus humanus, in nullo suo opere totaliter absolvitur a corpore, neque totaliter immergitur; quare non indigebit corpore tamquam subiecto, verum tamquam obiecto. Et sic medio modo inter abstracta et non abstracta erit actus corporis organici... At intellectus humanus in omni suo opere est actus corporis organici, cum semper dependeat a corpore tamquam obiecto, IX, 8). * * * Paragrafo 4 Così in conformità dei tre modi di separazione dalla materia si rinvengono in generale tre modalità di conoscenza. Infatti, talune forme sono totalmente separate dalla materia e così per conoscere esse non hanno bisogno del corpo né come soggetto né come oggetto. Infatti, la loro conoscenza non è ricevuta in un corpo, perché esse, essendo motrici non mosse, non sono in un corpo, né sono mosse da un corpo. Queste sono le sostanze separate, che chiamiamo Intelletti o Intelligenze, nelle quali non c è né discorsività né composizione, né un altro moto. Ve ne sono altre che... nel genere degli enti dotati di conoscenza sono le più basse e assai materiali, hanno bisogno nelle loro operazioni del corpo sia come soggetto, sia come oggetto... Esse perciò si rappresentano solo ciò che è singolare e sono mosse dalla sostanza corporea. E queste sono tutte le facoltà sensitive... tra questi due estremi, cioè tra il non aver bisogno del corpo come soggetto o come oggetto e l averne bisogno come soggetto e come oggetto, c è un intermedio che non è né totalmente astratto né totalmente immerso (Iuxta itaque tres modos separationis a materia tres modi cognitionis in universo reperiuntur. Quaedam enim sunt, quae totaliter sunt separata a materia; et sic haec in eorum cognitione neque indigent corpore tamquam subiecto, neque tamquam obiecto. Eorum enim cognitio non recipitur in corpore, cum ipsa non sint in corpore, neque a corpore moventur, cum sint moventia non mota. Et haec sunt substantiae separatae, quas intellectus vel Intelligentias appellamus, in quibus neque discursus, neque compositio, neque aliquis motus recipitur.quaedam vero sunt, quae... in genere cognoscentium infimae sunt et valde materiales, ideo in suis operibus indigent corpore et tamquam subiecto et tamquam obiecto... quare et solum singulariter repraesentant, et a re corporea moventur. Et haec sunt omnes vires sensitivae... inter ista duo extrema, scilicet non indigere corpore ut subiecto vel ut obiecto, et indigere corpore ut subiecto et obiecto, est medium quod neque est totaliter abstractum neque est totaliter immersum, IX, 5-7). L intelletto umano, nella dipendenza dal corpo, differisce dalla facoltà sensitiva perché la sensitiva dipende dal corpo sia soggettivamente sia oggettivamente, l intelletto umano dipende solo oggettivamente. E così l intelletto umano è atto del corpo organico in un modo intermedio tra le sostanze materiali e quelle immateriali (A sensitiva autem virtute differt 3
5 intellectus humanus in dependendo a corpore, quia sensitiva subiective et obiective dependet, humanus autem intellectus obiective tantum. Et sic medio modo humanus intellectus inter materialia et immaterialia est actus corporis organici, IX, 9). Aver bisogno di un organo come soggetto è l essere recepito in un corpo sia in modo quantitativo sia in modo corporeo, così da essere recepito con l estensione... Perciò non essere in un organo o non avere bisogno di esso soggettivamente significa o non essere in un corpo o non essere in esso in modo quantitativo. Per cui diciamo che l intelletto non ha bisogno del corpo come soggetto nella sua intellezione, non perché l intellezione non sia in alcun modo nel corpo; infatti, se l intelletto è in un corpo, non è possibile che la sua operazione immanente non sia in qualche modo in esso, perché dove c è il soggetto, è necessario che ci sia anche l accidente del soggetto. Ma proprio per questo si dice che l intellezione non è in un organo e in un corpo, poiché non è in esso in modo quantitativo e corporeo. Per questo l intelletto può riflettere su se stesso, può procedere discorsivamente e pensare in termini universali; cosa che le facoltà organiche ed estese non possono minimamente fare. Ciò proviene dall essenza dell intelletto, perché, in quanto è intelletto, non dipende dalla materia né dalla quantità. Se l intelletto umano dipende dalla materia, ciò è dovuto al fatto che è congiunto con il senso; quindi è possibile che, in quanto intelletto, dipenda accidentalmente dalla materia e dalla quantità. Per cui la sua operazione non è più astratta della sua essenza... per quanto l intelletto umano... non si serva della quantità nel pensare, tuttavia poiché è congiunto al senso, non può essere totalmente libero dalla materia e dalla quantità, poiché non conosce mai senza l immagine sensibile... Perciò, avendo così bisogno del corpo come oggetto, non può conoscere l universale in assoluto, ma pensa sempre l universale nel singolo... Infatti, in ogni conoscenza, per quanto astratta, l intelletto forma per sé una qualche immagine corporea. Per tale ragione l intelletto umano non pensa sé stesso primariamente e direttamente, ma compone ed ha un procedimento discorsivo, perché il suo pensare è continuo e nel tempo. Tutto l opposto accade nelle Intelligenze, che sono del tutto libere dalla materia. Dunque, l intelletto, stando nel mezzo tra l immateriale e il materiale, non è del tutto qui ed ora, né è del tutto libero dal qui ed ora. Per cui né la sua operazione è del tutto universale, né è del tutto particolare, né è del tutto soggetta al tempo, né del tutto libera dai vincoli temporali (Indigere itaque organo ut subiecto est in corpore recipi et modo quantitativo et corporali, sic quod cum extensione recipiatur... Quare non esse in organo sive subiective eo non indigere est vel non esse in corpore, vel in eo non esse modo quantitativo. Unde dicimus intellectum non indigere corpore ut subiecto in sui intellectione, non quia intellectio nullo modo sit in corpore, cum fieri nequit, si intellectus est in corpore, ut sua immanens operatio quoquo modo non sit in eo ubi enim subiectum est, et accidens subiecti necesse est esse sed pro tanto dicitur intellectio non esse in organo et in corpore, quoniam modo quantitativo et corporali non est in eo. Quapropter potest intellectus reflectere supra se ipsum, discurrere et universaliter comprehendere, quod virtutes organicae et extensae minime facere queunt; hoc autem totum provenit ex essentia intellectus, quoniam, qua intellectus est, non dependet a materia neque a quantitate. Quod si humanus intellectus ab ea dependet, hoc est, ut sensui coniunctus est; quare accidit sibi, qua intellectus est, a materia et quantitate dependere. Unde et eius operatio non est magis abstracta quam essentia... at quamvis intellectus humanus... intelligendo non fungatur quantitate, attamen quoniam sensui coniunctus est, ex toto a materia et quantitate absolvi non potest, cum numquam cognoscat sine phantasmate... Unde sic indigens corpore ut obiecto, neque simpliciter universale cognoscere potest, sed semper universale in singulari speculatur... In omni namque quantumcumque abstracta cognitione idolum aliquod corporale sibi format, propter quod humanus intellectus primo et directe non intelligit se, componitque et discurrit, quare suum intelligere est cum continuo et tempore, cuius totum oppositum contingit in Intelligentiis, quae sunt penitus liberatae a materia. Ipse igitur intellectus sic medius existens inter immaterialia et materialia, neque ex toto est hic et 4
6 nunc, neque ex toto ab hic et nunc absolvitur. Quapropter neque sua operatio ex toto est universalis, neque ex toto est particularis, neque ex toto subicitur tempori, neque ex toto a tempore removetur, IX, 16). Poiché, inoltre, si diceva che l anima viene da fuori, ciò deve essere inteso come mente in assoluto e non come mente umana, o, se ci si riferisce alla mente umana, bisogna intenderla non in assoluto, ma perché, rispetto alla sensitiva e alla vegetativa, partecipa di più della divinità (Cumque ulterius dicebatur ipsam venire de foris, intelligendum est ut mens simpliciter, non ut humana; vel si ut humana, intelligendum est non absolute, sed quod in ordine ad sensitivam et vegetativam magis participat de divinitate, IX, 26). Ci sono dunque nell universo tre tipologie di esseri animati, e poiché ogni essere animato conosce, ci sono tre tipi di conoscenza. Ci sono, infatti, gli esseri animati del tutto eterni, ci sono quelli del tutto mortali e ci sono quelli che sono intermedi tra questi due. I primi sono i corpi celesti e questi nel conoscere non dipendono in alcun modo dal corpo. Gli altri, invece, sono le bestie, che dipendono dal corpo come soggetto e come oggetto, per cui conoscono solo le cose singole. Gli esseri intermedi sono gli uomini che non dipendono dal corpo come soggetto, ma solo come oggetto; perciò non conoscono l universale in assoluto, come gli enti eterni, né solo le cose singole, come le bestie, ma osservano l universale nel singolo (Sunt itaque in universum tres modi animalium; cumque omne animal cognoscit, sunt et tres modi cognoscendi. Sunt enim animalia omnino aeterna, sunt et omnino mortalia, sunt et media inter haec. Prima sunt corpora caelestia, et haec nullo modo in cognoscendo dependent a corpore. Alia vero sunt bestiae, quae a corpore dependent ut subiecto et ut obiecto, quare tantum singulariter cognoscunt. Intermedia vero sunt homines, non dependentes a corpore ut subiecto, sed tantum ut obiecto; quare neque universale simpliciter, ut aeterna, neque singulariter tantum, ut bestias, sed universale in singulari contemplantur, IX, 30). l intelletto umano è sia intelletto sia umano. In quanto è intelletto, conosce l universale, ma in quanto è umano, non può conoscere l universale se non nelle cose singole (Intellectus enim humanus habet et quod sit intellectus et humanus. Qua enim intellectus est, universale cognoscit; sed qua humanus, universale nisi in singulari perspicere nequit, X, 7). Il pensare non è in una particolare parte del corpo, ma nel corpo intero, preso categorematicamente. Non è localizzato in una parte particolare perché altrimenti sarebbe un intelletto organico e o non conoscerebbe tutte le forme o, se le conoscesse, le conoscerebbe come la cogitativa solo come singolari e non come universali. Perciò come l intelletto è in tutto il corpo, così è anche il pensare (non tamen in aliqua parte corporis ponitur ipsum intelligere, sed in toto cathegorematice sumpto; non enim in aliqua parte, quoniam sic esset organicus intellectus, et vel non omnia cognosceret vel, si omnia cognosceret, ut cogitativa, tantum singulariter et non universaliter cognosceret. Quare sicut intellectus est in toto, ita et intelligere, X, 9). Opportunamente Alessandro ha sostenuto che tutto il corpo è strumento dell intelletto, perché l intelletto include tutte le sue facoltà e non solo una parte determinata; altrimenti non conoscerebbe tutte le forme, proprio come non le conosce nessuna delle facoltà sensitive. Ma per quanto si ammetta che tutto il corpo sia strumento dell intelletto quasi come soggetto, tuttavia il corpo non è veramente il soggetto del pensare, perché, come si è detto in precedenza, il pensare non può essere ricevuto in modo corporeo (Non inconvenienter igitur Alexander posuit totum corpus esse instrumentum intellectus, quoniam intellectus omnes vires comprehendit, et non aliquam partem determinatam; quoniam sic non omnia cognosceret, 5
7 sicut neque aliqua virtutum sensitivarum. Quamquam autem sic totum corpus ponatur instrumentum intellectus quasi ut subiectum, non tamen est vere ut subiectum, quoniam intelligere non recipitur in eo modo corporali, ut prius dictum est, X, 10). * * * Paragrafo 5 Si rinvengono tre tipi di uomini. Taluni, infatti, sebbene siano pochissimi, sono annoverati tra gli dèi; e questi sono coloro che, soggiogate la vegetativa e la sensitiva, si sono resi quasi totalmente razionali. Altri, invece, trascurato del tutto l intelletto, sottomettendosi esclusivamente alla vegetativa e alla sensitiva, sono quasi trasmigrati nelle bestie... Altri sono chiamati uomini puri e sono coloro che hanno condotto la vita con moderazione e secondo le virtù morali; tuttavia non si sono subordinati del tutto all intelletto, né si sono liberati del tutto delle facoltà corporee (I, 2). A ciascuna cosa si deve assegnare come fine non ciò che è bene in misura maggiore, ma solo ciò che si addice a quella natura e che sia ad essa proporzionato... quando si assegna un fine all uomo, se gli assegniamo lo stesso fine che assegneremmo a Dio e alle Intelligenze, l assegnazione non sarebbe appropriata perché in tal caso non sarebbe uomo (unicuique rei pro fine assignari, sed solum secundum quod convenit illi naturae et ei proportionatur... Quare et in assignando finem homini, si talem qualem Deo et Intelligentiis assignaremus, non conveniens foret assignatio, quandoquidem sic non esset homo, XIV, 2). Né tutte le cose possono essere di uguale perfezione, ma ad alcune sono date funzioni più perfette, ad altre più imperfette. Se si escludesse questa disuguaglianza, il genere umano o perirebbe o vivrebbe in gravi difficoltà... Né la disuguaglianza tra gli uomini, che è tuttavia commisurata, deve generare discordia; anzi, come in una sinfonia di voci la diversità commisurata rende dilettevole il concerto, così la diversità commisurata tra gli uomini genera la perfezione, la bellezza, il decoro e il dilettevole, quella oltre misura genera il contrario (Neque omnia possunt esse aequalis perfectionis, sed quibusdam data sunt perfectiora, quibusdam vero imperfectiora. Haecque inaequalitas si tolleretur, aut genus humanum periret, aut non commode constaret... Neque inaequalitas inter homines, commensurata tamen, debet discordiam parere; immo sicut in symphonia vocum commensurata diversitas concentum delectabilem facit, sic commensurata diversitas inter homines perfectum, pulchrum, decorum et delectabile generat, incommensurata vero contrarium, XIV, 5). Tutti gli uomini per conseguire siffatto fine comune debbono avere in comune tre intelletti: lo speculativo, il pratico o operativo e il fattivo. Infatti, non c è nessun uomo... che non possieda qualcosa di questi tre intelletti... Infatti, ogni uomo possiede in qualche misura l attitudine speculativa... Intorno all intelletto operativo, che si occupa dei costumi, degli affari pubblici e dell amministrazione privata, è evidentissimo che a ciascuno è stata data l opportunità di conoscere il bene e il male e di essere partecipi della società e della famiglia. Infatti, siffatto intelletto è detto veramente e propriamente umano... Riguardo all intelletto fattivo è sotto gli occhi di tutti che senza di esso nessun uomo può condurre la vita. Infatti, senza le attività produttive e senza il necessario la vita umana non può durare a lungo (omnes homines ad huiusmodi finem communem consequendum debent in tribus intellectibus communicare: speculativo videlicet, practico seu operativo, et factivo. Nullus etenim homo... qui aliquid horum trium intellectuum non habeat... Unusquisque etenim homo habet aliquid de speculatione... De intellectu autem operativo, qui est circa mores, res publicas et res 6
8 domesticas, illud quidem apertissimum est, cum unicuique datum sit bonum et malum cognoscere, esse partem civitatis et familiae. Etenim huiusmodi intellectus vere et proprie humanus nuncupatur... De factivo autem intellectu illud in propatulo est, quandoquidem nullus homo sine hoc vitam degere potest. Etenim sine mechanicis et necessariis ad vitam homo non potest durare, XIV, 6-7). Ma si deve sapere che, sebbene nessun uomo sia totalmente privo dei tre intelletti citati, tuttavia gli uomini non hanno con essi un uguale rapporto (Verum scire oportet quod, tametsi unusquisque homo de tribus enumeratis intellectibus ex toto non privetur, non tamen homo aequaliter se habet ad hos, XIV, 8). L intelletto speculativo non è dell uomo, ma degli dèi... Così, anche se tutti gli uomini posseggono qualcosa di questo intelletto, tuttavia solo pochissimi lo posseggono e possono possederlo interamente e perfettamente. Perciò accade che quella parte del genere umano, che si dedica interamente alla speculazione, sta rispetto al genere umano nello stesso rapporto in cui il cuore sta con il genere delle membra, sebbene ci sia una gamma di gradazioni per cui taluni sono matematici, altri fisici, altri metafisici (Speculativus namque intellectus non est hominis, verum est deorum... Ideo, etsi omnes homines aliquid huius habent, exacte tamen et perfecte paucissimi et habent et habere possunt. Propter quod contingit quod ea pars generis humani, quae se totam speculationi tradit, eam proportionem tenet in genere hominum, quam cor in genere membrorum, quamquam et latitudo sit, ut quidam mathematici, quidam physici, quidam vero metaphysici sint, XIV, 9). E come ciascun elemento, nell ambito della totalità, possiede categoricamente il proprio specifico posto... così ogni uomo possiede un fine ultimo che non si addice alla parte se non come parte di tutto il genere umano. Ma è sufficiente condividere un comune fine umano (Et sicut unumquodque elementum secundum totum cathegorematice est debite situatum... ita non quilibet habet ultimum finem qui convenit parti nisi ut pars generis humani. Sufficit autem habere communem finem humanum, XIV, 14). Il fine, però, che compete alla parte più perfetta del genere umano non può essere raggiunto da tutti, né si addice all uomo. Come non ogni membro può avere la perfezione del cuore o dell occhio altrimenti non esisterebbe l essere vivente così, se ogni uomo si dedicasse all attività speculativa, non esisterebbe la comunità umana (qui [finis] tamen competit parti perfectissimae, non potest neque convenit. Sicut non quodlibet membrum potest habere perfectionem cordis et oculi immo non constaret animal, sic, si quilibet homo esset speculativus, non constaret communitas humana, XIV, 15). Né il mortale deve desiderare la felicità immortale, perché l immortale non si addice all uomo mortale... Perciò abbiamo supposto innanzitutto che a ciascuna cosa sia assegnato un fine proporzionato. Se, infatti, l uomo sarà temperato, non desidererà l impossibile, che non gli si addice, perché il possesso di tale felicità è proprio degli dèi (Neque mortalis immortalem felicitatem appetere debet, quoniam immortale mortali non convenit... Quare primo supposuimus quod unicuique rei proportionatus finis assignetur. Si enim homo erit temperatus, non impossibilia appetet, neque sibi conveniunt; talem enim habere felicitatem est proprium deorum, XIV, 16). Il quarto dubbio era espresso in questi termini: quasi tutto il mondo sarebbe ingannato poiché tutte le religioni pongono l anima come immortale. Ad esso si risponde che... è necessario ammettere che o tutto il mondo si inganna o si inganna almeno la maggior parte. Infatti, supposto che ci siano solo tre religioni, quella di Cristo, di Mosè e di Maometto, o sono tutte 7
9 false, e così tutto il mondo è ingannato, o sono false almeno due di esse, e così è ingannata la maggior parte degli uomini (At quartum vero, in quo dicebatur quod fere totum universum esset deceptum, cum omnes leges ponant animam immortalem esse, ad quod dicitur quod... necesse est concedere, aut quod totus mundus decipitur aut saltem maior pars. Nam supposito quod tantum sint tres leges, Christi scilicet, Moysi et Mahumethi, aut igitur omnes sunt falsae, et sic totus mundus est deceptus, aut saltem duae earum, et sic maior pars est decepta, XIV, 28). Alcuni sono uomini di natura genuina e ben costituita da Dio; questi sono indotti alle virtù dalla sola nobiltà delle virtù ed altri sono allontanati dai vizi solo per la loro bruttura. Questi ultimi sono ottimamente disposti, sebbene siano pochissimi. Altri, invece... perseguono la virtù e fuggono il vizio per i premi, per le lodi e per gli onori o per le pene, come il biasimo e l infamia. E questi sono ad un secondo grado. Altri diventano virtuosi per la speranza di un bene o per il timore di una pena corporea; perciò per indurli a conseguire tale virtù, i politici stabiliscono premi come l oro o le dignità o qualcosa di simile e per indurli a fuggire i vizi stabiliscono punizioni come la multa o la perdita degli onori o pene corporee, come la mutilazione di un membro o la pena capitale... Così i politici hanno escogitato premi eterni ai virtuosi in un altra vita e ai viziosi afflizioni eterne che incutessero il massimo terrore... E poiché tale stratagemma può andare a genio di tutti gli uomini... il legislatore, consapevole dell inclinazione degli uomini al male, mirando al bene comune, incurante della verità, preoccupandosi solo dell onestà, per indurre gli uomini alla virtù, ha sancito che l anima è immortale (Aliqui enim sunt homines ingenui et bene institutae naturae a Deo, qui ad virtutes inducuntur ex sola virtutum nobilitate, et a vitiis retrahuntur ex sola eorum foeditate. Et hi optime dispositi sunt, licet perpauci sint. Aliqui vero... ex praemiis, laudibus et honoribus, ex poenis, ut vituperiis et infamia, studiosa operantur et vitia fugiunt. Et hi in secundo gradu sunt. Aliqui vero propter spem alicuius boni et timorem poenae corporalis studiosi efficiuntur; quare ut talem virtutem consequantur, statuunt politici vel aurum vel dignitatem, vel aliquid tale; ut vitia vero fugiant, statuunt vel in pecunia vel in honore vel in corpore, seu mutilando membrum seu occidendo, puniri... Ideo posuerunt virtuosis in alia vita praemia aeterna, vitiosis vero aeterna damna, quae maxime terrerent... Et quoniam hoc ultimum ingenium omnibus hominibus potest prodesse... respiciens legislator pronitatem virorum ad malum, intendens communi bono sanxit animam esse immortalem, non curans de veritate, sed tantum de probitate, ut inducat homines ad virtutem, XIV, 28). 8
Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività 2013-2015
 PRIN 2010-2011 Unità di Ricerca PRIN-ILIESI Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività 2013-2015 Consiglio Nazionale delle Ricerche
PRIN 2010-2011 Unità di Ricerca PRIN-ILIESI Il problema anima-corpo alla luce dell etica tra Rinascimento e Settecento: testi lessico fonti censure Attività 2013-2015 Consiglio Nazionale delle Ricerche
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C.
 ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
ARISTOTELE STAGIRA 384/83 A.C. CALCIDE 322 A.C. CONFRONTO CON PLATONE DA OSSERVARE: - DifFERENTE CONTESTO SOCIO-POLITICO; - INTERESSE POLITICO-EDUCATIVO IN PLATONE; INTERESSE CONOSCITIVO-SCIENTIFICO IN
Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva
 TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
TEMA 3: LE FACOLTÀ CONOSCITIVE E LA CONOSCENZA UMANA Tema 3/2: Le facoltà intellettive e la conoscenza intellettiva Tommaso d'aquino, Somma teologica: I, q. 79, aa. 1-3 Nuova Edizione On-Line in lingua
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio
 Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
Parte prima > Trattato relativo all'essenza di Dio > La scienza di Dio Prima pars Quaestio 14 Prooemium Prima parte Questione 14 Proemio [28893] Iª q. 14 pr. Post considerationem eorum quae ad divinam
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista. Se Dio esista
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 2 Se Dio esista Se Dio esista Prima pars Quaestio 2 Prooemium Prima parte Questione 2 Proemio [28298] Iª q. 2 pr. Quia igitur principalis intentio huius sacrae
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra
 Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
Il primato del bene sul vero nella dottrina dei perfettibili di Padre Alberto Boccanegra P. Giovanni Bertuzzi O.P. P. Alberto Boccanegra distingue, prima di tutto, il punto di vista analitico da quello
Boezio e la teoria delle proporzioni. Calcidio e il commento al Timeo di Platone
 Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Boezio e la teoria delle proporzioni Calcidio e il commento al Timeo di Platone 1 Boethii De institutione arithmetica libri duo 2. 40-54 dottrina delle proporzioni 2 media aritmetica posti tre o più termini,
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica
 Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
Padre Luigi Salerno, OP L oggetto della metafisica In relazione all opera fondamentale del Padre Tyn Metafisica della sostanza, ritengo opportuno esporre queste mie riflessioni, già contenute in una mia
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
> NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare, di Aristotele.
Cartesio. Dice di non aver mai acquisito un criterio che gli faccia distinguere il vero dal falso. Il suo compito filosofico consiste nel:
 Cartesio Dice di non aver mai acquisito un criterio che gli faccia distinguere il vero dal falso. Il suo compito filosofico consiste nel: 1. Formulare le regole del metodo. 2. Fondare con una ricerca metafisica
Cartesio Dice di non aver mai acquisito un criterio che gli faccia distinguere il vero dal falso. Il suo compito filosofico consiste nel: 1. Formulare le regole del metodo. 2. Fondare con una ricerca metafisica
Descartes Meditazioni Metafisiche. Schema
 Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Descartes Meditazioni Metafisiche Schema Corso di Storia della Filosofia 2015-16 Giovanni Paoletti Nota: La numerazione in paragrafi si riferisce all edizione a cura di S. Landucci, Laterza I meditazione
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015
 Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca
lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 Declinazione)
 māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II Misura 25 suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II Pronomi/Interrogativi 27 alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe
Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento
 _ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
_ Pro Loco di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento PREMIO LETTERARIO DI CULTURA LATINA Preside SALVATORE PACELLI Per gli studenti del penultimo e dell ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo.
 1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
1596-1650 Il Problema Come si fa a distinguere il vero dal falso? Occorre elaborare una filosofia pratica che migliori la vita dell uomo. Questa filosofia deve possedere un metodo unico e semplice che
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE
 I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
I PRONOMI RELATIVI. LA PROPOSIZIONE RELATIVA LA PROLESSI DELLA PROPOSIZIONE RELATIVA. IL NESSO RELATIVO. I PRONOMI RELATIVI-INDEFINITI IL PRONOME RELATIVO QUI, QUAE, QUOD (IL QUALE, LA QUALE, LA QUALE
La fisica. Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto)
 La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
La fisica Oggetto: essere in movimento (sua dimensione intrinseca per la composizione materia + forma = potenza + atto) Tre tipi di movimento quante sono le categorie. 4 sono quelli fondamentali: sostanza:
AGOSTINO. Vita. Opere. La lotta alle eresie. - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene.
 AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
AGOSTINO Vita Opere La lotta alle eresie Il manicheismo (cf. pp.382-383) La risposta di Agostino - Il male non è un essere sostanziale autonomo. - Il male è privazione di bene, accidenti del bene. Il donatismo
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE
 IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
IMMANUEL KANT CRITICA DELLA RAGION PURA LOGICA TRASCENDENTALE Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti,
Sacra Famiglia anno C
 1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
1 Prima lettura (1 Sam 1,20-22.24-28) Sacra Famiglia anno C Al finir dell anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva al Signore l ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con
!)Ku,Ky(! Luca Visone : PORTFOLIO :.
 .: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
.: PORTFOLIO :. ...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!...perchè!)ku,ky(!... i 2 punti esclamativi all inizio ed alla fine del logo rappresentano la ferma volontà di voler riuscire in quelli
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine. Il conseguimento della beatitudine
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 5 Il conseguimento della beatitudine Il conseguimento della beatitudine Prima pars secundae partis Quaestio 5 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione
Logica filosofica. Terza Parte Il ragionamento
 Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
Logica filosofica Terza Parte Il ragionamento Caratteristiche generali del ragionamento Definizione: Il ragionamento è un movimento della mente per il quale passiamo da diversi giudizi confrontatisi fra
MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA?
 Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
Bergamo, 2 Febbraio 2018 Dr.Gianna Beranti SSR INAIL Lombardia MALATTIE PROFESSIONALI: UN ADEGUATA TUTELA? DENUNCE MP LAVORATORI- anno di protocollazione 2012-2016- BANCA DATI INAIL 9.000 Denunce 8.000
RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile
 RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile
Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele
 Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano
Quaestio 76 De unione animae ad corpus
 Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
Quaestio 76 della Parte I della Summa Theologiae di San Tommaso d Aquino 1 A cura di Marcello Landi 2 Quaestio 76 De unione animae ad corpus Prooemium [31504] Iª q. 76 pr. Deinde considerandum est de unione
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO
 LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DELL ESISTENZA DI DIO Con Anselmo d Aosta nasce all interno della Chiesa una corrente di pensiero, la teologia analitica, che si ripropone di dimostrare l esistenza di Dio
ANSELMO D AOSTA
 Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI
 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI Linee guida per i beneficiari per realizzare targhe e cartelli informativi sugli interventi realizzati con il sostegno del PSR Toscana 2014-2020.
Introduzione. - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare
 Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
Falsiroli Simonetta 1 Introduzione Scopi: - Analizzare le parti fondamentali dell opera La logica o Arte di pensare - Focalizzare l attenzione ai riferimenti matematici contenuti nel testo 2 1 L opera:
ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio
 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT ANSELMO D'AOSTA Prova ontologica dell'esistenza di Dio Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora lo
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è la sua opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è la sua opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali
 S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
S. Th., I a, q. 19, a. 9 Se Dio voglia i mali Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid.,
LA SOMMA TEOLOGICA. eso S. TOMMASO D AQUINO. L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA
 S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
S. TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL EDIZIONE LEONINA V L* OPERA, DEI SEI GIORNI V UOMO : a) NATURA E POTENZE DELL ANIMA (I, qq.
Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo
 Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
Marco Rainini Crisi dell Eurocentrismo e futuro dell umanesimo europeo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 maggio 2015 1 «Hinc est, quod saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa. Divisione della vita in attiva e contemplativa
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 179 Divisione della vita in attiva e contemplativa Divisione della vita in attiva e contemplativa Prooemium Proemio [46084] IIª-IIae, q. 179 pr. Consequenter
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO
 LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
LO STATUTO EPISTEMOLOGICO DELLA METAFISICA IN TOMMASO D AQUINO Rafael Pascual, L.C. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Introduzione. 1. Tres sunt partes philosophiae theoricae, scilicet mathematica,
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità
 Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
Giampaolo Azzoni La legge in Tommaso d Aquino: una archeologia del principio di legalità Tommaso d Aquino 1225-1274 diritto naturale classico vs. antico vs. moderno Summa Theologiae I a -II ae, qq. 90
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo. Il fine ultimo dell'uomo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I-II, 1 Il fine ultimo dell uomo Il fine ultimo dell'uomo prima pars secundae partis Quaestio 1 Prooemium Prima parte della seconda parte Questione 1 Proemio [33405]
Aristotele a. C.
 Aristotele 384-322 a. C. La differenza con Platone Platone: le idee sono separate dalla realtà Aristotele: le idee si trovano all interno degli oggetti L esempio dello Stato ideale Il problema dell essere
Aristotele 384-322 a. C. La differenza con Platone Platone: le idee sono separate dalla realtà Aristotele: le idee si trovano all interno degli oggetti L esempio dello Stato ideale Il problema dell essere
ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI
 ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI Di Claudio Antonio Testi PREMESSA Con questo breve contributo vorrei sviluppare una breve analisi logica del termine naturale in un ottica tomista.
ANALISI LOGICA DEI DUE SENSI DI NATURALE E LORO APPLICAZIONI Di Claudio Antonio Testi PREMESSA Con questo breve contributo vorrei sviluppare una breve analisi logica del termine naturale in un ottica tomista.
Thomas Hobbes
 588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
588-676 Ebbe una vita lunga e dedita allo studio oltre che alla polemica erudita. Il leviatano, del 65, è l opera più nota. La filosofiadi Hobbes rappresenta l altra grande alternativa cui l elaborazione
 1 lucas@unigre.it www.ramonlucas.org 2 3 Satre Non c'è natura umana Libertà assoluta, senza norme di riferimento Valore soggettivo 4 5 Domanda Perché la vita umana è sempre un bene? Il fenomeno vita, nel
1 lucas@unigre.it www.ramonlucas.org 2 3 Satre Non c'è natura umana Libertà assoluta, senza norme di riferimento Valore soggettivo 4 5 Domanda Perché la vita umana è sempre un bene? Il fenomeno vita, nel
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO
 4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO Chiarita la natura delle sue proposizioni Aristotele negli analitici primi spiega quelle che sono le strutture e i modi del ragionamento, perché
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) IL SILLOGISMO Chiarita la natura delle sue proposizioni Aristotele negli analitici primi spiega quelle che sono le strutture e i modi del ragionamento, perché
Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo
 Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo Da https://www.edizionistudiodomenicano.it/on-line.php = Tommaso dʼaquino, La Somma Teologica, Tr. italiana
Tommaso dʼaquino, Summa Theologiae, I-II Indice delle prime 5 questioni, Prologo, e alcuni respondeo Da https://www.edizionistudiodomenicano.it/on-line.php = Tommaso dʼaquino, La Somma Teologica, Tr. italiana
TOMMASO DE VIO GAETANO, PIETRO POMPONAZZI E LA POLEMICA SULL IMMORTALITÀ DELL ANIMA. STATUS QUAESTIONIS E NUOVE SCOPERTE
 TOMMASO DE VIO GAETANO, PIETRO POMPONAZZI E LA POLEMICA SULL IMMORTALITÀ DELL ANIMA. STATUS QUAESTIONIS E NUOVE SCOPERTE ANNALISA CAPPIELLO I. Cronistoria di una amicizia : introduzione Non è facile ricostruire
TOMMASO DE VIO GAETANO, PIETRO POMPONAZZI E LA POLEMICA SULL IMMORTALITÀ DELL ANIMA. STATUS QUAESTIONIS E NUOVE SCOPERTE ANNALISA CAPPIELLO I. Cronistoria di una amicizia : introduzione Non è facile ricostruire
TOMMASO D'AQUINO. Legge naturale e legge umana
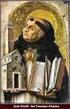 MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
MAAT CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT TOMMASO D'AQUINO Legge naturale e legge umana www.maat.it/maat4 1 I secolo a.c. Cicerone, De re publica Vi è una legge vera, ragione retta conforme
Percorso su LIM da Kant all idealismo
 Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
Percorso su LIM da Kant all idealismo CRITICA DELLA RAGION (PURA) PRATICA NON EMPIRICA VOLONTA Massime «SE.. Devi> Imperativi Imperativi ipotetici Imperativo categorico «Tu devi» Formulazioni dell imperativo
DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA
 DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA SIGNIFICATI DELL ESPRESSIONE DIRITTO COMUNE Diritto generale e universale, civile e canonico (Utrumque ius) Diritto generale rispetto ai diritti particolari
DIRITTO COMUNE TRA ETÀ MEDIEVALE E ETÀ MODERNA SIGNIFICATI DELL ESPRESSIONE DIRITTO COMUNE Diritto generale e universale, civile e canonico (Utrumque ius) Diritto generale rispetto ai diritti particolari
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE.
 PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
PRIMA PARTE. L AZIONE DIVINA NELLA GIUSTIFICAZIONE. -307- San Tommaso, prima di affrontare il tema dell azione divina per mezzo dell infusione della grazia, si chiede se la giustificazione è la remissione
Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo
 1 Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo
1 Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Tesi 16: L unione fra l anima e il corpo Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale
 Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814)
 Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, 19 maggio 1762 Berlino, 27 gennaio 1814) a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito. Fichte vuol costruire una filosofia
LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ
 LA PRIMA DECLINAZIONE LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ ALCUNE NOTAZIONI STORICHE LE CONGIUNZIONI E GLI AVVERBI FREQUENTI La prima declinazione comprende: -sostantivi femminili (la maggior parte) -sostantivi
LA PRIMA DECLINAZIONE LE DESINENZE E LE PARTICOLARITÀ ALCUNE NOTAZIONI STORICHE LE CONGIUNZIONI E GLI AVVERBI FREQUENTI La prima declinazione comprende: -sostantivi femminili (la maggior parte) -sostantivi
IMMANUEL KANT
 IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
IMMANUEL KANT 1724-1804 Prof. Monti a.s. 2017-2018 Parte prima Kant prende le mosse dall Empirismo arrivando a elaborare il suo CRITICISMO (anche detto filosofia trascendentale o filosofia del limite )
Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.
 La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie
Il sommo bene dell uomo
 Lettura 8 Boezio di Dacia Il sommo bene dell uomo Il sommo bene, in Boezio di Dacia - Giacomo da Pistoia, Ricerca della felicità e piaceri dell intelletto, a cura di F. Bottin, Firenze, Nardini Editore,
Lettura 8 Boezio di Dacia Il sommo bene dell uomo Il sommo bene, in Boezio di Dacia - Giacomo da Pistoia, Ricerca della felicità e piaceri dell intelletto, a cura di F. Bottin, Firenze, Nardini Editore,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio. L'amore di Dio
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae I, 20 L amore di Dio L'amore di Dio Prima pars Quaestio 20 Prooemium Prima parte Questione 20 Proemio [29285] Iª q. 20 pr. Deinde considerandum est de his quae absolute
IL DUBBIO METODICO IL DUBBIO IPERBOLICO. Riguarda inizialmente le conoscenze sensibili. Con l ipotesi del genio maligno si estende a tutto
 CARTESIO Filosofo,scienziato e matematico francese, considerato il fondatore della filosofia moderna e del razionalismo. Nasce il 31 marzo 1596 a La Haye, nella Touraine. Fu educato da gesuiti nel collegio
CARTESIO Filosofo,scienziato e matematico francese, considerato il fondatore della filosofia moderna e del razionalismo. Nasce il 31 marzo 1596 a La Haye, nella Touraine. Fu educato da gesuiti nel collegio
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara)
 APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
APPROFONDIMENTI DI FILOSOFIA MORALE (6 crediti) (Università degli Studi di Ferrara) Docente: Dr.ssa Federica Basaglia (bsgfrc@unife.it) Titolo del corso: LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA DI KANT Periodo:
OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986
 Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986-1- I. APPROCCIO FILOSOFICO L atto di pensare, che è proprio dell intelletto,
Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie OGGETTO E NATURA DELL INTELLIGENZA UMANA Centro San Domenico 1986-1- I. APPROCCIO FILOSOFICO L atto di pensare, che è proprio dell intelletto,
Il Metodo. Assi Cartesiani. Mathesis Universalis:
 1596-1650 Indice Il Metodo; Il Dubbio Metodico e Iperbolico; Il Cogito Ergo Sum; Le Idee Contenute Nel Cogito; Dio garante di verità; Il Meccanicismo; Il Dualismo Cartesiano; La Ghiandola Pineale; La Morale
1596-1650 Indice Il Metodo; Il Dubbio Metodico e Iperbolico; Il Cogito Ergo Sum; Le Idee Contenute Nel Cogito; Dio garante di verità; Il Meccanicismo; Il Dualismo Cartesiano; La Ghiandola Pineale; La Morale
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI. Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA
 UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
UMBERTO MURATORE CONOSCERE ROSMINI Vita, pensiero, spiritualità EDIZIONI ROSMINIANE - STRESA INDICE Presentazione p. 5 La vita La famiglia p. 9 L infanzia e l adolescenza (1797-1814) p. 11 L incontro con
Studia graeco-arabica
 Studia graeco-arabica 8 2018 Editorial Board Mohammad Ali Amir Moezzi, École Pratique des Hautes Études, Paris Carmela Baffioni, Istituto Universitario Orientale, Napoli Sebastian Brock, Oriental Institute,
Studia graeco-arabica 8 2018 Editorial Board Mohammad Ali Amir Moezzi, École Pratique des Hautes Études, Paris Carmela Baffioni, Istituto Universitario Orientale, Napoli Sebastian Brock, Oriental Institute,
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo Tertia pars Quaestio
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae III, 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo Tertia pars Quaestio
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642)
 Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
Schema prove dell esistenza di Dio in Descartes Meditazioni (1642) In tutte e tre le prove delle Meditazioni Descartes parte dall idea di Dio: III Meditazione: 2 prove a posteriori che procedono dall effetto
LA SOMMA TEOLOGICA SD1 S, TOMMASO D AQUINO. L U O M O : b) PENSIERO E ORIGINI
 S, TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TR AD U ZIO N E E COM M ENTO A C U R A DEI D O M E N IC A N I ITA LIA N I TESTO LA TIN O D E LL'E D IZIO NE L E O N IN A V I L U O M O : b) PENSIERO E ORIGINI (I,
S, TOMMASO D AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TR AD U ZIO N E E COM M ENTO A C U R A DEI D O M E N IC A N I ITA LIA N I TESTO LA TIN O D E LL'E D IZIO NE L E O N IN A V I L U O M O : b) PENSIERO E ORIGINI (I,
Cicerone, Somnium Scipionis 27-28
 Cicerone, Somnium Scipionis 27-28 Andrea Barabino Nel Somnium Scipionis, che costituisce la parte conclusiva del De re publica - un'opera a noi giunta solo in frammenti di varia estensione - Cicerone immagina
Cicerone, Somnium Scipionis 27-28 Andrea Barabino Nel Somnium Scipionis, che costituisce la parte conclusiva del De re publica - un'opera a noi giunta solo in frammenti di varia estensione - Cicerone immagina
Quesito intorno al libro delle Categorie
 Quesito intorno al libro delle Categorie Latino AD PER QUAM ILLUSTREM DOMINUM DIEGUM DE MENDOZA AD PAULUM III PONTIFICEM CAESAREUM LEGATUM. ANGELI THYI DE MORCIANO, YDRUNTINI SCHOLAE PATAVINAE PUBLICI
Quesito intorno al libro delle Categorie Latino AD PER QUAM ILLUSTREM DOMINUM DIEGUM DE MENDOZA AD PAULUM III PONTIFICEM CAESAREUM LEGATUM. ANGELI THYI DE MORCIANO, YDRUNTINI SCHOLAE PATAVINAE PUBLICI
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica
 RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
RIPARTIZIONE DELL ETICA DI ARISTOTELE (1.0) Etica caratteristica Tipo di virtù coinvolte Modalità Anima vegetativa o nutritiva (irrazionale) Nessuna Nessuna (non si nasce virtuosi) Nessuna Anima sensitiva
Boezio, Contra Eutychen et Nestorium. I. [Le diverse accezioni di «natura».]
![Boezio, Contra Eutychen et Nestorium. I. [Le diverse accezioni di «natura».] Boezio, Contra Eutychen et Nestorium. I. [Le diverse accezioni di «natura».]](/thumbs/98/135700172.jpg) Boezio, Contra Eutychen et Nestorium I. [Le diverse accezioni di «natura».] Natura, dunque, può dirsi o dei soli corpi o delle sole sostanze, ossia degli esseri corporei e incorporei, come di tutte le
Boezio, Contra Eutychen et Nestorium I. [Le diverse accezioni di «natura».] Natura, dunque, può dirsi o dei soli corpi o delle sole sostanze, ossia degli esseri corporei e incorporei, come di tutte le
F I L O S O F I A QUALE TIPO DI FILOSOFIA?
 CHE COSA E QUELLO CHE ABBIAMO DETTO FIN ORA? A QUALE SCIENZA APPARTIENE? PARTE II L EDUCAZIONE ANTROPOLOGIA PSICOLOGIA F I L O S O F I A QUALE TIPO DI FILOSOFIA? LOGICA? FISICA? IN QUANTO SCIENZA DELL
CHE COSA E QUELLO CHE ABBIAMO DETTO FIN ORA? A QUALE SCIENZA APPARTIENE? PARTE II L EDUCAZIONE ANTROPOLOGIA PSICOLOGIA F I L O S O F I A QUALE TIPO DI FILOSOFIA? LOGICA? FISICA? IN QUANTO SCIENZA DELL
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta
 BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
BREVE CENNO DI LOGICA CLASSICA La logica può essere definita come la scienza che studia le condizioni in base alle quali un ragionamento risulta corretto e vero. Un ragionamento è corretto se segue uno
Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto
 Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE
 FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
FILOSOFIA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE - UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO LINEE GENERALI E COMPETENZE Al termine del percorso liceale lo
Centro Informazioni turisti
 11/01/2016 09:39:16 Generale Nome sondaggio Centro Informazioni turisti Autore Richard Žižka Lingua Italiano URL Sondaggio http://www.survio.com/survey/d/v5o1a2q6h2p6a4c6a Prima risposta 28/02/2014 Ultima
11/01/2016 09:39:16 Generale Nome sondaggio Centro Informazioni turisti Autore Richard Žižka Lingua Italiano URL Sondaggio http://www.survio.com/survey/d/v5o1a2q6h2p6a4c6a Prima risposta 28/02/2014 Ultima
Tommaso d Aquino > NOTE INTRODUTTIVE <
 1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
1221 1274 > NOTE INTRODUTTIVE < Tommaso fu il più importante autore appartenente alla Scolastica. L epoca in cui egli visse fu caratterizzata da un intenso studio degliantichifilosofie, in particolare,
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO
 NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
NELLO SCRIPTUM DI PIETRO AUREOLO mente lo Scriptum super primum Sententiarum è soltanto uno dei tanti commenti al Libro delle Sentenze interesse storico Proœmium un in È Prooemium allo Scriptum Storia
NICOLA ABBAGNANO TULLIO GREGORY
 COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
COLLEZIONE FONDATA DA NICOLA ABBAGNANO DIRETTA DA TULLIO GREGORY LIBRO DELLA GUARIGIONE LE COSE DIVINE di Avicenna (Ibn Sīnā) a cura di AMOS BERTOLACCI UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 2007 Unione
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica
 4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica I movimenti La fisica è quella scienza che studia l essere come movimento. Quindi le sostanze in movimento, che si possono percepire attraverso i
4^ liceo Scientifico-Tecnologico (2010/2011) La fisica I movimenti La fisica è quella scienza che studia l essere come movimento. Quindi le sostanze in movimento, che si possono percepire attraverso i
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F
 A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
A cura di Alessandra Durando, Martina Ferrari, Serena Marsella, Ylenia Venturi. Liceo Classico G. Chiabrera 3^ F DUALISMO Ma che cos è il dualismo? Il termine dualismo definisce, in generale, ogni dottrina
Un corpo molti mo(n)di CORPO & OLTRE
 Valdagno 23 gennaio 2009 Un corpo molti mo(n)di CORPO & OLTRE PAOLO VIDALI La filosofia e la sua scena La filosofia pone problemi generali per affrontarli razionalmente. E simile alla religione e alla
Valdagno 23 gennaio 2009 Un corpo molti mo(n)di CORPO & OLTRE PAOLO VIDALI La filosofia e la sua scena La filosofia pone problemi generali per affrontarli razionalmente. E simile alla religione e alla
Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo
 ARISTOTELE Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo Organon (analitica) - Categorie Termini Soggetto predicati Le Categorie sostanza quantità qualità relazione luogo tempo giacere
ARISTOTELE Platone-Aristotele, visione d insieme e confronto introduttivo Organon (analitica) - Categorie Termini Soggetto predicati Le Categorie sostanza quantità qualità relazione luogo tempo giacere
68 h 40 min km. Da Kant a Hegel
 Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Da Kant a Hegel 68 h 40 min. 5.956 km Da Kant a Hegel La critica a Kant La critica a Kant riguarda il rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tra pensiero ed essere. Nella Critica della ragion
Pasquale Porro. Tommaso d Aquino. Un profilo storico-filosofico. Carocci editore
 Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
Pasquale Porro Tommaso d Aquino Un profilo storico-filosofico Carocci editore Frecce Indice Premessa 13 1. Gli anni della formazione e del baccellierato 19 Da Roccasecca a Parigi e Colonia: gli anni della
L INTELLETTO UMANO TENTATIVO DI UN APPROCCIO FILOSOFICO.
 Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie L INTELLETTO UMANO -1- TENTATIVO DI UN APPROCCIO FILOSOFICO. Parlare dell intelletto spetta certo a molte scienze che osservano, sperimentano,
Testo originale: Dattiloscritto di P.Tomas Tyn, OP Cartella Varie L INTELLETTO UMANO -1- TENTATIVO DI UN APPROCCIO FILOSOFICO. Parlare dell intelletto spetta certo a molte scienze che osservano, sperimentano,
La filosofia e i suoi concetti. Definizione, statuto e concetti
 La filosofia e i suoi concetti Definizione, statuto e concetti 1 Definizione del termine e prima accezione Filosofia deriva dal greco φιλοςοφία (philosophia), che vuol dire amore per la sapienza. Alle
La filosofia e i suoi concetti Definizione, statuto e concetti 1 Definizione del termine e prima accezione Filosofia deriva dal greco φιλοςοφία (philosophia), che vuol dire amore per la sapienza. Alle
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza. Il soggetto della speranza
 San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza Il soggetto della speranza Prooemium Proemio [39502] IIª-IIae q. 18 pr. Deinde considerandum est de subiecto spei. Et circa hoc
San Tommaso d Aquino Summa Theologiae II-II, 18 Il soggetto della speranza Il soggetto della speranza Prooemium Proemio [39502] IIª-IIae q. 18 pr. Deinde considerandum est de subiecto spei. Et circa hoc
Corso di istituzioni di diritto romano A.A parte II. Prof. Aurelio Arnese
 Corso di istituzioni di diritto romano A.A. 2016-2017 parte II Prof. Aurelio Arnese Status personarum: civitatis, libertatis,familiae la piena soggettività spetta a chi è libero, cittadino romano e sui
Corso di istituzioni di diritto romano A.A. 2016-2017 parte II Prof. Aurelio Arnese Status personarum: civitatis, libertatis,familiae la piena soggettività spetta a chi è libero, cittadino romano e sui
I PROBLEMI DELL INTERPRETAZIONE
 I PROBLEMI DELL INTERPRETAZIONE Il problema dell Interpretazione Riguarda sia i giuristi sia i giudici sia gli avvocati Ha caratteri particolari in quanto Riguarda un testo antico (il diritto romano),
I PROBLEMI DELL INTERPRETAZIONE Il problema dell Interpretazione Riguarda sia i giuristi sia i giudici sia gli avvocati Ha caratteri particolari in quanto Riguarda un testo antico (il diritto romano),
IL REALISMO GIURIDICO COME METODO ERMENEUTICO NECESSARIO ALL EQUITÀ FISCALE: L ANALISI DELLE CONCAUSE DEL TRIBUTO COME METODO GIURIDICO.
 IL REALISMO GIURIDICO COME METODO ERMENEUTICO NECESSARIO ALL EQUITÀ FISCALE: L ANALISI DELLE CONCAUSE DEL TRIBUTO COME METODO GIURIDICO. di Vincenzo Bassi* 1. Premessa La questione di cui si vuole discutere
IL REALISMO GIURIDICO COME METODO ERMENEUTICO NECESSARIO ALL EQUITÀ FISCALE: L ANALISI DELLE CONCAUSE DEL TRIBUTO COME METODO GIURIDICO. di Vincenzo Bassi* 1. Premessa La questione di cui si vuole discutere
POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D. Disciplina: FILOSOFIA
 POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D Disciplina: FILOSOFIA Che cos è la filosofia L amore per il sapere Il cammino della filosofia: l influsso dell
POLO FERMI -GIORGI - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE PROGRAMMA SVOLTO CLASSE TERZA sezione D Disciplina: FILOSOFIA Che cos è la filosofia L amore per il sapere Il cammino della filosofia: l influsso dell
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza
 L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
L univocità dell essere in Duns Scoto e Spinoza Premessa La filosofia e la matematica sono le uniche attività intellettuali dell uomo che per certi aspetti, nonostante il passare dei secoli, mantengono
L intelletto divino L INTELLETTUALITA SUSSISTENTE DI DIO.
 L intelletto divino Questo prezioso trattatello sull intelletto divino è estratto da un Corso di Padre Tomas Tyn sul Libro XII della Metafisica di Aristotele. Il commento fatto da P.Tomas al testo dello
L intelletto divino Questo prezioso trattatello sull intelletto divino è estratto da un Corso di Padre Tomas Tyn sul Libro XII della Metafisica di Aristotele. Il commento fatto da P.Tomas al testo dello
I PRONOMI E AGGETTIVI
 I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
I PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI Quis, quid Qui, quae, quod I pronomi e gli aggettivi indefiniti più frequenti Aliquis, aliquid Aliqui, aliqua, aliquod Quisquam, quidquam Ullus, a, um Quidam, quaedam,
FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA
 STUDI E RICERCHE Andrea Colli Chiara Selogna FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA UNO STUDIO SUL DE IMAGINE DI GIOVANNI DUNS SCOTO Il De imagine di GIOVANNI Duns Scoto Una nota introduttiva Il De imagine
STUDI E RICERCHE Andrea Colli Chiara Selogna FANTASIA IMMAGINAZIONE CONOSCENZA UNO STUDIO SUL DE IMAGINE DI GIOVANNI DUNS SCOTO Il De imagine di GIOVANNI Duns Scoto Una nota introduttiva Il De imagine
