Disponiamo ormai di alcune conoscenze
|
|
|
- Agostina Pagano
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2 La manutenzione urbana e la difesa locale dalle acque alte, il riequilibrio idraulico e fisico della laguna, le prospettive di STEFANO BOATO Disponiamo ormai di alcune conoscenze certe e non controverse per una valutazione del fenomeno delle acque alte nel passato e nel breve e medio periodo futuro, ma il dibattito è ancora troppo pesantemente condizionato dagli interessi in campo, dalla poca circolazione delle informazioni e dalle prevenzioni politico-ideologiche. Queste brevi note vogliono offrire un contributo al confronto a partire dai dati disponibili. Le acque alte Nell ultimo secolo (dal 1896) il livello complessivo del mare (subsidenza ed eustatismo) si è elevato di circa 23 cm, rimanendo però pressoché stabile negli ultimi trent anni: le spiegazioni di questa stasi sono controverse, ma è prevedibile una ripresa dell innalzamento nei prossimi decenni. Anche perché nei due ultimi millenni tra subsidenza ed eustatismo il livello si è alzato di oltre due metri (sia pur con notevoli diversificazioni da zona a zona del territorio e tra i diversi periodi climatici). Comunque nell ultimo secolo a Venezia il suolo si è mediamente abbassato di circa 9 cm per subsidenza indotta dall estrazione di acque dal sottosuolo (-11 cm con + 2 cm di recupero elastico per la ripressurizzazione delle falde sotterranee, dati non certissimi) e di circa -3 cm per subsidenza naturale (tettonica regionale), mentre il livello del mare si è mediamente alzato di circa +11 cm (eustatismo). Oltre a questi dati, sui quali più o meno convergono tutte le ricerche disponibili, gli studi del prof. Pirazzoli (CNRS francese) negli ultimi decenni sono venuti via via documentando che tra il 1881 e il 1989 le massime altezze di marea sono aumentate di circa 35 cm, ossia circa 12 cm in più rispetto all aumento del livello medio marino (e che per il 1975 la media mobile su 19 anni indica un livello che supera di ben 39 cm quello raggiunto mediamente attorno al 1885 o al 1893 ). Queste differenze nell aumento delle punte di massima altezza di marea (le acque alte) possono essere interpretate come dovute alla maggiore facilità con la quale i più alti livelli dell Adriatico (dovuti generalmente a perturbazioni meteorologiche) hanno potuto recentemente penetrare e propagarsi in laguna in seguito ad approfondimenti operati alle bocche di porto e nei principali canali di navigazione lagunare... si può stimare che le modifiche morfologiche subite dalla laguna hanno causato a Venezia un innalzamento dei livelli dell acqua alta estrema che è stato dello stesso ordine di grandezza di quello provocato dalla subsidenza o dall eustatismo e dalla tettonica regionale (relazione per il Gruppo di Lavoro di supporto all Ufficio di Piano, giugno 1999). Una conferma delle conseguenze sull innalzamento delle punte di marea (maggiori acque alte) a seguito dei grandi sconvolgimenti operati soprattutto a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta (abbassamento dei suoli per estrazione di acque dal sottosuolo e aumento dell idrodinamica lagunare per gli scavi alle bocche di porto e dei canali portuali e per le modifiche della morfologia e delle superfici lagunari) si può facilmente desumere dalla lettura del grafico sulla distribuzione decennale delle alte maree +120 cm sul medio marino, registrate a Punta della Salute dal 1923 al 1999 (Centro Maree Comune di Venezia, 2000). Gli eventi negli anni trenta, quaranta e cinquanta erano mediamente da 2 a 4 al decennio, dagli anni sessanta ad oggi sono balzati mediamente da 12 a 14 al decennio (Fig. 1). Analogo fenomeno di accentuazione si rileva nel passaggio tra gli anni cinquanta e sessanta sul grafico della distribuzione decennale delle maree +110 cm sul medio marino; questo grafico (Fig. 2) evidenzia anche un accentuazione di queste punte di marea nell ultimo decennio, accentuazione dovuta a nuove situazioni meteorologiche più favorevoli al rialzo del livello marino dell Alto Adriatico. Nell ultimo decennio i fenomeni di alta marea si sono verificati con una frequenza media pari a 4,4 casi all anno per le quote ai +110 cm, e 1,4 casi all anno per le quote +120 cm sul medio marino (tempo complessivo di permanenza 2 ore e 25 min., altezza 11 cm). Le quote della città storica La città di Venezia è stata oggetto di una prima rilevazione sistematica delle quote altimetriche da parte di CNR-UNESCO nel 1974 con l esclusione delle aree di Sant Elena, della Marittima e delle isole della Giudecca e di San Giorgio. La pubblicazione della ricerca (R. Frassetto, 1976) documentava che nelle aree oggetto di rilievo circa un terzo delle superfici (comprensivo delle aree scoperte e delle aree edificate) si trovava a quote 23
3 Fig. 1 - Distribuzione decennale delle alte maree +120 cm registrate dal mareografo di Punta della Salute dal 1923 al 1999 Fig. 2 - Distribuzione decennale delle alte maree +110 cm registrate dal mareografo di Punta della Salute dal 1923 al 1999 uguali o inferiori ai 120 cm sul medio marino. Una successiva rilevazione da parte del Magistrato alle Acque (attuata nel 1987 e collaudata nel 1990) confermava sostanzialmente le risultanze del primo rilievo. A tale proposito la relazione finale dello Studio per la verifica della possibilità di elevazione della quota delle difese locali mediante il rialzo della pavimentazione elaborato a cura della società Insula nel novembre 1999 recita: L area potenzialmente interessata è costituita da tutte le unità immobiliari a piano terra del centro storico di Venezia accessibili direttamente o indirettamente da soglie poste a quota +120 cm. sullo zero di Punta della Salute e affacciate su suolo pubblico la cui pavimentazione sia posta a sua volta a quota +120 cm. Tale porzione delle superfici pubbliche del centro storico è quantificabile in circa 34 ettari, pari al 31% della superficie pubblica totale, e si sviluppa su 112 isole delle 124 totali. Le indicazioni legislative per le acque alte Le leggi speciali a partire dal 1973, preso atto che le azioni antropiche avevano rotto gli equilibri precedenti, bloccarono ogni azione che potesse ulteriormente abbassare il livello dei suoli o innalzare i livelli delle massime maree e prescrissero in modo sempre più preciso gli interventi per il riequilibrio idraulico e fisico, fissando anche priorità e fasi di azione sia per gli interventi in laguna che sulle aree urbane. a) Relativamente al riequilibrio idrogeologico la legge del 1973 e gli indirizzi governativi del 1975 prevedono di operare per la riduzione dei livelli marini in laguna prescrivendo interventi per fasi e con gradualità per la riduzione a livello normale dei fondali ora profondamente erosi dalle correnti...nel Canale di San Nicolò, nonché allo sbocco in laguna di Malamocco e Chioggia e l apertura alla libera espansione delle maree delle valli da pesca. Oltre alla attenuazione dei livelli delle maree in laguna la legge del 1984 prevede la difesa dalle acque alte eccezionali anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili con caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità. Come si vede sin dall inizio non furono contrapposte le opere preliminari e prioritarie per il riequilibrio lagunare alla possibilità di intervenire in una seconda fase se necessario anche con sistemi sperimentali di regolazione delle maree. Solo che, 24
4 Fondamenta di Cannaregio, dicembre 2000 nonostante la successiva legge del 1992 abbia ulteriormente ribadito la successione delle fasi e le priorità di azione, gli interventi di riequilibrio (pur risollecitati dal Consiglio Comunale nel 1995, dal Comitatone nel 1997 e dai Ministeri dell Ambiente e dei Beni Culturali nel 1999) non sono mai iniziati. b) Dopo la legge del 1984 che prevedeva la difesa con interventi localizzati delle insulae dei centri storici, la legge del 1992 confermava e ribadiva la priorità della difesa dalle acque alte degli abitati insulari. L assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva inoltre precisato che le difese locali dalle acque alte sono il primo strumento di difesa realizzabile con una spesa più contenuta rispetto alle opere alle bocche, e certamente quello riconducibile agli interventi sulle insulae finalizzati non solo alla salvaguardia delle acque alte, ma al risanamento di tutta la rete dei servizi, interventi che oltre a richiedere una progettazione accurata richiedono un forte coordinamento tra i vari soggetti preposti alla loro elaborazione. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva in particolare prescritto la priorità della difesa a insula dalle acque alte di piazza San Marco, ma gli unici interventi avviati in forma sperimentale sino agli anni novanta erano stati quelli relativi all isola di Pellestrina e al centro storico di Malamocco. L avvio della manutenzione urbana e delle difese locali Sin dal 1985 si era realizzata una certa convergenza di intenti tra forze politiche diverse (ambientaliste e non) affinché si riavviasse finalmente la manutenzione urbana sospesa ormai da vari decenni, con lo scavo a secco dei rii, il rifacimento delle fondamenta e delle strutture pubbliche e private. Ma, in una fase ancora troppo attenta solamente alle grandi nuove opere, ci volle ancora un quinquennio per l avvio concreto dell iniziativa. L amministrazione comunale già nel aveva predisposto un primo Piano programma di interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia; come prima applicazione nel conclude con il Magistrato alle Acque un accordo di programma per l attuazione del progetto integrato rii. A proposito della difesa dalle acque alte degli abitati insulari, il Consiglio Comunale nel 1995 all unanimità afferma che con i fondi delle leggi speciali vanno assicurati con continuità adeguati finanziamenti al Piano programma per garantire l avvio e la continuità sistematica della manutenzione urbana per la città storica e le isole minori. Solo per questa via, questo secondo aspetto della difesa prioritaria dalle acque alte prende concreto e sistematico avvio, anche perché l amministrazione comunale costituisce un proprio braccio operativo (la società Insula) nel quale coinvolge tutte le società interessate alla realizzazione e alla manutenzione della rete dei sottoservizi (metano, acquedotto, fognature, elettricità, telefoni). 25
5 area esondata con marea a +120 cm rialzi eseguiti rialzi progettati (da Insula)
6 Le diverse tipologie di intervento: rialzi e insulae Già nel 1985 il Consiglio Comunale all unanimità aveva affermato: si ritiene che possano e debbano procedere tutti gli interventi di rifacimento dei marginamenti, delle pavimentazioni e dei collettori fognari con il rialzo in particolare degli spazi e dei percorsi pubblici (connesso agli interventi interni agli edifici) a quote attentamente valutate e progettate zona per zona; quote compatibili con il non stravolgimento dello specifico tessuto storico urbanistico, paesaggistico ed edilizio, e inoltre si ritiene invece che vada sottoposta ad attenta verifica la compatibilità e la opportunità ambientale paesaggistica e funzionale di qualsiasi progetto che punti a rendere artificiale la gestione con sistemi complessi del deflusso delle acque interne alle insulae e della difesa dalle maree medio-alte e ciò non solo rispetto ad una analisi costi-benefici, ma anche e sopratutto rispetto alla garanzia di ottenere i risultati ipotizzati (in riferimento all esperienza di Pellestrina in corso e alle prime ipotesi di intervento sull insula di San Marco). Si cominciavano così a delineare gli indirizzi per le diverse possibili tipologie di intervento non ancora chiaramente definite: da un lato la possibilità di operare contestualmente alla manutenzione con la tecnica dei rialzi senza definire una quota unica a priori, ma studiando attentamente caso per caso lo specifico contesto pubblico e privato per verificare le quote di rialzo compatibili; dall altro iniziava la discussione sulle modalità di intervento di difesa ai margini di una o più insulae (difesa a insula o a macro-insula ). La discussione e le verifiche sui rialzi La tecnica del rialzo delle aree scoperte pubbliche e private evidentemente è stata sempre attuata nei secoli: un qualsiasi lavoro in città porta a scoprire le diverse quote dei secoli precedenti. Ma ormai la città storica è definita e consolidata in quasi tutte le sue parti e non è pensabile di attuare la tecnica, grandemente in uso nei secoli scorsi, della demolizione e ricostruzione ex novo. È ormai consapevolezza generale che le tecniche del restauro e del risanamento per nuovi usi compatibili devono partire dal rispetto delle tipologie strutturali dell intero tessuto urbano storico e non solo degli edifici monumentali. Né è pensabile di agire con rialzi che forzino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche come pur si è fatto nell ultimo secolo con grande disinvoltura. Anche la difesa interna degli edifici esistenti con le diverse tecniche in uso ormai da decenni (rialzo delle soglie, degli architravi e talvolta dei soffitti, delle pavimentazioni, sistema a vasca, sistemi combinati) ha dei limiti di compatibilità oltre i quali non è possibile andare. Ma detto tutto ciò non è possibile prendere alcuna decisione unica e generalizzata ed è assurdo cercare di imporre una quota massima unica (il metro) oltre la quale non si deve andare. Ed è ridicolo pensare di operare in due tempi: con rialzi più contenuti in una prima fase per accentuarli eventualmente in seguito (proposta del gruppo di esperti internazionali). È proprio operando contestualmente con la manutenzione urbana e territoriale che gli interventi di rialzo vengono semplificati e riducono notevolmente l onerosità (come dimostrano i consuntivi degli interventi già svolti). Per fortuna queste discussioni astratte, disinformate, prevenute e accademiche sono state messe fuori campo dalle esperienze concrete già realizzate o già progettate e approvate dalla Sopraintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali e dalla Commissione di Salvaguardia dopo una attenta verifica caso per caso, situazione per situazione, zona per zona. Successivamente, su richiesta del Comitatone, una prima verifica della possibilità di elevare le difese locali tendendo a 120 cm operata nel 1999 dal Comune di Venezia insieme al Magistrato alle Acque e alla Sopraintendenza è arrivata ad alcuni punti significativi: - La fattibilità degli interventi di rialzo interni alle abitazioni ed esterni non presenta difficoltà tecniche e non è particolarmente gravosa dal punto di vista finanziario. - Di ben maggiore difficoltà è la valutazione del limite imposto da esigenze di carattere architettonico e ambientale. Dall ampio campione indagato (52% del totale delle soglie) il Coses ha rilevato che meno del 10% di tali soglie risulta non rialzabile e solo il 5% è non rialzabile per motivi esclusivamente o parzialmente architettonici. Il costo complessivo per gli interventi previsti sia su area pubblica che su area privata, stimati da Insula, è di poco meno di 640 miliardi ai quali vanno aggiunti i costi per gli interventi che riguardano i monumenti e gli elementi di pregio dell arredo urbano, che si ritiene comunque non possano andare oltre l ordine di grandezza degli interventi studiati. Le prime osservazioni e conclusioni della Sopraintendenza recitano: Gli interventi realizzati si sono basati su analisi punto per punto e si sono concretizzati in progetto esecutivo dopo approfondite valutazioni. Il risultato di questo lavoro è che si sono già rialzatidifesi oltre tre ettari di superficie calpestabile partendo da quote che stavano tra m + 0,90 e + 1,00 raggiungendo quote tra m + 1,10 e + 1,20. Dunque il progetto di difesa tendenziale a quota m + 1,20 è una strada che va percorsa, nonostante non esista, allo stato attuale delle ricerche, sicurezza in tale direzione, soprattutto per l'insufficienza dei dati. Un giudizio di merito complessivo sarà possibile solamente dopo: 1) che sarà indagato nella sua interezza il quadro delle potenzialità fisiche del contesto edificato sulla base del rilevamento in fase di 27
7 INTERVENTI DI INSULA COMPRENDENTI RIALZI PAVIMENTAZIONE: SUPERFICI E QUOTE (cm sullo zero di Punta Salute) SOGLIE (n ) MAREE (n /anno) superficie stato di fatto stato di progetto coinvolte da rialzare prima dopo soggetta a rialzo min max media min max media Insulae Ghetto S.Giovanni in Bragora S. Stefano S. Trovaso S. Giacomo dell Orio Fond.te e Rive Fond.ta della Croce Fond.ta Ponte Longo Fond.ta S. Girolamo Fond.ta S. Severo Riva di Biasio Fond.ta del Monastero Fond.ta dei Tolentini Fond.tina della Tana Fond.ta Venier Parmense Altri Rio terà S. Leonardo Rialto Pescheria Calle del Forno Totale Nota: i valori minimi e massimi sono rappresentativi delle situazioni più frequenti e non estreme; i dati delle ultime due colonne quantificano indicativamente i benefici diretti delle operazioni di rialzo in termini di esondazioni evitate. Essi vanno tuttavia considerati con molta prudenza in quanto sono calcolati su valori medi non ponderati rispetto ad una realtà molto eterogenea. Il numero degli eventi di marea è calcolato sulla media del periodo completamento, compresa l area del Comune di Chioggia; 2) aver analizzato, tramite progetti esecutivi redatti secondo le modalità già sperimentate, caso per caso, la situazione emersa dalle rilevazioni; 3) aver verificato la possibilità di adottare soluzioni tecniche che prevedano oltre al semplice rialzo per sopraelevazione dell intero piano di calpestio, anche la protezione perimetrale verticale per raggiungere comunque, tendenzialmente, la quota 120, con i connessi temi di organizzazione complessiva dei sottoservizi. I tempi per l esecuzione dei progetti esecutivi non potranno essere inferiori ai tre-quattro anni. Gli interventi sono successivamente proseguiti per tutto l anno Lo stato di avanzamento dell attività della Società Insula, attività di manutenzione urbana e connessa azione di sovralzo (progetti realizzati e progetti già approvati in corso di realizzazione), risulta dalla mappa di pag. 26 e dalla tabella precedente ove si può constatare che gli innalzamenti portano concretamente a quote medie sempre superiori ai +110 cm sul medio marino sino a quote di +125 cm. Il problema metodologico fondamentale della progettazione L esperienza sin qui svolta permette di fare una considerazione molto importante. La progettazione della manutenzione straordinaria delle strutture urbane e delle aree pubbliche deve partire dalle aree edificate, in gran parte private. Si devono rilevare le misure e le quote principali di tutti gli edifici, uno per uno, soglie e portali innanzitutto. Se si deve progettare in una qualsiasi altra città storica (Assisi, Siena, Gubbio, Firenze) si deve fare lo stessa cosa. Questa metodologia comporta una rivoluzione in termini di tempo, di risorse, di gestione; e la necessità di comunicare con tutti i cittadini e talvolta di coinvolgere i singoli nella determinazione dell intervento. È un grandissimo minuzioso lavoro ma non è evitabile in una città storica: non si può progettare una fondamenta urbana come se fosse una banchina portuale. Che si sia a Pellestrina, Burano, Venezia o Chioggia, bisogna partire dagli edifici, verificando gli interventi possibili, tecnicamente ed economicamente fattibili e ambientalmente, architettonicamente e paesaggisticamente compatibili. Dal tempo dei nostri padri, qualunque residenza, negozio o agenzia nel restaurare il piano terra cerca di alzare il più possibile la pavimentazione o di combinare l intervento con la tecnica a vasca. Il problema si complica perché anziché fare un intervento alla volta, quando si opera su un intera fondamenta bisogna affrontare tutti i singoli casi contemporaneamente. Sappiamo però, e le relazioni 28
8 DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI RIALZATE PER FASCIE DI QUOTA QUOTE (cm) SUPERFICIE (mq) % , ,0 116-> , ,0 di Edilvenezia lo confermano, che la gran parte dei privati (99 %) se informati e coinvolti per tempo sono disposti a collaborare all intervento. Non è semplice, anzi è molto complicato, ma purtroppo è la situazione che è complessa e la complessità non è eliminabile. È nella città storica, nella diversità delle situazioni, delle case, delle quote; è nel fatto che un edificio ha mille anni, un altro 500, un altro 100 e un altro ancora è recentissimo. Questo è il problema principale quando si interviene con i restauri in un centro storico. Il progetto sulle strutture pubbliche si deve definire in base a quanto si può fare sul privato. Il punto di partenza e la metodologia sono rovesciati. Il modo di fare i rilievi, elaborare i dati, fare i preventivi, di avvisare ed eventualmente contattare i singoli privati in tempo utile, costituiscono una metodologia di progettazione e azione che comporta l adeguarsi alla città e non viceversa obbligare la città ad adeguarsi ad un progetto rigido precostituito. È su questo che è avvenuta la polemica sull intervento alla fondamenta dei Tolentini. Nel 1995 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto del Consorzio Venezia Nuova che pur non era accettabile (per l imposizione rigida della quota di rialzo limitata al metro sul medio marino) perché la sua immediata revisione avrebbe comportato un notevole ritardo nei tempi di avvio dei lavori. Si era però concordato e formalizzato nell atto di approvazione del progetto originario l impegno ad una revisione delle quote del rialzo e ad una verifica di dettaglio di quanto era possibile rialzare ulteriormente in corso d opera. Ma al momento dell attuazione le misure e le quote sono rimaste le stesse del progetto originario. Poi si è verificato (con un impegno del Comune che ha coinvolto anche Insula) che specialmente nella parte terminale della fondamenta e nella prospiciente fondamenta Condulmer era possibile portare le quote del rialzo sino a +1,15-1,20 m sul medio marino. Ma bisognava volerlo e impegnarsi seriamente per ottenerlo. Le difese locali dalle acque alte a insula o a macroinsula: il caso di piazza San Marco In alcuni casi non è possibile o opportuno per motivi tecnici o paesaggistici cercare di operare un rialzo delle pavimentazioni e può essere indispensabile progettare una difesa locale dalle acque alte operando una difesa verticale ai margini perimetrali di un insula o di più insule aggregate (sistema a macro-insula proposto da un gruppo di ingegneri veneziani). Questa situazione è innanzitutto quella tipica delle situazioni più antiche e più basse come piazza San Marco o l isola di Burano nella quale ci si appresta ad un intervento misto: sopralzo in alcune situazioni sino a quote compatibili con il contesto e difesa verticale perimetrale ai margini sino a quote maggiori. Fondamenta Condulmer, dicembre
9 Fondamenta della Misericordia, rialzata nel 1998 Già a Pellestrina e nel centro storico di Malamocco sono state realizzate difese ai margini anche con tecniche troppo impattanti rispetto al contesto (con quote di difesa dalle acque alte sino a oltre +150 cm sul medio marino). Data l importanza e la complessità del caso è probabilmente utile fare qualche considerazione su piazza San Marco. Circa cinque anni fa fu elaborata una prima bozza del progetto di piazza San Marco. Questo progetto prevedeva di stendere sotto tutta la Piazza una grande membrana orizzontale. Contestualmente si proponeva di abbandonare completamente tutti i condotti fognari e acquei sotterranei e costruire un sistema completamente nuovo di sottoservizi. Tre anni e mezzo fa in una serie di riunioni presso il Comune di Venezia e poi in una serie di confronti e verifiche più approfondite presso la Sopraintendenza erano state date delle valutazioni critiche e delle indicazioni diverse. Si era segnalato che quella proposta non era accettabile: non era possibile né opportuno mettere la membrana orizzontale e chiuderla in particolare dalla parte delle Procuratie Vecchie e della basilica di San Marco. Bisogna impermeabilizzare e alzare per quanto possibile i bordi al margine perimetrale dell insula, verso il bacino di San Marco e verso il bacino Orseolo in particolare. Non si devono abbandonare ma individuare, riconoscere (anche storicamente), ricostruire, risistemare e manutenere i vecchi collettori fognari e delle acque ridando loro significato e funzione, facendoli poi confluire collettati verso uscite con valvole di sicurezza senza ritorno controllate a sistema. Si tratta di impermeabilizzare con metodi, materiali e tecnologie appropriate la parete verticale dei marginamenti perimetrali. Si tratta di installare un sistema di pompaggio che raccolga ed espella l acqua della pioggia in esubero (qualcosa del genere si è già fatto a Pellestrina). È stato proposto anche di limitarsi a dare un indennizzo alle poche attività che sono soggette al fenomeno dell acqua alta. Si può comunque fare, ma personalmente ritengo invece che si possano eliminare le acque alte anche in piazza San Marco. Va verificato qual è il massimo livello di difesa locale dalle acque alte che si può realizzare, fattibile e compatibile con il contesto. In particolare si deve valutare quale sia il recupero altimetrico che si può ottenere dalla parte del Bacino Orseolo con una leggera pendenza nella pavimentazione e/o con un gradino ai margini del sottoportico o al bordo della fondamenta. Dalla parte del Bacino di San Marco ad un terzo di distanza (10 metri) tra Palazzo Ducale e il bordo sul bacino (in corrispondenza del fianco meridionale del ponte della Paglia), la pavimentazione con una leggera pendenza sinora non avvertita è già oggi a +115 cm sul medio marino. Credo che con altri due terzi di percorso la quota di difesa al bordo perimetrale (a 30 m dal Palazzo Ducale) potrebbe tranquillamente essere portata a +120 cm sul medio mareale. Comunque già con la sola difesa perimetrale verticale si può passare dalle attuali 48 acque alte all anno (nel punto più basso della piazza prospiciente la basilica) alle 4,4 all anno già raggiungendo quota +1,10 m sul medio marino o alle 1,4 volte all anno raggiungendo quota +1,20 m. In ogni caso c è da sperare che il progetto che si sta per proporre all approvazione abbia tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni, che non si riproponga la grande membrana orizzontale né il rifacimento integrale del sistema dei condotti e cunicoli sotterranei per le acque, che si vogliano progettare e sperimentare l impermeabilizzazione 30
10 verticale dei bordi perimetrali dell insula, il funzionamento e la gestione di un sistema controllato dello smaltimento delle acque e la non risalita delle maree in occasione delle acque alte. Il riequilibrio idraulico e fisico della laguna Nei paragrafi precedenti si è verificato come sia possibile portare avanti il sistematico lavoro della manutenzione urbana e territoriale operando nel contempo le azioni possibili per la difesa locale dalle acque alte. Con interventi di sopraelevazione e/o con la difesa verticale perimetrale a insula o a macro-insula (più insule aggregate) è possibile difendere la città almeno sino a quote di cm sul medio mare (in molti casi a quote ben superiori). Con il che si possono già ridurre le acque alte a uno o due eventi all anno di impatto molto contenuto (per durata e altezza). Questi sono interventi che vanno comunque fatti, sarebbe da irresponsabili fermarli o ridurli essendo comunque utili (come lo sono sempre stati nei secoli precedenti) e relativamente poco costosi. Ma non possono e non devono essere letti come interventi alternativi: serviranno anche a ridurre il numero di chiusure se in futuro si fosse costretti (da una grande ripresa dell innalzamento del livello del mare) a realizzare opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto. Ma dovrebbe finalmente avviarsi anche l azione per il riequilibrio dell idrodinamica lagunare. Nel 1999, su richiesta del Comitatone, sono state nuovamente verificati gli effetti dei possibili interventi: modifica delle configurazioni alle bocche di porto (rialzo dei fondali e pennelli trasversali per ridurre la portata, curvamento dei tratti terminali dei moli e scogliere a mare per ridurre il set up, l onda montante, da vento di scirocco), riduzione degli impatti dei canali portuali, riapertura al flusso delle maree delle valli da pesca. La stessa Autorità Portuale e il Ministero dei Trasporti hanno dato la disponibilità a rialzare i fondali delle bocche di porto. Gli studi di verifica hanno portato ad una ennesima conferma della possibilità e dell efficacia degli interventi ipotizzati. In particolare la relazione finale presentata dal Ministero dell Ambiente nel gennaio del 2000 recita a tale proposito: Effetti sulla riduzione dei livelli di marea Le riduzioni di livello ottenute dalle simulazioni (condotte dal Magistrato alle Acque) delle diverse soluzioni esaminate, evidenziano che le modifiche morfologiche alle bocche hanno un effetto 31
11 Fig. 3 Eustatismo e subsidenza: stime per il XXI secolo Fonte: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 1999 significativo nel contenimento dei fenomeni di allagamento delle aree cittadine prodotti dagli eventi di marea. Analoghe indagini sono state condotte, ma sulle maree reali, per conto del Ministero dell Ambiente...Complessivamente le elaborazioni svolte segnalano la possibilità di ottenere (senza Mose e senza irrigidimento e rivestimento del fondale, con una configurazione dei varchi intermedia tra l ipotesi larga e l ipotesi stretta) una riduzione delle punte di marea mediamente di 20,2 cm. Si evidenzia infine che per il caso di Burano l efficacia media dell apertura delle valli da pesca nelle simulazioni operate per il Ministero dell Ambiente ha un efficacia media di 9,1 cm (e di quasi 10 cm con l effetto sinergico degli interventi alle bocche). Efficacia sulla riduzione degli allagamenti Nell ipotesi di un intervento alle bocche con una configurazione intermedia le simulazioni svolte per il Ministero dell Ambiente segnalano che si possono ottenere riduzioni delle punte di marea (dell ordine di oltre 20 cm) che combinate con il massimo rialzo possibile (difese locali orizzontali) e le difese verticali e a macro-insula possono ridurre il numero degli allagamenti a Punta della Salute (con esclusione dell evento alluvionale con tempo di ritorno plurisecolare) mediamente ad 1 evento ogni 5-6 anni per una durata media di 2 h 40 e una altezza massima di 9,1 cm (dati del Centro Maree del Comune di Venezia). Le prospettive Le documentazioni sin qui avanzate consentono di verificare che le acque alte sono eliminabili per questa fase storica con l azione congiunta delle difese locali e l azione di riequilibrio dell idrodinamica lagunare. Ma quali sono le prospettive a più lungo termine? L unica relativa certezza riguarda la subsidenza: se non si autorizzeranno estrazioni di fluidi dal sottosuolo (vedi richieste Agip) e se si metteranno sotto controllo le estrazioni delle acque nella pianura retrostante (che alla lunga potrebbero avere ripercussioni anche sull area veneziana) nel prossimo secolo l abbassamento del suolo per subsidenza naturale degli insediamenti lagunari non supererà i 3 o 4 cm. Grande incertezza vi è invece sulle previsioni di aumento dei livelli del mare. Le previsioni del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) rese note nel 1999, sono quanto mai aleatorie: si va da una previsione minima di un aumento sull ordine di grandezza del secolo trascorso, da cm, ad un ipotesi massima di cm (Fig. 3). L aumento del livello del mare dovrebbe comunque avere un avvio relativamente lento ed una accentuazione nella seconda metà del secolo. E non è tutto: queste sono ipotetiche medie mondiali, ma i dati sin qui disponibili e pubblicati dal CNRS francese documentano che sono ancor meno prevedibili le evoluzioni delle singole situazioni 32
12 regionali che nelle misurazioni dirette dei fenomeni si discostano, e di molto, dalle medie mondiali. In sintesi, tutti gli esperti del settore concordano che per avere dati attendibili occorrerà attendere la misurazione concreta dei fenomeni nelle diverse aree regionali per un ciclo almeno trentennale; nel frattempo si dovrebbe poter anche valutare l attendibilità delle capacità della gestione mondiale di ridurre effettivamente l effetto serra (energie rinnovabili, riduzione dei consumi e delle emissioni, passaggio dal petrolio all idrogeno, ecc). È per questi motivi (come sottolineavano anche gli ingegneri veneziani alla presentazione del progetto delle macro-insulae ) che le difese locali dalle acque alte e le azioni di riequilibrio lagunare diventano ancor più importanti: possono consentire alla città di eliminare le punte di alta marea in questi primi decenni del secolo senza pregiudicare le scelte future a più lungo termine, per avere il tempo di verificare l evolversi delle situazioni reali e delle tecnologie disponibili. Le scelte di lungo periodo dovranno essere valutate con molta attenzione non tanto per gli aspetti economici (costi e benefici degli interventi e della gestione e manutenzione), quanto perché, se le azioni dell uomo e le evoluzioni delle tecnologie e del clima non fossero veramente in grado di scongiurare un grande aumento del livello del mare, alle future generazioni si imporrebbero decisioni drastiche oggi certamente non programmabili: - occorrerebbe attuare un sistema di protezione fisso e solo parzialmente mobile per regolare frequentemente e non saltuariamente l afflusso di marea; - la drastica riduzione dei ricambi di acque garantito dal libero afflusso delle maree richiederebbe una altrettanto drastica riduzione degli apporti inquinanti dai territori agricoli, dagli insediamenti industriali e civili e dagli stessi corsi d acqua e impianti di depurazione; - probabilmente le attività industriali e portuali diverrebbero incompatibili e andrebbero riallocate all esterno dell ambito lagunare; - i sistemi di difesa, drenaggio e gestione delle acque dell intero territorio costiero dell Alto Adriatico (già oggi sotto il livello del mare) andrebbero riadeguati. Mentre quindi si attuano gli interventi che consentono di salvaguardare la città e la laguna in questa fase storica, Venezia è particolarmente interessata (per garantire il suo futuro) a diventare un centro promotore non secondario delle azioni di riqualificazione ambientale del modo di vivere, produrre e consumare dei paesi sviluppati. La città può candidarsi ad avere un ruolo sia sugli aspetti promozionali culturali, scientifici e politici sia sugli aspetti di attuazione e sperimentazione di nuovi approcci tecnologici e produttivi impiegando in modo intelligente e lungimirante le grandi risorse economiche pubbliche e private che vengono attivate in questo territorio. Fondamenta dei Mori, dicembre
Il progetto definitivo, pur essendo redatto in
 Difesa dalle acque medio-alte: alternative progettuali Il progetto definitivo, pur essendo redatto in modo unitario, ha sviluppato due alternative che tra loro si differenziano soprattutto in relazione
Difesa dalle acque medio-alte: alternative progettuali Il progetto definitivo, pur essendo redatto in modo unitario, ha sviluppato due alternative che tra loro si differenziano soprattutto in relazione
I rialzi IN SU LA NUMERO 5 ANNO II DICEMBRE 2000 DOCUMENTI SULLA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
 IN SU LA DOCUMENTI SULLA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA NUMERO 5 ANNO II DICEMBRE 2000 INSULA QUADERNI - TRIMESTRALE N 5 ANNO II - Spedizione in abbonamento postale 45% - DCI/VE - In caso di mancato recapito
IN SU LA DOCUMENTI SULLA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA NUMERO 5 ANNO II DICEMBRE 2000 INSULA QUADERNI - TRIMESTRALE N 5 ANNO II - Spedizione in abbonamento postale 45% - DCI/VE - In caso di mancato recapito
Il MO.S.E. MO.S.E. INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA (BARRIERE MOBILI)
 Il MO.S.E. MO.S.E. INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA (BARRIERE MOBILI) Elementi principali Progetto Definitivo (DIC2003) Magistrato alle Acque Consorzio Venezia Nuova
Il MO.S.E. MO.S.E. INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA (BARRIERE MOBILI) Elementi principali Progetto Definitivo (DIC2003) Magistrato alle Acque Consorzio Venezia Nuova
C O L L E G I O I N G E G N E R I V E N E Z I A
 C O L L E G I O I N G E G N E R I V E N E Z I A www.collegioingegnerivenezia.it ALCUNE CONSIDERAZIONI A SEGUITO DELL ACQUA ALTA ECCEZIONALE DEL 29 OTTOBRE 2018, PER SOTTOLINEARE L ECCEZIONALITA DELL EVENTO
C O L L E G I O I N G E G N E R I V E N E Z I A www.collegioingegnerivenezia.it ALCUNE CONSIDERAZIONI A SEGUITO DELL ACQUA ALTA ECCEZIONALE DEL 29 OTTOBRE 2018, PER SOTTOLINEARE L ECCEZIONALITA DELL EVENTO
Lido. Mestre. Porto Marghera. Cavallino. S. Erasmo Venezia 10. Treporti. Bocca di Lido. Casse di colmata. Malamocco. Bocca di Malamocco
 Studi / progetti / opere 98 Mestre 1 Porto Marghera 11 12 7 10 1 2 3 4 5 8 9 6 15 Murano 14 13 2 17 3 6 7 S. Erasmo 11 Venezia 10 8 16 17 9 12 13 18 14 15 19 16 4 5 Treporti Cavallino 1 20 18 19 Lido Bocca
Studi / progetti / opere 98 Mestre 1 Porto Marghera 11 12 7 10 1 2 3 4 5 8 9 6 15 Murano 14 13 2 17 3 6 7 S. Erasmo 11 Venezia 10 8 16 17 9 12 13 18 14 15 19 16 4 5 Treporti Cavallino 1 20 18 19 Lido Bocca
Lido. Mestre 1. Porto Marghera. Venezia. Cavallino. Bocca di Lido. Casse di colmata. Malamocco. Bocca di Malamocco. San Pietro in volta.
 Studi / progetti / opere 50 1 Mestre 1 2 3 4 Murano 5 6 7 Porto Marghera 2 3 4 8 Venezia 9 5 6 7 S. Erasmo Treporti 10 8 9 14 11 10 13 19 20 12 15 21 16 17 18 22 11 12 Bocca di Lido 13 Lido 14 15 16 23
Studi / progetti / opere 50 1 Mestre 1 2 3 4 Murano 5 6 7 Porto Marghera 2 3 4 8 Venezia 9 5 6 7 S. Erasmo Treporti 10 8 9 14 11 10 13 19 20 12 15 21 16 17 18 22 11 12 Bocca di Lido 13 Lido 14 15 16 23
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO TITOLO DOCUMENTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO VALUTAZIONE SUGLI ASPETTI IDRAULICI GEOLOGO: Geol. Gianni Focardi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO TITOLO DOCUMENTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO VALUTAZIONE SUGLI ASPETTI IDRAULICI GEOLOGO: Geol. Gianni Focardi
CONSEGUENZE DELL INNALZAMENTO DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE SULLA LAGUNA DI VENEZIA E SUI TERRITORI ADIACENTI
 Museo Regionale della Bonifica - Ca Vendramin, 22 settembre 2017 CONSEGUENZE DELL INNALZAMENTO DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE SULLA LAGUNA DI VENEZIA E SUI TERRITORI ADIACENTI Luigi D Alpaos Laguna di Marano
Museo Regionale della Bonifica - Ca Vendramin, 22 settembre 2017 CONSEGUENZE DELL INNALZAMENTO DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE SULLA LAGUNA DI VENEZIA E SUI TERRITORI ADIACENTI Luigi D Alpaos Laguna di Marano
Opere di difesa dell insula di San Marco dalle Acque medio alte
 Opere di difesa dell insula di San Marco dalle Acque medio alte Interventi di Salvaguardia di Piazza San Marco dalle alte maree Convegno tra geologia e geofisica 2018 Geologia e Geofisica applicate ai
Opere di difesa dell insula di San Marco dalle Acque medio alte Interventi di Salvaguardia di Piazza San Marco dalle alte maree Convegno tra geologia e geofisica 2018 Geologia e Geofisica applicate ai
Oltre l acqua alta. Nuovi scenari di gestione del MOSE
 Oltre l acqua alta. Nuovi scenari di gestione del MOSE Prof. Enrico Foti Consorzio Venezia Nuova, Venezia Università di Catania Indice Premessa Sistema Mo.S.E. attività in corso Bocca di Chioggia Bocca
Oltre l acqua alta. Nuovi scenari di gestione del MOSE Prof. Enrico Foti Consorzio Venezia Nuova, Venezia Università di Catania Indice Premessa Sistema Mo.S.E. attività in corso Bocca di Chioggia Bocca
Bocca di porto di Chioggia
 Venezia Bocca di porto di Lido Bocca di porto di Malamocco Bocca di porto di Chioggia Chioggia 41 Sistema Mose per la difesa dalle acque alte. Avanzamento lavori (febbraio 2010) Il Mose. Cos è e come funziona
Venezia Bocca di porto di Lido Bocca di porto di Malamocco Bocca di porto di Chioggia Chioggia 41 Sistema Mose per la difesa dalle acque alte. Avanzamento lavori (febbraio 2010) Il Mose. Cos è e come funziona
Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale e artificiale e sulle aree costiere lacuali e marine in Regione Veneto
 Allegato 6.6 alla Relazione tecnica del Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale
Allegato 6.6 alla Relazione tecnica del Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione Mappatura della pericolosità sul reticolo secondario, naturale
Progetto: LIFE11 ENV/IT/ LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL EMILIA
 Progetto: LIFE11 ENV/IT/000243 LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL EMILIA ROMAGNA Finanziamento Contributo UE 599.250 Regione Emilia
Progetto: LIFE11 ENV/IT/000243 LIFE RII RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA IDRAULICO-AMBIENTALE DEI RII APPARTENENTI ALLA FASCIA PEDEMONTANA DELL EMILIA ROMAGNA Finanziamento Contributo UE 599.250 Regione Emilia
Studi / progetti / opere
 Studi / progetti / opere 76 2 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 7 15 1 15 16 17 3 18 4 8 11 12 16 17 18 19 9 10 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 6 1 19 21 20 23 24 22 29 2 26 25 30 31 32 33 34 35 36 37
Studi / progetti / opere 76 2 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 7 15 1 15 16 17 3 18 4 8 11 12 16 17 18 19 9 10 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 6 1 19 21 20 23 24 22 29 2 26 25 30 31 32 33 34 35 36 37
Registro protocollo Regione Abruzzo
 Registro protocollo Regione Abruzzo Archivio Codice Registro Tipo Documento Progressivo Annuo Data Protocollo Trasmissione Mittente/Destinatari Annullato PROTOCOLLO UNICO RA RP001 Posta in arrivo 0012382/18
Registro protocollo Regione Abruzzo Archivio Codice Registro Tipo Documento Progressivo Annuo Data Protocollo Trasmissione Mittente/Destinatari Annullato PROTOCOLLO UNICO RA RP001 Posta in arrivo 0012382/18
Il verde pensile ed il costruito. Matteo Fiori
 Il verde pensile ed il costruito matteo.fiori@polimi.it Perché intervenire? 2 Creazione di nuovi spazi di relax Riqualificazione architettonica Miglioramento della qualità ambientale dell ambiente confinato
Il verde pensile ed il costruito matteo.fiori@polimi.it Perché intervenire? 2 Creazione di nuovi spazi di relax Riqualificazione architettonica Miglioramento della qualità ambientale dell ambiente confinato
L esperienza della Regione Molise nel settore della difesa della costa dalla erosione marina
 L esperienza della Regione Molise nel settore della difesa della costa dalla erosione marina Regione molise Direzione Generale IV Servizio Opere Idrauliche e Marittime Fase preliminare di studio e di sperimentazione
L esperienza della Regione Molise nel settore della difesa della costa dalla erosione marina Regione molise Direzione Generale IV Servizio Opere Idrauliche e Marittime Fase preliminare di studio e di sperimentazione
Adeguamento via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta Sant'Angelo.
 Adeguamento via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta Sant'Angelo. Paolo Costa Presidente Autorità Portuale di Venezia APV, Santa
Adeguamento via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al canale Contorta Sant'Angelo. Paolo Costa Presidente Autorità Portuale di Venezia APV, Santa
PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
 REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE ALL AMBIENTE DIREZIONE TUTELA DELL AMBIENTE PIANO PER LA PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA
Registrazione ed elaborazione dei parametri meteomarini nella Laguna di Venezia
 Registrazione ed elaborazione dei parametri meteomarini nella Laguna di Venezia 2002 La presente pubblicazione è stata curata da: Paolo Canestrelli (direttore dell I.C.P.S.M.) Franca Pastore Annamaria
Registrazione ed elaborazione dei parametri meteomarini nella Laguna di Venezia 2002 La presente pubblicazione è stata curata da: Paolo Canestrelli (direttore dell I.C.P.S.M.) Franca Pastore Annamaria
Venezia. Bocca di porto di Lido. Bocca di porto di Malamocco. Bocca di porto di Chioggia. Chioggia
 Venezia Bocca di porto di Lido Bocca di porto di Malamocco Bocca di porto di Chioggia Chioggia 37 Sistema MOSE. Avanzamento lavori (gennaio 2008) Il sistema di difesa dalle acque alte Per la protezione
Venezia Bocca di porto di Lido Bocca di porto di Malamocco Bocca di porto di Chioggia Chioggia 37 Sistema MOSE. Avanzamento lavori (gennaio 2008) Il sistema di difesa dalle acque alte Per la protezione
3.2 - REGIONE BASILICATA
 3.2 - Ing. Umberto De Matteis Tutor regionale 3.2.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.2.1.1 - Premessa Il progetto LSU bis ha avuto inizio nell agosto 1997 e si è concluso
3.2 - Ing. Umberto De Matteis Tutor regionale 3.2.1 - RAPPORTO TECNICO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL AMBITO DEL PROGETTO 3.2.1.1 - Premessa Il progetto LSU bis ha avuto inizio nell agosto 1997 e si è concluso
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quarta Commissione consiliare
 Richiesta del Consigliere Francesco Calzavara sugli effetti della legge regionale n. 11/2014 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, in particolare sul numero di PAT e PI approvati
Richiesta del Consigliere Francesco Calzavara sugli effetti della legge regionale n. 11/2014 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, in particolare sul numero di PAT e PI approvati
INSULA S.p.A. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA STATO, REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI VENEZIA
 AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001/2000 Commessa PA.00475 INSULA S.p.A. Legge 139/92 Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna Piano programma per la manutenzione
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001/2000 Commessa PA.00475 INSULA S.p.A. Legge 139/92 Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna Piano programma per la manutenzione
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA STRUTTURA E PRIMI CONTENUTI. Mestre 14 Novembre
 IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA STRUTTURA E PRIMI CONTENUTI Mestre 14 Novembre LA LEGGE REGIONALE 11/2004 I PRINCIPI INNOVATIVI 1.Fase di concertazione obbligatoria, preliminare
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA STRUTTURA E PRIMI CONTENUTI Mestre 14 Novembre LA LEGGE REGIONALE 11/2004 I PRINCIPI INNOVATIVI 1.Fase di concertazione obbligatoria, preliminare
Gli eventi meteo-marini di inizio febbraio 2015 nel Nord Adriatico
 Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Gli eventi meteo-marini di inizio febbraio 215 nel Nord Adriatico Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521
Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Gli eventi meteo-marini di inizio febbraio 215 nel Nord Adriatico Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521
Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare.
 Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare. Dall inizio del 2010 si stanno eseguendo ricerche e monitoraggio circa i movimenti verticali del mare particolarmente accentuati
Di nuovo Acqua Alta ad Ischia Porto e Lipari: le banchine basse invase dal mare. Dall inizio del 2010 si stanno eseguendo ricerche e monitoraggio circa i movimenti verticali del mare particolarmente accentuati
Analisi eventi di marea
 Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 1/211-1 Marzo 211 Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521 Segreteria
Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 1/211-1 Marzo 211 Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521 Segreteria
I tempi di attuazione delle opere pubbliche e gli strumenti di controllo disponibili
 I tempi di attuazione delle opere pubbliche e gli strumenti di controllo disponibili Carla Carlucci DPS UVER Forum PA Rimettere i tempi al centro dell azione pubblica 30 maggio 2013 Palazzo dei Congressi
I tempi di attuazione delle opere pubbliche e gli strumenti di controllo disponibili Carla Carlucci DPS UVER Forum PA Rimettere i tempi al centro dell azione pubblica 30 maggio 2013 Palazzo dei Congressi
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Provincia di Livorno)
 Variante urbanistica per modifica normativa zona AB a Donoratico complesso immobiliare "IL Cantinone", mediante procedura di cui alla L.R. 1/05 Artt. 15, 16, 17 e 18. (Rif. 4/06) RELAZIONE Premesso Che
Variante urbanistica per modifica normativa zona AB a Donoratico complesso immobiliare "IL Cantinone", mediante procedura di cui alla L.R. 1/05 Artt. 15, 16, 17 e 18. (Rif. 4/06) RELAZIONE Premesso Che
Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua.
 Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua. Valerio Buonomo, borsista c/o CNR-ISAFOM. Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, docente del Master in Pianificazione Comunale,
Romagna: l alluvione perfetta durante le 15 ore di acqua alta marina continua. Valerio Buonomo, borsista c/o CNR-ISAFOM. Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, docente del Master in Pianificazione Comunale,
Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell approccio regionale
 LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE TRA RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell
LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE TRA RISCHIO IDRAULICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO Dalle criticità idrauliche alla gestione della vegetazione: la manutenzione dei corsi d acqua nell
Stato di avanzamento dell attività 2010 per lo sviluppo di una procedura di allertamento costiero in caso di mareggiate a supporto del Centro
 Stato di avanzamento dell attività 2010 per lo sviluppo di una procedura di allertamento costiero in caso di mareggiate a supporto del Centro Multirischio della Protezione Civile Premessa Nell ambito delle
Stato di avanzamento dell attività 2010 per lo sviluppo di una procedura di allertamento costiero in caso di mareggiate a supporto del Centro Multirischio della Protezione Civile Premessa Nell ambito delle
Mose. I cantieri in corso alla bocca di porto di Chioggia. Premessa. A sinistra Cantieri del Mose alla bocca di porto di Chioggia
 51 Mose. I cantieri in corso alla bocca di porto di Chioggia Premessa Il Mose prevede per Chioggia una barriera formata da 18 paratoie che servirà a coprire il varco di 360 m tra le due sponde della bocca
51 Mose. I cantieri in corso alla bocca di porto di Chioggia Premessa Il Mose prevede per Chioggia una barriera formata da 18 paratoie che servirà a coprire il varco di 360 m tra le due sponde della bocca
Acqua alta ad Ischia: c entra anche il cambiamento climatico? L 1 e 2 gennaio 2010 il Golfo di Napoli, come il Tirreno Meridionale, è stato
 Acqua alta ad Ischia: c entra anche il cambiamento climatico? L 1 e 2 gennaio 2010 il Golfo di Napoli, come il Tirreno Meridionale, è stato interessato da una forte mareggiata che ha variamente danneggiato
Acqua alta ad Ischia: c entra anche il cambiamento climatico? L 1 e 2 gennaio 2010 il Golfo di Napoli, come il Tirreno Meridionale, è stato interessato da una forte mareggiata che ha variamente danneggiato
SOS Acqua. Le città e i territori alla sfida del clima. Andrea Minutolo Coordinatore ufficio scientifico di Legambiente
 SOS Acqua Le città e i territori alla sfida del clima Andrea Minutolo Coordinatore ufficio scientifico di Legambiente La lista della spesa sul dissesto idrogeologico Bisogna superare un approccio al dissesto
SOS Acqua Le città e i territori alla sfida del clima Andrea Minutolo Coordinatore ufficio scientifico di Legambiente La lista della spesa sul dissesto idrogeologico Bisogna superare un approccio al dissesto
Analisi eventi di marea
 Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 2/211-12 - 13 Aprile 211 Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521
Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 2/211-12 - 13 Aprile 211 Castello, 4665-3122 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521
Il nuovo Laboratorio di analisi chimiche del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo
 11 Giorgio Ferrari * * Responsabile della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) Il nuovo Laboratorio di analisi chimiche del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo
11 Giorgio Ferrari * * Responsabile della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque (SAMA) Il nuovo Laboratorio di analisi chimiche del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo
2012. Al via la prima barriera del Mose
 1 2012. Al via la prima barriera del Mose I cantieri del Mose alle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia sono ormai arrivati a oltre due terzi di quanto previsto. Dal 2003 a oggi, le bocche di porto lagunari
1 2012. Al via la prima barriera del Mose I cantieri del Mose alle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia sono ormai arrivati a oltre due terzi di quanto previsto. Dal 2003 a oggi, le bocche di porto lagunari
STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAZZALE SALANDRA
 STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAZZALE SALANDRA 1. Premessa Nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. si rende
STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAZZALE SALANDRA 1. Premessa Nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. si rende
NODO DI ATTACCO A TERRA
 SISTEMA TECNOLOGICO Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura Corso di Laurea Magistrale in Architettura 5UE Laboratorio di Costruzione dell Architettura prof. arch. Mario
SISTEMA TECNOLOGICO Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura Corso di Laurea Magistrale in Architettura 5UE Laboratorio di Costruzione dell Architettura prof. arch. Mario
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE LEGGE OBIETTIVO Attività ai sensi della L. 21 dicembre 2001 n. 443 E del D.Lgs 20 agosto 2002 n. 190 Del. CIPE 121/2001 VENEZIA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE LEGGE OBIETTIVO Attività ai sensi della L. 21 dicembre 2001 n. 443 E del D.Lgs 20 agosto 2002 n. 190 Del. CIPE 121/2001 VENEZIA
PREFAZIONE. Dr. Aldino Bondesan SIGEA Triveneto
 PREFAZIONE Il contesto geologico veneziano riassume in sé tutte le peculiarità proprie delle aree di transizione tra terra e mare, non soltanto in relazione all attuale assetto geografico-fisico, ma anche
PREFAZIONE Il contesto geologico veneziano riassume in sé tutte le peculiarità proprie delle aree di transizione tra terra e mare, non soltanto in relazione all attuale assetto geografico-fisico, ma anche
Vai agli allegati sulla normativa - incentivazione degli interventi - obblighi di termoregolazione e contabilizzazione
 Il bilancio energetico del territorio di Bologna è caratterizzato dagli elevati consumi del settore residenziale: 39% del totale al 2005 (e oltre 44% al 2013). Sono molti i condomini con impianti centralizzati,
Il bilancio energetico del territorio di Bologna è caratterizzato dagli elevati consumi del settore residenziale: 39% del totale al 2005 (e oltre 44% al 2013). Sono molti i condomini con impianti centralizzati,
Gronda di Genova. LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE Attività svolte, metodologie di studio e indirizzi futuri. Dibattito pubblico
 Gronda di Genova LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE Attività svolte, metodologie di studio e indirizzi futuri Dibattito pubblico 4 aprile 2009 INDICE 1. I temi ambientali e socio-economici
Gronda di Genova LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICHE Attività svolte, metodologie di studio e indirizzi futuri Dibattito pubblico 4 aprile 2009 INDICE 1. I temi ambientali e socio-economici
2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ONDOSE ALL IMBOCCATURA... 3
 PREMESSE... 2 2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ONDOSE ALL IMBOCCATURA... 3 3. TRASFERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO ALL IMBOCCATURA DELL AREA PORTUALE... 5 Risultati delle simulazioni
PREMESSE... 2 2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ONDOSE ALL IMBOCCATURA... 3 3. TRASFERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO ALL IMBOCCATURA DELL AREA PORTUALE... 5 Risultati delle simulazioni
Margaretha Breil (Dipartimento di Economia, Università Ca Foscari di Venezia)
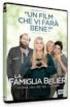 VECTOR - Cliven Valutazione di impatti da cambiamenti climatici sul centro storico di Venezia: Strutture edilizie e attività economiche Valuation of climate change impacts on the historic centre of Venice:
VECTOR - Cliven Valutazione di impatti da cambiamenti climatici sul centro storico di Venezia: Strutture edilizie e attività economiche Valuation of climate change impacts on the historic centre of Venice:
Per rendere attuabili tali proposte si propongono strumenti mirati a programmi territoriali complessivi quali Corona Verde.
 GRUPPO DI LAVORO 2 Gli obiettivi principali del progetto e risultati attesi dalla realizzazione degli interventi in via di definizione, discussi nell ambito del gruppo di lavoro 2 sono: - recupero della
GRUPPO DI LAVORO 2 Gli obiettivi principali del progetto e risultati attesi dalla realizzazione degli interventi in via di definizione, discussi nell ambito del gruppo di lavoro 2 sono: - recupero della
prof. ing. Anna Magrini Il progetto del recupero: problematiche
 prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
prof. ing. Anna Magrini Università degli Studi di Pavia Il progetto del recupero: problematiche Efficienza energetica dell involucro edilizio Edificio degli anni 1950-80 200-250 kwh/m 2 a Legge 373 / 1976
ASSE I PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
 POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE I PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.2 -- "Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale" Azione 1.2.2 - "Supporto alla
POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE I PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE Obiettivo specifico 1.2 -- "Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale" Azione 1.2.2 - "Supporto alla
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI VENEZIA. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia
 Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia In data 26 novembre 2016 è stato siglato il Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia attraverso il quale
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia In data 26 novembre 2016 è stato siglato il Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia attraverso il quale
Corso Integrato: Idrologia e Infrastrutture Idrauliche T
 LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Corso Integrato: Idrologia e Infrastrutture Idrauliche T 11 Ottobre 2018 Incontro informativo con gli studenti IDROLOGIA E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO Corso Integrato: Idrologia e Infrastrutture Idrauliche T 11 Ottobre 2018 Incontro informativo con gli studenti IDROLOGIA E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi
 Settore Statistica e S.I.T Servizio Statistica Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi Introduzione L Indagine sui consumi delle famiglie milanesi realizzata dalla Camera
Settore Statistica e S.I.T Servizio Statistica Calcolo dell inflazione per differenti tipologie di famiglie milanesi Introduzione L Indagine sui consumi delle famiglie milanesi realizzata dalla Camera
ACUSTICA IN EDILIZIA SPERIMENTAZIONE IN LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009
 ACUSTICA IN EDILIZIA SPERIMENTAZIONE IN LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009 DIVULGAZIONE DEI RISULTATI: MILANO - LUNEDì 9 NOVEMBRE 2009 Motivazioni della ricerca Ambito legislativo: legge regionale
ACUSTICA IN EDILIZIA SPERIMENTAZIONE IN LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009 DIVULGAZIONE DEI RISULTATI: MILANO - LUNEDì 9 NOVEMBRE 2009 Motivazioni della ricerca Ambito legislativo: legge regionale
Acque sotterranee, lo stato chimico è buono
 Acque sotterranee, lo stato chimico è buono Il monitoraggio dell'ispra ha rilevato uno stato buono delle acque sotterranee e superficiali, mentre la situazione è meno confortante per quelle di bacini e
Acque sotterranee, lo stato chimico è buono Il monitoraggio dell'ispra ha rilevato uno stato buono delle acque sotterranee e superficiali, mentre la situazione è meno confortante per quelle di bacini e
Mappe di pericolosità e rischio in ambito costiero
 DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO di INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Mappe di pericolosità e rischio in ambito costiero Luisa Perini, Lorenzo
DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010 PERCORSO PARTECIPATIVO CICLO di INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI (27 febbraio 17 aprile 2014) Mappe di pericolosità e rischio in ambito costiero Luisa Perini, Lorenzo
Laurea in Ingegneria per l ambiente e il territorio Sede di Rieti
 Consiglio d Area Ingegneria Rieti A.A. 2008-09 Laurea in Ingegneria per l ambiente e il territorio Sede di Rieti Classe n o 8 (Ingegneria Civile ed Ambientale) Didattica Ordinamento 2000 Sede di Rieti
Consiglio d Area Ingegneria Rieti A.A. 2008-09 Laurea in Ingegneria per l ambiente e il territorio Sede di Rieti Classe n o 8 (Ingegneria Civile ed Ambientale) Didattica Ordinamento 2000 Sede di Rieti
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
 PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI Le elaborazioni seguenti, frutto della collaborazione tra i Settori della Giunta Regionale della Campania Opere Pubbliche e Sistemi Informativi,
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI Le elaborazioni seguenti, frutto della collaborazione tra i Settori della Giunta Regionale della Campania Opere Pubbliche e Sistemi Informativi,
relazione sulla situazione economica e gestionale
 relazione sulla situazione economica e gestionale relatori Paolo Sprocati presidente Insula spa Claudio Orazio vicepresidente Insula spa VIII commissione consiliare Venezia, fusione con Edilvenezia spa:
relazione sulla situazione economica e gestionale relatori Paolo Sprocati presidente Insula spa Claudio Orazio vicepresidente Insula spa VIII commissione consiliare Venezia, fusione con Edilvenezia spa:
loro installazione. alla fine del mese di agosto.
 Studi / progetti / opere 51 Opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree in laguna. Interventi in corso (agosto 2005) Premessa La costruzione del sistema di difesa dalle acque alte prevede
Studi / progetti / opere 51 Opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree in laguna. Interventi in corso (agosto 2005) Premessa La costruzione del sistema di difesa dalle acque alte prevede
Università degli Studi di Ferrara Polo Scientifico Tecnologico
 La ricerca scientifica italiana nel campo dell idraulica: presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 Ferrara, 24 25 gennaio 2013 PROGETTO: ECO MORFODINAMICA DI AMBIENTI A MAREA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
La ricerca scientifica italiana nel campo dell idraulica: presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008 Ferrara, 24 25 gennaio 2013 PROGETTO: ECO MORFODINAMICA DI AMBIENTI A MAREA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
RISCHI DA CAMBIAMENTO CLIMATICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
 RISCHI DA CAMBIAMENTO CLIMATICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO Piogge intense e forte impermeabilizzazione del suolo sono i due principali fattori che causano l aumento del rischio idraulico che comunque
RISCHI DA CAMBIAMENTO CLIMATICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO Piogge intense e forte impermeabilizzazione del suolo sono i due principali fattori che causano l aumento del rischio idraulico che comunque
IMPIANTI PROGETTAZIONE EDILIZIA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
 IMPIANTI ARCHITETTO RAPPRESENTA IL RIFERIMENTO UNICO SUL QUALE DEVONO CONVERGERE LE SCELTE PROGETTUALI PROGETTAZIONE EDILIZIA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA In altre parole gli impianti tecnici vengono considerati
IMPIANTI ARCHITETTO RAPPRESENTA IL RIFERIMENTO UNICO SUL QUALE DEVONO CONVERGERE LE SCELTE PROGETTUALI PROGETTAZIONE EDILIZIA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA In altre parole gli impianti tecnici vengono considerati
Analisi eventi di marea
 Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 5/21-22-26 Dicembre 21 San Polo, 5-3125 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521 Segreteria
Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine Servizio Laguna di Venezia Analisi eventi di marea Rapporto n. 5/21-22-26 Dicembre 21 San Polo, 5-3125 Venezia Tel: 41 522555 / 5235895 - Fax: 41 522521 Segreteria
Pianificazione e gestione del territorio in materia idraulica
 Pianificazione e gestione del territorio in materia idraulica Il ruolo del Consorzio di bonifica Acque Risorgive e degli altri Enti In collaborazione con Teatro comunale di Borgoricco (PD) Il Piano Generale
Pianificazione e gestione del territorio in materia idraulica Il ruolo del Consorzio di bonifica Acque Risorgive e degli altri Enti In collaborazione con Teatro comunale di Borgoricco (PD) Il Piano Generale
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA RELAZIONE
 Comune di ARQUA POLESINE Comune di VILLAMARZANA OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA RELAZIONE VARIANTE MARZO 2014 INTERNA ALLA ZONIZZAZIONE DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DENOMINATO MACROAREA S.S. 434-TRANSPOLESANA
Comune di ARQUA POLESINE Comune di VILLAMARZANA OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA RELAZIONE VARIANTE MARZO 2014 INTERNA ALLA ZONIZZAZIONE DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DENOMINATO MACROAREA S.S. 434-TRANSPOLESANA
e rischio idraulico Applicazione alle reti fognarie Invarianza idraulica, idrologica Ruolo del gestore Crema, 23 maggio 2019
 Invarianza idraulica, idrologica e rischio idraulico Ruolo del gestore Applicazione alle reti fognarie ing. Sara Fertonani Servizio Fognatura di Padania Acque SpA Crema, 23 maggio 2019 1 Gestore unico
Invarianza idraulica, idrologica e rischio idraulico Ruolo del gestore Applicazione alle reti fognarie ing. Sara Fertonani Servizio Fognatura di Padania Acque SpA Crema, 23 maggio 2019 1 Gestore unico
ANALISI DEI FLUSSI ATTRAVERSO LE BOCCHE DI PORTO MEDIANTE MODELLO IDRODINAMICO FEM
 Area 3. Processi ambientali Line 3.5 Quantità e qualità degli scambi tra laguna e mare WBS3: Modellistica ANALISI DEI FLUSSI ATTRAVERSO LE BOCCHE DI PORTO MEDIANTE MODELLO IDRODINAMICO FEM Andrea Cucco
Area 3. Processi ambientali Line 3.5 Quantità e qualità degli scambi tra laguna e mare WBS3: Modellistica ANALISI DEI FLUSSI ATTRAVERSO LE BOCCHE DI PORTO MEDIANTE MODELLO IDRODINAMICO FEM Andrea Cucco
Terzo report bimestrale di monitoraggio di FQTS I laboratori regionali e la formazione formatori (1/7/ 2014)
 Terzo report bimestrale di monitoraggio di FQTS 204 I laboratori regionali e la formazione formatori (/7/ 204) Abstract: I laboratori sui Fondi Strutturali hanno segnato in questo periodo un buon livello
Terzo report bimestrale di monitoraggio di FQTS 204 I laboratori regionali e la formazione formatori (/7/ 204) Abstract: I laboratori sui Fondi Strutturali hanno segnato in questo periodo un buon livello
1 VALIDAZIONE DATI DA SATELLITE: confronto dati da boe vs. dati da satellite
 Presentazione ufficiale V.E.C.T.O.R. (VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti climatici e loro ruolo nei cicli del carbonio mediterraneo) LINEA 1 CLICOST Effetti dei
Presentazione ufficiale V.E.C.T.O.R. (VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti climatici e loro ruolo nei cicli del carbonio mediterraneo) LINEA 1 CLICOST Effetti dei
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA
 CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
CONTROLLI SUGLI ELETTRODOTTI DI ALTA TENSIONE TRANSITANTI SUL TERRITORIO DELLA VALLE D AOSTA Valeria Bottura, C. Desandré, E. Imperial, Leo Cerise ARPA Valle d Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 St.
Nota tecnica n. 01/2011 Lido diga sud Proposta di variazione della quota del caposaldo e relativa correzione dei dati di marea
 Nota tecnica n. 01/2011 Lido diga sud Proposta di variazione della quota del caposaldo e relativa correzione dei dati di marea In questo documento si vuole porre l attenzione sui livelli di marea registrati
Nota tecnica n. 01/2011 Lido diga sud Proposta di variazione della quota del caposaldo e relativa correzione dei dati di marea In questo documento si vuole porre l attenzione sui livelli di marea registrati
Osservatorio sul Mercato Immobiliare, Luglio 2016 NOTA CONGIUNTURALE SUL MERCATO IMMOBILIARE A MAGGIO
 Osservatorio sul Mercato Immobiliare, Luglio 21 PALERMO NOTA CONGIUNTURALE SUL MERCATO IMMOBILIARE A MAGGIO 21 1 Quota di edifici residenziali e ad uso produttivo nelle zone amministrative Quota di edifici
Osservatorio sul Mercato Immobiliare, Luglio 21 PALERMO NOTA CONGIUNTURALE SUL MERCATO IMMOBILIARE A MAGGIO 21 1 Quota di edifici residenziali e ad uso produttivo nelle zone amministrative Quota di edifici
Cinzia Talamo del Politecnico di Milano
 URBAN UTILITY _ milano 22 03 2013 LA COSTRUZIONE DEL DATO COME PRESUPPOSTO DELLA DECISIONE TERZA SESSIONE RICOGNIZIONI E PRATICHE DI MANUTENZIONE URBANA: IL FACILITY MANAGEMENT URBANO Cinzia Talamo del
URBAN UTILITY _ milano 22 03 2013 LA COSTRUZIONE DEL DATO COME PRESUPPOSTO DELLA DECISIONE TERZA SESSIONE RICOGNIZIONI E PRATICHE DI MANUTENZIONE URBANA: IL FACILITY MANAGEMENT URBANO Cinzia Talamo del
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
 REGIONE TOSCANA Giunta Regionale DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI ED AMBIENTALI E PER LA MOBILITA Settore Pianificazione del territorio Oggetto: Comune di San Vincenzo (Li) - Adozione di
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI ED AMBIENTALI E PER LA MOBILITA Settore Pianificazione del territorio Oggetto: Comune di San Vincenzo (Li) - Adozione di
MOSE, la specificità del caso Venezia per la difesa del territorio
 MOSE, la specificità del caso Venezia per la difesa del territorio Ing. Fabio Riva Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto Ingegnere Capo del Mose Laguna di Venezia Venezia Laguna
MOSE, la specificità del caso Venezia per la difesa del territorio Ing. Fabio Riva Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto Ingegnere Capo del Mose Laguna di Venezia Venezia Laguna
STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE
 STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE 1. Premessa Nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. si rende necessario, tra l altro, lo studio di fattibilità ambientale dell
STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE 1. Premessa Nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. si rende necessario, tra l altro, lo studio di fattibilità ambientale dell
Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) in materia di edilizia
 ALLEGATO 5 a) Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) in materia di edilizia lett. d) punto 2 del documento approvato nella riunione del 16/4/2012 Tavolo Permanente per la Semplificazione 1 Misurazione
ALLEGATO 5 a) Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) in materia di edilizia lett. d) punto 2 del documento approvato nella riunione del 16/4/2012 Tavolo Permanente per la Semplificazione 1 Misurazione
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA PRATICA AIA PER IL POTENZIAMENTO DEL POLO TECNOLOGICO CHIARIMENTI IN MERITO AI POZZI DRENANTI Rev. 00 del 10 SETTEMBRE 2013 Ospedale Niguarda
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA PRATICA AIA PER IL POTENZIAMENTO DEL POLO TECNOLOGICO CHIARIMENTI IN MERITO AI POZZI DRENANTI Rev. 00 del 10 SETTEMBRE 2013 Ospedale Niguarda
Per uscire dalla crisi: un Piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico
 ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L ENERGIA E L AMBIENTE Per uscire dalla crisi: un Piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico Marco Citterio, Gaetano
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L ENERGIA E L AMBIENTE Per uscire dalla crisi: un Piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico Marco Citterio, Gaetano
Facciamo Centro insieme!
 Comune di Campiglia Marittima Provincia di Livorno Facciamo Centro insieme! Esperienza progettuale di partecipazione per la rivitalizzazione e la riqualificazione del Centro Storico Obiettivi del progetto
Comune di Campiglia Marittima Provincia di Livorno Facciamo Centro insieme! Esperienza progettuale di partecipazione per la rivitalizzazione e la riqualificazione del Centro Storico Obiettivi del progetto
N.T.A. del P.R.G. CON MODIFICHE
 N.T.A. del P.R.G. CON MODIFICHE ( Cancellazioni / aggiunte ) Art. 83 - Ambito di recupero ambientale della zona produttiva lungo la Statale Fermana (sottozona D 1.3) 1 Il fondovalle del Rio Petronilla,
N.T.A. del P.R.G. CON MODIFICHE ( Cancellazioni / aggiunte ) Art. 83 - Ambito di recupero ambientale della zona produttiva lungo la Statale Fermana (sottozona D 1.3) 1 Il fondovalle del Rio Petronilla,
CONDUZIONE AGRICOLA E CRITICITÀ (IDRAULICHE) NELL INTERFACCIA TERRITORIO AGRICOLO/AMBITI EDIFICATI Monza, EMERLAB 27 maggio 2016
 CONDUZIONE AGRICOLA E CRITICITÀ (IDRAULICHE) NELL INTERFACCIA TERRITORIO AGRICOLO/AMBITI EDIFICATI Monza, EMERLAB 27 maggio 2016 Dr.For.Michele Cereda Inquadramento Area del Pianalto «Mindelliano», caratterizzata
CONDUZIONE AGRICOLA E CRITICITÀ (IDRAULICHE) NELL INTERFACCIA TERRITORIO AGRICOLO/AMBITI EDIFICATI Monza, EMERLAB 27 maggio 2016 Dr.For.Michele Cereda Inquadramento Area del Pianalto «Mindelliano», caratterizzata
Sardegna Ingegneria Scarl
 Sardegna Ingegneria Scarl RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 1. PREMESSA La presente relazione ha come oggetto il censimento e progetto di risoluzione delle interferenze relativamente ai lavori di realizzazione
Sardegna Ingegneria Scarl RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 1. PREMESSA La presente relazione ha come oggetto il censimento e progetto di risoluzione delle interferenze relativamente ai lavori di realizzazione
Economia dell ambiente
 1 Economia dell ambiente Introduzione Elisa Montresor 2008-2009 2 Obiettivi Il corso intende introdurre lo stato dell arte negli studi di economia ambientale. Il suo scopo è di fornire: Alcuni strumenti
1 Economia dell ambiente Introduzione Elisa Montresor 2008-2009 2 Obiettivi Il corso intende introdurre lo stato dell arte negli studi di economia ambientale. Il suo scopo è di fornire: Alcuni strumenti
ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 03 febbraio 2010 pag. 1/8
 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 03 febbraio 2010 pag. 1/8 (SCHEMA) ADDENDUM ALL ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 06.03.2003 E ALL ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO DEL 17.01.2008 STIPULATI
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 03 febbraio 2010 pag. 1/8 (SCHEMA) ADDENDUM ALL ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 06.03.2003 E ALL ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO DEL 17.01.2008 STIPULATI
Editoriale Il Comitatone del 4 novembre 2004
 Editoriale Il Comitatone del 4 novembre 2004 Il 4 novembre scorso si è riunito a Roma, a Palazzo Chigi, il Comitato ex articolo 4, legge n.798/84, il cosiddetto Comitatone che indirizza, coordina e controlla
Editoriale Il Comitatone del 4 novembre 2004 Il 4 novembre scorso si è riunito a Roma, a Palazzo Chigi, il Comitato ex articolo 4, legge n.798/84, il cosiddetto Comitatone che indirizza, coordina e controlla
Piani terra in centro storico
 Piani terra in centro storico di GIULIANO ZANON Ma non era proibito?... Non c è un provvedimento del Comune che lo impedisce?. Non è infrequente trovare chi si Come? stupisca nel constatare che i piani
Piani terra in centro storico di GIULIANO ZANON Ma non era proibito?... Non c è un provvedimento del Comune che lo impedisce?. Non è infrequente trovare chi si Come? stupisca nel constatare che i piani
Il Programma Energetico Comunale e il nuovo Piano Strutturale del Comune di Bologna
 Associazione Nazionale Coordinamento Agende 21 Locali Italiane Seminario Nazionale IL CLIMA DELLE CITTA Città e territori nel cambiamento climatico: esperienze partecipative di mitigazione e adattamento
Associazione Nazionale Coordinamento Agende 21 Locali Italiane Seminario Nazionale IL CLIMA DELLE CITTA Città e territori nel cambiamento climatico: esperienze partecipative di mitigazione e adattamento
Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus
 Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus Articolo 1, comma 2, lettera c) L. Stabilità 2017 Roma, 28 febbraio 2017 28/02/2017 Il Sismabonus come occasione
Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus Articolo 1, comma 2, lettera c) L. Stabilità 2017 Roma, 28 febbraio 2017 28/02/2017 Il Sismabonus come occasione
PROGETTO ANNALI METEO-MAREOGRAFICI
 Contenuto del CD allegato alla TESI di STAGE PROGETTO ANNALI METEO-MAREOGRAFICI 2002-2005 Dr.ssa Daniela Lo Castro CONTENUTO DEL CD Il seguente CD contiene tutte le tabelle elaborate per il Progetto Annali
Contenuto del CD allegato alla TESI di STAGE PROGETTO ANNALI METEO-MAREOGRAFICI 2002-2005 Dr.ssa Daniela Lo Castro CONTENUTO DEL CD Il seguente CD contiene tutte le tabelle elaborate per il Progetto Annali
Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus
 Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus Articolo 1, comma 2, lettera c) L. Stabilità 2017 Roma, 28 febbraio 2017 12/05/2017 Il Sismabonus come occasione
Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus Articolo 1, comma 2, lettera c) L. Stabilità 2017 Roma, 28 febbraio 2017 12/05/2017 Il Sismabonus come occasione
Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia
 Assessorato Ambiente Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia Claudia Ferrari 1,5 milioni di anni fa 20.000 anni fa Durante l ultima fase di espansione glaciale il livello del mare era circa 120
Assessorato Ambiente Origini e trasformazioni della Laguna di Venezia Claudia Ferrari 1,5 milioni di anni fa 20.000 anni fa Durante l ultima fase di espansione glaciale il livello del mare era circa 120
METODOLOGIE PER LA MAPPATURA DELLE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INONDAZIONE
 AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE COMITATO TECNICO REGIONALE CRITERI PER L ELABORAZIONE DEI PIANI DI BACINO METODOLOGIE PER LA MAPPATURA DELLE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INONDAZIONE RACCOMANDAZIONE
AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE COMITATO TECNICO REGIONALE CRITERI PER L ELABORAZIONE DEI PIANI DI BACINO METODOLOGIE PER LA MAPPATURA DELLE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INONDAZIONE RACCOMANDAZIONE
Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico
 Relazione finale dell attività di tirocinio Il consumo del suolo. Anna Maria Antonucci 360074 Tutor: arch. Stefano Merola Regione Lazio - SITR Centro di Ricerca CERI Previsione, Prevenzione e Controllo
Relazione finale dell attività di tirocinio Il consumo del suolo. Anna Maria Antonucci 360074 Tutor: arch. Stefano Merola Regione Lazio - SITR Centro di Ricerca CERI Previsione, Prevenzione e Controllo
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE NORME DI TUTELA IDRAULICA
 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE NORME DI TUTELA IDRAULICA Con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2016 nella seduta del 08/09/2016 è stata approvata la Variante
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE NORME DI TUTELA IDRAULICA Con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2016 nella seduta del 08/09/2016 è stata approvata la Variante
UNITA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA UTEE
 UNITA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA UTEE QUADRO DI SINTESI PRELIMINARE DEI DATI DEL TRIENNIO 2007 2009 PER LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
UNITA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA UTEE QUADRO DI SINTESI PRELIMINARE DEI DATI DEL TRIENNIO 2007 2009 PER LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni marini nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Giuseppe Fragola
 Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni marini nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali Giuseppe Fragola Le Direttive Acque e Alluvioni. II sessione: stato di attuazione e prospettive,
Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni marini nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali Giuseppe Fragola Le Direttive Acque e Alluvioni. II sessione: stato di attuazione e prospettive,
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
 COMUNE DI ISOLA VICENTINA Ufficio: TECNICO PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 19-01-2016 Predisposta da GARELLO VILMA Oggetto: Piano d'azione per l'energia Sostenibile (P.A.E.S.) - Approvazione.
COMUNE DI ISOLA VICENTINA Ufficio: TECNICO PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 19-01-2016 Predisposta da GARELLO VILMA Oggetto: Piano d'azione per l'energia Sostenibile (P.A.E.S.) - Approvazione.
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE. Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
 DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COSTIERE Venezia, 7 Novembre 2014 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Il piano di gestione del rischio alluvioni per i fenomeni
