LO GNOSTICISMO DI GIUSEPPE BARZAGHI 1
|
|
|
- Giulietta Vaccaro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LO GNOSTICISMO DI GIUSEPPE BARZAGHI 1 Il sistema di Barzaghi può essere classificato come una forma di gnosticismo panteista monista non di tipo storicista, come quello hegeliano, ma di tipo eternalista come quello di Severino. Autore: Giovanni Cavalcoli, OP Monsignor Antonio Livi, illustre epistemologo del sapere teologico, in una recente sua opera 2 prende brevemente in esame, tra gli altri Autori, l opera del Padre domenicano Giuseppe Barzaghi, della Facoltà Teologica di Bologna. Poiché conosco molto bene il suo pensiero essendo stato suo collega d insegnamento nella medesima Facoltà, ho pensato di far cosa utile ampliare ed arricchire di più precise informazioni critiche, le note su Barzaghi fatte da Antonio Livi. Al riguardo Antonio Livi ha il merito di prendere in considerazione un caso di falsa teologia, del quale tuttora si parla troppo poco e che purtroppo sta avendo successo; mi auguro quindi che questo suo intervento possa essere ripreso e confermato da altri teologi, nella speranza di poter correggere questo tipo di deviazione teologica. Illustrerò brevemente il quadro generale del pensiero di Giuseppe Barzaghi, nel quale gli errori denunciati da Antonio Livi 1 Per non appesantire l esposizione senza privarla del doveroso rigore scientifico, rimando all ampia e commentata documentazione degli errori di Barzaghi giacente presso la Congregazione per la Dottrina della Fede e reperibile anche presso l autore di questo articolo. 2 Vera e falsa telogia. Come distinguere l autentica scienza della fede da un equivoca filosofia religiosa, Casa Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2012, pp
2 trovano la loro spiegazione di fondo. Prima di farsi Domenicano, Barzaghi si è laureato all Università Cattolica di Milano. È stato allievo di Gustavo Bontadini come lo è stato Emanuele Severino. Si è poi addottorato in teologia alla Pontificia Università San Tommaso di Roma. Lo gnosticismo di Barzaghi appare a partire dal 1997 col libro «Soliloqui sul divino. Meditazioni sul segreto cristiano», Edizioni ESD, mentre in precedenza le sue opere riflettono il pensiero tomista. Questa tendenza gnostica era rimasta allo stato latente, giacchè, come dirò, essa in parte era già stata assorbita durante i suoi studi all Università Cattolica di Milano. Barzaghi infatti assume la visione bontadiniana del rapporto fra pensiero medioevale (San Tommaso) e pensiero moderno (Hegel). Secondo Bontadini il pensiero moderno idealista non contraddice il pensiero medioevale, ma al contrario ne rivela l anima originaria e profonda, che Bontadini s incarica di mettere in evidenza. In questo senso Bontadini, con apparente lode a Tommaso, dice che il pensiero di Tommaso è «più moderno del moderno». Barzaghi, sulla scia di Bontadini, intende proporre una nuova interpretazione della metafisica tomista ispirata al monismo parmenideo mediato da Bontadini e Severino, confondendo in San Tommaso l esse con l ipsum Esse, l essere analogico con l Essere divino. Da qui un tomismo panteista, che è quanto di più opposto si possa immaginare al vero tomismo, che tutti sanno esser basato sul realismo e non sull idealismo. Quanto a Bontadini, egli vede quest anima originaria di San Tommaso nel cogito cartesiano successivamente sviluppato dall 2
3 idealismo tedesco sino a Gentile, del quale Bontadini è stato discepolo, benchè egli abbia cercato di mitigarne l idealismo. Resta tuttavia in Bontadini l identificazione dell essere col pensiero, che è il dogma fondamentale dell idealismo Su ciò si basa la dottrina bontadiniana della «Unità dell Esperienza», che non è esperienza sensibile, ma esperienza dell essere. Nulla è presupposto al pensiero, l essere è immanente al pensiero, il quale è intrascendibile. Queste idee si ritrovano in Barzaghi. Seguendo Bontadini, Barzaghi sostiene così che non si dà essere non pensato, perché nel momento in cui lo penso, diventa pensato. Seguendo invece il Bontadini, Barzaghi interpreta la gnoseologia e la metafisica dell Aquinate in senso hegeliano-severiniano, con la mediazione di Giovanni Gentile, maestro del Bontadini. In questa visuale il punto di partenza del pensiero è identico al punto di partenza dell essere. Barzaghi interpreta in senso idealistico l assioma aristotelico-tomista secondo il quale nell atto del conoscere «anima est quodammodo omnia», applicandolo sul piano dell essere: ne risulta che l anima è ontologicamente tutto, ossia, in ultima analisi, Dio, come nella filosofia indiana. Come per Severino anche per Barzaghi non esiste un vero progresso nella conoscenza della verità, ma la verità o la si conosce tutta intera sin dall inizio o non la si conosce, e questo sempre in nome della sua metafisica parmenidea, per la quale o l essere è il Tutto, o non c è nulla. Nessuna molteplicità, ma tutto è Uno. Nessun passaggio dalla potenza all atto, ma tutto è atto. Non esiste contingente, ma tutto è necessario. Non c è via di mezzo: nessuna idea di partecipazione o di similitudine o di analogia. Il progres- 3
4 so non è altro che lo svolgimento concettuale di quanto il pensiero coglie originariamente e preconcettualmente nella sua totalità. Falsificazione del pensiero di San Tommaso Sappiamo come invece ben diverso è il punto di vista di San Tommaso. Per l Aquinate Dio non è il primum cognitum se non riguardo alla stessa scienza divina. Il punto di partenza del nostro conoscere non è l Ipsum Esse, ma sta nell esperienza sensibile, per la quale l intelletto coglie la quidditas rei materialis, dalla quale successivamente si può ricavare l affermazione dell esistenza dell Ipsum Esse, cioè di Dio, applicando il principio di causalità. L Ipsum Esse, per l Aquinate, è il punto di partenza dell essere, ma non del conoscere. Da Dio Ipsum Esse, infatti, proviene l ente causato, analogo e per partecipazione, ossia il mondo, fuori di Dio, distinto da Dio, al di sotto di Dio e creato da Dio dal nulla, sì che il tempo di questo mondo ha un inizio e una fine. Per Barzaghi, invece, che qui segue Severino, il tempo è mera apparenza. «Il tempo non esiste». Da qui egli trae la conseguenza che «tutto è adesso», che non esiste un «prima» dell inizio del tempo e che la risurrezione non è futura ma è già adesso nell istante nella morte. Sempre influenzato dall idea severiniana dell essere, Barzaghi attribuisce anche a San Tommaso la tesi secondo la quale l essere «non può non essere», ossia che non esiste il contingente, ma l essere, oggetto di un esperienza originaria preconcettuale, è necessario, uno, unico, univoco, eterno, infinito ed assoluto. Non si 4
5 vede, osservo io, come questo «essere» dovrebbe distinguersi da Dio. E di fatti per Barzaghi «solo Dio esiste», per cui il mondo non è fuori di Dio, ma «in Dio». Ma non in Dio nel senso paolino dell in ipso sumus, ma proprio nel senso panteistico che Dio è l essere degli enti. Gli enti non sono che un «apparire», una «teofania» di questo unico «essere», il solo vero essere. Questa esperienza apriorica dell essere è poi «condizione di possibilità dell esperienza», dalla quale l intelletto umano ricaverebbe la conoscenza delle cose e della stessa esistenza di Dio. Ma dovrebbe esser chiaro che questo «essere» non è per nulla il vero esse tomistico, il quale invece è affermato dall intelletto non in forza di una simplex apprehensio o un «autocoscienza» cartesiana, ma nell atto del giudizio, sulla base di una precedente concezione dell ens come id quod habet esse. L esse tomistico, dunque, da Barzaghi non è fatto risalire ad Aristotele o al realismo biblico, ma a Parmenide, col suo caratteristico principio di non contraddizione: «l essere è, il non essere non è», fondamento dell univocità dell essere e quindi del principio i- dealistico già espresso dallo stesso Parmenide: «La stessa cosa è l essere e il pensare» (to autòn to einai kai to noèin). «Il nulla non esiste», per cui non ha senso parlare di una creazione dal nulla, ma la creazione non è altro che la «dipendenza» degli enti da Dio nel senso che ne sono la sua «teofania». Nessun passaggio dal non essere all essere, ma solo manifestazione dell Essere, che poi è Dio. Osserviamo invece che la dipendenza da Dio non è l atto dell esser creato, ma è lo stato di creatura, che consegue all esser creato, perché l esser creato è effetto di causalità efficiente, men- 5
6 tre la dipendenza si aggiunge come accidente alla sostanza della creatura 3. Si potrebbe dire che è giusto collegare l Ipsum Esse (Dio) a Parmenide, perché l essere di Parmenide è più vicino di quello di Aristotele al Nome del Dio Biblico (Es 3,14), ma lo sbaglio di Barzaghi è l impostazione monistica ed univocistica che confonde l ens ut ens tomistico, analogo e partecipativo (ens in communi vel universale), con l Ipsum Esse, ossia confonde l ente della metafisica con l ente teologico, Dio stesso. L esse tomistico non è univoco ma analogico, ed è sussistente solo in Dio, atto puro di essere. Barzaghi invece ritiene che l esse tomistico originario, rintracciabile in Severino, sia univoco, mentre l esse analogico del tomismo tradizionale sarebbe solo derivato, così come l umano deriva dal divino. Il metodo tipico degli idealisti Il pensiero per Barzaghi, secondo il metodo caratteristico degli i- dealisti, si pone su due piani, potremmo dire due registri : un piano originario, di tipo monistico, che va scoperto per mezzo della filosofia (ossia del cogito), nel puro pensiero, che egli chiama il «punto di vista di Dio» o lo «sguardo di Dio», corrispondente alla gnoseologia idealistica. È il piano trascendentale, piano della 3 Infatti, come insegna San Tommaso, «creatio in creatura» ossia l esser creato come stato della creatura «non est nisi relatio quaedam ad Creatorem, ut ad principium sui esse», Sum.Theol., I, q.45,.3. Ora la relazione è un accidente della creatura. 6
7 verità. Barzaghi poi confonde questo «punto di vista» idealistico con la fede. E si dà un piano derivato, quello dell analogia e della molteplicità, corrispondente all ordinario senso comune non elevato alla filosofia, piano dell apparenza o dell apparire, proprio della gnoseologia realista, relativo alla lettera del pensiero di San Tommaso e della stessa Sacra Scrittura, e che corrisponde a quello che Barzaghi chiama «punto di vista psicologico» o piano «categoriale». Su questo piano le cose sembrano altre dall io e fuori dell io, contingenti, spaziali e temporali; sennonché però, se ci poniamo «dal punto di vista di Dio», che non è quello del semplice pensare comune, ma è quello della vera sapienza, qui Barzaghi ama rifarsi al vedere sub specie aeternitatis di Spinoza, e allora qui le cose appaiono una cosa sola, eterne, immanenti all io, sostanzialmente i- dentiche all io nell unità dell essere, un io che non è più l io empirico, ma l io trascendentale, momento a sua volta dell Io assoluto. Anche l affermazione realistica, secondo la quale la realtà è esterna al pensiero, è un pensato, per cui Barzaghi pensa di poterla riassorbire nel suo idealismo, sempre nel suo presupposto dell identificazione del pensiero con l essere. L univocità dell essere porta dunque Barzaghi a interpretare San Tommaso in senso panteistico: come esiste un unico e solo essere, l essere che non può non essere, in nome dello stesso principio di non-contraddizione, che esclude l esistenza del non-essere (il non-essere non può essere), così esiste un unico e solo Dio. 7
8 E qui sembrerebbe assicurato il monoteismo. Senonchè però per Barzaghi il monoteismo vuol dire che esiste solo Dio, tutto è in Dio e non c è nulla fuori di lui. Quindi egli non si accontenta di dire che non c è altro Dio al di fuori di Lui, ma afferma che non c è nulla al di fuori di Lui. Quindi non solo c è un solo Dio, ma c è solo Dio. Per Barzaghi Dio crea il mondo non dal nulla, ma dalla sua essenza e nella sua essenza. Quindi l atto creativo non è productio de nihilo, ma è teofania divina, sicchè non si vede come sia garantita la distinzione fra Dio e il mondo. Barzaghi riconduce la creazione non alla causa efficiente, che può essere trascendente, ma alla causa formale, la quale è evidentemente immanente all ente (qui il mondo), del quale è forma. Barzaghi dice esplicitamente che «Dio non è trascendente, ma immanente». Dio è un pensato. Ma il pensato è in me. E dunque Dio non è al di sopra di me. Come per Severino, la creazione non è passaggio dal possibile al reale o dal non-essere all essere o produzione dell essere dal nulla, perché ciò offenderebbe il principio di non-contraddizione, ma è determinazione ed apparire del puro Esse divino. Nulla esiste di possibile, ma tutto è reale ed attuato. Il panteismo Quindi, sotto pretesto che Dio è tutto e che nulla si può aggiungere a Dio, il mondo per Barzaghi non esiste realmente distinto da Dio e fuori di Dio. Il mondo sì esiste, con la molteplicità e il divenire, col suo misto di affermazione e negazione, essere e non essere, vero e falso, bene e male. Ma esiste solo in Dio. Da qui la conseguenza terrificante che affermazione e negazione (la dialetti- 8
9 ca ), essere e non essere, vero e falso, bene e male esistono anche in Dio. Per questo Barzaghi in un recente libro dice che Dio non toglie la sofferenza, ma esiste accanto alla sofferenza, giacchè in Dio stesso c è la sofferenza. Dunque, per Barzaghi, alla faccia del suo monismo apparentemente ottimistico, gli opposti si richiamano a vicenda, sono necessari, logici e divini, come in Hegel. L affermazione in Dio non toglie la negazione, il vero non toglie il falso, il male non toglie il bene. Ma tutto è necessariamente e logicamente collegato, tutto è essere, tutto è vero, tutto è bene, come in Spinoza, per il quale Barzaghi non nasconde la sua ammirazione. Nella visuale di Barzaghi, dove tutto è essere, il male come privatio, come stèresis, ossia come carenza di essere, non può esistere. Se di male si vuol parlare, anch esso è nell orizzonte dell essere, come momento della divisione dell unità 4 e della distinzione fra le cose o, per esprimerci in termini hegeliani, come momento dell antitesi preparatorio alla sintesi. Il male dunque è una divisione dell unità originaria divina, per cui l unità divina ricongiunge gli elementi dispersi, li chiama a se stessa per ricomporre se stessa. Il male dunque non è qualcosa di ripugnante, che debba o possa essere tolto, ma è un ingrediente logico e necessario dell unità e della totalità. Voler togliere il male sarebbe come voler eliminare la distinzione fra le cose. Per questo, per Barzaghi la Redenzione, come egli dice espressamente con un accento di ironia, 4 Idee del genere, che ho esposto in un recente articolo sull Isola di Patmos [vedere QUI], le si può trovare anche nel Card. Giacomo Biffi, che del resto è un ammiratore di Giuseppe Barzaghi: vedi la prefazione che ha fatto al libro di Barzaghi Lo sguardo di Dio, Cantagalli, Siena
10 non è una riparazione, ma semplicemente un apparizione di Dio in Cristo e nell uomo. Dio non salva dal male, ma salva nel male. Come in ogni visione dialettico-panteista, non esiste l amore nel mondo di Barzaghi. Nel mondo dell unità assoluta non può esistere la dualità. Ora, per amarsi, bisogna essere in due. Oppure c è il conflitto, perchè distinguere per l idealista vuol dire opporre. Sicché, in conclusione, nei sistemi dell univocità, dove manca l analogia, non esistono l armonia, la diversità e la reciprocità, ma per sua essenza ogni cosa, essendo tutto, o si confonde con l altra nell unità assoluta o se è distinta, è contro l altra, perché un assoluto non può tollerare un altro assoluto, ed è in opposizione dialettica, perché la distinzione, che è opposizione, è il principio del male. Quindi c è solo o la confusione o l antagonismo, il conflitto e l esclusione reciproca. Accanto al mio io non c è posto per altri io. O per lo meno gli altri devono essere approvati da me. O ti i- dentifichi con me, o sparisci. Homo homini lupus. Non esiste per Barzaghi fuori di Dio una vera molteplicità, ma tutto è uno in Dio, tanto che per sua espressa dichiarazione se fosse soppresso un solo elemento del tutto, il tutto sarebbe negato, così come la negazione di un attributo divino comporterebbe la negazione di tutti gli altri. Molteplicità, divenire, spazio, tempo, materia, generazione e corruzione, nulla, falso, male sono mere apparenze, punti di vista psicologici, che, per apprezzarne il valore, vanno considerati sub specie aeternitatis o con lo «sguardo di Dio» e così hanno la loro necessità in Dio o sono apparizioni di Dio. 10
11 Certo se ne può parlare alla maniera ordinaria e realistica di San Tommaso e del dogma cattolico. Ma qui siamo sul piano antropomorfico, derivato, delle apparenze ordinarie, non sul piano originario e speculativo del pensiero e della pura scienza, che a questo punto appare come vera gnosi. Occorre dunque per Barzaghi superare l immaginario popolare e la ingenua rappresentazione realistica e raggiungere con un atto di autocoscienza e critico, di elevazione del pensiero, l assoluto del Pensiero e della Coscienza. Così Barzaghi parla della necessità di andare «oltre Dio» 5 per raggiungere l Assoluto. I dogmi della creazione, del peccato, della Trinità, dell Incarnazione, della Redenzione e della grazia sono figure o metafore della Verità assoluta che sconfinano nella mitologia, benchè utili per l educazione del popolo. Sono figure del pensiero ordinario, come tali normali e doverose, ma non corrispondono alla scienza suprema del puro Intellegibile e del puro Pensiero. Il linguaggio della Chiesa, della liturgia e del dogma non supera questo piano inferiore del pensiero e dello stesso linguaggio. Per Barzaghi il mondo è semplice negazione dialettica dell infinito, secondo il principio di Spinoza: omnis determinatio est negatio (infiniti). Il mondo è o una «finitizzazione di Dio» o una semplice «esplicazione» di Dio, come nel Cusano. E l «apparire degli eterni», come in Severino. Questo concetto di creazione, che esclude che l essere possa avere inizio e fine, porta come conseguenza, per quanto riguarda il dogma dell Incarnazione, che Barzaghi fa propria la tesi di Severi- 5 Questo è il titolo di uno dei suoi libri. 11
12 no secondo la quale l umanità di Cristo non ha avuto inizio e fine nel tempo, ossia nella storia (concepimento e morte di Cristo), ma, come si esprime lo stesso Severino, essa non è che l apparire nel mondo di un «Incarnazione» che esiste ab aeterno: «il Verbo che è eternamente presso la carne è entrato nell apparire» 6. Per Barzaghi, l uomo non è un animale razionale, se non sul piano del sapere empirico ordinario (vedi l antropologia tomista), ma nella sua essenza profonda, che è la vera concezione cristiana dell uomo, l uomo è «l eterno sguardo di Dio col quale Dio contempla se stesso». Per questo, come in Eckhart, «lo sguardo col quale il sapiente guarda Dio è lo stesso sguardo col quale Dio guarda l uomo». Per Barzaghi il peccato è sì una negazione, ma non si pone sul piano di un non-essere esterno a Dio, perché non esiste nulla di esterno a Dio, ma si pone sul piano dell unica esistenza del nonessere che è quella interna a Dio. Quindi il male ha origine da Dio, e sostanzialmente il male è bene, se non altro come relativo al bene, giacchè Dio è bontà infinita. Da qui il fatto che la redenzione e la misericordia divine non vanno intese come espiazione e liberazione dal male e dalla sofferenza, ma come Dio che vede il male come bene e «sta accanto alla sofferenza». Occorre avere lo «sguardo di Dio sulla sofferenza», in quanto Dio la vede come un bene ed Egli stesso soffre. Come in Rahner, la grazia non è dono di Dio, creato da Dio, ma è Dio stesso, sicchè il cristiano si identifica con Cristo ossia con Dio, similmente alla concezione di Eckhart e di Rahner. La natura 6 Barzaghi appoggia questa concezione su di una falsa traduzione di Ap 13,8, secondo cui «L Agnello è immolato sin dalla fondazione del mondo». 12
13 umana non è un ente realmente distinto da un altro ente, l ente divino, ma è semplicemente l apparire di Dio. Tutti sono già salvi adesso e radicati in Dio, anche se peccatori (simul iustus et peccator) o, come dice Barzaghi con una delle sue caratteristiche frasi icastiche: «Tutto è adesso». O come recita il sottotitolo di un suo libro: omnia in omnibus. «Tutto è in tutto», «Tutto è bene così com è»: il problema è solo quello di rendersi conto di ciò. Visione spinozistica. Il sistema di Barzaghi può essere classificato come una forma di gnosticismo panteista monista non di tipo storicista, come quello hegeliano, ma di tipo eternalista come quello di Severino. In questo sistema infatti c è il principio fondamentale dello gnosticismo, che è l orientamento del pensiero non verso l essere come altro dal pensiero, per adeguarsi - adaequatio all essere, ma il pensiero è inteso esso stesso come ipsum esse, così come l essere è pensiero, per cui si dà il ritorno del pensiero su se stesso a causa della risoluzione dell essere nell essere pensato esse est percipi. Il pensiero gira su se stesso autonomamente dalla realtà. In queste condizioni la fede dogmatica col suo timbro realista evidentemente perde di senso. Tutt al più resta un punto di vista psicologico, ma non si eleva alla scienza suprema del sapiente o, come ama dire Barzaghi, del genio ; per cui viene sostituita con una ragione o con la coscienza dell Io trascendentale, ultima conseguenza del cogito cartesiano, che avoca a sé l infinità del sapere divino. E questo è appunto lo gnosticismo. 13
14 L etica che discende da questo pensiero evidentemente intende la libertà come assoluta ed autofondata, libera da qualunque legge che non sia la volontà dell individuo, ovvero come divina necessità, indipendente da un Dio trascendente, così come il pensiero assurge all assolutezza del pensiero divino. Se il genio mantiene l osservanza di un codice morale onesto e cristiano, lo fa solo per accondiscendenza o convenienza e per mantenersi su quel piano ordinario e parziale del punto di vista psicologico, dal quale il genio si eleva per sollevarsi al piano divino dell Intero o del puro pensiero. Varazze, 15 agosto 2012 Solennità di Maria Santissima Assunta Copyright Giovanni Cavalcoli, OP L Isola di Patmos 31 agosto 2015 Per riprodurre questo articolo rivolgersi a isoladipatmos@gmail.com 14
Spinoza e il Male. Saitta Francesco
 Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
Spinoza e il Male di Saitta Francesco La genealogia del male è sempre stato uno dei problemi più discussi nella storia della filosofia. Trovare le origini del male è sempre stato l oggetto principale di
Cap. 1 PUSC. Giulio Maspero I anno, I sem (ver. 2006-7)
 Cap. 1 1) Qual è il trattato più importante del mondo? 2) Perché questa disciplina ha subito un eclissi? 3) Perché si parla di Mistero della Trinità? Si può capire la Trinità? Cos è l apofatismo? 4) Cosa
Cap. 1 1) Qual è il trattato più importante del mondo? 2) Perché questa disciplina ha subito un eclissi? 3) Perché si parla di Mistero della Trinità? Si può capire la Trinità? Cos è l apofatismo? 4) Cosa
COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE.
 COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE. UNA METAFORA PER SPIEGARE I DSA La psicologa americana ANIA SIWEK ha sviluppato in anni di pratica professionale un modo semplice ed efficace di spiegare i DSA ai bambini,
COME PARLARE DI DISLESSIA IN CLASSE. UNA METAFORA PER SPIEGARE I DSA La psicologa americana ANIA SIWEK ha sviluppato in anni di pratica professionale un modo semplice ed efficace di spiegare i DSA ai bambini,
Scopri il piano di Dio: Pace e vita
 Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
Scopri il piano di : Pace e vita E intenzione di avere per noi una vita felice qui e adesso. Perché la maggior parte delle persone non conosce questa vita vera? ama la gente e ama te! Vuole che tu sperimenti
VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013
 VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013 1. VANGELO SECONDO GIOVANNI LEZIONE DEL 21-09-2012 ARGOMENTI: a. Introduzione al corso; i. Il Vangelo di Giovanni parla di che cos
VANGELO SECONDO GIOVANNI PROF. CARLO RUSCONI ANNO ACCADEMICO 2012-2013 1. VANGELO SECONDO GIOVANNI LEZIONE DEL 21-09-2012 ARGOMENTI: a. Introduzione al corso; i. Il Vangelo di Giovanni parla di che cos
Teorie Etiche - Kant
 Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
Teorie Etiche - Kant Gianluigi Bellin January 27, 2014 Tratto dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy online alle voce Kant s Moral Philosophy. La filosofia morale di Immanuel Kant Immanuel Kant, visse
Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma
 Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma LA COPPIA NON PUO FARE A MENO DI RICONOSCERE E ACCETTARE CHE L ALTRO E UN TU E COME TALE RAPPRESENTA NON UN OGGETTO DA MANIPOLARE
Alessandro Ricci Psicologo Psicoterapeuta Università Salesiana di Roma LA COPPIA NON PUO FARE A MENO DI RICONOSCERE E ACCETTARE CHE L ALTRO E UN TU E COME TALE RAPPRESENTA NON UN OGGETTO DA MANIPOLARE
AUTOREGOLAZIONE PER IL COMPITO
 B5 queste schede ti aiuteranno a scoprire quanto sia utile autointerrogarsi e autovalutarsi potrai renderti conto di quanto sia utile porsi domande per verificare la propria preparazione se ti eserciterai
B5 queste schede ti aiuteranno a scoprire quanto sia utile autointerrogarsi e autovalutarsi potrai renderti conto di quanto sia utile porsi domande per verificare la propria preparazione se ti eserciterai
La ricerca empirica in educazione
 La ricerca empirica in educazione Alberto Fornasari Docente di Pedagogia Sperimentale Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Il ricercatore ha il compito di trovare relazioni
La ricerca empirica in educazione Alberto Fornasari Docente di Pedagogia Sperimentale Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Il ricercatore ha il compito di trovare relazioni
#Essere umani. Scuola Statale Primaria di Foglizzo Istituto Comprensivo di Montanaro (To)
 #Essere umani Progetto realizzato dall insegnante di Religione Cattolica Elsa Feira con la collaborazione delle docenti Donatella Gravante, Dolores Chiantaretto, Daniela Milanaccio, Paola Racca. Scuola
#Essere umani Progetto realizzato dall insegnante di Religione Cattolica Elsa Feira con la collaborazione delle docenti Donatella Gravante, Dolores Chiantaretto, Daniela Milanaccio, Paola Racca. Scuola
Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI. la persona
 Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI la persona 2012 Edizioni ART Titolo originale dell opera Explícame la persona 2ª edizione 2012 Via dei Del Balzo, 10-00165 ROMA Tel. 06 66 52 77 84 Fax 06 66 52 79 07 E- mail:
Ramón Lucas Lucas SPIEGAMI la persona 2012 Edizioni ART Titolo originale dell opera Explícame la persona 2ª edizione 2012 Via dei Del Balzo, 10-00165 ROMA Tel. 06 66 52 77 84 Fax 06 66 52 79 07 E- mail:
Qui cade sua altezza
 Qui cade sua altezza Silvia Sbaragli N.R.D. Bologna DFA, SUPSI Locarno (Svizzera) Pubblicato in: Sbaragli S. (2010). Qui cade sua altezza. La Vita Scolastica. 18, 25-27. Nell insegnamento della matematica
Qui cade sua altezza Silvia Sbaragli N.R.D. Bologna DFA, SUPSI Locarno (Svizzera) Pubblicato in: Sbaragli S. (2010). Qui cade sua altezza. La Vita Scolastica. 18, 25-27. Nell insegnamento della matematica
a. Legga questo primo brano e scelga il titolo corretto tra i tre proposti: Una parola chiave non comune di questo primo brano è speculazione.
 Recupero TVI per matricole straniere a.a. 2010-11 Rosella Bozzone Costa - Lingua Italiana (13049 e 92020) Materiale 1c PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA TEST D INGRESSO CHIAVI E PRIMI ESERCIZI a. Legga questo
Recupero TVI per matricole straniere a.a. 2010-11 Rosella Bozzone Costa - Lingua Italiana (13049 e 92020) Materiale 1c PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA TEST D INGRESSO CHIAVI E PRIMI ESERCIZI a. Legga questo
Rappresentare i nessi logici con gli insiemi
 Rappresentare i nessi logici con gli insiemi È un operazione molto utile in quesiti come quello nell Esempio 1, in cui gruppi di persone o cose vengono distinti in base a delle loro proprietà. Un elemento
Rappresentare i nessi logici con gli insiemi È un operazione molto utile in quesiti come quello nell Esempio 1, in cui gruppi di persone o cose vengono distinti in base a delle loro proprietà. Un elemento
Siamo così arrivati all aritmetica modulare, ma anche a individuare alcuni aspetti di come funziona l aritmetica del calcolatore come vedremo.
 DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti
Claudio Bencivenga IL PINGUINO
 Claudio Bencivenga IL PINGUINO 1 by Claudio Bencivenga tutti i diritti riservati 2 a mia Madre che mi raccontò la storia del pignuino Nino a Barbara che mi aiuta sempre in tutto 3 4 1. IL PINGUINO C era
Claudio Bencivenga IL PINGUINO 1 by Claudio Bencivenga tutti i diritti riservati 2 a mia Madre che mi raccontò la storia del pignuino Nino a Barbara che mi aiuta sempre in tutto 3 4 1. IL PINGUINO C era
MANIFESTO DELLA VITA
 Leonardo da Vinci L annunciazione MANIFESTO DELLA VITA Dedicato a Sua Santità Giovanni Paolo II Dove si deduce come non sia intelligenza della realtà e sia negazione di un Dio creatore e del bene dell
Leonardo da Vinci L annunciazione MANIFESTO DELLA VITA Dedicato a Sua Santità Giovanni Paolo II Dove si deduce come non sia intelligenza della realtà e sia negazione di un Dio creatore e del bene dell
Programma di Filosofia della classe 4 A a.s. 2012/13
 Liceo Scientifico di Stato G. BATTAGLINI 74100 TARANTO C.so Umberto I,106 Programma di Filosofia della classe 4 A a.s. 2012/13 Testo in adozione: Abbagnano Fornero La ricerca del pensiero, 2B, Paravia
Liceo Scientifico di Stato G. BATTAGLINI 74100 TARANTO C.so Umberto I,106 Programma di Filosofia della classe 4 A a.s. 2012/13 Testo in adozione: Abbagnano Fornero La ricerca del pensiero, 2B, Paravia
I libri di testo. Carlo Tarsitani
 I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA FINESTRA INTERCULTURALE
Capitolo 2. Operazione di limite
 Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A
COMUNICAZIONE E ASCOLTO NELLA COPPIA
 COMUNICAZIONE E ASCOLTO NELLA COPPIA Comunicare vuol dire scambiare informazioni legate a fatti o ad emozioni personali con un'altra persona. La vera comunicazione avviene quando uno riceve il messaggio
COMUNICAZIONE E ASCOLTO NELLA COPPIA Comunicare vuol dire scambiare informazioni legate a fatti o ad emozioni personali con un'altra persona. La vera comunicazione avviene quando uno riceve il messaggio
CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI
 CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI 1. Vai a visitare un cliente ma non lo chiudi nonostante tu gli abbia fatto una buona offerta. Che cosa fai? Ti consideri causa e guardi
CORSO VENDITE LIVELLO BASE ESERCIZIO PER L ACQUISIZIONE DEI DATI 1. Vai a visitare un cliente ma non lo chiudi nonostante tu gli abbia fatto una buona offerta. Che cosa fai? Ti consideri causa e guardi
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE
 LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
LE SUCCESSIONI 1. COS E UNA SUCCESSIONE La sequenza costituisce un esempio di SUCCESSIONE. Ecco un altro esempio di successione: Una successione è dunque una sequenza infinita di numeri reali (ma potrebbe
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
 CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
CONSIGLI PER POTENZIARE L APPRENDIMENTO DELLA LINGUA Possiamo descrivere le strategie di apprendimento di una lingua straniera come traguardi che uno studente si pone per misurare i progressi nell apprendimento
LA BIBBIA. composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18
 GRUPPOQUINTAELEMENTARE Scheda 02 LA La Parola di Dio scritta per gli uomini di tutti i tempi Antico Testamento composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18 Nuovo
GRUPPOQUINTAELEMENTARE Scheda 02 LA La Parola di Dio scritta per gli uomini di tutti i tempi Antico Testamento composto da 46 libri, suddivisi in Pentateuco Storici Sapienziali Profetici 5 16 7 18 Nuovo
PROMUOVERSI MEDIANTE INTERNET di Riccardo Polesel. 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15
 Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
Indice Introduzione pag. 9 Ringraziamenti» 13 1. Promuovere il vostro business: scrivere e gestire i contenuti online» 15 1. I contenuti curati, interessanti e utili aiutano il business» 15 2. Le aziende
Roberto Farnè Università di Bologna
 Roberto Farnè Università di Bologna Ora l apertura della parte scientifica a questi lavori, per capire innanzitutto il senso di questo appuntamento. Non abbiamo bisogno, nessuno di noi credo abbia bisogno
Roberto Farnè Università di Bologna Ora l apertura della parte scientifica a questi lavori, per capire innanzitutto il senso di questo appuntamento. Non abbiamo bisogno, nessuno di noi credo abbia bisogno
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Università di Genova MATEMATICA Il
 Lezione 5:10 Marzo 2003 SPAZIO E GEOMETRIA VERBALE (a cura di Elisabetta Contardo e Elisabetta Pronsati) Esercitazione su F5.1 P: sarebbe ottimale a livello di scuola dell obbligo, fornire dei concetti
Lezione 5:10 Marzo 2003 SPAZIO E GEOMETRIA VERBALE (a cura di Elisabetta Contardo e Elisabetta Pronsati) Esercitazione su F5.1 P: sarebbe ottimale a livello di scuola dell obbligo, fornire dei concetti
Esercizi su. Funzioni
 Esercizi su Funzioni ๒ Varie Tracce extra Sul sito del corso ๓ Esercizi funz_max.cc funz_fattoriale.cc ๔ Documentazione Il codice va documentato (commentato) Leggibilità Riduzione degli errori Manutenibilità
Esercizi su Funzioni ๒ Varie Tracce extra Sul sito del corso ๓ Esercizi funz_max.cc funz_fattoriale.cc ๔ Documentazione Il codice va documentato (commentato) Leggibilità Riduzione degli errori Manutenibilità
LE STRATEGIE DI COPING
 Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
Il concetto di coping, che può essere tradotto con fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, capacità di risolvere i problemi, indica l insieme di strategie mentali e comportamentali che sono
FINESTRE INTERCULTURALI
 Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
Scuola Classe 1C FINESTRE INTERCULTURALI DIARIO DI BORDO 2013 / 2014 IC Gandhi - Secondaria di primo grado Paolo Uccello Insegnante / materia Anelia Cassai/lettere Data Febbraio Durata 4h TITOLO DELLA
Ciao, intanto grazie per essere arrivato/a fin qui.
 2 Ciao, intanto grazie per essere arrivato/a fin qui. Probabilmente ti stai chiedendo se posso aiutarti, la risposta è sì se: vuoi raccontare qualcosa di te o di quello che fai; vuoi dei testi che descrivano
2 Ciao, intanto grazie per essere arrivato/a fin qui. Probabilmente ti stai chiedendo se posso aiutarti, la risposta è sì se: vuoi raccontare qualcosa di te o di quello che fai; vuoi dei testi che descrivano
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 1^ - sez. B
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 1^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 1^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
Anno 2004/2005 CORSO SNES-CSI PER FORMATORI. Bologna, 3 dicembre 2005. Lara Rossin
 Anno 2004/2005 LA FIGURA DEL FORMATORE CSI -LE SUE PECULIARITÀ E LA SUA MISSION- CORSO SNES-CSI PER FORMATORI Bologna, 3 dicembre 2005 Lara Rossin 1 INTRODUZIONE Non si insegna e non si può insegnare,
Anno 2004/2005 LA FIGURA DEL FORMATORE CSI -LE SUE PECULIARITÀ E LA SUA MISSION- CORSO SNES-CSI PER FORMATORI Bologna, 3 dicembre 2005 Lara Rossin 1 INTRODUZIONE Non si insegna e non si può insegnare,
FARE O ESSERE VOLONTARI?
 Corso di formazione FARE O ESSERE VOLONTARI? Il volontariato come manifestazione dell essere e dell operare a favore dell altro Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai via San Bernardino 4 20122 Milano
Corso di formazione FARE O ESSERE VOLONTARI? Il volontariato come manifestazione dell essere e dell operare a favore dell altro Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai via San Bernardino 4 20122 Milano
LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE
 Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una
IT Questionario per formatori di insegnanti di lingue Analisi dei dati
 IT Questionario per formatori di insegnanti di lingue Analisi dei dati Tu 1. Al questionario hanno risposto sette formatori di insegnanti di lingue. 2. Sei formatori parlano l inglese, sei il francese,
IT Questionario per formatori di insegnanti di lingue Analisi dei dati Tu 1. Al questionario hanno risposto sette formatori di insegnanti di lingue. 2. Sei formatori parlano l inglese, sei il francese,
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO. VERZINI-ZANARINI-STAGNOLI «Società da capire, società da agire»
 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO VERZINI-ZANARINI-STAGNOLI «Società da capire, società da agire» DISTINGUIAMO: PSICOLOGIA DELL ETA EVOLUTIVA SEGUE LE FASI DI CRESCITA DELL INDIVIDUO FINO ALLA MATURAZIONE BIOLOGICA
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO VERZINI-ZANARINI-STAGNOLI «Società da capire, società da agire» DISTINGUIAMO: PSICOLOGIA DELL ETA EVOLUTIVA SEGUE LE FASI DI CRESCITA DELL INDIVIDUO FINO ALLA MATURAZIONE BIOLOGICA
La firma digitale. Autore: Monica Mascia
 La firma digitale Università degli studi di Cagliari Facoltà di giurisprudenza Diritto privato dell informatica A.A. 2006/2007 Docenti: prof. Bruno Troisi Dott. Massimo Farina Autore: Monica Mascia Che
La firma digitale Università degli studi di Cagliari Facoltà di giurisprudenza Diritto privato dell informatica A.A. 2006/2007 Docenti: prof. Bruno Troisi Dott. Massimo Farina Autore: Monica Mascia Che
Voci dall infinito. richiami per l Anima
 Voci dall infinito richiami per l Anima Copertina di Rocco Vassallo. Disegni di Mario G. Galleano. Mario Giovanni Galleano VOCI DALL INFINITO richiami per l Anima www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
Voci dall infinito richiami per l Anima Copertina di Rocco Vassallo. Disegni di Mario G. Galleano. Mario Giovanni Galleano VOCI DALL INFINITO richiami per l Anima www.booksprintedizioni.it Copyright 2013
IL MODELLO CICLICO BATTLEPLAN
 www.previsioniborsa.net 3 Lezione METODO CICLICO IL MODELLO CICLICO BATTLEPLAN Questo modello ciclico teorico (vedi figura sotto) ci serve per pianificare la nostra operativita e prevedere quando il mercato
www.previsioniborsa.net 3 Lezione METODO CICLICO IL MODELLO CICLICO BATTLEPLAN Questo modello ciclico teorico (vedi figura sotto) ci serve per pianificare la nostra operativita e prevedere quando il mercato
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA
 PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
PROCESSO DI INDICIZZAZIONE SEMANTICA INDIVIDUAZIONE DEI TEMI/CONCETTI SELEZIONE DEI TEMI/CONCETTI ESPRESSIONE DEI CONCETTI NEL LINGUAGGIO DI INDICIZZAZIONE TIPI DI INDICIZZAZIONE SOMMARIZZAZIONE INDICIZZAZIONE
Cartella: L esperienza del contare. Attività: CONTIAMO I FAGIOLI
 Cartella: L esperienza del contare Attività: CONTIAMO I FAGIOLI www.quadernoaquadretti.it Attività testata da Martina Carola (Gruppo di ricerca sulla scuola primaria del Seminario di Didattica della Matematica
Cartella: L esperienza del contare Attività: CONTIAMO I FAGIOLI www.quadernoaquadretti.it Attività testata da Martina Carola (Gruppo di ricerca sulla scuola primaria del Seminario di Didattica della Matematica
Programma di Filosofia
 Programma di Filosofia Anno Scolastico 2013/2014 Sede Liceo scientifico Fabio Besta, Orte Docente Antonella Bassanelli Classe IV B Umanesimo e Rinascimento Capitolo 1: Coordinate storico sociali e concetti
Programma di Filosofia Anno Scolastico 2013/2014 Sede Liceo scientifico Fabio Besta, Orte Docente Antonella Bassanelli Classe IV B Umanesimo e Rinascimento Capitolo 1: Coordinate storico sociali e concetti
NOTE. ARTE E CONTEMPLAZIONE 1 di Santino Cavaciuti
 ARTE E CONTEMPLAZIONE 1 di Santino Cavaciuti Uno dei caratteri fondamentali dell arte è quello di essere contemplativa, distinguendosi, in tal modo, da ciò che è attivo, nel senso, quest ultimo, di prendere
ARTE E CONTEMPLAZIONE 1 di Santino Cavaciuti Uno dei caratteri fondamentali dell arte è quello di essere contemplativa, distinguendosi, in tal modo, da ciò che è attivo, nel senso, quest ultimo, di prendere
Apporti, Asporti e Regali
 Apporti, Asporti e Regali Collana: Ali d Amore N. 9 A Dilaila e alle anime candide dell Altra Dimensione A P P O R T I Gli apporti sono materializzazioni di oggetti, di animali, di piante o fiori, che
Apporti, Asporti e Regali Collana: Ali d Amore N. 9 A Dilaila e alle anime candide dell Altra Dimensione A P P O R T I Gli apporti sono materializzazioni di oggetti, di animali, di piante o fiori, che
PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare
 PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare Sottogruppo coordinato da Fortunata Capparo (verbale 2 incontro - 18 /11 2002) L ispettore Gandelli ha iniziato l incontro
PSA: Laboratorio disciplinare di religione per gli insegnanti della scuola elementare Sottogruppo coordinato da Fortunata Capparo (verbale 2 incontro - 18 /11 2002) L ispettore Gandelli ha iniziato l incontro
La mia autostima. Edizioni Erickson. Deborah Plummer. Dario Ianes Centro Studi Erickson Università di Bolzano www.darioianes.it
 Edizioni Erickson La mia autostima Dario Ianes Centro Studi Erickson Università di Bolzano www.darioianes.it Deborah Plummer Introduzione L immaginazione come strumento per il cambiamento Imagework: un
Edizioni Erickson La mia autostima Dario Ianes Centro Studi Erickson Università di Bolzano www.darioianes.it Deborah Plummer Introduzione L immaginazione come strumento per il cambiamento Imagework: un
La rivista aziendale. Tavola rotonda Comunicare la salute: gli strumenti Modena, 30 ottobre 2003
 La rivista aziendale Tavola rotonda Comunicare la salute: gli strumenti Modena, 30 ottobre 2003 Conflitti d interesse del relatore Il relatore è amministratore dell Agenzia Zadig di giornalismo scientifico,
La rivista aziendale Tavola rotonda Comunicare la salute: gli strumenti Modena, 30 ottobre 2003 Conflitti d interesse del relatore Il relatore è amministratore dell Agenzia Zadig di giornalismo scientifico,
f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da
 Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Data una funzione reale f di variabile reale x, definita su un sottoinsieme proprio D f di R (con questo voglio dire che il dominio di f è un sottoinsieme di R che non coincide con tutto R), ci si chiede
Mario Basile. I Veri valori della vita
 I Veri valori della vita Caro lettore, l intento di questo breve articolo non è quello di portare un insegnamento, ma semplicemente di far riflettere su qualcosa che noi tutti ben sappiamo ma che spesso
I Veri valori della vita Caro lettore, l intento di questo breve articolo non è quello di portare un insegnamento, ma semplicemente di far riflettere su qualcosa che noi tutti ben sappiamo ma che spesso
L uso e il significato delle regole (gruppo A)
 L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
L uso e il significato delle regole (gruppo A) Regole organizzative: devono essere rispettare per far sì che la struttura possa funzionare e che si possa vivere in un contesto di rispetto reciproco; Regole
FISICA. Le forze. Le forze. il testo: 2011/2012 La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri IPSIA A.
 01 In questa lezione parliamo delle forze. Parliamo di forza quando: spostiamo una cosa; solleviamo un oggetto; fermiamo una palla mentre giochiamo a calcio; stringiamo una molla. Quando usiamo (applichiamo)
01 In questa lezione parliamo delle forze. Parliamo di forza quando: spostiamo una cosa; solleviamo un oggetto; fermiamo una palla mentre giochiamo a calcio; stringiamo una molla. Quando usiamo (applichiamo)
Test d ipotesi. Statistica e biometria. D. Bertacchi. Test d ipotesi
 In molte situazioni una raccolta di dati (=esiti di esperimenti aleatori) viene fatta per prendere delle decisioni sulla base di quei dati. Ad esempio sperimentazioni su un nuovo farmaco per decidere se
In molte situazioni una raccolta di dati (=esiti di esperimenti aleatori) viene fatta per prendere delle decisioni sulla base di quei dati. Ad esempio sperimentazioni su un nuovo farmaco per decidere se
Il linguaggio moderno: linguaggio scientifico, linguaggio del realismo politico. 2a liceo classico 2014/15
 Il linguaggio moderno: linguaggio scientifico, linguaggio del realismo politico 2a liceo classico 2014/15 ell età moderna il campo scientifico e quello politico assumono una nuova autonomia. Nasce l esigenza
Il linguaggio moderno: linguaggio scientifico, linguaggio del realismo politico 2a liceo classico 2014/15 ell età moderna il campo scientifico e quello politico assumono una nuova autonomia. Nasce l esigenza
Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica. xiv legislatura disegni di legge e relazioni documenti
 Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei
Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei
Sommario. Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi.
 Algoritmi 1 Sommario Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi. 2 Informatica Nome Informatica=informazione+automatica. Definizione Scienza che si occupa dell
Algoritmi 1 Sommario Definizione di informatica. Definizione di un calcolatore come esecutore. Gli algoritmi. 2 Informatica Nome Informatica=informazione+automatica. Definizione Scienza che si occupa dell
LANCIAMO UN DADO PER DECIDERE CHI DEVE INIZIARE IL GIOCO. PARTIRA IL NUMERO PIU ALTO
 IL GIOCO DEL CALCIO I bimbi della sezione 5 anni sono molto appassionati al gioco del calcio. Utilizzo questo interesse per costruire e proporre un gioco con i dadi che assomigli ad una partita di calcio.
IL GIOCO DEL CALCIO I bimbi della sezione 5 anni sono molto appassionati al gioco del calcio. Utilizzo questo interesse per costruire e proporre un gioco con i dadi che assomigli ad una partita di calcio.
ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO
 ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO 1 PERCHÉ CONOSCERE L ITALIANO È UN PLUSVALORE? 2 Italiano lingua del cuore Feten Fradi - esperta comunicazione audiovisiva Copeam La mia esperienza personale
ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO 1 PERCHÉ CONOSCERE L ITALIANO È UN PLUSVALORE? 2 Italiano lingua del cuore Feten Fradi - esperta comunicazione audiovisiva Copeam La mia esperienza personale
Come chiamare il nostro studio legale? Sembra
 DIMMI COME TI CHIAMI E TI DIRÒ CHE STUDIO SEI di mario alberto catarozzo * Come chiamare il nostro studio legale? Sembra facile, ma solo a parole. Un tempo, gioco forza, lo studio prendeva il nome del
DIMMI COME TI CHIAMI E TI DIRÒ CHE STUDIO SEI di mario alberto catarozzo * Come chiamare il nostro studio legale? Sembra facile, ma solo a parole. Un tempo, gioco forza, lo studio prendeva il nome del
Capitolo 3: Cenni di strategia
 Capitolo 3: Cenni di strategia Le "Mobilità" L obiettivo fondamentale del gioco è, naturalmente, catturare semi, ma l obiettivo strategico più ampio è di guadagnare il controllo dei semi in modo da poter
Capitolo 3: Cenni di strategia Le "Mobilità" L obiettivo fondamentale del gioco è, naturalmente, catturare semi, ma l obiettivo strategico più ampio è di guadagnare il controllo dei semi in modo da poter
U.D.U. Unione Degli Universitari Bari
 1. A quale Corso di Laurea appartieni? Informatica N.O. Informatica e Comunicazione Digitale Informatica e Tecnologie per la Produzione del Informatica V.O. Laurea Specialistica in Informatica ( I Anno
1. A quale Corso di Laurea appartieni? Informatica N.O. Informatica e Comunicazione Digitale Informatica e Tecnologie per la Produzione del Informatica V.O. Laurea Specialistica in Informatica ( I Anno
INCONTRO CON L AUTORE JACOPO OLIVIERI
 INCONTRO CON L AUTORE JACOPO OLIVIERI Lo scrittore Jacopo Olivieri ha incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola A. Aleardi del plesso di Quinto nelle giornate del 18 e 19 febbraio
INCONTRO CON L AUTORE JACOPO OLIVIERI Lo scrittore Jacopo Olivieri ha incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola A. Aleardi del plesso di Quinto nelle giornate del 18 e 19 febbraio
APPARIZIONI DELLA REGINA DELLA FAMIGLIA Ghiaie di Bonate, Bergamo (13-31 maggio 1944)
 APPARIZIONI DELLA REGINA DELLA FAMIGLIA Ghiaie di Bonate, Bergamo (13-31 maggio 1944) Posizione della Santa Chiesa Queste apparizioni della Madre di Dio non hanno ancora ottenuto il verdetto di autentica
APPARIZIONI DELLA REGINA DELLA FAMIGLIA Ghiaie di Bonate, Bergamo (13-31 maggio 1944) Posizione della Santa Chiesa Queste apparizioni della Madre di Dio non hanno ancora ottenuto il verdetto di autentica
come nasce una ricerca
 PSICOLOGIA SOCIALE lez. 2 RICERCA SCIENTIFICA O SENSO COMUNE? Paola Magnano paola.magnano@unikore.it ricevimento: martedì ore 10-11 c/o Studio 16, piano -1 PSICOLOGIA SOCIALE COME SCIENZA EMPIRICA le sue
PSICOLOGIA SOCIALE lez. 2 RICERCA SCIENTIFICA O SENSO COMUNE? Paola Magnano paola.magnano@unikore.it ricevimento: martedì ore 10-11 c/o Studio 16, piano -1 PSICOLOGIA SOCIALE COME SCIENZA EMPIRICA le sue
Salvatore Salamone. Manuale d istruzione per. Coppie che. Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE! ... tutto sommato un libro d amore
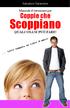 Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
Salvatore Salamone Manuale d istruzione per Coppie che Scoppiano QUALCOSA SI PUÒ FARE!... tutto sommato un libro d amore CAPITOLO 18 Voler avere ragione Spesso le coppie incontrano delle barriere insormontabili
Questionario Insegnante-Alunno
 Questionario Insegnante-Alunno A cura di Silvia Spaziani (TPRI: The Teacher Pupil Relationship Inventory): modulo per lo studente di G. T. Barrett- Lennard Introduzione Godfrey T. Barrett-Lennard Ph.D.,
Questionario Insegnante-Alunno A cura di Silvia Spaziani (TPRI: The Teacher Pupil Relationship Inventory): modulo per lo studente di G. T. Barrett- Lennard Introduzione Godfrey T. Barrett-Lennard Ph.D.,
Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
ANNO SCOLASTI CO 2010/ 2011
 ANNO SCOLASTI CO 2010/ 2011 ANNO SCOLASTI CO 2010/ 2011 FINALITA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI Acquisire atteggiamenti di stima e sicurezza di se e degli altri Scoprire attraverso i racconti
ANNO SCOLASTI CO 2010/ 2011 ANNO SCOLASTI CO 2010/ 2011 FINALITA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI Acquisire atteggiamenti di stima e sicurezza di se e degli altri Scoprire attraverso i racconti
CONFLITTO D INTERESSI TRA MEDICI E INDUSTRIA FARMACEUTICA
 CONFLITTO D INTERESSI TRA MEDICI E INDUSTRIA FARMACEUTICA Uno studio quali-quantitativo sulla percezione degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna Alice Fabbri Centro Studi e Ricerche
CONFLITTO D INTERESSI TRA MEDICI E INDUSTRIA FARMACEUTICA Uno studio quali-quantitativo sulla percezione degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna Alice Fabbri Centro Studi e Ricerche
sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
Dio, il mondo e il Big- -Bang
 Dio, il mondo e il Big- -Bang come parlare di Dio creatore ome ha fatto Dio a fare il Mondo? Dio, i miracoli e le leggi della natura DIO e il Mondo Dio, Adamo ed Eva, e l evoluzione Dio o il Big Bang?
Dio, il mondo e il Big- -Bang come parlare di Dio creatore ome ha fatto Dio a fare il Mondo? Dio, i miracoli e le leggi della natura DIO e il Mondo Dio, Adamo ed Eva, e l evoluzione Dio o il Big Bang?
Curricolo di Religione Cattolica
 Curricolo di Religione Cattolica Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria - L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù
Curricolo di Religione Cattolica Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria - L alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù
Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica
 Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica Si rifà alla concezione ciclica della storia, formata da fasi alterne che si ripetono
Pareto (1848-1923) Si oppone alla teoria positivista di Comte per essere andato al di là dei limiti della scienza empirica Si rifà alla concezione ciclica della storia, formata da fasi alterne che si ripetono
Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B. Evento prodotto: Evento in cui si verifica sia A che B ; p(a&b) = p(a) x p(b/a)
 Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B Eventi indipendenti: un evento non influenza l altro Eventi disgiunti: il verificarsi di un evento esclude l altro Evento prodotto:
Probabilità condizionata: p(a/b) che avvenga A, una volta accaduto B Eventi indipendenti: un evento non influenza l altro Eventi disgiunti: il verificarsi di un evento esclude l altro Evento prodotto:
Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile
 Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente
Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente
«Il Padre vi darà un altro Paraclito»
 LECTIO DIVINA PER LA VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) Di Emio Cinardo «Il Padre vi darà un altro Paraclito» Gv 14,15-21 Lettura del testo Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) In quel tempo, Gesù disse
LECTIO DIVINA PER LA VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) Di Emio Cinardo «Il Padre vi darà un altro Paraclito» Gv 14,15-21 Lettura del testo Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) In quel tempo, Gesù disse
I.I.S.S. Francesco Ferrara. Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale
 I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità
I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità
L apprendimento si verifica in un atmosfera sicura derivante dall aver formato solide relazioni interpersonali.
 L apprendimento si verifica in un atmosfera sicura derivante dall aver formato solide relazioni interpersonali. (Michael Grinder dopo aver osservato Carl Rogers). Prima che qualcuno si interessi a quello
L apprendimento si verifica in un atmosfera sicura derivante dall aver formato solide relazioni interpersonali. (Michael Grinder dopo aver osservato Carl Rogers). Prima che qualcuno si interessi a quello
Test di Autovalutazione
 Test di Autovalutazione Il test può essere fatto seguendo alcune semplici indicazioni: Nelle aree segnalate (risposta, domanda successiva, spazio con la freccia,) sono collocati già dei comandi Con un
Test di Autovalutazione Il test può essere fatto seguendo alcune semplici indicazioni: Nelle aree segnalate (risposta, domanda successiva, spazio con la freccia,) sono collocati già dei comandi Con un
Come fare una scelta?
 Come fare una scelta? Don Alberto Abreu www.pietrscartata.com COME FARE UNA SCELTA? Osare scegliere Dio ha creato l uomo libero capace di decidere. In molti occasioni, senza renderci conto, effettuiamo
Come fare una scelta? Don Alberto Abreu www.pietrscartata.com COME FARE UNA SCELTA? Osare scegliere Dio ha creato l uomo libero capace di decidere. In molti occasioni, senza renderci conto, effettuiamo
Istituto Comprensivo Perugia 9
 Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2015/2016 Programmazione delle attività educativo didattiche SCUOLA PRIMARIA Disciplina RELIGIONE CLASSE: PRIMA L'alunno: - Riflette sul significato dell
Istituto Comprensivo Perugia 9 Anno scolastico 2015/2016 Programmazione delle attività educativo didattiche SCUOLA PRIMARIA Disciplina RELIGIONE CLASSE: PRIMA L'alunno: - Riflette sul significato dell
Ventilazione del locale di carica carrelli elevatori
 Ventilazione del locale di carica carrelli elevatori In ambito industriale è ormai consolidato l uso di carrelli elevatori elettrici. Queste macchine sono corredate di un gruppo batterie ricaricabili che
Ventilazione del locale di carica carrelli elevatori In ambito industriale è ormai consolidato l uso di carrelli elevatori elettrici. Queste macchine sono corredate di un gruppo batterie ricaricabili che
TRAPIANTI DI PERSONA
 TRAPIANTI DI PERSONA Illustrazione di Matteo Pericoli 2003 Lui. [Si ferma davanti a un portone.] Che mal di testa. [Concitato, legge la targa.] Clinica Zoom. Trapianti Ogni Organo. Ogni organo? È quello
TRAPIANTI DI PERSONA Illustrazione di Matteo Pericoli 2003 Lui. [Si ferma davanti a un portone.] Che mal di testa. [Concitato, legge la targa.] Clinica Zoom. Trapianti Ogni Organo. Ogni organo? È quello
SISTEMA di GESTIONE QUALITÀ Non Conformità ed Efficacia delle Azioni Correttive Preventive
 SISTEMA di GESTIONE QUALITÀ Non Conformità ed Efficacia delle Azioni Correttive Preventive Il sistema di gestione della qualità a cui mi riferisco è quello relativo alla norma ISO-9001:2000. Prima di entrare
SISTEMA di GESTIONE QUALITÀ Non Conformità ed Efficacia delle Azioni Correttive Preventive Il sistema di gestione della qualità a cui mi riferisco è quello relativo alla norma ISO-9001:2000. Prima di entrare
ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO
 ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO 1 PERCHÉ CONOSCERE L ITALIANO È UN PLUSVALORE? 2 Perché conoscere l italiano è un plusvalore? Un esempio dal Marocco Malika Eddakhch- docente di italianistica
ITALIANO PONTE TRA LE CULTURE NEL MEDITERRANEO 1 PERCHÉ CONOSCERE L ITALIANO È UN PLUSVALORE? 2 Perché conoscere l italiano è un plusvalore? Un esempio dal Marocco Malika Eddakhch- docente di italianistica
CONSIGLI PER GIOVANI NAVIGANTI (anche già navigati).
 CONSIGLI PER GIOVANI NAVIGANTI (anche già navigati). HEY! SONO QUI! (Ovvero come cerco l attenzione). Farsi notare su internet può essere il tuo modo di esprimerti. Essere apprezzati dagli altri è così
CONSIGLI PER GIOVANI NAVIGANTI (anche già navigati). HEY! SONO QUI! (Ovvero come cerco l attenzione). Farsi notare su internet può essere il tuo modo di esprimerti. Essere apprezzati dagli altri è così
Istruzioni per leggere bene. Istruzioni per leggere bene
 Istruzioni per leggere bene A cura di Silvana Loiero 1 La lettura orientativa La prima: farsi un idea generale La seconda: identificare le parti La terza: scorrere indici e sintesi La quarta: leggere rapidamente
Istruzioni per leggere bene A cura di Silvana Loiero 1 La lettura orientativa La prima: farsi un idea generale La seconda: identificare le parti La terza: scorrere indici e sintesi La quarta: leggere rapidamente
La Trottola. Questa è una storia vera ma, se l avessi inventata, mi premierei per la fantasia! Questo e-book fa parte della collana Punture di Vespe
 Questo e-book fa parte della collana Punture di Vespe La Trottola Questa è una storia vera ma, se l avessi inventata, mi premierei per la fantasia! Questo documento è stato realizzato da MarcaturaCe.Net.
Questo e-book fa parte della collana Punture di Vespe La Trottola Questa è una storia vera ma, se l avessi inventata, mi premierei per la fantasia! Questo documento è stato realizzato da MarcaturaCe.Net.
queste domande e l importanza delle loro risposte, per quanto concerne questo lavoro.
 ABSTRACT La presenti tesi affronterà i problemi legati ai diritti umani, focalizzandosi specificatamente sul trattamento e lo sviluppo di questi diritti in Cina e nelle sue due Regioni Amministrative Speciali,
ABSTRACT La presenti tesi affronterà i problemi legati ai diritti umani, focalizzandosi specificatamente sul trattamento e lo sviluppo di questi diritti in Cina e nelle sue due Regioni Amministrative Speciali,
La Convenzione sui diritti dell infanzia
 NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre
NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre
ADOZIONE E ADOLESCENZA: LA COSTRUZIONE DELL IDENTITÀ E RICERCA DELLE ORIGINI
 ADOZIONE E ADOLESCENZA: LA COSTRUZIONE DELL IDENTITÀ E RICERCA DELLE ORIGINI DOTT. CARLOS A. PEREYRA CARDINI - PROF.SSA ALESSANDRA FERMANI PROF.SSA MORENA MUZI PROF. ELIO RODOLFO PARISI UNIVERSITÀ DEGLI
ADOZIONE E ADOLESCENZA: LA COSTRUZIONE DELL IDENTITÀ E RICERCA DELLE ORIGINI DOTT. CARLOS A. PEREYRA CARDINI - PROF.SSA ALESSANDRA FERMANI PROF.SSA MORENA MUZI PROF. ELIO RODOLFO PARISI UNIVERSITÀ DEGLI
I modelli di qualità come spinta allo sviluppo
 I modelli di qualità come spinta allo sviluppo Paolo Citti Ordinario Università degli studi di Firenze Presidente Accademia Italiana del Sei Sigma 2005 1 Si legge oggi sui giornali che l azienda Italia
I modelli di qualità come spinta allo sviluppo Paolo Citti Ordinario Università degli studi di Firenze Presidente Accademia Italiana del Sei Sigma 2005 1 Si legge oggi sui giornali che l azienda Italia
Adulti - Fragilità. Valeria Cavallina Responsabile Unità Attività Sociale Sanitaria Distretto Porretta Terme
 Adulti - Fragilità Valeria Cavallina Responsabile Unità Attività Sociale Sanitaria Distretto Porretta Terme Noi Fragili«Fragilità» ha la stessa radice di frangere, che significa rompere. Chi è fragile
Adulti - Fragilità Valeria Cavallina Responsabile Unità Attività Sociale Sanitaria Distretto Porretta Terme Noi Fragili«Fragilità» ha la stessa radice di frangere, che significa rompere. Chi è fragile
Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008
 Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008 L Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e l Ufficio Nazionale per l Educazione,
Convegno GIOVANI E LAVORO Roma 13-15 ottobre 2008 L Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e l Ufficio Nazionale per l Educazione,
PIANO ANNUALE I.R.C.
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOGRATO (BS) SCUOLA DELL INFANZIA ZIROTTI DI MACLODIO (BS) PIANO ANNUALE I.R.C. ( INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA) A.A. 2015/2016 INSEGNANTE: Cutrupi Alessia 1. U.d.A. IL DONO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOGRATO (BS) SCUOLA DELL INFANZIA ZIROTTI DI MACLODIO (BS) PIANO ANNUALE I.R.C. ( INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA) A.A. 2015/2016 INSEGNANTE: Cutrupi Alessia 1. U.d.A. IL DONO
Principi generali. Vercelli 9-10 dicembre 2005. G. Bartolozzi - Firenze. Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli
 Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli Principi generali Carlo Federico Gauss Matematico tedesco 1777-1855 G. Bartolozzi - Firenze Vercelli 9-10 dicembre 2005 Oggi il nostro lavoro
Il Pediatra di famiglia e gli esami di laboratorio ASL Vercelli Principi generali Carlo Federico Gauss Matematico tedesco 1777-1855 G. Bartolozzi - Firenze Vercelli 9-10 dicembre 2005 Oggi il nostro lavoro
Le scoperte rivoluzionarie di Galileo Galilei
 Italian Level 2 Final Examination 2012 Time: 2 hours A. Leggi il brano seguente e rispondi alle domande. (30 punti) Le scoperte rivoluzionarie di Galileo Galilei Galileo Galilei è uno dei principali studiosi
Italian Level 2 Final Examination 2012 Time: 2 hours A. Leggi il brano seguente e rispondi alle domande. (30 punti) Le scoperte rivoluzionarie di Galileo Galilei Galileo Galilei è uno dei principali studiosi
