La Luna con il binocolo
|
|
|
- Susanna Sasso
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La Luna con il binocolo Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli Terzo Incontro - 17/08/ Teatro Talia di Tagliacozzo - astro@progetto-comune.it Adolfo De Sanctis Associazione Culturale Progetto Comune Sommario In questo incontro parleremo del primo strumento ottico che utilizzeremo: il binocolo. Questo è uno strumento molto versatile, economico e di facile utilizzo che può regalare all'astrolo alle prime armi immagini davvero emozionanti. L'osservazione del cielo con strumenti ottici nasce al tempo di Galileo Galilei il quale modicò il progetto del cannocchiale (nato in Olanda) per adattarlo all'osservazione celeste. Nacque così il Telescopio. Nel tempo gli strumenti ottici si sono evoluti e sono stati aancati due cannocchiali di piccole dimensioni in un unico strumento, il binocolo appunto. I vantaggi che si traggono da una visione con entrambi gli occhi sono notevoli. Il basso ingrandimento e la portabilità sono i punti di forza del binocolo come strumento per l'osservazione amatoriale del Cielo. Il primo corpo celeste che osserveremo con il binocolo è il nostro satellite naturale: la Luna. L'uso di uno strumento ottico immediatamente permette di cogliere la vera natura del suolo lunare: fatto di crateri, valli, montagne e altopiani. In questa lezione vedremo alcuni consigli per l'osservazione della Luna e alcune delle principali caratteristiche del suo suolo che sono osservabili con il binocolo. Fig. 1: Luna: foto di A. De Sanctis. Nikon D3000, 200mm f5.6. Indice 1 Gli strumenti ottici: il binocolo Che cos'è e come funziona L'uso del binocolo in astronomia L'osservazione della Luna Topograa lunare Quando e cosa osservare
2 2 1 Gli strumenti ottici: il binocolo 1 Gli strumenti ottici: il binocolo Il binocolo è spesso additato come il telescopio dei poveri, ma nulla è più lontano dalla realtà. Un binocolo ore una immagine del cielo che non è possibile ottenere con altri strumenti. La regola d'oro per l'uso degli strumenti astronomici è: il giusto strumento per il giusto oggetto celeste. Il Binocolo, infatti, permette di osservare un grande campo, grazie al suo basso ingrandimento. La capacità di usare entrambi gli occhi ore numerosi vantaggi tra cui la comodità e il fatto di non dover sforzare un solo occhio. Gli oggetti principali che si possono osservare con un binocolo dipendono dalle sue caratteristiche. 1.1 Che cos'è e come funziona Un binocolo è in sostanza una coppia di cannocchiali aancati, con un sistema di messa a fuoco comune. Esso è contrassegnato da due numeri che ne indicano le caratteristiche fondamentali (comuni a molti altri strumenti ottici), ovvero ingrandimento e diametro della lente principale (apertura): ad esempio un binocolo 7 50 (sette per cinquanta) ha un ingrandimento di 7 (sette per) e un diametro della lente principale di 50 mm (le misure in ottica sono sempre espresse in millimetri per le lunghezze e in gradi per gli angoli). L'ingrandimento denisce il campo visivo a disposizione e in astronomia deve andare di pari passo con il diametro della lente principale poichè quest'ultimo determina la quantità di luce che viene raccolta dallo strumento. Un diametro maggiore corrisponde ad una mggiore raccolta di luce e quindi alla possibilità di vedere oggetti più deboli. In tabella 1a è riportata la magnitudine visuale limite osservabile con lenti di diversi diametri (aperture). Apertura Magnitudine Apertura Magnitudine 50mm mm 11 60mm mm 12 70mm mm 13.4 (a) Magnitudine visuale limite per diverse aperture. Apertura Risoluzione Apertura Risoluzione 50mm mm mm mm mm mm 0.8 (b) Risoluzione (in secondi d'arco) per diverse aperture. Tab. 1 L'apertura inuenza anche un'altro parametro ottico: la risoluzione angolare. Questa è il minimo angolo che un sistema ottico (come una lente, un microscopio o un telescopio) è in grado di distinguere, senza che il fenomeno della dirazione confonda l'immagine. Ovvero è il minimo angolo di separazione tra due oggetti identici sotto cui questi appaiono distinti. In tabella 1b è riportata la risoluzione calcolata per diverse aperture attraverso la regola del pollice (detto criterio di Dawes): sep = 116 D (1) dove sep è la separazione in secondi d'arco e D è il diametro della lente principale in mm. Questi due parametri, magnitudine limite e risoluzione, debbono essere sempre noti per il proprio strumento in quanto servono per sapere se un determinato oggetto è visibile oppure no con lo strumento Tipologie di binocoli I binocoli si distinguono in primo luogo per il tipo di costruzione ottica e meccani Le due categorie principali sono: con prismi di porro e con prismi a tetto. In gura 2 è mostrata la dierenza costruttiva. Non esiste un tipo più indicato dell'altro ma in astronomia, per quanto detto prima, si cerca sempre un diametro maggiore della lente principale e questo obbliga all'uso di una costruzione con prismi di porro. Il binocolo è composto da quattro parti principali: gli obiettivi (lenti primarie), i tubi ottici (con sistema di messa a fuoco e correzione diottrica), i prismi e gli oculari Test e messa a fuoco del binocolo La scelta del binocolo è materia complicata e dipende molto da cosa si vuole osservare. Un binocolo non deve essere necessariamente costoso, purchè faccia quello che deve fare e sia privo di grossolani difetti ottici. Nella scelta di un binocolo, anche uno economico, è molto importante vericare che non ci siano disallineamenti nelle due immagini. In gura 3a sono riportati due disallineamenti tipici che si osservano inquadrando un oggetto (ad esempio il bordo di un tetto) tenendo il binocolo leggermente lontano dagli occhi. Benchè un piccolo disallineamento verticale (al centro in g. 3a) sia tollerabile, una inclinazione non lo è aatto. Un difetto di questo tipo può obbligare il cervello a correggere l'immagine e quindi dare un forte mal di testa dopo qualche minuto di osservazione.
3 1.2 L'uso del binocolo in astronomia 3 Fig. 2: Tipologie di binocoli. L'uso del binocolo prevede alcuni aggiustamenti tra cui la messa a fuoco. In gura 3b è mostrata la sequenza di operazioni da compiere per mettere a fuoco correttamente un binocolo. Queste consistono in: 1. Impostare la distanza interpupillare aprendo o chiudendo le due parti; 2. Usando solo la parte sinistra mettere a fuoco su un oggetto usando la vite centrale; 3. Inne mettere a fuoco la parte destra usando la correzione diottri La correzione diottrica è la possibilità di ruotare uno o entrambi gli oculari indipendentemente dal sistema di messa a fuoco principale. Questa è necessaria per chi ha difetti visivi e deve compensare, ad esempio, la miopia di un solo occhio. 1.2 L'uso del binocolo in astronomia La scelta del binocolo per astronomia è dettata da alcuni fattori: il tipo di oggetti che si vuole osservare, il peso e l'ingombro dello strumento e la postazione di osservazione che si ha a disposizione. Strumenti molto grandi ed ingombranti normalmente pesano anche molto, per usarli è necessario un supporto stabile (ad es. un treppiedi) e non permettono facili spostamenti. Strumenti di piccole e medie dimensioni, al contrario, possono essere usati anche senza supporto (anche se è sempre raccomandato) e sono facilmente trasportabili. In più il ridotto peso stanca di meno le braccia durante una sessione di osservazione. Ovviamente il compromesso deve essere tra peso, ingombro, praticità e potenza ottica! In tabella 2 riportiamo le caratteristiche di alcuni tra i principali binocoli ad uso astronomico, in base a queste caratteristiche ognuno può scegliere il più adatto alle sue esigenze. Per quanto riguarda il peso c'è una regola da seguire. Benchè sia sempre raccomandato l'uso di un treppiedi o di un altro tipo di supporto, alcuni binocoli di piccole dimensioni possono essere usati senza, in particolare se si adoperano anche per osservazioni diurne. I binocoli con peso superiore ad 1 però necessitano quasi tutti di un supporto adatto per un uso prolungato Cura e mantenimento Se un binocolo viene usato con attenzione può durare tutta la vita. L'importante è seguire poche semplici regole. Quando si passa da un ambiente freddo ad uno caldo e umido (ad esempio rientrando in casa dopo un'osservazione) si può formare della condensa sulle lenti: è importante non rimuoverla con panni o spugne, ma lasciarla evaporare naturalmente senza porre sul binocolo i tappi delle lenti. Questi tappi però devono essere sempre tenuti sulle lenti quando il binocolo non è in uso, per prevenire l'accumulo di polvere. Questa non va mai eliminata troppo di frequente (meglio un pò di polvere che una lente graata) e quando necessario va fatto usando un getto d'aria delicato (non bombolette) o un pennellino morbido. Se necessario è possibile usare un liquido per lenti fotograche e un apposito panno per rimuovere macchie o altro sporco.
4 4 1 Gli strumenti ottici: il binocolo (a) Fig. 3: I difetti di costruzione meccanica che danno disallineamenti nell'immagine sono da evitare. Difetti di costruzione e messa a fuoco del binocolo. (b) Messa a fuoco del binocolo. Benchè un piccolo disallineamento verticale (al centro) sia tollerabile, una inclinazione non lo è a atto. Modello Descrizione 8 20 Peso Binocolo tascabile, utile per uso occasionale durante il giorno. Poco luminoso 450 g 710 g per l'uso in astronomia, è in grado di mostrare i crateri lunari e molte più stelle di quelle visibili ad occhio nudo. Uno strumento piccolo e leggero, utile da portare durante una passeggiata Un buon strumento: leggero e molto versatile. Di notte mostra molte stelle in zone dove ad occhio nudo non se ne vedono ed è in grado di mostrare i più brillanti oggetti di profondo cielo. Uno strumento leggero che può essere usato senza supporto Spesso de nito come il binocolo ideale per astronomia: fornisce un'immagine davvero brillante con un ampio campo. Buono per osservare oggetti poco luminosi ma di grandi dimensioni, come i grandi ammassi stellari e le grandi nebulose. L'ampio campo è utile per trovare oggetti da osservare in seguito con un telescopio. Ottimo per osservare il suolo lunare. Uno strumento ottimo per iniziare, meglio se accoppiato ad un treppiedi Lo strumento di base per molti astro li. Ha un buon compromesso tra ingrandimento e apertura. Leggermente pesante per un uso prolungato senza treppiedi ma utile anche per osservazioni diurne Buono per osservare le stelle e per osservazioni da aree con elevato g inquinamento luminoso. Riesce a mostrare ancora i più brillanti oggetti di profondo cielo ma il ridotto campo lo rende meno utile per la localizzazione Il binocolo per gli astro li. Troppo pesante ed ingombrante per essere usato senza un supporto ma ottimo per ottenere immagini dettagliate delle stelle e di molti oggetti di profondo cielo. Mostra dettagli della Luna e dei pianeti, spesso usato in coppia con un telescopio Binocolo di grandi dimensioni, troppo pesante per essere usato senza un robusto treppiedi. La grande apertura permette di osservare anche oggetti molto deboli. L'elevato ingrandimento permette di osservare la Luna e i pianeti con notevole dettaglio. Uno strumento per l'astro lo con esperienza. Tab. 2: Caratteristiche di diversi tipi di binocolo ad uso astronomico. costruttore. Il peso è una stima e varia in base al
5 5 2 L'osservazione della Luna La Luna, il nostro satellite naturale, è senza dubbio il primo oggetto verso cui si può puntare un binocolo. Immediatamente balzano agli occhi delle immagini meravigliose e ci si rende davvero conto del fatto che la Luna è composta da valli, montagne, altipiani e crateri. La Luna presenta delle fasi (g. 4a), ovvero non è sempre visibile completamente dalla Terra. Conoscere il calendario e le fasi lunari è molto importante per pianicare un'osservazione. Un almanacco permette di trovare tutti i dati necessari. Non è consigliabile osservare la Luna quando è piena, almeno non solo. In ogni sua fase la Luna permette di osservare le sue caratteristiche topograche sempre sotto luci diverse, in quanto il Sole illumina con angoli diversi la sua supercie. Un buon atlante o una mappa topograca sono necessari per familiarizzare con il suolo lunare e per orientarsi durante l'osservazione. Benchè noto lo ripetiamo: la Luna ci mostra sempre la stessa faccia o lato, in quanto il suo periodo di rotazione è in sincrono con il suo periodo di rivoluzione, un moto comune a molti altri satelliti naturali di altri pianeti. (a) Fasi lunari. (b) Coordinate selenograche. Fig. 4: Le fasi lunari e le coordinate selenograche. 2.1 Topograa lunare Il suolo lunare è costellato di formazioni rocciose; vi si riconoscono crateri, valli, montagne e altopiani. I nomi di queste formazioni (disponibili su atlanti e mappe) sono solitamente in latino (come per i grandi piani detti maria) oppure riportano il nome dello scopritore o di qualche famoso personaggio che ha legato il suo nome alla Scienza. Il posizionamento sulla Luna di una determinata formazione (cratere, valle o montagna) avviene tramite le sue coordinate dette selenograche: per la Luna, secondo la convenzione dell'iau l'ovest si trova verso l'oceanus Procellarum e l'est verso il Mare Crisium. Per coordinata selenograca si intende una delle due coordinate, la latitudine e la longitudine, espresse entrambe in gradi, utilizzate per identicare univocamente la posizione di un punto sulla supercie della Luna (g. 4b): la latitudine selenograca indica la posizione a nord o a sud dell'equatore lunare (di latitudine 0 ); è positiva verso Nord (verso il cratere Plato) e negativa verso Sud (verso il cratere Tycho). la longitudine selenograca indica la posizione a est o ad ovest rispetto al meridiano centrale della Luna (di longitudine 0 ); aumenta verso Est (verso il Mare Crisium): è 90 al bordo esterno (o lembo medio) Est della Luna, 180 nella posizione opposta alla Terra, 270 al bordo esterno Ovest, e arriva 360 al meridiano centrale.
6 6 Riferimenti bibliograci il meridiano centrale è la linea di longitudine che passa per il punto medio centrale del disco lunare visibile, ossia il punto di metà della Luna, come si vede dalla Terra. La topograa lunare comprende diverse formazioni: Terrae e Maria L'emisfero visibile della Luna mostra due tipi di terreno: le pianure scure ( maria) e le terre chiare o altopiani (terrae). Le terrae coprono buona parte della supercie lunare e sono crivellate di crateri da impatto. Queste formazioni costituiscono la parte più antica della crosta lunare. I maria sono formazioni più recenti dovute alla fuoriuscita di magma dall'interno della Luna a seguito di una frattura causata dall'impatto di piccoli asteroidi. Crateri da impatto Sull'emisfero visibile della Luna ci sono crateri con diametro maggiore di 1 Km, mentre quelli con diametro maggiore di 100 km sono 234. In generale, i crateri da impatto si formano quando un asteroide cade sulla supercie di un corpo celeste. Il numero di crateri in una determinata zona è legato all'età della formazione, formazioni più antiche (le terrae) sono sature di crateri da impatto, mentre formazioni più recenti (i maria) sono quasi sgombre da crateri. La morfologia di un cratere dipende dal diametro: crateri più piccoli hanno la forma di una scodella, mentre crateri più grandi presentano un picco al centro. Queste dierenze sono dovute al processo che porta alla formazione del cratere. Crateri vulcanici Alcuni piccoli crateri sono causati da vulcanismo e non da impatti. Sono solitamente più piccoli e con pareti esterne molto ripide e pareti interne più dolci (al contrario dei crateri da impatto) e presentano una bassa erosione da micrometeoriti. Raggi lunari Sono spesso ben visibili anche a piccoli ingrandimenti e si irradiano a partire da un cratere. Questi sono dovuti alla rottura della crosta a seguito di un grande impatto e al successivo deposito di materiale espulso dall'impatto stesso. Alcuni complessi di raggi coprono quasi metà della supercie lunare. Catene montuose Le più grandi strutture da impatto sono circondate da anelli concentrici di montagne ( montes). Questi però non sono frutto degli stessi processi che hanno generato le montagne terrestri, bensì sono dovuti all'impatto di grandi asteroidi. Le catene sono spesso dislocate attorno a maria, dove la fuoriuscita di magma non è riuscita a superare il dislivello di quota tra bacino d'impatto e bordo rialzato. Spesso hanno i nomi degli analoghi terrestri come Montes Appenninus e Montes Alpes. 2.2 Quando e cosa osservare In gura 5 sono mostrate le formazioni osservabili sulla Luna nelle diverse fasi di Luna crescente: Fig. 5a Maria della Luna. 1: Oceanus Procellarum; 2: Mare Imbrium; 3: Mare Humorum; 4: Mare Nubium; 5: Mare Serenitatis; 6: Mare Tranquillitatis; 7: Mare Nectaris; 8: Mare Fecunditatis; 9: Mare crisium. Fig. 5b Luna crescente (prima falce). 1: Mare Crisium; 2: Langrenus; 3: Petavius. Fig. 5c Luna crescente. 1: Hercules, Atlas; 2: Palus Somni, Proclus; 3: Theophilus, Cyrillus, Catharina. Fig. 5d Primo quarto. 1: Montes Caucasus; 2: Aristillus; 3: Montes Apennine; 4: Hipparchus, Albategnius. Fig. 5e Gibbosa crescente. 1: Plato; 2: Sinus Iridum; 3: Copernicus; 4: Bullialdus; 5: Tycho. Fig. 5f Con la Luna piena molti crateri sono dicili da vedere a causa della forte illuminazione, inoltre non proiettano ombre. Ad ogni modo la dierenza di tonalità tra Terrae e Maria è ben visibile. 1: Aristarcus; 2: Kepler; 3: Grimaldi; 4: Schickard; 5: Mare Frigoris; 6: Mare Vaporum; 7: Sinus Medii. Come abbiamo precedentemente detto e come si può osservare dalle immagini proposte l'osservazione visuale della Luna non può essere limitata alla fase di plenilunio. L'osservazione, l'individuazione e la descrizione delle diverse formazioni può essere portata avanti sfruttando l'intero ciclo lunare, perchè in ogni fase la Luna ci orirà sempre un dettaglio diverso dello stesso oggetto. Riferimenti bibliograci [1] A complete manual of Amateur Astronomy - Tools and Techniques for Astronomical Observations - P. Clay Sherrod, Thomas L. Koed - Dover Publications, ISBN: [2] Practical Astronomy, Storm Dunlop, PHILIP'S [3] Stargazing with binoculars, R. Scagell, D. Frydman, PHILIP'S [4] Conoscere e osservare la Luna, dal disegno al CCD, Manuale della sezione Luna dell'uai, allegato a l'astronomia n 237 dicembre 2002 (
7 7 Riferimenti bibliogra ci (a) (c) (e) Luna piena: maria Luna crescente Gibbosa crescente Fig. 5: (b) Luna crescente (prima falce) (d) (f) Primo quarto Luna piena Formazioni osservabili sulla Luna nelle diverse fasi di crescenza.
Il Telescopio (Parte I)
 Il Telescopio (Parte I) Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli Quinto Incontro - 21/09/2013 - Palazzo Ducale di Tagliacozzo www.progetto-comune.it/astro - astro@progetto-comune.it
Il Telescopio (Parte I) Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli Quinto Incontro - 21/09/2013 - Palazzo Ducale di Tagliacozzo www.progetto-comune.it/astro - astro@progetto-comune.it
Stelle doppie e Ammassi con il binocolo
 Stelle doppie e Ammassi con il binocolo Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli Quarto Incontro - 31/08/2013 - Sala Consiliare di Tagliacozzo www.progetto-comune.it/astro - astro@progetto-comune.it
Stelle doppie e Ammassi con il binocolo Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli Quarto Incontro - 31/08/2013 - Sala Consiliare di Tagliacozzo www.progetto-comune.it/astro - astro@progetto-comune.it
L ORIGINE DELLA LUNA
 LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
LA LUNA L ORIGINE DELLA LUNA La luna è l unico satellite naturale della Terra: un corpo celeste che ruota attorno alla Terra Appare molto più grande delle altre stelle ed anche più vicina L origine della
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior. Problemi con soluzioni
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2012 GARA INTERREGIONALE - Categoria Senior Problemi con soluzioni Problema 1. Un sistema binario visuale si trova ad una distanza D=42 anni-luce dalla Terra. Le due stelle
Relazione. Esperienza didattica all'osservatorio astronomico (POF 2011)
 1 Esperienza didattica all'osservatorio astronomico (POF 2011) Relazione Gruppo: Camilla Chiappetta, Anna D Errico, Caterina Filippini, Sara Giorgini, Giulia Laura Montani Procedura calcolo Moretus Il
1 Esperienza didattica all'osservatorio astronomico (POF 2011) Relazione Gruppo: Camilla Chiappetta, Anna D Errico, Caterina Filippini, Sara Giorgini, Giulia Laura Montani Procedura calcolo Moretus Il
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO
 Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
Area tematica SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO Sin dai tempi più remoti il cielo ha avuto grande importanza per l uomo. Il cielo è testimone di miti, di leggende di popoli antichi; narra di terre lontane,
Il taccuino dell esploratore
 Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Il taccuino dell esploratore a cura di ORESTE GALLO (per gli scout: Lupo Tenace) QUINTA CHIACCHIERATA L ORIENTAMENTO (prima parte) Un buon escursionista fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno
Scientifico Tecnologico
 Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
Scientifico Tecnologico Compiti vacanze estive giugno 2016 La Terra nel sistema solare S.L.Murialdo Pinerolo Materiale didattico co-finanziato dal POR FSE 2014-2020 PERIODO DI RIFERIMENTO OBIETTIVO VALUTATO
Corso di astronomia pratica
 Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
Corso di astronomia pratica CRASL Gruppo Astrofili Astigiani Andromedae Fondamenti di astronomia pratica Tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!!! Stasera
3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
 Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
Introduzione 3. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine Ogni volta che vogliamo individuare un punto sulla superficie terrestre gli associamo due numeri, le coordinate geografiche: la latitudine
LA TERRA. La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI.
 LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
LA TERRA La TERRA ha la forma di una grande sfera un po schiacciata alle estremità, chiamate POLI. Per poterla studiare possiamo rappresentare la TERRA per mezzo di un mappamondo (globo). Su di esso possiamo
Un percorso di ottica parte II
 Un percorso di ottica parte II Isabella Soletta Liceo Fermi Alghero Documento riadattato da MyZanichelli.it Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti
Un percorso di ottica parte II Isabella Soletta Liceo Fermi Alghero Documento riadattato da MyZanichelli.it Questo simbolo significa che l esperimento si può realizzare con materiali o strumenti presenti
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra
 Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Unità 4 Paragrafo 1 La forma e le dimensioni della Terra forma ellissoide di rotazione più precisamente geoide sfera schiacciata ai poli solido più gonio dove ci sono i continenti e un po depresso nelle
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica
 Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
Tempi d esposizione e magnitudine limite nella fotografia astronomica Vediamo un metodo per calcolare i valori di esposizione basato su di una formula dell International Standard Organization (ISO); esso
il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione
 il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione Il microscopio è un occhio affascinante attraverso cui è possibile scoprire un nuovo mondo di sapere, un mondo popolato di esseri viventi e
il Microscopio Strumento di osservazione e di sperimentazione Il microscopio è un occhio affascinante attraverso cui è possibile scoprire un nuovo mondo di sapere, un mondo popolato di esseri viventi e
L illuminazione della Terra
 L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
L illuminazione della Terra I moti della Terra nello spazio Sole Mercurio Venere Terra La Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole, che è una stella con un raggio di circa 700 000 km e dista
Le Coordinate Astronomiche
 Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
Le Stelle vanno a scuola Le Coordinate Astronomiche Valentina Alberti Novembre 2003 1 2 INDICE Indice 1 Coordinate astronomiche 3 1.1 Sistema dell orizzonte o sistema altazimutale.......... 3 1.2 Sistema
Di cosa parliamo stasera
 1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
1 Di cosa parliamo stasera Posizioni reciproche dei pianeti Orbite dei pianeti Effemeridi e pianificazione delle osservazioni L'aspetto dei pianeti al telescopio Fasi di Venere e Mercurio Bande di Giove
Calcolo dell altezza di un rilievo lunare: l esempio di Arzachel
 Calcolo dell altezza di un rilievo lunare: l esempio di Arzachel Lo scopo della suddetta esperienza è il calcolo dell altezza di un particolare rilievo lunare, scelto appositamente per la conformazione
Calcolo dell altezza di un rilievo lunare: l esempio di Arzachel Lo scopo della suddetta esperienza è il calcolo dell altezza di un particolare rilievo lunare, scelto appositamente per la conformazione
Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo
 Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo Nel 1610 Galilei scoprì col suo cannocchiale che intorno al Pianeta Giove ruotavano quattro satelliti, scomparendo e ricomparendo continuamente.
Misure di longitudine con le lune di Giove di Lucia Corbo Nel 1610 Galilei scoprì col suo cannocchiale che intorno al Pianeta Giove ruotavano quattro satelliti, scomparendo e ricomparendo continuamente.
SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$
![SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$ SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,<$](/thumbs/54/35044472.jpg) &$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
&$/(1'$5,2 $6752120,&2 SHUO DQQR $QQR,QWHUQD]LRQDOH GHOO $VWURQRPLD,
LA LUNA fasi Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto crescente
 LA LUNA La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Essa ruota intorno al nostro pianeta, seguendo un'orbita ellittica, in 27 giorni e 8 ore, a una distanza media di circa 384000 km. L'orbita è inclinata
LA LUNA La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Essa ruota intorno al nostro pianeta, seguendo un'orbita ellittica, in 27 giorni e 8 ore, a una distanza media di circa 384000 km. L'orbita è inclinata
sfera celeste e coordinate astronomiche
 sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
sfera celeste e coordinate astronomiche sfera celeste La sfera celeste appare come una grande sfera che ruota su se stessa, al cui centro sta la Terra immobile, e sulla cui superficie stanno le stelle
ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA
 ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA Ci proponiamo in questo articolo di gettare luce su tre argomenti sempre molto confusi e malcompresi: l acuità
ACUITÀ VISIVA, DIOTTRIE E LENTI CORRETTIVE: TUTTO CIÒ CHE NON SERVE SAPERE PER GUARIRE LA VISTA Ci proponiamo in questo articolo di gettare luce su tre argomenti sempre molto confusi e malcompresi: l acuità
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI
 IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
IL PLANETARIO DEL LICEO SCACCHI Prof. Luciana Carrieri (responsabile del planetario) Il Planetario del Liceo Scacchi di Bari è uno strumento ottico che proietta su una cupola di 5 metri di diametro l immagine
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO).
 L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
L UNIVERSO L UNIVERSO È IMMENSO. CONTIENE TUTTE LE STELLE E TUTTI I PIANETI CHE ESISTONO (MOLTI SONO COSÌ LONTANI CHE NOI NON LI CONOSCIAMO). LA SCIENZA CHE STUDIA I CORPI CELESTI (CIOE' LE STELLE E I
La Luna è il nostro satellite naturale e ha scandito per millenni il trascorrere del tempo, le cerimonie religiose, i lavori agricoli e altre
 La luna La Luna è il nostro satellite naturale e ha scandito per millenni il trascorrere del tempo, le cerimonie religiose, i lavori agricoli e altre attività. Ha un raggio circa ¼ di quello terrestre
La luna La Luna è il nostro satellite naturale e ha scandito per millenni il trascorrere del tempo, le cerimonie religiose, i lavori agricoli e altre attività. Ha un raggio circa ¼ di quello terrestre
1. Le stelle. corpi celesti di forma sferica. costituite da gas (idrogeno ed elio)
 LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
LE STELLE 1. Le stelle corpi celesti di forma sferica costituite da gas (idrogeno ed elio) producono energia al loro interno tramite reazioni di fusione nucleare, la emettono sotto forma di luce che arriva
Si tratta di un modello dalla forma classica, corredato di 4 obbiettivi e di 3 oculari intercambiabili che permettono di spaziare da 40 a 1200
 Il microscopio Per dedicarsi allo studio del mondo invisibile è necessario naturalmente avere un microscopio, per chi desiderasse acquistarne uno consigliamo di evitare certi modelli di microscopio giocattolo
Il microscopio Per dedicarsi allo studio del mondo invisibile è necessario naturalmente avere un microscopio, per chi desiderasse acquistarne uno consigliamo di evitare certi modelli di microscopio giocattolo
CONCETTO. DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo
 DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo CONCETTO Il Deep Sky ReiseAtllas è l'equivalente cartografico della guida del profondo cielo e integra dati, mappe dettagliate, descrizioni, foto e
DEEP SKY REISEATLAS Atlante guida del Profondo cielo CONCETTO Il Deep Sky ReiseAtllas è l'equivalente cartografico della guida del profondo cielo e integra dati, mappe dettagliate, descrizioni, foto e
1 p. 1 q 1 R. altrimenti se il mezzo circostante ha un indice di rifrazione n 0. , al posto di n si deve usare
 2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
2 Lenti Le lenti sono costituite da un mezzo rifrangente, di indice di rifrazione n, omogeneo, delimitato da superfici sferiche nel caso in cui il mezzo circostante é l aria: l equazione delle lenti é
Astronomia Osservazione del cielo
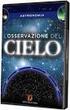 Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
Corso facoltativo Astronomia Osservazione del cielo Christian Ferrari & Gianni Boffa Liceo di Locarno Parte O: Osservazione del cielo Osservazione semplici (occhio nudo, binocolo) Sviluppo degli strumenti
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA CLASSE 1^ H. a. s Prof.ssa RUBINO ALESSANDRA
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "ENRICO FERMI" Via Luosi n. 23-41124 Modena Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 E-mail: info@fermi.mo.it Pagina web: www.fermi.mo.it PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA
Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica
 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica Progetto Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica Antonio Maggio
LE LENTI GRAVITAZIONALI. Luca Ciotti
 LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
LE LENTI GRAVITAZIONALI Luca Ciotti 1. Introduzione storica Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività Generale del 1915 fece una delle deduzioni che più avrebbero acceso l'immaginazione del grande
IL SISTEMA SOLARE. Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da :
 IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da : IL SISTEMA SOLARE I pianeti sono Corpi celesti di forma sferica che non brillano di luce propria, ma
IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE Il sistema solare è un insieme di corpi celesti E formato da : IL SISTEMA SOLARE I pianeti sono Corpi celesti di forma sferica che non brillano di luce propria, ma
COS E LA SCIENZA? SCIENZA VUOL DIRE CONOSCENZA, PERCIO ESSA STUDIA TUTTO CIO CHE E INTORNO A NOI: OSSERVA LA MAPPA E IMPARA
 COS E LA SCIENZA? SCIENZA VUOL DIRE CONOSCENZA, PERCIO ESSA STUDIA TUTTO CIO CHE E INTORNO A NOI: OSSERVA LA MAPPA E IMPARA CI SONO MOLTI TIPI DI SCIENZIATI E OGNUNO STUDIA DELLE COSE DIVERSE: OSSERVA
COS E LA SCIENZA? SCIENZA VUOL DIRE CONOSCENZA, PERCIO ESSA STUDIA TUTTO CIO CHE E INTORNO A NOI: OSSERVA LA MAPPA E IMPARA CI SONO MOLTI TIPI DI SCIENZIATI E OGNUNO STUDIA DELLE COSE DIVERSE: OSSERVA
IL MOTO di ROTAZIONE. CONSEGUENZE del MOTO di ROTAZIONE
 IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
IL MOTO di ROTAZIONE moto di rotazione: il moto di rotazione è il movimento che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, in senso antiorario per un osservatore posto al polo nord celeste;
MAPPA PROGETTO TERRA e UNIVERSO. VIAGGI NELLO SPAZIO (le stelle e il sole, i pianeti, i satelliti ) VIAGGIO NEL TEMPO:
 MAPPA PROGETTO 2009-2010 VIAGGIO NEL TEMPO: Le ere Geologiche CONTESTO TEMATICO TERRA e UNIVERSO VIAGGI NELLO SPAZIO (le stelle e il sole, i pianeti, i satelliti ) I GRANDI FENOMENI NATURALI ( ATMOSFERICI,
MAPPA PROGETTO 2009-2010 VIAGGIO NEL TEMPO: Le ere Geologiche CONTESTO TEMATICO TERRA e UNIVERSO VIAGGI NELLO SPAZIO (le stelle e il sole, i pianeti, i satelliti ) I GRANDI FENOMENI NATURALI ( ATMOSFERICI,
Fenomeni astronomici del Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti
 Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
Fenomeni astronomici del 2014 Cometa ISON Calendario Eclissi Luna Pianeti Cometa che nel 2014 potrebbe diventare interessante è la C/2012 K1 ( PanSTARRS ) scoperta nel maggio 2012 dal sistema Pan-STARRS
LUNA - Eclissi Totale
 DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
DATI GENERALI Data: 03.03.07 Ora Media: 23.40 LT Luogo Osserv.: Rho (Mi) Strumento Usato: C8 F/10 + Riduttore a f/6,3 + Focheggiatore SC Analog Microfocuser + Eos Canon 300D (foto) - KASAI 80 mm f/6 (visuale)
Per andare avanti, fai click!! Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna?
 Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna? La Luna non è una stella, perché le stelle sono grandissime sfere di gas che brillano di luce propria. Come il nostro Sole La Luna non
Che cos è la Luna? Come si è formata? Come è fatta la nostra Luna? La Luna non è una stella, perché le stelle sono grandissime sfere di gas che brillano di luce propria. Come il nostro Sole La Luna non
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE
 MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
MISURA DI LUNGHEZZE D ONDA CON UNO SPETTROSCOPIO A RETICOLO DI DIFFRAZIONE Il reticolo di diffrazione può essere utilizzato per determinare la lunghezza d onda di una radiazione monocromatica. Detto d
1. La luce delle stelle
 1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
1. La luce delle stelle 2. La scala delle magnitudini La luminosità delle stelle appare diversa a occhio nudo. Ipparco di Nicea creò, intorno al 120 a.c., una scala di luminosità che assegnava il valore
DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI. Cap.5 STRUMENTI OTTICI
 DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI Cap.5 STRUMENTI OTTICI Ing. Fabrizio Liberati Cap. 5 STRUMENTI OTTICI Gli strumenti ottici utilizzati direttamente dall occhio umano,
DISPENSE DI PROGETTAZIONE OTTICA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI OTTICI Cap.5 STRUMENTI OTTICI Ing. Fabrizio Liberati Cap. 5 STRUMENTI OTTICI Gli strumenti ottici utilizzati direttamente dall occhio umano,
Moti della Terra. Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari
 Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
Moti della Terra Rotazione Rivoluzione Precessione e nutazioni Moti millenari Asse terrestre 23 27 asse equatore Piano eclittica L asse terrestre -passante per il centro, emergente ai Poli, punti della
MOTO DI ROTAZIONE da ovest verso est asse terrestre
 I moti della Terra La Terra compie numerosi movimenti poiché gira: intorno a se stessa a 0,4 Km/s; attorno al Sole a 30 Km/s; insieme a tutto il sistema solare a 220 Km/s quindi è come se si muovesse
I moti della Terra La Terra compie numerosi movimenti poiché gira: intorno a se stessa a 0,4 Km/s; attorno al Sole a 30 Km/s; insieme a tutto il sistema solare a 220 Km/s quindi è come se si muovesse
Topografia, Cartografia e GIS. Prof. Carlo Bisci. Modulo Topografia e Cartografia (6 CFU) Nozioni di base
 Topografia, Cartografia e GIS Prof. Carlo Bisci Modulo Topografia e Cartografia (6 CFU) 0 Nozioni di base Topografia e Cartografia = Rappresentazione del territorio su carta Le carte Sono rappresentazioni
Topografia, Cartografia e GIS Prof. Carlo Bisci Modulo Topografia e Cartografia (6 CFU) 0 Nozioni di base Topografia e Cartografia = Rappresentazione del territorio su carta Le carte Sono rappresentazioni
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia
 Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
Unità di misura di lunghezza usate in astronomia In astronomia si usano unità di lunghezza un po diverse da quelle che abbiamo finora utilizzato; ciò è dovuto alle enormi distanze che separano gli oggetti
CARATTERISTICHE DELLE STELLE
 CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
CARATTERISTICHE DELLE STELLE Lezioni d'autore di Claudio Censori VIDEO Introduzione I parametri stellari più importanti sono: la le la la luminosità, dimensioni, temperatura e massa. Una stella è inoltre
Sfera Celeste e Coordinate Astronomiche. A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011
 Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
Astronomiche A. Stabile Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio Benevento Atripalda, 9 Maggio 2011 Unità di lunghezza e distanze tipiche 1. Sistema Solare: 1 UA = 149,5 milioni di
Orientarsi Bussola e Azimut Carte e scale Misure. Topografia. Basi minime di topografia. Reparto Aquile Randage. Chirignago 1
 Basi minime di topografia. Chirignago 1 2008 Contenuti 1 Orientarsi La bussola Orientarsi con il sole Orientarsi con le stelle 2 Marcia all azimut Percorso rettificato 3 Paralleli e meridiani Scala 4 La
Basi minime di topografia. Chirignago 1 2008 Contenuti 1 Orientarsi La bussola Orientarsi con il sole Orientarsi con le stelle 2 Marcia all azimut Percorso rettificato 3 Paralleli e meridiani Scala 4 La
OTTO ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO CAI SAT 2 LEZIONE: USO
 OTTO ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO CAI SAT 2 LEZIONE: USO e UTILIZZO della BUSSOLA 1 SAT 2 Lezione aggiornata al 24 Settembre 2015 (ultima) 1 Poli Magnetici. 2 Longitudine e Latitudine. 3 Bussole.
OTTO ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO CAI SAT 2 LEZIONE: USO e UTILIZZO della BUSSOLA 1 SAT 2 Lezione aggiornata al 24 Settembre 2015 (ultima) 1 Poli Magnetici. 2 Longitudine e Latitudine. 3 Bussole.
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017. Scuola di Astronomia. Contenuti dei corsi e dei seminari.
 Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
Centro Sperimentale per la Didattica dell'astronomia A.A. 2016/2017 Scuola di Astronomia Contenuti dei corsi e dei seminari Corso A 1.1. Didattica dell astronomia 1.2. Approccio sperimentale all'astronomia
LEZIONI DI CARTOGRAFIA
 LEZIONI DI CARTOGRAFIA by Andrea ErDuca Palladino PART. 2 LA CARTA TOPOGRAFICA IMPORTANTE: QUESTA GUIDA E STATA REDATTA ESCLUSIVAMENTE PER UN USO INTERNO DELL ASSOCIAZIONE E PERTANTO VIETATA LA DIVULGAZIONE
LEZIONI DI CARTOGRAFIA by Andrea ErDuca Palladino PART. 2 LA CARTA TOPOGRAFICA IMPORTANTE: QUESTA GUIDA E STATA REDATTA ESCLUSIVAMENTE PER UN USO INTERNO DELL ASSOCIAZIONE E PERTANTO VIETATA LA DIVULGAZIONE
I buchi ne!: piccoli. e gran" cannibali
 I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio Astronomico di Brera) I mostri del cielo I buchi ne!: piccoli e gran" cannibali insaziabili Tomaso Belloni (Osservatorio
La Luna e le sue fasi
 La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
La Luna e le sue fasi nella scuola di base Giordano Enrica, Onida Monica, Rossi Sabrina Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, Italia Percorso e Metodologia MARZO
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015
 FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
FENOMENI ASTRONOMICI NOVEMBRE 2015 In questo mese inizia a essere osservabile abbastanza comodamente Giove, che domina il cielo nella seconda parte della notte. Il 1 di Novembre, intorno alle 02:00 T.U.
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania. Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia
 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astrofisico di Catania Università degli Studi di Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia Eclisse parziale di Sole 29 Marzo 2006 A cura di: G. Leto,
pianeta Terra caratteristiche generali
 pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE
 LC.06.02.06 LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE Prerequisiti: nozioni scientifiche e matematiche acquisite durante la scuola secondaria di primo grado Obiettivi: studio della latitudine e della longitudine
LC.06.02.06 LA LATITUDINE E LA LONGITUDINE Prerequisiti: nozioni scientifiche e matematiche acquisite durante la scuola secondaria di primo grado Obiettivi: studio della latitudine e della longitudine
TOPOGRAFIA e CARTOGRAFIA
 1. Un ettometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 2. Un chilometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 3. Un decametro corrisponde a : a. 0,1 m ; b. 0,01 m ; c. 10
1. Un ettometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 2. Un chilometro corrisponde a : a. 100 m ; b. 1.000 m ; c. 10.000 m ; 3. Un decametro corrisponde a : a. 0,1 m ; b. 0,01 m ; c. 10
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote
 Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
Spettroscopia ottica di sorgenti celesti ignote Filippo Dalla, Angelo La Rocca, Luca Palmieri ABSTRACT La spettroscopia è la scienza che si occupa dello studio e della misura di uno spettro, i dati che
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni hanno comunque un indubbio valore storico/culturale, oltre a permettere un facile orientamento nel cielo
 LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
LE COSTELLAZIONI Le costellazioni sono raggruppamenti arbitrari di stelle Le stelle che formano una costellazione possono essere lontanissime tra di loro e non rappresentare, dunque, un sistema legato
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO. Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011.
 Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
Progetto legge 6/2000 IL PLANETARIO Nautico San Giorgio Istituto Tecnico dei Trasporti e la Logistica Genova 28 gennaio 2011 Iniziative previste Presentazione ai docenti Visite degli studenti Visite di
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior
 OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA 2015 FINALE NAZIONALE 19 Aprile Prova Teorica - Categoria Senior 1. Vero o falso? Quale delle seguenti affermazioni può essere vera? Giustificate in dettaglio la vostra
1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6.
 1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6. Le eclissi 7. Le maree Il pianeta blu Ecco come appare
1. Il pianeta blu 2. La longitudine e la latitudine 3. I moti della Terra nello spazio 4. Luce e buio sulla Terra 5. La Luna, il nostro satellite 6. Le eclissi 7. Le maree Il pianeta blu Ecco come appare
How to compute the sun vector for path planning
 How to compute the sun vector for path planning 1 Calcolo dell illuminazione delle celle solari Si consideri la Fig. 1. Il rover si sposta sulla mappa, variando nel tempo la sua posizione p = ( x y z )
How to compute the sun vector for path planning 1 Calcolo dell illuminazione delle celle solari Si consideri la Fig. 1. Il rover si sposta sulla mappa, variando nel tempo la sua posizione p = ( x y z )
Dalla Luna, la Scienza
 Dalla Luna, la Scienza PROGETTO MoonKAM - Parte 2 Fabrizio Bernardini MoonKAM Prospettiva MoonKAM Nomenclatura Ripassiamo Mare Bacino Crateri Zone montuose Raggi MoonKAM Ripassiamo Nomenclatura LUNA AL
Dalla Luna, la Scienza PROGETTO MoonKAM - Parte 2 Fabrizio Bernardini MoonKAM Prospettiva MoonKAM Nomenclatura Ripassiamo Mare Bacino Crateri Zone montuose Raggi MoonKAM Ripassiamo Nomenclatura LUNA AL
Prestazioni dei telescopi
 Prestazioni dei telescopi Commento. Siamo partiti con fasci di raggi paralleli provenienti da una sorgente, per finire nuovamente con fasci di raggi paralleli che escono dall oculare. Questa condizione
Prestazioni dei telescopi Commento. Siamo partiti con fasci di raggi paralleli provenienti da una sorgente, per finire nuovamente con fasci di raggi paralleli che escono dall oculare. Questa condizione
OTTICA DELLA VISIONE. Disegno schematico dell occhio umano
 OTTICA DELLA VISIONE Disegno schematico dell occhio umano OTTICA DELLA VISIONE Parametri fisici Raggio di curvatura (cm) Cornea 0.8 Anteriore del cristallino Posteriore del cristallino.0 0.6 Indice di
OTTICA DELLA VISIONE Disegno schematico dell occhio umano OTTICA DELLA VISIONE Parametri fisici Raggio di curvatura (cm) Cornea 0.8 Anteriore del cristallino Posteriore del cristallino.0 0.6 Indice di
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO
 L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
L USO DEL MICROSCOPIO OTTICO Visualizzazione dei microrganismi La visualizzazione dei microrganismi richiede l uso del microscopio ottico o del microscopio elettronico. Il microscopio ottico composto in
IL PIANETA URANO. Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL.
 IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
IL PIANETA URANO Il pianeta fu SCOPERTO nel 1781 da WILLIAM HERSCHEL. A causa di un URTO PLANETARIO L ASSE del pianeta È INCLINATO DI CIRCA 90 e quindi Urano ruota su se stesso con MOTO RETROGRADO Il SUO
LA VOCE DEL PASSATO e del presente
 LA VOCE DEL PASSATO e del presente Numero 4 - Periodico gratuito a cura degli anziani della casa di Riposo Don Rossi e degli alunni della scuola primaria di Branzola. STRATEGIE E INGANNI. PER SFUGGIRE
LA VOCE DEL PASSATO e del presente Numero 4 - Periodico gratuito a cura degli anziani della casa di Riposo Don Rossi e degli alunni della scuola primaria di Branzola. STRATEGIE E INGANNI. PER SFUGGIRE
Latitudine e longitudine: come misurarle nel cortile di casa di Diego Alberto
 Latitudine e longitudine: come misurarle nel cortile di casa di Diego Alberto Questo articolo illustra come misurare la latitudine e la longitudine di un luogo: nel caso specifico, il Comune di Foglizzo,
Latitudine e longitudine: come misurarle nel cortile di casa di Diego Alberto Questo articolo illustra come misurare la latitudine e la longitudine di un luogo: nel caso specifico, il Comune di Foglizzo,
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
 GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA Che cos è la geografia La geografia (dal greco géo, Terra, e graphìa, scrittura, disegno) è la disciplina che studia e descrive la Terra e il rapporto che esiste fra l uomo
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA Che cos è la geografia La geografia (dal greco géo, Terra, e graphìa, scrittura, disegno) è la disciplina che studia e descrive la Terra e il rapporto che esiste fra l uomo
Unione Astrofili Italiani Sezione di Ricerca - Luna
 Unione Astrofili Italiani Unione Astrofili Italiani a cura di: claudio vantaggiato indice 1. Pleniluni di perigeo. pag. 2 2. Le foto della - UAI. pag. 3 3. Transient Lunar Phenomena.. pag. 10 4. Vallis
Unione Astrofili Italiani Unione Astrofili Italiani a cura di: claudio vantaggiato indice 1. Pleniluni di perigeo. pag. 2 2. Le foto della - UAI. pag. 3 3. Transient Lunar Phenomena.. pag. 10 4. Vallis
IL SISTEMA SOLARE IL SISTEMA SOLARE E FORMATO DA: -IL SOLE -I PIANETI -I SATELLITI -GLI ASTEROIDI -LE COMETE -I METEORITI/METEORE
 IL SISTEMA SOLARE HA AVUTO ORIGINE CIRCA 4 MILIARDI E MEZZO DI ANNI FA DA UNA NUBE DI GAS E MINUSCOLE PARTICELLE SOLIDE, CHIAMATE DAGLI SCIENZIATI POLVERE. A CAUSA DELLA FORZA DI GRAVITA QUESTE PARTICELLE
IL SISTEMA SOLARE HA AVUTO ORIGINE CIRCA 4 MILIARDI E MEZZO DI ANNI FA DA UNA NUBE DI GAS E MINUSCOLE PARTICELLE SOLIDE, CHIAMATE DAGLI SCIENZIATI POLVERE. A CAUSA DELLA FORZA DI GRAVITA QUESTE PARTICELLE
 www.nikkostirling.com IT Anello di fissaggio Obiettivo Regolazione della parallasse Tubo del cannocchiale Cappuccio della torretta Elevazione Deriva Regolazione dell ingrandimento Illuminazione Oculare
www.nikkostirling.com IT Anello di fissaggio Obiettivo Regolazione della parallasse Tubo del cannocchiale Cappuccio della torretta Elevazione Deriva Regolazione dell ingrandimento Illuminazione Oculare
Il Sistema Solare. Che cos è?
 L ITTE G. Galilei in collaborazione con Lora Stefano e l Associazione Celi Perduti -Astronomia Alto Vicentino- presenta il Progetto: Alla riscoperta dell Astronomia 1 lezione: Il Sistema Solare 2 lezione:
L ITTE G. Galilei in collaborazione con Lora Stefano e l Associazione Celi Perduti -Astronomia Alto Vicentino- presenta il Progetto: Alla riscoperta dell Astronomia 1 lezione: Il Sistema Solare 2 lezione:
LEZIONE 6. L Universo al telescopio
 L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
L Universo al telescopio LEZIONE 6 1: La velocità della luce Come abbiamo già accennato, la luce viaggia nel vuoto ad una velocità pari a 300'000 km/s. Per fare un paragone, la luce ci impiega circa 1
MANUALE UTENTE STEREOMICROSCOPI Serie StereoBlue
 MANUALE UTENTE STEREOMICROSCOPI Serie StereoBlue Rupac S.r.l Via Alamanni 14, 20141 Milano Tel: +39 02.5392212 - Fax: +39 02.5695321 Internet: www.rupac.com Mail: tecnico@rupac.com 2 1.0 Introduzione Con
MANUALE UTENTE STEREOMICROSCOPI Serie StereoBlue Rupac S.r.l Via Alamanni 14, 20141 Milano Tel: +39 02.5392212 - Fax: +39 02.5695321 Internet: www.rupac.com Mail: tecnico@rupac.com 2 1.0 Introduzione Con
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari
 Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
Moti della Terra: Rotazione, Rivoluzione, Moti millenari moto di rotazione giorno sidereo: 23h 56m 4s velocità di rotazione moto di rotazione: conseguenze Alternarsi del dì e della notte Moto apparente
Laura Girola Liceo scientifico G.B.Grassi Saronno (VA) CLASSE PRIMA
 Laura Girola Liceo scientifico G.B.Grassi Saronno (VA) CLASSE PRIMA 1 CHIMICA 2 ESERCIZI SULLE UNITA DI MISURA 3 4 Le caratteristiche di un corpo Ogni corpo possiede proprietà fisiche definite da grandezze
Laura Girola Liceo scientifico G.B.Grassi Saronno (VA) CLASSE PRIMA 1 CHIMICA 2 ESERCIZI SULLE UNITA DI MISURA 3 4 Le caratteristiche di un corpo Ogni corpo possiede proprietà fisiche definite da grandezze
Ciao! Ma puoi sapere qualcos altro dalla luce?
 Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
Ciao! Eccoci qua a parlare ancora di stelle. Le stelle ci mandano della luce visibile (quella che vedi con gli occhi) e da questa luce possiamo studiare quei puntini luminosi che vedi in cielo la notte.
OSSERVARE E MISURARE
 OSSERVARE E MISURARE Per essere degli scienziati precisi dobbiamo poter descrivere i fenomeni che avvengono intorno a noi non soltanto con le parole (quindi in maniera qualitativa) ma anche in maniera
OSSERVARE E MISURARE Per essere degli scienziati precisi dobbiamo poter descrivere i fenomeni che avvengono intorno a noi non soltanto con le parole (quindi in maniera qualitativa) ma anche in maniera
1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le
 1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le leggi di Keplero Il Sistema solare le orbite dei pianeti
1. In giostra intorno al Sole 2. Il Sole, la nostra stella 3. Pianeti rocciosi e pianeti gassosi 4. Asteroidi e comete 5. Il moto dei pianeti: le leggi di Keplero Il Sistema solare le orbite dei pianeti
162. Determinazione approssimata delle coordinate geografiche terrestri Michele T. Mazzucato
 162. Determinazione approssimata delle coordinate geografiche terrestri Michele T. Mazzucato cercherò stanotte di precisare la nostra latitudine e domani a mezzogiorno la nostra longitudine. Cyrus Smith
162. Determinazione approssimata delle coordinate geografiche terrestri Michele T. Mazzucato cercherò stanotte di precisare la nostra latitudine e domani a mezzogiorno la nostra longitudine. Cyrus Smith
PLS. Per insegnanti delle scuole secondarie. Camerino febbraio maggio 2011
 PLS Per insegnanti delle scuole secondarie Camerino febbraio maggio 2011 Obiettivo L obiettivo primario del progetto è quello di coinvolgere insegnanti delle scuole secondarie di scienze e di fisica per
PLS Per insegnanti delle scuole secondarie Camerino febbraio maggio 2011 Obiettivo L obiettivo primario del progetto è quello di coinvolgere insegnanti delle scuole secondarie di scienze e di fisica per
La Terra nello spazio
 La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
La Terra nello spazio L'Universo è sempre esistito? L'ipotesi più accreditata fino ad ora è quella del Big Bang. Circa 20 miliardi di anni fa, una massa di piccolo volume, in cui vi era racchiusa tutta
Il nostro Universo. Che cos è il Big Bang? Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011
 Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
Che cos è il Big Bang? Il nostro Universo Istituto comprensivo Statale Filippo Mazzei Scuola Primaria Lorenzo il Magnifico 5 dicembre 2011 roberto spighi 1 Che cosa sono i corpi celesti? Come si è formato?
pianeta Terra caratteristiche generali
 pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra, alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
pianeta Terra caratteristiche generali Eratostene 275 195 ac http://www.youtube.com/watch?v=-o99ih9kbpw pianeta Terra, alcune delle caratteristiche principali Massa: 5,9 x 10 24 kg Raggio medio: 6.371
Fisica II - CdL Chimica. Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici
 Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici Ottica geometrica In ottica geometrica si analizza la formazione di immagini assumendo che la luce si propaghi in modo rettilineo
Topografia e orientamento
 CAI - ALPINISMO GIOVANILE Secondo Corso Di Avvicinamento Alla Montagna 2012 Topografia e orientamento C A I B o r g o m a n e r o A l p i n i s m o G i o v a n i l e 2 0 1 2 Pagina 1 Introduzione Per un
CAI - ALPINISMO GIOVANILE Secondo Corso Di Avvicinamento Alla Montagna 2012 Topografia e orientamento C A I B o r g o m a n e r o A l p i n i s m o G i o v a n i l e 2 0 1 2 Pagina 1 Introduzione Per un
Corso di ASTRONOMIA DI BASE Esercitazioni: MOVIMENTO DEI CORPI. Allegato alla seconda serata del corso 09/02/2012.
 Corso di ASTRONOMIA DI BASE - 2012 Esercitazioni: MOVIMENTO DEI CORPI Allegato alla seconda serata del corso 09/02/2012. Esercitazione alla prima seconda del corso di astronomia di base 2012 di Skylive-123
Corso di ASTRONOMIA DI BASE - 2012 Esercitazioni: MOVIMENTO DEI CORPI Allegato alla seconda serata del corso 09/02/2012. Esercitazione alla prima seconda del corso di astronomia di base 2012 di Skylive-123
IL SISTEMA TERRA- LUNA
 L UNIVERSO o COSMO È l insieme di tutti i corpi celesti (galassie,stelle,pianeti,satelliti ecc.) e dello spazio che li contiene. Si è formato circa 13.7 miliardi di anni fa, per cause sconosciute,in seguito
L UNIVERSO o COSMO È l insieme di tutti i corpi celesti (galassie,stelle,pianeti,satelliti ecc.) e dello spazio che li contiene. Si è formato circa 13.7 miliardi di anni fa, per cause sconosciute,in seguito
Come costruire una meridiana equatoriale
 Pagina 1 di 5 Come costruire una meridiana equatoriale La meridiana equatoriale è l'orologio solare più semplice da costruire. Per capire come funziona, supponiamo che la Terra sia disposta in modo che
Pagina 1 di 5 Come costruire una meridiana equatoriale La meridiana equatoriale è l'orologio solare più semplice da costruire. Per capire come funziona, supponiamo che la Terra sia disposta in modo che
NAVIGAZIONE ASTRONOMICA parte 3. Circolo Astrofili di Mestre Guido Ruggieri
 parte 3 3 Novembre 2008, ore 21:00 Introduzione. Orientamento sulla Terra. Coordinate orizzontali degli astri, azimuth e altezza. Coordinate equatoriali degli astri, Ascensione Retta e Declinazione. 17
parte 3 3 Novembre 2008, ore 21:00 Introduzione. Orientamento sulla Terra. Coordinate orizzontali degli astri, azimuth e altezza. Coordinate equatoriali degli astri, Ascensione Retta e Declinazione. 17
Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane.
 Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Libbiano, 7 Dicembre 2014 Occhi di Libbiano su pianeti di stelle lontane. A cura di Alberto Villa Pianeti extrasolari Pianeti extrasolari In conseguenza di questo effetto, se la disposizione geometrica
Misurazioni. Manuale d istruzioni
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Misurazioni Manuale d istruzioni Accessori per misurazioni Micrometro per oggetti (1) per tarature Reticoli di misurazione con diverse suddivisioni (2) in mm e pollici Reticolo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Misurazioni Manuale d istruzioni Accessori per misurazioni Micrometro per oggetti (1) per tarature Reticoli di misurazione con diverse suddivisioni (2) in mm e pollici Reticolo
